 di Sandra Burchi e Fabio Dei [*]
di Sandra Burchi e Fabio Dei [*]
“Terra” di Monica Mariniello: fragilità, connessioni e ibridismi
Terra è il titolo del percorso espositivo che si è tenuto nella primavera 2022 in due città, a Pisa presso la Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium dell’Università di Pisa, e a Volterra presso i Sotterranei della Pinacoteca Civica.
La ricerca dell’artista, Monica Mariniello, sensibile ai temi dell’ecologia, è incentrata sui temi che preoccupano il presente. Le opere in mostra, sculture in terracotta colorata da ossidi che le conferiscono diverse tonalità (il cobalto tinge di blu; il manganese di nero; il cromo di verde; il caolino è bianco) sembrano nascere per ispirazione della stessa materia e invitano a una meditazione sui legami fragili e potenti tra gli esseri che popolano il pianeta.
L’incontro fra specie diverse è risolto nel gioco in una scultura come Aeroplano (in cui un primate gioca con un cucciolo d’uomo, una bambina, o nella silenziosa armonia di Insieme in cui una ragazza bendata lascia che sia un grande orso a guardarle le spalle. Figure che esprimono il desiderio di una storia diversa da quella passata e di un futuro diverso da quello annunciato.
Un’ecologia politica che, nelle mani di un’artista, diventa una diversa trama del rapporto fra i viventi. Sapiens2 sposta più in là i toni di una preoccupazione evidente fra i lavori in mostra. Riferita al libro di Yuval Noah Harari [1], questa scultura sintetizza i disastri di una colonizzazione che in pochi secoli ha trasformato il continente riducendo le specie animali e impoverendone la biodiversità. Lo scheletro d’uomo, minuscolo e fragile, se paragonato alla saldezza del corpo del koala, richiama il teschio di uccello di Une annunciation appoggiato sulle spalle di un uomo che apre le braccia come a completare un gesto ormai impossibile per l’animale di cui sono visibili solo i resti.
Gli scheletri, i denti, le corna animali sono usati spesso da Monica Mariniello. Ripensati come copricapo, come dettagli, a volte come veri e propri abbellimenti, questi elementi corporei perdono il loro lato macabro, suggeriscono riferimenti a culture che ne fanno usi simili e, più di tutto, danno indicazioni sull’intreccio di temporalità che caratterizzano le sculture. Il sistema dei segni lascia pensare a un tempo indefinibile, fuori dalla storia, un tempo lungo che scarta la modernità, l’epoca che ha forgiato il nostro modo di pensare alla natura attraverso la mediazione di una cultura scientifico-tecnologica che ha tardato – e tarda tutt’oggi – a riconoscere le connessioni tre le forme di vita che abitano il pianeta.
La riflessione di Monica Mariniello si è mossa con continuità intorno a questi temi, portando avanti nel tempo il gusto di assemblare simboli, codici, linguaggi e dando vita a un immaginario ibrido e metamorfico che oggi è particolarmente presente nelle arti visive, nel dibattito filosofico e nelle teorie che guardano criticamente al modello di sviluppo e al sistema economico in cui siamo immersi.
Il nesso natura – cultura è una tematica antropologica cruciale. Rinominata nel gergo teorico come rapporto fra umani e non umani o fra le rispettive ontologie, questa tematica ha punteggiato la storia del pensiero attraverso un gioco di contrapposizioni e allineamenti, tra chi ha definito la civiltà umana come progressivo distanziamento dallo stato naturale e chi ha sostenuto la necessità di mantenere un rapporto con la condizione di natura, o con lo stato selvaggio.
Oggi, anche in relazione al pensiero post-coloniale o decoloniale, l’antropologia torna su questi temi rinnovando la propria attenzione verso la visione del mondo di quelle culture che un tempo si sarebbero chiamate “animiste” e che suggeriscono la possibilità di un continuum natura-cultura o la reale e letterale esistenza di mondi differenti e paralleli, di ontologie plurali. Una svolta ontologica che almeno dagli anni Novanta si muove cercando di smontare le dicotomie su cui è costruito il nostro immaginario, alla ricerca di un nuovo regime di sociabilità fra le specie.
Un dibattito che nei lavori di Monica Mariniello risuona come un’aspirazione, un desiderio, un atto di volontà mosso dalla preoccupazione per le sorti del pianeta. Nella serie i Viaggiatori, figure umane a dorso di grandi animali, superano i limiti della propria specie affidandosi a guide esperte e a una relazione contraria alle leggi di natura, per portarsi in salvo e sovvertire gli esiti di una civilizzazione che è avanzata distruggendo.
L’idea di natura che propone Monica Mariniello è una natura sublimata, che potrebbe esistere o è già esistita, inafferrabile, inappropriabile. Una natura d’artista che deve molto della sua bellezza e della sua integrità a chi riesca a immaginare o forse, meglio a sentire: «Il sentire è ciò che ci fa fare esperienza del bordo tra le cose nel loro apparire e il lato viscerale, inconscio della natura». Chiara Zamboni nel suo testo [2], riprende questo pensiero di Maria Zambrano, una filosofa che ha trovato parole per dare conto della forza che la natura preserva, proprio nei suoi aspetti pulsionali e sorgivi. Le creature animali modellate da Mariniello nascono su questo bordo, trattengono nella forma, una forza e una sapienza che non si esauriscono. Perfette, definite, espressive si lasciano guardare come appartenenti a un mondo di mezzo che è necessario imparare ad immaginare per progettare nuove alleanze fra quelle che Donna Haraway chiama “specie compagne” [3], rovesciando – in maniera immaginifica – i rapporti di forza.
È un’umanità dolente quella che ci viene consegnata da sculture come The dreamer, o Terre Humaine 4, corpi raccolti, rannicchiati, umani a cui è rimasta la possibilità di ritrovarsi nel silenzio o nel sogno. Guardandoli si è spinti verso un sentimento di attesa, come se dalla loro immobilità potessero uscire immaginando nuovi inizi.
C’è una pluralità di storia e di storie che Monica Mariniello insegue sui volti degli umani, come dimostrano le teste di Teatrum Mundi, una serie portata avanti negli anni.
Le sculture di Teatrum Mundi popolano l’atelier di Monica Mariniello, la accompagnano, le permettono di restare in relazione con i tanti volti che incrocia nei normali transiti della sua vita quotidiana, dando loro una forma che dura nel tempo. Immagini catturate in velocità che si fanno spazio nella memoria dell’artista prima di assumere un’identità propria, immaginaria ma definita.
Il nome della serie rimanda a un’idea di mondo che si fa teatro, eppure, issati sui loro piedistalli, questi personaggi sembrano voler restare in scena a sipario calato, prendersi lo spazio che serve loro per rimanere e per esserci veramente.
Natura e cultura. Lo “stato selvaggio” nella ricerca antropologica
La mostra “Terra” di Monica Mariniello rimanda in modo assai suggestivo, nell’aspetto sensibile e materico non meno che nelle evocazioni figurali, a una tematica antropologica cruciale. È quella che si sarebbe chiamata una volta la relazione fra natura e cultura, e che nel gergo teorico oggi più di moda si chiamerebbe il rapporto tra umani e non umani, o fra le rispettive “ontologie”. Le opere di Mariniello indugiano su una sorta di territorio di mezzo fra natura e cultura, o fra le categorie di “civiltà” e di “selvatichezza” o “stato selvaggio”, mostrandone l’inevitabile intreccio: anzi, meglio ancora, mostrando le possibilità di relazioni metamorfiche, che ricordano un immaginario sciamanico e si collegano ai temi centrali di quell’indirizzo di pensiero che si definisce oggi “svolta ontologica”.
L’arte, il lavoro sulla materia e sui segni, si presta forse meglio della speculazione filosofica a dar conto di questi aspetti. Tuttavia, in questo breve intervento, non mi azzarderò su un terreno che non è il mio – quello della interpretazione e della critica delle opere. Cercherò semmai di delineare, in modo necessariamente schematico, la problematica del rapporto fra la cultura e lo “stato selvaggio” come si presenta nella tradizione antropologica: nella speranza che ciò sia di qualche utilità nel nutrire la riflessione che l’arte di Monica Mariniello ci propone.
Intanto, direi che nella storia del pensiero antropologico si contrappongono, ma talvolta anche si intrecciano, due diverse posizioni. La prima è quella che definisce la civiltà umana come progressivo distanziamento dallo stato naturale. La seconda esprime in vari modi l’idea della necessità di mantenere un rapporto con la condizione di natura, o con lo stato “selvaggio”, nella costituzione della soggettività “civilizzata”. Il primo punto di vista è quello illuminista, e più in generale proprio della tradizione razionalista del pensiero occidentale. È la base di tutte quelle filosofie della storia che vedono il fondamento della ragione nel passaggio, che sarebbe avvenuto in qualche luogo e momento nell’antica Grecia, dal mythos al logos: in una liberazione dalla natura che al tempo stesso la costituisce, in quanto physis, come oggetto di un discorso positivo.
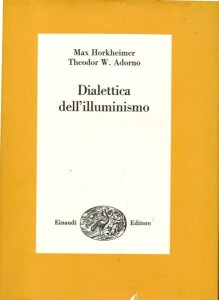 È bene notare che si tratta di un assunto comunque condiviso anche da quelle teorie che criticano la contemporaneità sulla base di una “dialettica dell’Illuminismo”, come quella francofortese. Il celebre libro di Adorno e Horkheimer con questo titolo sostiene che la lotta contro la dipendenza dalla natura, nelle condizioni del capitalismo avanzato, finisce per volgersi nel suo contrario: vale a dire in una nuova dipendenza che si realizza attraverso quegli stessi mezzi tecnici – e quella stessa organizzazione del lavoro – che contro la natura erano stati diretti. Il capitalismo come modo di produzione e la “civiltà” come forma di repressione libidica, in senso freudiano, precipiterebbero i soggetti umani in un nuovo assoggettamento a entità ancora più misteriose di quelle del mito.
È bene notare che si tratta di un assunto comunque condiviso anche da quelle teorie che criticano la contemporaneità sulla base di una “dialettica dell’Illuminismo”, come quella francofortese. Il celebre libro di Adorno e Horkheimer con questo titolo sostiene che la lotta contro la dipendenza dalla natura, nelle condizioni del capitalismo avanzato, finisce per volgersi nel suo contrario: vale a dire in una nuova dipendenza che si realizza attraverso quegli stessi mezzi tecnici – e quella stessa organizzazione del lavoro – che contro la natura erano stati diretti. Il capitalismo come modo di produzione e la “civiltà” come forma di repressione libidica, in senso freudiano, precipiterebbero i soggetti umani in un nuovo assoggettamento a entità ancora più misteriose di quelle del mito.
A proposito di Dialettica dell’illuminismo, varrà qui la pena rammentare la fascinosa lettura dell’Odissea che i due autori propongono: il ritorno di Ulisse a casa, cioè alla civiltà, è costellato da insidie mostruose e terrificanti, ma al tempo stesso anche attraenti, che rimandano allo stato di natura, alla indistinzione di soggetto e oggetto. I Lotofagi, Circe, Polifemo, le Sirene, rappresentano tutti in qualche modo una regressione pre-categoriale: il ritorno ad uno stadio in cui il soggetto “moderno” non si è ancora costituito e non ha ancora costituto di fronte a sé un mondo stabile – una “natura” – che può assumere come oggetto del pensiero e dell’azione. Nella resistenza di Odisseo a queste (talvolta seducenti) minacce, per Adorno e Horkheimer, c’è sempre una componente di auto-repressione. L’episodio delle Sirene è a tal proposito il più significativo: Odisseo non vuol rinunciare ad ascoltare il canto delle mostruose creature (emblema dell’arte), ma per farlo deve privarne i suoi compagni che remano (tappando loro le orecchie con la cera) ed escogitare per sé una tecnica di disciplinamento forzato (farsi legare all’albero della nave). Ecco il prezzo pagato per uscire dal mito – il quale finisce sempre per ritornare in forme nuove e inaspettate.
Cambiando scenario. Per l’etnologo più razionalista del ventesimo secolo, Claude Lévi-Strauss, una filosofia della storia che vede la razionalità emergere o liberarsi dal mito non ha senso. Il suo punto di vista non ammette una origine precategoriale della cultura umana. Nella prospettiva strutturale, il mito è già razionalità completamente dispiegata, tutta incentrata attorno all’elaborazione dell’opposizione natura-cultura. Nei miti amerindi, che analizza con tanta finezza, Lévi-Strauss vede all’opera un pensiero logico centrato sulle classificazioni del mondo naturale e di quello sociale, che vengono articolate una sull’altra in configurazioni narrative. Il lavoro della cultura, più in generale, ha il compito cruciale di trasformare gli aspetti naturali della vita umana (come quelli vitali, condivisi con le specie animali, come l’alimentazione e la riproduzione) in forme di vita sociale guidate da codici semiotici approvati dalla tradizione.
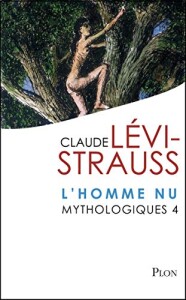 Da qui ad esempio l’importanza della distinzione tra cibi crudi e cotti, tema che per Lévi-Strauss è centrale e fondante nella mitologia amazzonica. Questo è anche il senso della sua lettura dei sistemi di parentela: l’universalità della proibizione dell’incesto si spiega col fatto che tale norma è basilare nella distinzione tra la riproduzione e la sessualità animale e quella umana. Sprofondare nella “natura” è per Lévi-Strauss l’incubo di ogni cultura umana, ed evitarlo è l’obiettivo ultimo di una moltitudine di istituzioni e riti – così diversi ma accomunati da una stessa grammatica generativa.
Da qui ad esempio l’importanza della distinzione tra cibi crudi e cotti, tema che per Lévi-Strauss è centrale e fondante nella mitologia amazzonica. Questo è anche il senso della sua lettura dei sistemi di parentela: l’universalità della proibizione dell’incesto si spiega col fatto che tale norma è basilare nella distinzione tra la riproduzione e la sessualità animale e quella umana. Sprofondare nella “natura” è per Lévi-Strauss l’incubo di ogni cultura umana, ed evitarlo è l’obiettivo ultimo di una moltitudine di istituzioni e riti – così diversi ma accomunati da una stessa grammatica generativa.
A queste posizioni si contrappongono quelle che, fin dall’inizio del ventesimo secolo, hanno invece postulato due forme radicalmente diverse di pensiero umano, o di esperienza umana del mondo. Al pensiero razionale, logico ed empiricamente fondato, si affiancherebbero modalità diverse che non si basano sull’oggettivazione del mondo ma sulla “partecipazione” ad esso. Quest’ultimo termine era usato da Lucien Lévy-Bruhl per definire la mentalità primitiva, cioè quella dei selvaggi, che sarebbero a suo parere “impermeabili all’esperienza”, prelogici, dominati da un rapporto mistico e appunto partecipativo con il mondo. Non potrebbe spiegarsi altrimenti il loro comportamento magico e religioso. Cose che per noi sono chiaramente distinte, a partire dal soggetto e dall’oggetto, per “loro” partecipano misticamente l’una dell’altra. I “primitivi” vivrebbero dunque in un universo radicalmente anticartesiano, incommensurabile rispetto alla visione del mondo razionale. Nell’ultima parte della sua carriera, Lévy-Bruhl non attribuirà più questa modalità prelogica solo ai “primitivi”. Ammetterà che essa è presente in ogni essere umano, anche nei moderni, rappresentando la base del pensiero analogico e delle pratiche simboliche, che non potrebbero spiegarsi in altro modo. Superata una visione decisamente implausibile di selvaggi mistici, resta però un modello dicotomico del pensiero, in cui la razionalità empiricamente e logicamente orientata e le forme simboliche e analogiche si fonderebbero su diverse e incommensurabili facoltà.
 Su tutt’altro versante, la dicotomia è riproposta da Rudolf Otto in un libro – dal titolo Il sacro – che fonda un intero filone di interpretazione fenomenologica della religione. L’esperienza religiosa, che pure le diverse culture o civiltà umane elaborano razionalmente, costruendo su di essa grandi sistemi istituzionali e dottrinali, non ha una base razionale. È piuttosto il frutto dell’“incontro” con il numinoso, qualcosa di “radicalmente altro”, che al tempo stesso affascina e atterrisce gli esseri umani. L’irriducibilità di questa esperienza significa anche che non la si può comprendere (o spiegare), ma solo – eventualmente – rivivere.
Su tutt’altro versante, la dicotomia è riproposta da Rudolf Otto in un libro – dal titolo Il sacro – che fonda un intero filone di interpretazione fenomenologica della religione. L’esperienza religiosa, che pure le diverse culture o civiltà umane elaborano razionalmente, costruendo su di essa grandi sistemi istituzionali e dottrinali, non ha una base razionale. È piuttosto il frutto dell’“incontro” con il numinoso, qualcosa di “radicalmente altro”, che al tempo stesso affascina e atterrisce gli esseri umani. L’irriducibilità di questa esperienza significa anche che non la si può comprendere (o spiegare), ma solo – eventualmente – rivivere.
Fra gli autori che nella storia dell’antropologia hanno insistito sulla verità dell’esperienza magico-religiosa da un lato, e dall’altro sulla sua incommensurabilità rispetto al pensiero scientifico, si potrebbe citare Carlos Castaneda. È vero che si tratta di un personaggio ambiguo, il cui successo editoriale è stato tanto grande quanto lo scetticismo dell’antropologia scientifica nei suoi confronti. Le sue esperienze di apprendistato con lo stregone yaqui Don Juan sono state quasi unanimemente considerate come inventate – in altre parole, frutto di invenzione letteraria e non di esperienza etnografica. È probabile che sia così, e che comunque la sua narrazione abbia accentuato gli aspetti destinati a suscitare l’interesse delle controculture psichedeliche di fine anni Sessanta. Tuttavia, Castaneda ha influito ampiamente su quello che potremmo chiamare un immaginario antropologico diffuso, e la sua visione di una sfera di esperienza separata e incommensurabile con quella ordinaria è paradigmatica. Don Juan pone il suo adepto in rapporto con il nagual, spirito protettore nella mitologia mesoamericana, e più in generale dimensione che trascende l’intelligibilità razionale, che si dà all’esperienza più che alla comprensione. “The nagual is unspeakable”, dice don Juan. Non può essere detto, come il Sacro per Otto, come la Parola del Tuono nella Terra desolata di Eliot. Viene prima del logos e non vi si sottomette. Come negli stati alterati di coscienza, funziona secondo il principio della metamorfosi, non dell’identità.
 Il tema è ripreso nell’opera dell’antropologo tedesco Hans Peter Duerr, Traumszeit, che tenta di legittimare filosoficamente le intuizioni di Castaneda. Per Duerr, nell’umanità “arcaica” (primitiva, antica) esisteva una permeabilità fra civiltà e stato selvaggio. L’attraversamento del confine era una esperienza possibile, anzi per certi versi obbligatoria. Come nei poemi classici, discendere prima agli inferi è cruciale perché si possa poi fondare un ordine culturale. Ma cos’è il selvaggio? Anche per Duerr, è uno stato precategoriale in cui viene meno la costituzione della soggettività e insieme a essa l’oggettività del mondo. Sia Castaneda che Duerr, pur flirtando con la cultura psichedelica, riprendono un filone assai ben incardinato nella storia culturale del Novecento, che ha il suo precursore fondamentale in Heidegger (e probabilmente il suo più celebre antenato in Nietszche). Al centro sta la critica alla limitatezza della civiltà occidentale e “tecnica” che, diversamente dalle culture arcaiche, non è più in grado di riconoscere quell’aspetto oscuro dell’esistenza, lunare, femminile, quello di Diana e delle signore dei boschi e degli animali, delle “donne che corrono con i lupi”, delle figure del margine. La modernità non le riconosce ma le respinge nell’ambito del demoniaco, di ciò che è totalmente disumano, con cui non si può entrare in contatto ma dev’essere solo esorcizzato come minaccia.
Il tema è ripreso nell’opera dell’antropologo tedesco Hans Peter Duerr, Traumszeit, che tenta di legittimare filosoficamente le intuizioni di Castaneda. Per Duerr, nell’umanità “arcaica” (primitiva, antica) esisteva una permeabilità fra civiltà e stato selvaggio. L’attraversamento del confine era una esperienza possibile, anzi per certi versi obbligatoria. Come nei poemi classici, discendere prima agli inferi è cruciale perché si possa poi fondare un ordine culturale. Ma cos’è il selvaggio? Anche per Duerr, è uno stato precategoriale in cui viene meno la costituzione della soggettività e insieme a essa l’oggettività del mondo. Sia Castaneda che Duerr, pur flirtando con la cultura psichedelica, riprendono un filone assai ben incardinato nella storia culturale del Novecento, che ha il suo precursore fondamentale in Heidegger (e probabilmente il suo più celebre antenato in Nietszche). Al centro sta la critica alla limitatezza della civiltà occidentale e “tecnica” che, diversamente dalle culture arcaiche, non è più in grado di riconoscere quell’aspetto oscuro dell’esistenza, lunare, femminile, quello di Diana e delle signore dei boschi e degli animali, delle “donne che corrono con i lupi”, delle figure del margine. La modernità non le riconosce ma le respinge nell’ambito del demoniaco, di ciò che è totalmente disumano, con cui non si può entrare in contatto ma dev’essere solo esorcizzato come minaccia.
Questo è il punto di giunzione con quanto chiamiamo oggi “svolta ontologica”: un vasto e differenziato movimento sviluppato a partire dagli anni ’90, centrato sulla polemica contro il cosiddetto dualismo cartesiano, in particolare proprio contro la dicotomia natura/cultura, vista per l’appunto come la base di quella oggettivazione del mondo naturale – o meglio, delle realtà dei non umani – che sta alla base, contemporaneamente, delle forme di conoscenza naturalistica o scientifica e, insieme, del loro dominio e sfruttamento. All’irresistibile attrazione per il precategoriale, gli autori della svolta ontologica uniscono altri ingredienti, che li fanno apparire “nuovi”, come l’impianto postcoloniale o decoloniale e il riferimento alle filosofie poststrutturaliste: queste ultime li portano ad abbracciare l’opzione paradossale del multinaturalismo (da contrapporre al multiculturalismo), vale a dire la reale, letterale esistenza di mondi differenti e paralleli, di ontologie plurali, e non solo di una pluralità di rappresentazioni del mondo. Philippe Descola sostiene così che nelle mitologie e cosmologie di molte etnie indie «non si operano marcate distinzioni ontologiche fra gli umani da una parte e un buon numero di specie animali e vegetali dall’altra».
La maggior parte delle entità che popolano il mondo sarebbero legate le une alle altre in un vasto continuum animato da principi unitari e governato da uno stesso regime di sociabilità. Quello che chiamavamo un tempo “animismo” (attribuire agli animali un’anima, dei rapporti di parentela etc.) non è una bizzarra credenza, ma la “ribellione” contro l’idea di una separazione netta fra l’ambiente fisico e quello sociale. L’ambiente sarebbe percepito dagli indios amazzonici come essenzialmente indistinto da sé, come un’atmosfera dove fiorisce l’identità collettiva. Indistinzione. E siamo così di nuovo al precategoriale.
Pur con un più sofisticato linguaggio filosofico, la svolta ontologica ripropone le dicotomie di Lévy-Bruhl (razionale/mistico, esperienza/conoscenza) e l’irriducibilità al logos di Castaneda o Duerr. Ma davvero per capire gli Altri c’è bisogno di immaginarli come perduti in una primaria indistinzione fra Sé e mondo? Non è invece possibile una diversa prospettiva, che colga la sfida dello “stato selvaggio” senza il rischio di cadute irrazionaliste? A me sembra di riconoscerla nella teoria di Ernesto de Martino sulla crisi della presenza e la sua risoluzione mitico-rituale. Anche per de Martino la presenza al mondo (l’unità categoriale) e il mondo che si fa presente non sono dati una volta per tutte: possono andare perdute di fronte alla precarietà dell’esistenza. Ma l’umanità è impegnata in una costante lotta per restarvi aggrappata, per mezzo degli strumenti della cultura. La discesa agli inferi (oltrepassare il confine, smarrirsi nel mito) è sì necessaria, ma non per raggiungere una “realtà separata”: piuttosto, come momento di un percorso rituale che inizia mimando la “caduta” ma si rivolge poi alla ripresa, al riscatto, al ritorno. Contro la “nostalgia dell’essere” heideggeriana, contro l’impulso di perdersi nell’abisso, de Martino usava la metafora dello scalatore, che ha l’abisso sotto di sé ma lotta costantemente – con le sue tecniche, con i suoi strumenti – per sfuggirgli. Da qui la necessità di una costante esplorazione del “confine oscuro” – la stessa che, per concludere, ritrovo nelle opere di Monica Mariniello: ma nel quadro di una fedeltà razionalista che non dobbiamo illuderci di poter abbandonare.
Dialoghi Mediterranei, n. 59, gennaio 2023
[*] Il paragrafo “Terra” di Monica Mariniello: fragilità, connessioni e ibridismi è da attribuire a Sandra Burchi; Natura e cultura. Lo “stato selvaggio” nella ricerca antropologica è firmato da Fabio Dei.
Note
[1] Yuval Noah Harari, Sapiens da animali a dèi. Breve storia dell’umanità, Bompiani Milano, 2017
[2] Chiara Zamboni, Sentire e scrivere la natura, Mimesis, Milano, 2020
[3] Donna Haraway, Chthulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto, Neroedizioni, Roma, 2019
______________________________________________________________
Sandra Burchi, ricercatrice indipendente, interessata ai linguaggi delle arti visive e performative, cura percorsi di ricerca multidisciplinari ed espositivi. Dopo la laurea in filosofa, ha ottenuto il dottorato di ricerca in Sociologia presso l’Università di Pisa dove ha svolto attività di ricerca e di docenza. Si occupa di trasformazioni sociali e cambiamenti del lavoro, con una particolare attenzione alle teorie e agli studi femministi. Ha scritto Ripartire da casa. Reti e lavori nello spazio domestico, Franco Angeli Editori 2014. Con Teresa di Martino ha curato il volume Come un paesaggio. Pensieri e Pratiche fra lavoro e non lavoro, Iacobelli Editori, 2013.
Fabio Dei, insegna Antropologia Culturale presso l’Università di Pisa. Si occupa di antropologia della violenza e delle forme della cultura popolare e di massa in Italia. Dirige la rivista Lares e ha pubblicato fra l’altro Antropologia della cultura materiale (con P. Meloni, Carocci, 2015), Terrore suicida. Religione, politica e violenza nelle culture del martirio (Donzelli, 2016), Antropologia culturale (Il Mulino, 2016, 2.a ed.), Cultura popolare in Italia. Da Gramsci all’Unesco, Il Mulino, 2018). Con C. Di Pasquale ha curato i volumi Stato, violenza, libertà. La critica del potere e l’antropologia contemporanea (Donzelli, 2017) e Rievocare il passato. Memoria culturale e identità territoriali (Pisa University Press, 2017), James G. Frazer e la cultura del Novecento. Antropologia, psicoanalisi, letteratura (Carocci 2021). Dirige la Rivista di antropologia contemporanea.
______________________________________________________________

















