di Leo Di Simone
«Non c’è capitolo della storia più somigliante a un romanzo di quello che racconta l’improvvisa ascesa e il breve splendore della Casa di Altavilla. In una generazione, i figli di Tancredi passarono dalla condizione di signorotti della valle normanna del Cotentin al rango di re dell’isola più ricca del Mediterraneo. Gli avventurieri norreni divennero sultani di una capitale orientale. Insieme allo scettro, quei pirati si impossessarono della cultura di una corte araba. I predoni i cui eserciti ridussero Roma in cenere ricevettero dalle mani del papa la mitra e la dalmatica come simboli della giurisdizione ecclesiastica». Così John Addington Symons in Sketches in Italy and Greece [1]. E André Chastel, nella sua Storia dell’arte italiana, nel capitolo dedicato a Italia meridionale e Sicilia, si interroga sul fenomeno degli archi intrecciati degli edifici normanni in Calabria e Sicilia «che non hanno nulla di romanico o di bizantino» e che «si ritrovano a Durham, in Inghilterra, nello stesso momento», focalizzando il problema della “complessità” che caratterizza l’architettura normanna [2].
 Nell’accingermi allo studio di tale “complessità” estesa ai fenomeni artistici generati dalla dominazione normanna in Sicilia, è giusto che illustri preliminarmente la prospettiva nella quale intendo collocarmi nel trattare l’argomento. Sicuramente non mi addentrerò in questioni estetico-formali né in discussioni che hanno suscitato e suscitano sterili diatribe tra gli storici dell’arte, per esempio sulle aggettivazioni dell’arte normanna; preferisco anzi, a questo riguardo, parlare di arte in Sicilia durante il periodo della dominazione normanna, a ragione della mia posizione che intende sondare la possibilità di una decodificazione della struttura simbolica che regge quasi invisibilmente ogni fenomeno artistico.
Nell’accingermi allo studio di tale “complessità” estesa ai fenomeni artistici generati dalla dominazione normanna in Sicilia, è giusto che illustri preliminarmente la prospettiva nella quale intendo collocarmi nel trattare l’argomento. Sicuramente non mi addentrerò in questioni estetico-formali né in discussioni che hanno suscitato e suscitano sterili diatribe tra gli storici dell’arte, per esempio sulle aggettivazioni dell’arte normanna; preferisco anzi, a questo riguardo, parlare di arte in Sicilia durante il periodo della dominazione normanna, a ragione della mia posizione che intende sondare la possibilità di una decodificazione della struttura simbolica che regge quasi invisibilmente ogni fenomeno artistico.
Non posso inoltre, in questa sede, fare una panoramica completa ed esaustiva di tutto ciò che dell’epoca normanna è giunto fino a noi, ma semplicemente servirmi di alcune emblematiche esemplificazioni che interagendo tra loro potranno costituire griglia ermeneutica utilizzabile per la corretta lettura dei reperti nella significazione linguistica del discorso fluente delle arti e del loro confluire simbolico verso l’unità di senso impressa al discorso stesso nel progetto culturale e/o ideologico da cui esso è sfociato come simbolo, appunto.
Nel trattare il tema evidentemente do per scontata la cognizione almeno delle principali posizioni storico-critiche intorno al fenomeno in oggetto; in ognuna ho potuto scorgere elementi di oggettività così come arroccamenti su posizioni ideologiche che viziano non poco l’obiettiva visione del reale, ossia del discorso artistico, nella sua completa articolazione. Cito, ad esempio, la riduttiva ma ormai corrente e banale dicitura “arte arabo normanna”. Tenterò quindi di percorrere altra strada che possa convincerci non soltanto della possibilità, ma della necessità di rivedere e riprendere problemi che sono stati già analizzati innumerevoli volte in passato, in quanto la forza straordinaria del sapere deve consistere nel potersi porre problemi antichi con interrogativi nuovi, con strumenti di analisi nuovi che sono frutto del sapere stesso e che germogliano da quella esperienza storica che, per dirla con Gadamer, è coestensiva alla vita.
Seguiremo in questo percorso le suggestioni, gli stimoli e le indicazioni epistemologiche dell’estetica gadameriana che potranno guidarci nella lettura dei fenomeni artistici e orientare alla considerazione del simbolico quale strumento ermeneutico di decodifica del bello, sia in sede ontologica sia nella sua epifanicità storica rifratta nelle opere d’arte; perché evidentemente, la significanza che è propria del bello dell’arte, dell’opera d’arte, rimanda a qualcosa che non si trova immediatamente nell’aspetto visibile e comprensibile in quanto tale. La sua autentica funzione di veicolo simbolico è spostare l’attenzione su qualcosa di diverso, su qualcosa che non si può avere o esprimere immediatamente e tuttavia non in maniera tale da additare ad un altro allegoricamente; semmai di rappresentare come un frammento di essere, ed anche, essere l’altro frammento sempre cercato che completa in un tutto il nostro frammento di vita [3].
Il discorso del simbolo come passaporto culturale o di strumento per cui si riconosce qualcuno come «vecchio amico» [4] è passibile di sviluppi sia metafisici che estetici evidentemente; lo utilizzeremo a supporto di una lettura della percezione del bello nel suo manifestarsi nella poiesi artistica normanna, come fenomeno scaturente dall’apporto di tanti altri fenomeni che in esso si sono rifratti e coagulati. Non si tratta di una lettura semplice; la mia vuol essere una proposta e semplicemente la proposta di gettare un ponte sul baratro dello scontato, dell’apologetico, del pregiudiziale, delle precomprensioni di analisi riduttive che riducono di fatto il fenomeno stesso e lo defraudano delle ricchezze che lo rendono peculiare ed emblematico di una situazione, e soltanto a partire dal contesto della cultura che lo ha generato.
Il ponte che intendo gettare si costituisce nella sua complessione funzionalmente metodologica, che mi porta al di là nel decifrare la progettazione stessa del processo simbolico, dello gettare in uno: cultura, da una parte, come prodotto dell’antropo che coltiva in maniera variegata i semi della sua complessità psicofisica; e storia dall’altra parte, come alveo diacronico di accadimento di eventi in cui il fiume culturale scorre ora unitariamente, ora diramandosi, ora intrecciandosi, ora sfociando nel mare dell’esserci che gli dà senso e lo invera. Il ponte è ermeneutico funzionalmente. Elementi agevolanti la sua percorribilità devono essere: l’antropologia culturale, da un lato, e la fenomenologia come scienza dall’altro. Raccolta dei dati antropologici inerenti il fenomeno, per un verso, analisi archeologica e critica dei dati coagulati per converso. Il ponte è simbolico strutturalmente.
In quest’ottica l’arte, e quindi anche quella normanna in Sicilia, costituisce proiezione simbolica con duplice movimento: fontale e teleologico. In quanto unità simbolica riporta qui e adesso la germinalità fenomenica cresciuta e irradiatasi storicamente; ad un tempo ri-produce, progettualmente, accumuli di significazioni tali e tanti che l’antropo se ne avvantaggia per la sua stessa riunificazione esistenziale nella verità; e ciò solo a partire da una disincantata lettura coerente dei dati a disposizione, senza camuffamenti apologetici della loro nuda datità. Il godimento estetico, in tal senso, è la percezione del tutto nel frammento, la riunificazione di ciò che era disperso e che ora si simbolizza in maniera definitiva ed inconfutabile in relazione con la sua genesi storica.
Perché il godimento estetico può anche essere diabolico e alienante se gli stessi dati reperibili, come tessere di mosaico, vengono non coerentemente disposti sulla sinopia di un progetto estetico che non dice solo bellezza ma la sua relazione osmotica con bontà e verità. La bellezza, infatti, estrapolata da questo virtuoso e relazionale circuito e situata in posizione monadica è mera apparenza, prezioso sudario di solitudine e morte. Siccome il simbolo porta qui e adesso ciò che lo ha generato, l’amnesia o l’ignoranza della sua genesi culturale provocano equivoci ermeneutici di non poca entità ai fini, almeno, di un corretto sviluppo e di una interna coerenza dei processi culturali. I periodi più bui della storia dell’umanità sono sempre la risultante di errate interpretazioni ed innaturali quanto arbitrarie riproposizioni di modelli culturali precedenti. Sin qui ho dato ragione della prima parte del titolo del tema; anch’esso, globalmente preso è simbolo della relazione e della osmoticità delle discipline nominate e utilizzate per la sua trattazione.
Se in sede estetica l’arte è proiezione simbolica, ora dobbiamo comprendere che nel gioco caleidoscopico delle proiezioni, in riferimento al nostro argomento, si possono considerare due modelli culturali che nel fenomeno artistico si rifrangono più di altri perché più di altri inglobano complessi di valori, sentimenti, credenze, costumi, linguaggi… tutto ciò, insomma, che costituisce la trama della cultura in cui neanche un filo può essere strappato o cambiato senza che tutto il modello ne risulti variato, mutato in altro modello. Parecchi sono stati i modelli teologici nella Chiesa e parecchi i modelli politici nella storia delle civiltà, compresa la nostra. Quelli utilizzati dalla cultura normanna in Sicilia pur nella loro notorietà nascondono le dinamiche dei processi di acculturazione che formano nuovi universi a partire da elementi diversi che si adattano gli uni agli altri più o meno volutamente. Ogni contatto fra uomini di origine diversa produce infatti risultati che non possono essere semplici e che tuttavia possono emblematizzarsi e a volte ipostatizzarsi.
Ritengo che per leggere l’arte del periodo normanno in sé, non si possa fare a meno di considerare il fenomeno, mai abbastanza considerato o letto isolatamente, della Legazia Apostolica, ossia del potere religioso concesso ai dominatori normanni dal potere pontificio [5]. Fenomeno esclusivo e per questo catalizzante una situazione di cui costituisce il fulcro; potrei dire, anzi, che esso è speculare dell’artistico perché lo è di quella cultura nuova venutasi a tessere nella nostra terra di Sicilia che probabilmente ancora ci portiamo dentro e dalla quale metodologicamente dobbiamo prendere le distanze per analizzarla e comprenderla in maniera fenomenologica. Potremmo avere anche la sorpresa di scoprire che nonostante un distacco etico, intellettuale e culturale i suoi temi e i suoi modelli influenzano ancora la nostra vita di siciliani tecnologizzati di inizio terzo millennio.
Non basta affermare il carattere di crocevia culturale della Sicilia e rilevare in sede di estetica formale influssi innegabili che la cultura greca, romana, bizantina, araba, nordeuropea hanno esercitato ed esercitano nella vita e nella lingua del popolo siciliano e nella sua poiesi artistica. Il problema non è quello di identificare quale peculiare influsso abbia prodotto il miracolo architettonico e stilisticamente originale delle absidi di Monreale o mostrare, a partire dal dato della coesistenza e convivenza sotto il dominio normanno di almeno tre o quattro grandi culture, il fatto che quella forma di governo sia stata tra le più tolleranti e illuminate della storia della civiltà occidentale. Procedimenti di questo tipo risultano, a ben guardare, pregni di quell’apologetica che estrapolando un dato da tutto il complesso lo assolutizza e lo distorce.
Il problema è di identificare la struttura del processo di simbolizzazione e la sua direzione funzionale, il modo in cui le costanti culturali assolute sono state assemblate nel progetto culturale dei Normanni e leggerle nel loro contesto originario. Esse sottendono una visione del mondo, una concezione politica, una visione religiosa, una certa considerazione culturale del cristianesimo. Il progetto culturale normanno trae da ogni cultura tutti quei temi capaci di illustrare e sostenere la sua causa e di renderla credibile agli occhi dei contemporanei e dei posteri. Ci resta da vedere cosa l’arte normanna dice ancora oggi, in verità, a noi e in quale considerazione possiamo tenerla.
Abbiamo dato per scontato che i re normanni siano stati dei “re cristianissimi”, abilitati a fondare diocesi e nominare vescovi, nonostante la consapevolezza storica degli harem nei loro palazzi e il loro tenore di vita piuttosto libertino. Ma, quanto incise, nel processo di edificazione del Regno normanno, la cultura cristiana di base? Che ruolo giocarono i temi fondamentali del cristianesimo nel processo di acculturazione che pur ha prodotto, artisticamente parlando, opere incredibili? Come leggiamo oggi questa incredibilità? É l’incredibile che suscita stupore o la sensazione della poca credibilità? E ancora: leggiamo a partire da quale cultura di base, da quali coordinate culturali profondamente acquisite? Voglio dire che nonostante la consapevolezza della nostra modernità, occidentalità o/e della nostra adesione culturale o sacramentale alla “novità cristiana”, ci portiamo dentro accumuli di anacronismi culturali tali da farci apparire tutto ciò che appartiene alla nostra cultura occidentale come ovvio; invece ovvio non è affatto se appena ci rendiamo conto che la nostra identità culturale è la risultanza di una mescolanza di ingredienti non tutti tra di loro coerenti e compatibili. Per chi asserisce che Cristo è determinante ai fini della propria identità culturale la questione non è di poco conto.
La cultura cristiana che guarda a Cristo come fonte di sviluppo delle tematiche antropologiche e trova in Lui il coordinatore del loro aggregarsi modulare, ha sviluppato, anche istituzionalmente, originalità tale da essere, globalmente presa, contraddittoria statutariamente rispetto ad altri statuti culturali che diacronicamente ha incrociato. E questo perché pretende di aver scoperto, nell’asse diacronico delle eventualità, l’Evento unico e irripetibile che ha spezzato quell’asse divenendone punto di equilibrio sia storico che metafisico. «Cristo ieri e oggi, principio e fine, A e Ώ» canta la liturgia cristiana. Da questo punto di vista vorrei poter leggere il fenomeno dell’arte normanna in Sicilia dando per ovvio, per scontato, che si tratta di un fenomeno germogliato nel giardino della cultura cristiana, tenendo conto che i Normanni sono considerati gli “eroi” che hanno reintrodotto il culto cristiano in Sicilia dopo secoli di islamizzazione ed anzi il “retto culto” della Chiesa Romana ad alcuni anni di separazione dalla Chiesa di Costantinopoli. Ma questo è il ritornello che sento da sempre! Dovrò chiarire dunque, anzitutto a me stesso, cos’è cultura cristiana e probabilmente dovrò attendermi qualche sorpresa circa la non ovvietà dell’ovvio.
La conoscenza della propria condizione culturale, antropologicamente parlando, ha il suo perfetto omologato, in psicologia, nel problema della conoscenza del sé, quello profondo, quello che genera immagini e simboli di cui il sogno è iconica espressione estetica. Il metodo proposto, in altri termini, altro non è che una sorta di psicoanalisi applicata al fenomeno simbolico-estetico dell’arte. In fondo, modelli e comportamenti culturali trovano nella psiche il filtro e il motore che li muove e li indirizza concretizzandoli in poiesi storica.
Iconicità e abbagli ermeneutici
Proiezione simbolica dei fenomeni artistici può anche voler dire, in altre parole, che i temi di una determinata cultura, i valori cioè che una cultura apprezza di più, quando diventano modelli di vivere sociale e coniano a loro supporto strutture filosofiche, ideologiche o sociologiche, ex-primono o pro-iettano sia il pensato che il vissuto nell’opera d’arte che lega insieme, simbolizza tali modelli in forme di fruizione estetica, immediatamente e spontaneamente.
Saremo entrati più volte, sicuramente, nella chiesa di santa Maria dell’Ammiraglio, a Palermo, comunemente detta della Martorana. La prima cosa che ci si trova sotto gli occhi entrando, a destra, è lo splendido mosaico dell’incoronazione di Ruggero II da parte di Cristo. É una visione innegabilmente bella, che produce un certo godimento estetico. Cristo con in mano il rotolo della legge, soggetto caro all’iconografia cristiana dei primi secoli, che con l’altra mano, la destra, pone in capo a Ruggero il “diadema bizantino”. Il re accoglie il dono con intima gratitudine, con le braccia allargate, come in orazione. Probabilmente avverte tutta la responsabilità di dover custodire un dono così grande perché la sua potestas, stando all’espressione di Giovanni di Salisbury è «in terris quaedam divinae maiestatis imago» [6]. Certo è sintomatica l’espressione di Giovanni di Salisbury, ma c’è qualche concetto analogo nel Nuovo Testamento? No! E nella Bibbia? Si! La Bibbia dice che ogni essere umano è «immagine e somiglianza di Dio!». É questa l’antropologia cristiana! Allora, tenuto conto che l’icona più bella della potestas Christi è quella della “lavanda dei piedi”, ci si comincia a chiedere della legittimità di un tale modo di iconizzare alla Martorana, ed anche sul significato profondo che origina e permea l’innegabile dimensione simbolica del mosaico.
Cosa vuol dire veramente la scena di Ruggero che sembra in procinto di ricevere l’impronta del Pantocràtore che dona la legge? Forse il re voleva trasmettere ai cristiani del suo regno di ambo i riti, di ambo le lingue, l’idea che la sua azione altro non era che l’attuazione della volontà divina. Il significato più immediatamente palese della scena è senz’altro quello che in essa si sta descrivendo una trasmissione di poteri. Ruggero sta ricevendo una delega, amplissima, da parte di Cristo: la legge, il regno, il governo… e se lì ci fosse l’essenza dello spirito della Legazia Apostolica? e tutta una serie di questioni che ne costituiscono la storia, la preistoria e una progettazione a suo modo coerente e simbolicamente efficace a tal punto da proiettarsi almeno fino al Settecento, come mostra la tela conservata nella chiesa madre di Calascibetta che ritrae il padre di Ruggero II, il Granconte, come gonfaloniere e difensore della Chiesa. Si simbolizza, nel mosaico, l’ontologia del potere regale, che è di origine divina e si trasmette di padre in figlio.
I simboli non guardano in faccia a nessuno e poco importa che si tratti di due Ruggeri differenti; nell’uno e nell’altro caso è una data realtà che viene portata qui e resa presente a coloro i quali parlano la lingua di quella cultura che ha ribadito lo stesso discorso per secoli. É il fenomeno del permanere della cultura nonostante il mutare della cultura: la transculturazione. Il Gattopardo, nella persona del principe di Salina, ne sapeva qualcosa. Nell’uno e nell’altro iconizzare è innegabile un’aura di ieraticità soffusa, di religiosità intuita, di sacralità accattivante, di coerenza tematica che ammalia; una figurazione che può provocare nei singoli diverse sfumature di significato ma che tuttavia cattura ed attrae, perché la sacralità è l’imponderabile ed incute sempre rispetto e timore. É il discorso del sacro in antropologia che tutti conosciamo. Ma nelle due immagini c’è ancora di più del semplice e universale senso del sacro: c’è il tentativo di iconizzare gli effetti del sacro-santo che è altro rispetto alla sacralità naturale di qualsiasi altra sacralità religiosa anche confessionale.
É il tentativo di trasposizione significativa quello attuato nell’iconografia della Martorana: il Pantocràtore della cupola, circondato da quattro arcangeli prostrati in adorazione e dominante lo spazio in cui si celebra il mistero liturgico, è lo stesso giudice severo che trasmette a re Ruggero gli strumenti del giudizio? Pare di sì! Il processo di transignificazione è sottile e di fatto sortisce l’effetto voluto: anche gli altri pantocràtori, della Palatina, di Monreale, di Cefalù, col rinforzo della suggestione prospettica del catino absidale, suggeriscono soggezione davanti ad un “mondo superiore”, ad una potenza divina che inebria, domina e atterrisce ad un tempo. Così il “Dio tre volte santo” della liturgia manifesta la sua volontà e la sua gloria nel Figlio, e nel mosaico della Martorana. Questi la riversa su Ruggero; la stessa gloria si manifesta per l’ipostasi angelica recante il “vexillum gloriae” nella tela di Calascibetta. Una è però la volontà che la gloria manifesta ed essa è riversata in unica soluzione sui due Ruggeri: essi guideranno la cristianità al suo vero telos, la Gerusalemme celeste. Essi costituiscono un tipo.
Non so se la città dipinta sullo sfondo della tela di Calascibetta sia la Gerusalemme del cielo o no. Si tratta sicuramente di Calascibetta, ma poco importa. Importa che nel linguaggio del simbolo, nella cultura cristiana, ogni città è destinata ad essere incastonata, come gemma, nelle mura della città eterna. Anche nel mosaico della Martorana lo sfondo di luce delle tessere d’oro evoca spazialità assoluta e definitiva alle spalle delle due figure ieratiche di Cristo e di Ruggero II; in fondo, la dimensione della città eterna è l’irradiazione della luce totale e il Cristo-luce ne è l’onfalos mistico.
La cultura cristiana ha preso a prestito sin dal suo sorgere la simbologia cosmica e naturalistica per attribuire a Cristo ciò che altre culture attribuivano a divinità che presiedevano all’organizzazione delle diverse parti del cosmo o della natura, per additarlo come reggitore di tutto: Pantokràtor. Tale processo ha creato la teologia simbolica dell’Apocalisse e suscitato le prime forme di arte cristiana. Questo linguaggio simbolico-iconografico è preso a prestito anche dal progetto iconologico delle nostre due figurazioni, e per dire unicamente che a Ruggero, primo o secondo che sia, è dato il potere, la maestà, il singolare privilegio di condurre l’umanità al suo vero approdo. Di questo progetto divino il “tipo Ruggero” è ministro, diacono rivestito dei paludamenti liturgici della sua peculiare dignità. Nel XIII secolo il Sacro Romano Imperatore si presentava alle grandi celebrazioni della Chiesa con l’abito cerimoniale di re Ruggero: tunica linea, dalmatica di seta siciliana, calzari e calze rosse: la gloria di Ruggero era passata a Federico, stupor mundi, nel lascito del mantello, come quello di Elia che aveva trasmesso ad Eliseo le virtù profetiche.
Il sovrano rex et sacerdos, elevato con la sacra unzione ad uno stato superiore a quello dei comuni mortali è un riflesso di Dio sulla terra. Nella tela di Calascibetta l’abito di corte e di cerimonia è sintetizzato e simbolizzato nella fascia d’oro che attraversa il petto del Granconte, sulla corazza, dalla spalla sinistra al fianco destro, al modo dei diaconi. Il mantello è rosso, serico, reminiscenza della porpora romana denotante l’esercizio del potere di chi se ne riveste. Il potere del Granconte è totale nella visione iconologica del XVIII secolo: nella mano sinistra reca l’asta del gonfalone papale e la regge come un baculo pastorale nell’atto di incedere quasi benedicente per la postura della mano destra, recante il rotolo-scettro che nel mosaico della Martorana lo stesso Cristo tiene in mano. La Chiesa è implorante ai suoi piedi, in simmetria perfetta con lo strumento con cui egli governa: una tiara di corone e blasoni da cui sembra scaturire la mazza pesante, ferrea, dello stesso colore della corazza, che egli deve usare per sgominarne i nemici. Immagine di una pastoralità dura e intrepida di cui qualche secolo prima si erano rivestiti papi come Giulio II.
Si connota il persistere, nonostante la chiarezza rivelata della Lettera agli Ebrei, della cultura della mediazione tra Dio e l’umanità; Ruggero II, nel mosaico della Martorana, ha le stesse sembianze del Figlio di Dio. Non è una coincidenza, poiché egli è il rappresentante di Cristo sulla terra, quasi il suo fratello gemello; una concezione che consacrò l’imperialità di Costantino con alle spalle una solida elaborazione teologica del non disinteressato Eusebio di Cesarea, suo consigliere e padre spirituale.
Nato ed educato in Palestina Eusebio apparteneva a quel ristretto gruppo di intellettuali della giovane Chiesa che si erano lasciati affascinare dalle dottrine neoplatoniche. Mise tutto il suo sapere al servizio di Costantino e forse fu l’amore per Plotino, Porfirio e Giamblico che sollecitò a Costantino il salto verso il cristianesimo, ma un cristianesimo filosofico, fatto di nature, sostanze ed ipostasi... Eusebio, dal suo canto, esaltò Costantino in maniera smodata, equiparandolo agli angeli di Dio, a Mosè, e di grado in grado lo portò su fino alla vicinanza col Redentore. Eusebio aveva mutuato da Origene un modello di mondo e di cielo che corrispondeva abbastanza bene alla piramide neoplatonica alla cui sommità stava l’Unico Sublime. In termini cristiani significava che dove siede il Padre non può starci il Figlio. Questi si dovette accontentare di un gradino più basso. E siccome l’imperatore altro non era che il fratello di Cristo le conclusioni erano facilmente deducibili [7].
Il potere di Costantino fu di fatto assoluto, senza precedenti. Lo Stato dioclezianeo venne perfezionato e rafforzato con al vertice l’imperatore vestito d’oro, ornato con un diadema di perle con incastonati i presunti chiodi della croce. Tutto ciò che faceva e diceva era sacro e bisognava prostrarsi al suo cospetto con la proskýnesis. Dal suo sacrum cubiculum il potere si diramava verso il basso, piramidalmente. Fu imperatore, dio, gran sacerdote e creò un modello che sarebbe stato riprodotto da Carlo Magno e da Federico II nell’Occidente cristiano. Ma c’era anche un altro modello dalle simili prerogative: quello papale. E fu scontro tra i due per i lunghi secoli del Medioevo ed oltre. I Normanni, in verità, o almeno in teoria, più che la Chiesa difendevano il potere del papa in qualità di vassalli. Ma a quei tempi Chiesa e papato erano sinonimi.
 Ambiguità, genialità e trasformismo
Ambiguità, genialità e trasformismo
Se la Legazia Apostolica è stata quell’espediente che salvando la forma, ossia il riconoscimento indiscusso dell’autorità papale, manteneva in sostanza il Granconte nella piena autonomia dell’organizzazione ecclesiastica della sua contea, gli conferiva inoltre un potere eccezionale nell’orientare i fatti ecclesiastici della Sicilia e si rivelava uno strumento provvidenziale al fine del perseguimento di un progetto politico. Il genio di questa stirpe normanna discendente dagli intraprendenti Vikinghi è consistito nell’individuare lo strumento giusto per la fondazione di un regno e l’esercizio del potere politico sia in campo laico che ecclesiastico. Dico, il genio che si correla inevitabilmente a personalità, individuale e corporativa culturalmente parlando, ossia a quella particolare abilità di mettere insieme intelligenza, sensibilità artistica, volontà, energia, in maniera catalizzante; il saper cogliere nel fluire del continuum culturale tutti i segmenti, i temi che vi interagiscono, facendone una sintesi che li oggettiva e li rivela a se stessi intanto. É così che il genio esprime al meglio le caratteristiche della sua cultura, facendosi egli stesso simbolo di essa, nel senso che tutti vi si possano riconoscere.
Il tipo Ruggero, simbolicamente considerato, è l’espressione emblematica di una concezione culturale dell’immanente e del trascendente, una concezione che l’iconografia normanna non si inventò, avendola trovata già imbastita nella trama del panorama cristiano del tempo che considerava il potere di questo mondo e il suo esercizio politico proveniente da Dio. Il Granconte colse il meglio di tale concezione dal piatto d’argento della Legazia Apostolica offertogli da un debole ed impaurito Urbano II e se ne rivestì. Ogni produzione della cultura normanna in Sicilia, in primis quella artistica, è illustrativa di quel paludarsi, ed anzi l’arte ne è espressione eccellente. Richiamo ancora come modulo espressivo il mosaico della Martorana e il suo omologo significante della cattedrale di Monreale: Guglielmo II incoronato da Cristo. Declino qui regalità tipologicamente.
Che la concezione della regalità, così come questa iconografia la riproduce, sia di matrice costantiniano-bizantina lo abbiamo indicato. Ma questa concezione non fu estranea alle culture cosiddette barbariche del nord Europa precedenti gli stanziamenti normanni in Inghilterra prima, nelle Gallie e nel sud d’Italia e Sicilia poi. Sia i nuovi regni barbarici alleati e delegati dell’Impero Romano, sia i regni tribali della penisola scandinava avevano maturato una concezione sacrale della regalità che considerava il re come rappresentante del popolo presso gli dèi, gran sacerdote che presiedeva ai sacrifici e divinità egli stesso. In Svezia fino al XII secolo la monarchia conservò il suo carattere religioso arcaico e l’istituzione regale rimase connessa al santuario del dio Ynqvi Frei, nella vecchia Upsala, di cui il re gran sacerdote è copia umana [8]. Si trattava evidentemente di una concezione pagana della divinità, ma il principio della monarchia divina era indiscusso.
Il problema della cristianizzazione di quei regni consistette nel vincere le resistenze culturali dei loro popoli per i quali era difficile accettare l’idea che il loro re, dio sulla terra, si dovesse adattare, prima che loro, alla concezione cristiana della mitezza e del perdono. Eppure era necessario per quei re divenire cristiani, dall’oggi al domani, per entrare a far parte del circuito culturale dell’Europa e trovare altri posti al sole per i loro cadetti. Pipino, nel prendere il posto della precedente dinastia merovingia, sancì la fusione dei temi della regalità barbarica con quelli della regalità cristiana in un simbolo di consacrazione religiosa. Nel 751 si faceva incoronare e ungere con olio da Bonifacio; a partire da quel momento la consacrazione del re doveva costituire un tratto caratteristico della regalità occidentale. Il Rito di incoronazione che si codificherà poi nell’Ordo del Pontificale romano germanico [9] avveniva nel rispetto di tutte le costanti antropologiche rilevabili nelle più antiche culture, non esclusa quella israelitico-giudaica. Le insegne regali, come l’abito speciale, lo scettro, la corona e altre insegne analoghe, sono sempre legate ad una sorta di simbolismo cosmico [10].
Tale simbolismo è presente nella “stoffa rotata” che costituisce lo splendido manto regale confezionato per Ruggero II nei tiraz di corte a Palermo: un grande sciamito ricamato in oro a “punto spiccato” frammisto a perle su fondo rosso vivo. Nella figurazione che lo ricopre quasi totalmente, due leoni si avventano su due cammelli accosciati. A dividere le due coppie di animali una palma stilizzata che nella significazione islamica, per ascendenze bibliche, ha valore di Albero della vita. Si trasforma, nella significazione giudaica, in candelabro a sette bracci che a sua volta concorda in modo sorprendente con una raffigurazione sumerica dell’Albero della vita che cresce sulla montagna del mondo [11]. Vita che trionfa sulla morte, luce della regalità divina, porpora e oro, è l’abito del re. Anche le borchie in smalto, ai lati dell’allacciatura, sono decorate con un simbolo cosmologico: due quadrati si intrecciano a formare una stella, come nell’antica simbolizzazione iranica, e al centro il disco solare splendente.
La magnificenza di questo manto regale mostra non solo la fusione di più culture nell’unico manufatto ma anche la preesistenza di una simbolizzazione che assume i suoi temi negli strati più antichi della cultura umana, quelli impregnati profondamente di sacralità cosmica e naturalistica e tendenti ad evidenziare la natura del re quale “figlio del cielo”. Ne illustra la potenza, la regalità indiscussa caratterizzata dalla forza del leone, simbolo araldico degli Altavilla, e in chiave politica anche la supremazia di Ruggero sull’Islam rappresentato dai cammelli. Tutto in maniera perfetta, data la rappresentazione speculare della scena.
La raffigurazione del mantello contiene però un’altra significazione che coesiste con la prima di stampo naturalistico, ed è di natura biblico-teologica: il cammello per la Bibbia è un animale impuro e simboleggia le forze del male tanto da trasformarsi, in estreme stilizzazioni iconografiche, in drago o serpente. Il leone, emblema della tribù di Giuda, da cui proviene Cristo, è tipo zoomorfo del Salvatore: attacca il male che giace accosciato e lo accascia annientandolo. Tutto il mantello, con al centro la palma-vite-luce, albero-croce è simbolo di Cristo e il re se ne riveste, o meglio: ne viene rivestito e come unto avendo la seta fluidità simile all’olio. Il manto di Ruggero, letto in chiave simbolico-cosmologica contraddice la concezione teocratica soggiacente alla consacrazione di Pipino indicativa piuttosto della dipendenza del potere temporale da quello spirituale del profeta, come nel caso di Samuele che consacra Davide al posto di Saul (1 Sam 16,13) o nella storia ancor più drammatica della missione di Eliseo che è inviato a consacrare re Jehu perché distrugga il casato di Acab (2Re 6,24–7,20). Inoltre, la lettura in chiave biblico-teologica afferma implicitamente la superiorità del potere spirituale e la necessità dell’esservi soggetto standovi sotto, standovi dentro ammantato.
Non sappiamo a chi faccia capo il progetto iconologico, ma esso appare tuttavia geniale in quanto la bellezza vi si legge a seconda della possibilità culturale. Non sappiamo con quale consapevolezza Ruggero abbia portato l’impegnativo manto; forse non si pose neppure il problema in quanto la preziosità del manufatto era di per sé simbolica del suo status e della sua potestas [12]. Un manto, comunque, non assimilabile a quell’altro «scarlatto» (Mt 27, 28) di cui fu ammantato il Re dei Giudei prima del suo innalzamento al trono della croce.
Teocrazia e cesaropapismo, queste sono le unità tematiche che rinveniamo nei nostri reperti; sono le facce di una stessa medaglia o le lame di una stessa arma che si rivolge ora verso il potere temporale, laico, ora verso quello spirituale, religioso. Insieme sono simbolo e nel contempo diabolo che affonda le sue radici in una concezione sacrale dell’autorità e del potere sconfessato dalle fonti evangeliche. Anche gli antichi Stati del bacino del Mediterraneo, come il regno degli Ittiti, dell’Egitto, la Grecia arcaica e i potentati italici ebbero a loro fondamento un regno sacro guidato da tipici re-sacerdoti. In Egitto il faraone era il Netjer Nefer, il “buon dio” e nei Paesi a est del vicino Oriente, in Iran e poi in Cina e in India si trovavano regni sacri, mentre gli imperatori giapponesi hanno goduto fino ai nostri tempi di un culto divino [13].
Antichi processi di sacralizzazione
Per transculturare questi temi di sacralità religiosa era necessario battezzarli per mettere in evidenza, con tutti i mezzi culturali possibili, che essi erano legittimati dal fondatore stesso del cristianesimo. Nella chiesa di san Vitale a Ravenna Giustiniano e Teodora appaiono “nimbati” nella rappresentazione musiva, in atteggiamento di sacrale maestà. Lo stesso nimbo circonda, in altra rappresentazione musiva a Santa Sofia, il capo di Costantino IX Monomaco e di sua moglie Zoe; egli subentrò nel 1034, sia nel matrimonio che nel trono, a Romano III Argirio e il mosaico che lo raffigura fu scomposto e ricomposto per collocarlo alla destra di un Cristo assiso su un trono gemmato, reggitore di tutto l’universo [14]. L’imperatore sta alla destra della maestà divina come Cristo sta “alla destra del Padre”.
Appena vent’anni dopo, Umberto da Silva Candida, cardinale cluniacense e propugnatore della “riforma ecclesiastica” che auspicava separazione fra trono e altare, perché la Chiesa dello spirito fosse superiore al potere politico, recandosi a Costantinopoli non esitò di accusare il potere bizantino sostenendo che il regime di cesaropapismo era più vicino all’islam che al mondo occidentale [15]. Si recò a Santa Sofia, salì sull’altare e vi depose la bolla di scomunica contro il patriarca Cerulario. Poi tornò a Roma. Era il 16 luglio del 1054. La conquista normanna della Sicilia sarebbe iniziata solo sei anni dopo e portata a termine nel 1093. La corona che Ruggero riceve da Cristo, nel mosaico della Martorana, ha la stessa foggia di quella di Costantino IX Monomaco. Il cesaropapismo esorcizzato da Umberto è un demone difficile da scacciare e può, da buon demone, manifestarsi in più luoghi simultaneamente e vestire i panni della teocrazia.
L’ideale di riforma di Umberto, perciò, consisteva nella proposta teocratica fondata sulla supremazia della Chiesa rispetto al potere temporale, poiché il potere spirituale era giudicato superiore a quello del re, in quanto il cielo è “superiore” alla terra. La Chiesa deve governare e guidare lo Stato come l’anima governa il corpo. Parlare di “riforma” in questi termini, si capisce, è quanto mai improprio; si trattava di ribaltare ancora le posizioni, di sovvertire l’antica tradizione bizantina e carolingia del “diritto divino” dei re. Ma i Normanni erano ormai giunti per prendere le difese del papato e con la Legazia Apostolica avrebbero ottenuto la patente di “campioni” di san Pietro. Intanto cominciavano a costruire chiese, palazzi, monasteri e basiliche e a consacrare, con più o meno consapevolezza, lo status quo, circondando con l’aureola di una tradizione sacra i diritti acquisiti. Federico II, frutto dei loro lombi, ne trarrà i vantaggi che conosciamo e regnerà come nuovo Costantino. Il trionfo dei simboli sacri coinciderà con la vittoria dia-bolica, nella lotta tra papato e normanni per l’acquisizione della supremazia.
 Tutto il Medioevo si snoda lungo la gara al sorpasso fra teocrazia e cesaropapismo. L’avvio della corsa fu dato dalla Chiesa, nel periodo del basso impero, quando al patrimonio iniziale della Rivelazione aggiunse il bagaglio ideologico. Le nozze di Mercurio con la filologia, che tratta in forma mitologica della classificazione delle scienze, delle sette arti liberali, scritta agli inizi del V secolo dal retore Marziano Capella, fu un’opera che costituì, specialmente in epoca carolingia, il punto di riferimento intellettuale per i chierici medievali [16]. La liturgia cominciò a ricalcare i rituali imperiali: cerimonie, paramenti, oggetti di culto, posture, dovevano illustrare la maiestas del pontefice che presiedeva circondato dai diversi ordini in cui si costituiva la torma dei chierici. Per l’Eucaristia e la preghiera l’officiante cominciò a voltarsi verso est, verso il sole nascente, e il banchetto sacrificale e conviviale, la cena della Pasqua, diventò un rito ieratico che invece del raduno intorno all’unica mensa vedeva il celebrante sempre più lontano dall’assemblea, nella zona sacra del sancta sanctorum, su un’alta ara, nel santuario dell’edificio assembleare detto chiesa per una efficace metafora; così, da “casa del popolo di Dio” si trasformò in tempio.
Tutto il Medioevo si snoda lungo la gara al sorpasso fra teocrazia e cesaropapismo. L’avvio della corsa fu dato dalla Chiesa, nel periodo del basso impero, quando al patrimonio iniziale della Rivelazione aggiunse il bagaglio ideologico. Le nozze di Mercurio con la filologia, che tratta in forma mitologica della classificazione delle scienze, delle sette arti liberali, scritta agli inizi del V secolo dal retore Marziano Capella, fu un’opera che costituì, specialmente in epoca carolingia, il punto di riferimento intellettuale per i chierici medievali [16]. La liturgia cominciò a ricalcare i rituali imperiali: cerimonie, paramenti, oggetti di culto, posture, dovevano illustrare la maiestas del pontefice che presiedeva circondato dai diversi ordini in cui si costituiva la torma dei chierici. Per l’Eucaristia e la preghiera l’officiante cominciò a voltarsi verso est, verso il sole nascente, e il banchetto sacrificale e conviviale, la cena della Pasqua, diventò un rito ieratico che invece del raduno intorno all’unica mensa vedeva il celebrante sempre più lontano dall’assemblea, nella zona sacra del sancta sanctorum, su un’alta ara, nel santuario dell’edificio assembleare detto chiesa per una efficace metafora; così, da “casa del popolo di Dio” si trasformò in tempio.
E siccome ogni tempio esige un altare e una casta sacerdotale… si sviluppò un processo di templarizzazione a catena che si riprodusse nel campo dell’arte. In architettura la funzionale e sobria struttura rettangolare della “laica” basilica fu corredata dell’arco di trionfo e da una decorazione sempre più fastosa. Si approntarono progetti di iconologia coerenti con una teologia sempre più platonizzante e idealistica e il tutto sfociò in un certo esibizionismo, per via dell’accumulo di decorazioni sempre più tendenti a sottolineare l’aura di regalità che si sintonizza con la ricchezza e lo sfarzo; nel luogo in cui si celebrava il Cristo povero e regnante dalla croce.
Oltre a ciò un altro tipo di chiesa edificio, a pianta centrale, riprendeva l’antica ideologia dello spazio rotondo immagine dell’universo e della perfezione. A Roma santa Costanza, santo Stefano Rotondo, e a Milano san Lorenzo, inaugurano questa tipologia, tra il 320 e il 470. Tali modelli crearono cultura, opere d’arte irripetibili anche per via degli ingenti costi di produzione, con programmi d’iconologia elaboratissimi, con simbologie stupefacenti ma ad usum Delphini, e nella riabilitazione della concezione sacrale del tempio sconfessata con forza da Gesù Cristo.
Dato per buono l’intento iconologico dei committenti e la necessità di produzione artistica che è propria dell’uomo in quanto animale simbolico, ciò che immediatamente si percepiva da parte del popolo era ancora il senso di sacralità, di soggezione timida davanti ad una regalità irraggiungibile che confonde e allontana, separata e intoccabile, superiore e potente, ontologicamente dominatrice. Il pontefice in trono, rivestito di abiti imperiali e circondato dalla sua corte non poteva essere visto come pastor bonus attento ai bisogni del suo gregge. Il Dictatus Papae di Gregorio VII sancì la superiorità del papa rispetto ai regnanti della terra. Tutto questo, comunemente, si denomina cultura cristiana. I modelli si consolidano istituzionalizzandosi; poi non ci si fa più caso, rappresentano l’ovvietà, e la cultura entra nel sangue col gioco simbolizzante degli archetipi che vi hanno interagito subliminalmente. Di tali contraddizioni si tesse anche il sublime.
Quando i Normanni arrivarono in Sicilia, la conquistarono e vi impiantarono il Regno, non dovettero stupirsi troppo davanti ai modelli culturali cristiani; né di quelli occidentali né di quelli orientali. E in Sicilia, nonostante siano visti ancor oggi come campioni della restaurazione del “Rito Romano”, fu al “Bizantino”, in effetti, che accordarono le loro preferenze. Si trovarono in sintonia culturale! I loro parenti Vikinghi, il secolo prima, si erano spinti verso oriente, fino a Kiev, sfruttando le popolazioni slave dell’Ucraina e respingendo i Kazari dal Mar Nero. Conobbero il cristianesimo bizantino tramite Vladimiro che nel 988 prese la decisione di convertire la Russia a quella religione, dopo aver assunto informazioni anche presso i musulmani, gli ebrei e i latini. Il fatto decisivo per tale scelta fu lo splendore che i suoi inviati videro in Santa Sofia, a Costantinopoli; così nacque il desiderio di accostare e imitare quel prestigioso impero. Gli influssi di quella nuova cultura si estesero fino al golfo di Finlandia.
Che senso avrebbe avuto decorare con mosaici bizantini una chiesa fortezza-mausoleo come quella di Cefalù? O una chiesa monastica come quella di Monreale che, anche nella rilassatezza dell’ordine cluniacense che la officiava si sarebbe dovuta mantenere nei limiti di una sobrietà stilistica occidentale, così come l’abate-architetto Sugero stava mostrando in Francia proprio in quegli anni? [17] Evidentemente l’accordo ai moduli stilistici dell’arte bizantina derivava da una simpatia culturale che doveva coniugarsi con la necessità di costruire edifici solidi per la difesa ed anche emblematici della monumentalizzazione dei successi militari degli Altavilla. Anche qui ci troviamo davanti ad una costante antropologica: misero mano all’iconizzazione spaziale della “maestà”, verticalmente ed orizzontalmente, ossia della maestà divina e dell’umana che di quella si fa specchio ed ipostasi.
La Cappella di Palazzo a Palermo risultò così bifunzionale: da una parte sede del Dio del cielo che si mostra sotto il velo dei misteri; dall’altra sala del trono dove lo stesso Dio crisma la divinità del re. L’uno siede sul trono gemmato al centro della cupola, l’altro su un trono non meno prezioso posto sul “soglio” della differenza con alle spalle il Pantocratore. La Palatina venne dedicata a san Pietro, il patrono da cui deriva il dominio di Ruggero sul regno, mentre Sugero progettava di portare a Saint Denis la memoria del principe degli apostoli e del pontefice romano nel simbolo delle colonne granitiche da “prelevare” dalle terme di Diocleziano e da far giungere su navi saracene fino all’estuario della Senna. Desiderio di Montecassino, cent’anni prima, aveva fatto la stessa operazione e prima di lui Carlo Magno aveva posto nella sua Palatina le colonne del palazzo dell’esarca di Ravenna [18]. Ogni potere ha bisogno di rinforzi, di simboliche autorevoli colonne, sia civili che religiose.
Le icone della Sfinge
Qualche cenno, adesso, sulla natura composita degli edifici normanni, specie quelli edificati per il culto. Facendo cenno alla bifunzionalità della Palatina ci si riferisce ad un modello di edificio cui corrisponde una bipolarità strutturale. La coesistenza nelle chiese normanne degli influssi culturali sia della Chiesa latina che della bizantina, determinante un certo ibridismo, può apparire una soluzione di compromesso, di irrisoluzione culturale o forse anche di equilibrio fra due tendenze che almeno sul piano confessionale, dopo la frattura scismatica, sembravano ormai inconciliabili. Per noi cristiani occidentali dei primordi del terzo millennio è normale osservare, nei più importanti complessi chiesiastici europei, la cupola sovrastante l’incrocio della nave principale col transetto. La cupola rappresenta l’elemento architettonico più vistoso delle più belle basiliche della cristianità; elemento strutturalmente più arduo e funzionalmente più luminoso, trae origine dal modulo architettonico bizantino.
Quando Giustiniano nel 527 dovette ricostruire le antiche basiliche costantiniane distrutte dalla rivolta dei Nika accordò la sua preferenza all’edificio a cupola sviluppantesi da un ottagono inscritto in una struttura quadrata. Questa struttura era diffusa in Oriente, soprattutto in Siria, in concomitanza col modello basilicale. I filosofi della storia hanno interpretato la vittoria della cupola come la manifestazione di un profondo mutamento spirituale, intellettuale e psichico. Non si può ritenere perciò che sia solo il trionfo della cultura araba, anche se è innegabile che sia un prodotto dell’Oriente. Gli architetti romani la videro in Asia Minore e in Siria e la riprodussero, all’epoca di Adriano, nella costruzione del Pantheon; l’operazione fu il risultato di un comune sentire la dimensione trascendente come “totalmente altro” e quindi iconizzabile con le figure geometriche del cerchio e della sfera. La fortuna della cupola nel mondo arabo può giustificarsi col fatto che l’Islam ebbe orrore dell’incarnazione, del fatto che la divinità possa sposare la cultura dell’umano e redimerla immergendovisi. L’ipotesi che i precursori di Maometto siano stati ariani e monofisiti non è del tutto peregrina [19]; i cristiani delle province orientali dell’impero, non convinti della dottrina trinitaria, salutarono gli arabi come restauratori di una più primordiale concezione di Dio. La cupola fu il trionfo di questa concezione metafisico-religiosa che però è in rapporto dialettico con la Káaba della Mecca, iconizzazione cubica di un intervento di Dio nella storia o nostalgia simbolica di una dottrina cristiana rifiutata.
L’organismo chiesiastico quadrato era nato dall’incrocio di due navate, due bracci di uguale lunghezza coperti da volta a botte. Ne deriva una pianta cruciforme. Il modello architettonico della croce greca inscritta nel quadrato avrà grande fortuna nelle elaborazioni architettoniche, sia teoriche che monumentali, sino al Rinascimento tosco-romano. Ora, è stato dimostrato abbondantemente che in tutte le chiese del periodo normanno in Sicilia, ed anche oltre, è constatabile «risolto o irrisolto che sia, l’innesto architettonico fra pianta bizantina e pianta basilicale latina» [20]. Questa giustapposizione ha dato forma ad impianti di chiesa-edificio tra i più interessanti dal punto di vista tipologico, ma anche tra i più enigmatici dal punto di vista ermeneutico. I ritrovati tecnici per la giustapposizione strutturale delle due tipologie hanno prodotto soluzioni diversificate che testimoniano la drammatica tensione nel tentativo di conciliare i due filoni.
Da qui il fascino scaturente dall’ibridismo dell’architettura del periodo normanno che volendo valorizzare due tradizioni così differenti e così importanti si risolse, infine, nel fenomeno della Sfinge il cui indovinello ha fortemente inquietato, fino a noi, gli storici dell’arte. Ma era necessario, anche in questo caso, coniugare esigenze funzionali con altre di carattere ideologico. La cattedrale fortezza di tipo basilicale offriva il vantaggio di poter contenere un maggior numero di persone rispetto alla struttura quadrata bizantina, mentre quest’ultima forniva la possibilità di simbolizzare in maniera sacrale la volumetricità cubica con quella sferica: la fusione della terra con il cielo, dell’umano col divino. Una tale posizione ideologica non poteva concretizzarsi simbolicamente se non nel luogo dove doveva essere affermata tale congiunzione ipostaticamente, nella persona del “re fratello di Gesù Cristo”.
La Cappella Palatina è l’esempio più emblematico della fusione delle due tipologie, ma anche della simbolizzazione dei due poteri, spirituale e temporale, nella persona del re-sacerdote. Il re, come Salomone, sta su una tribuna, la piattaforma mesopotamica Kiur, il basamento che delimita il mondo sotterraneo da quello superiore. Anche l’altare in area mesopotamica poggiava su una piattaforma, Heq ha’ares, il “grembo della terra”, e simboleggiava ciò che si erge in alto, la “montagna di Dio” [21]. Il re normanno in trono, sulla piattaforma, è figurazione speculare del Pantocràtore dell’abside, colui che sta in alto e che nell’icona della Pasqua si erge vittorioso sulla piattaforma delle porte scardinate dello Sheol, il mondo degli inferi o il grembo della terra da cui tira fuori colui che fu fatto di terra, il primo Adamo. Accade che quando il simbolizzarsi degli archetipi si fa così intricato la vittoria sembra davvero arridere alla Sfinge! Ci si trova dunque ancora davanti ad un simbolismo cosmico che trovò in Mesopotamia la culla per un suo fertile sviluppo e che attraversando diacronicamente le culture è giunto fino a noi intatto. La chiesa madre di Gibellina, nella valle del Belìce, strutturalmente sfera e cubo incastrati singolarmente, è l’esempio contemporaneo della persistenza di quei modelli sacrali [22]. La sua pressoché nulla funzionalità liturgica deve farci interrogare circa la convenienza di utilizzarli ancora.
La Sfinge ha anche una coda di drago, ossia l’inclinazione non debole dei sovrani normanni per i paradisi islamici. Se furono cristiani, mezzo latini o e mezzo bizantini non importa, lo furono nella vita istituzionale; in quella privata furono arabi. La Kuba, la Zisa, il castello della Favara, i parchi, i giardini attraversati da canali e lussureggianti di vegetazione assemblano il simbolismo paradisiaco anch’esso di mesopotamica memoria. Le forme quadrangolari, cubiche, degli edifici da diporto sorgono in mezzo al giardino del paradiso, il persiano Pardes, dove c’è una sorgente e un albero ritenuti sacri. Il Gi-par sumerico, in accadico Giparru, abitazione buia o stanza centrale del tempio, era in relazione ad un sacro boschetto, il giardino dove si celebravano le nozze sacre tra il re e la dea Ishtar. É lì che il re riceveva scettro e trono.
Residenze divine in mezzo al paradiso, simbolicamente, le dimore voluttuarie dei re normanni. Iconografia paradisiaca quella della “sala di Ruggero” nel palazzo reale, dove l’albero con tutte le sue variazioni è il simbolo costante del dominio. In tal senso è ricorrente nelle tradizioni veterotestamentarie e giudaiche stando alle quali sia Mosè che Aronne tengono in mano un ramo verde. Dello scettro di Mosè è detto poi che era stato tagliato dall’albero paradisiaco della conoscenza del bene e del male [23]. Anche una certa tradizione cristiana ha attribuito potere all’albero in senso sacrale, ritenendo che l’albero della croce sia stato fabbricato col legno dell’albero che stava “al centro del giardino”. La rivelazione neotestamentaria di tutto ciò non dice nulla, in quanto con essa è superato il tempo delle sacralizzazioni e dei poteri umani da essi emblematizzati. Il potere della croce di Cristo è reale, e però non è quello che i re normanni intesero esercitare in nome di Dio. Così come il Regno di Dio proclamato da Cristo si differenzia sostanzialmente dai regni umani.
Infine, chi afferma perentoriamente influsso della cultura islamica nel processo di iconizzazione sia figurativa che spaziale dell’arte normanna in Sicilia afferma solo in parte il vero. La verità di quei simboli è molto più antica e l’Islam costituisce solo un transito culturale che li ha condotti fino ai normanni, attraverso una serie incalcolabile di passaggi che solo una serie altrettanto incalcolabile di studi e di ricerche comparative potrà districare. Allo stato attuale delle cose solo la Sfinge ne custodisce il segreto.
Conclusioni inattuali
L’inattualità delle conclusioni inerisce all’inattualità stessa della simbolicità cristiana: Signum cui contradicetur è il Cristo stesso nella costituzione della simbolica umano-divina. Inoltre, se come diceva il giovane Hegel «Contradictio est regula veri», le non poche contraddizioni rilevate nei processi di simbolizzazione analizzati ci conducono al significato vero del processo culturale generatore dell’arte normanna in Sicilia. Possiamo pertanto dire:
Tra i diversi impulsi determinanti proiezione simbolica come risultante della logica dei processi di acculturazione giunti ad uno stato di maturazione storica, la cultura normanna, nel suo impiantarsi in Sicilia (e nel sud Italia), ha focalizzato sia modelli teologici a connotazione genericamente religiosa sia modelli politici a connotazione assolutistica. Ambedue sono risultati congeniali alla loro cultura di partenza e sono stati integrati senza difficoltà. La proiezione simbolica nel fenomeno artistico, almeno sull’asse della sincronicità, è stata compensativa e gratificante, in quanto ha preteso imitare, eguagliare e superare modelli significativi autorevoli quanto consolidati. La situazione storica, d’altra parte, contemplava una certa omologazione dei modelli teologici, elaborati da una teologia speculativa, e quelli politici, prodotti dalla stessa speculazione.
Durante il regno di Ruggero II si consumò la feroce battaglia tra Bernardo di Chiaravalle e Abelardo; quest’ultimo accusato dal grande abate di aver introdotto in teologia il sistema della filosofia, un lógos pre-cristiano che riduceva il cristianesimo ad un fatto dottrinario; né però la teologia biblica di Bernardo aveva mitigato i suoi culturali istinti bellici di ex cavaliere che lo portarono a predicare la crociata e a fondare l’ordine monastico-militare dei Cavalieri Templari. Una contraddizione che rivela la verità dello stato culturale del tempo che rivendicava lo statuto di “civiltà cristiana” mentre non avvertiva lo stridente conflitto tra lo stato di belligeranza continuo e i dettati normativi delle Beatitudini evangeliche che prescrivono la mitezza e la ricerca operativa della pace.
Altri elementi di ambiguità si sono accumulati nella processualità artistica nelle operazioni che hanno inglobato temi e modelli importati dall’estetica cristiana di matrice liturgica e altri assolutamente asimmetrici e sviluppatisi lungo l’asse diacronico del farsi storico, carichi di significazione riduttiva e regressiva della cultura cristiana in chiave meramente religiosa e sacrale. Alla coerenza biblica dell’invenzione iconologica della simbolicità del ciclo liturgico non corrispondono, a Monreale per esempio, iconologia e iconografia del ciclo della regalità che è pensato a corollario del mosaico dell’incoronazione di Guglielmo II che a sua volta è speculare a quello di Ruggero II alla Martorana. Ma la discrasia non era né intenzionale né avvertita; già ai tempi di Carlo Magno il suo cappellano Alcuino e poi il suo discepolo Amalario di Metz avevano infranto l’unità simbolica della liturgia inventando l’allegorismo liturgico, attribuendo ad ogni sintagma della liturgia un significato arbitrario: morale, tipologico, rievocativo, escatologico… tutte cose che richiedevano elaborate spiegazioni e soprattutto lontane dall’immediatezza simbolica, quando invece l’esperienza simbolica è un evento di partecipazione che implica coinvolgimento. Asserisce acutamente Jaques Le Goff: «L’allegoria rompe il simbolo mentre l’antichità è finita. Il cristianesimo romano è ormai pronto a riprendere la funzione ideologica in Occidente» [24]. Si coniò una sorta di gnosi liturgica che resistette fino alle soglie del Vaticano II e ancora oggi trova settari e retrivi sostenitori.
Per una corretta ermeneutica del fenomeno appare dunque essenziale l’analisi sull’asse diacronico delle emergenze fenomeniche. Prescindendo da ciò sarà conseguenziale l’ambiguità ermeneutica che risiede nell’assenza di un punto focale di interpretazione che consenta di percepire il fenomeno, al di là della sua manifestazione esteticamente ammaliante, nella quota di livello partecipativo all’organizzazione dell’estetica cristiana almeno. E lo abbiamo detto: la bellezza cristiana si colloca all’interno di un circolo ermeneutico osmoticamente pericoreutico, ove si muove in sincronia e sintonia con verità e bontà. Altrimenti la bellezza sarà un abbaglio ammaliante quanto vacuo e transeunte.
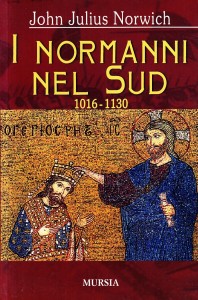 Chi legge la storia dell’avventura normanna nel sud Italia e in Sicilia così come la racconta John Julius Norwich [25], si accorge che questa storia si sviluppa all’interno di uno stato di belligeranza incessante; per la costituzione del ducato di Puglia e Calabria da parte del Guiscardo, della contea e poi del regno da parte dei due Ruggeri, padre e figlio. Lotta feroce per il potere, ribellioni feudali, tradimenti, inganni, tranelli politici, invasioni e devastazioni di terre e decimazioni di popolazioni, stragi, carestie, epidemie… tutte cose a cui non furono estranei né i papi né gli imperatori che anelavano al dominio su quegli ambitissimi territori. A tali lotte tra cristiani si assommano le altre contro bizantini e musulmani che erano stati ed erano stanziali in quegli stessi territori: Bellum omnium contra omnes!
Chi legge la storia dell’avventura normanna nel sud Italia e in Sicilia così come la racconta John Julius Norwich [25], si accorge che questa storia si sviluppa all’interno di uno stato di belligeranza incessante; per la costituzione del ducato di Puglia e Calabria da parte del Guiscardo, della contea e poi del regno da parte dei due Ruggeri, padre e figlio. Lotta feroce per il potere, ribellioni feudali, tradimenti, inganni, tranelli politici, invasioni e devastazioni di terre e decimazioni di popolazioni, stragi, carestie, epidemie… tutte cose a cui non furono estranei né i papi né gli imperatori che anelavano al dominio su quegli ambitissimi territori. A tali lotte tra cristiani si assommano le altre contro bizantini e musulmani che erano stati ed erano stanziali in quegli stessi territori: Bellum omnium contra omnes!
L’ermeneutica artistica può prescindere dal collocare le opere d’arte, gli edifici, i mosaici, le istituzioni civili ed ecclesiastiche al di fuori di tale contesto? La cattedrale-fortezza di Cefalù reca nel suo Pantocràtore tracce di un simile contesto di cui non può non considerarsi parte simbolica? La sua fisionomia cristiana esige relazione simbolica con la verità storica dell’incarnazione e con la bontà pacificante del Salvatore effigiato per mostrare sofianica bellezza! La sua contemplazione simbolica esige la collocazione in un ambiente vitale di verità e bontà, diacronicamente e sincronicamente, altrimenti la si riduce a reperto estetico museale così come la si ridusse ad instrumentum regni. La focalizzazione cristiana del fenomeno necessita dunque di attente analisi dei fenomeni che mettano in luce i temi fondativi della cultura cristiana, quelli a più chiara ed autentica connotazione evangelica, così come quelli che come risultanti di incrostazioni e stratificazioni culturali di cristiano posseggono soltanto il nome. Separazione e distinzione, in sede ermeneutica, consentono una più attenta lettura di temi, modelli, istituzioni coinvolti nelle dinamiche culturali. La natura simbolica dell’arte non può essere sganciata dalla verità storica e dalla bontà etica, altrimenti diventa favola o leggenda, idealizzazione e falsificazione.
Della cattedrale normanna di Mazara che si vuole edificata dal Granconte Ruggero intorno all’anno fondativo della Diocesi, nel 1093, resta soltanto qualche brandello di muro e non pochi segreti custoditi sotto il pavimento. La memoria del Granconte che sconfigge “il saraceno” è conservata nella scultura marmorea adesso incastonata nella specchiatura architettonica sovrastante la porta. Anch’essa costituisce un tipo, ma un tipo nato da procedimenti leggendari di falsificazione storica, da sentimenti proiettivi in cerca di un simbolo a sintesi di un cogente desiderio o di una vittoria ottenuta quanto insperata. Gli storici locali tramandano della primitiva collocazione del gruppo scultoreo sul vecchio campanile della cattedrale, che sorgeva dove ora c’è la statua di san Vito, ad opera del toledano Bernardo Gasch che fu vescovo di Mazara dal 1579 al 1586 [26]. Non conosciamo la paternità artistica della scultura ma per comparazione iconografica rintracciamo la sua provenienza culturale spagnola: si tratta di san Giacomo Matamoros, titolare della leggenda di Santiago de Compostela e simbolo dell’orgoglio iberico.
É naturalmente una leggenda la credenza religiosa legata all’intervento sovrannaturale dell’Apostolo San Giacomo il Maggiore nella famosa battaglia di Clavijo dell’844, in cui si narra apparisse miracolosamente, su un cavallo bianco, per aiutare gli asturiani a sconfiggere gli islamici. La raffigurazione di san Giacomo come “uccisore dei mori” divenne il simbolo della Reconquista spagnola nel XV secolo. Non è difficile pensare che il vescovo Gasch portò con sé dalla Spagna il gruppo scultoreo, o che lo facesse giungere a Mazara successivamente, attribuendogli l’identità ruggeriana dopo aver appreso dell’altrettanto leggendaria battaglia del Granconte contro Mokarta. Ruggero assume le sembianze e il ruolo simbolico di Santiago Matamoros, campione della vittoria cristiana sugli “infedeli”, ma il simbolo riposa su un falso storico e sulla verità della perdita di una quantità ingente di vite umane immolate sull’altare del potere, dell’uno e dell’altro esercito. Dio non può essere chiamato a patrocinare una guerra, né un Apostolo di Cristo può essere immaginato come autore di una strage etnica otto secoli dopo la sua morte.
Sappiamo della collocazione del gruppo scultoreo sulla facciata della Cattedrale Barocca inaugurata dal Vescovo Graffeo da un documento del 1696. Le sculture che componevano il gruppo erano reduci del crollo del vecchio campanile, collassato nel 1587 e mai più ripristinato [27]; per non perdere la memoria dell’epopea ruggeriana l’icona marmorea fu collocata in posizione di evidente preminenza, ma di patente contraddizione con la scritta evangelica correttamente posta sulla porta: «Per me si quis introierit salvabitur» (Gv 10, 9). Il versetto evangelico è un loghion di Gesù che simbolizza se stesso come “porta”: chi passa attraverso di lui, cioè attraverso la sua vita, sarà salvo. C’è un’evidente distonia tra la parola di Gesù che promette vita a chi è assimilato alla sua vita, e l’immagine di morte e di violenza che la sovrasta.
Qui è infranta l’unità simbolica dell’estetica cristiana che è essenzialmente iconologica: la parola si fa icona, la parola vera diventa fatto visibile: verum et factum convertuntur, nell’unità simbolica della persona di Cristo Verbo ed Immagine perfetta del Padre. Teologicamente ragionando è sconveniente, contraddittorio che quell’immagine occupi ancora quel posto. Disorienta, dia-bolizza, infrange l’unità della struttura simbolica della liturgia che in quel luogo si celebra, a partire dalla porta che immette nel luogo ecclesiale della Trasfigurazione. Contraddice inoltre i propositi di dialogo interreligioso inaugurati dal Vaticano II e caldeggiati da papa Francesco. Nulla deve far sospettare dell’incoerenza dei propositi cristiani le cui espressioni devono anch’esse tradursi in fatti salvifici. Ne auspichiamo pertanto la rimozione e la musealizzazione, perché si possa sempre trarre lezione dalla storia, anche dalle pagine più buie che l’arte registra e tramanda; perché la guerra, l’odio, la prevaricazione, la brama di potere, l’ingiustizia e tutto ciò che uccide venga cancellato dal vocabolario esistenziale e considerato semplicemente come errore del passato da non ripetere mai più.
Mi piace chiudere con un’affermazione di Marko Ivan Rupnik che di simbolismo artistico cristiano se ne intende: «Se il vero e il bene non appartengono più a una realtà viva, personale, ma al mondo astratto delle idee, anche la bellezza si riduce semplicemente al rivestimento di queste idee, e diventa quindi solo una forma estetica» [28].
Dialoghi Mediterranei, n. 54, marzo 2022
Note
[1] In esergo al libro di J. J. Norwich I normanni del sud, 1016-1130, Sellerio, Palermo 2021: 11.
[2] A. Chastel, Storia dell’arte italiana, Laterza, Bari 19964: 108.
[3] Cfr. H. G. Gadamer, L’attualità del bello, Marietti, Genova 1996: 34-35.
[4] Ivi: 34.
[5] Con la bolla Quia propter prudentiam tuam, papa Urbano II equiparava il Granconte Ruggero d’Altavilla ai suoi rappresentanti (Legati) e praticamente riconosceva la sua ingerenza, in Sicilia, sua e dei suoi successori, negli affari e nella vita della Chiesa, subordinandola all’esecuzione delle direttive pontificie. Il Granconte poteva erigere Diocesi e sceglierne i vescovi che presentava al papa per ottenerne l’approvazione. Solo nel 1864, Papa Pio IX abolì tale istituto col breve Multis gravissimis. Il Governo del Regno d’Italia, nonostante ciò, rinunciò ufficialmente a questa speciale prerogativa solo nel 1971, con l’art. 15 della legge delle Guarentigie.
[6] Il concetto della sacralità del potere regale che discende da Dio viene ribadito da re Ruggero nell’assise di Ariano del 1140. Cfr. F. Abbate, Storia dell’arte nell’Italia meridionale, Donzelli, Roma 1997: 207.
[7] Cfr. G. Herm, I bizantini, Garzanti, Milano 1987:113-134.
[8] Cfr. C. Dawson, Religione e cristianesimo nella storia della civiltà, Ed. Paoline, Roma 1984: 314.
[9] Il Pontificale è il libro liturgico che contiene tutti i riti celebrati dal vescovo. Il Pontificale Romano-Germanicum [Ottonisches Pontifikale] fu redatto tra il 950 e il 962 nell’Abbazia di Sant’Albano presso Magonza e può essere considerato un prototipo, il modello che ispirò quelli redatti dalla Curia Romana fino a quello successivo al Concilio di Trento. Contiene una ritualità complicata e farraginosa, croce e delizia dei cerimonieri, specie in epoca barocca. Il Vaticano II ha profondamente emendato e semplificato quello tridentino rimasto invariato per cinque secoli. Cfr. C. Vogel, Les motifs de la romanisation du culte sous Pépin et Charlemagne, in Accademia tudertina. Centro di studi sulla spiritualità medievale (a cura di), Culto cristiano. Politica imperiale carolingia, Todi 1979; C. Vogel-R. Elze (ed.), Le pontifical romano-germanique du dixièm siècle, 3 voll. (Studi e testi, 226, 227, 269), Città del Vaticano 1963-1972.
[10] Cfr. G. Widengren, Fenomenologia della religione, EDB, Bologna 1984:525-529.
[11] Ibid.: 478.
[12] La banda che corre lungo l’orlo curvilineo del mantello reca, in caratteri cufici, una iscrizione araba da cui risulta che venne eseguito nell’anno 528 dell’Egira (quindi 1133-34) nel “tiraz” reale di Palermo. L’iscrizione, dedicata a Ruggero, dice: «Lavoro eseguito nella fiorente officina reale, con felicità e onore, impegno e perfezione, possanza ed efficienza, gradimento e buona sorte, generosità e sublimità, gloria e bellezza, compimento di desideri e speranze, giorni e notti propizie, senza cessazione né rimozione, con onore e cura, vigilanza e difesa, prosperità e integrità, trionfo e capacità, nella Capitale della Sicilia, l’anno 528». Il mantello fu trafugato dal tesoro reale di Palermo da Enrico VI, marito di Costanza d’Altavilla e padre di Federico II. Portato in Germania e custodito assieme ad altri importanti reperti come la tunica talare, l’alba, i guanti, la cintura, le calze, non è stato più restituito alla Sicilia. Attualmente è custodito al Kunsthistorisches Museum di Vienna.
[13] Cfr. G. Widengren, Fenomenologia della religione, op. cit.: 503-506.
[14] Cfr. C. Schug-Wille, L’arte bizantina, Rizzoli, Milano 1970: 164.
[15] Cfr. G.Herm, op. cit.: 241.
[16] J. Le Goff, Il cristianesimo medioevale, in Storia delle religioni, X, con Jules Leroy e Olivier Clément, Collana Universale n. 416, Laterza, Roma-Bari 1977: 24.
[17] Cfr. l’opera di M. Bur, L’Abate Sugero, statista e architetto della luce, Jaca Book, Milano 1995.
[18] Ibid.: 195.
[19] Il primitivo giudeo-cristianesimo era arrivato in Arabia per lo più dalla Siria, dall’Iraq, dall’Iran e infine dall’Etiopia. Le comunità giudaico-cristiane dovrebbero aver dispiegato un’influenza importante su Maometto per la fondazione dell’Islam. Una significativa sintesi della questione la si trova nel volume di Hans Küng, Islam, passato, presente, futuro, Rizzoli, Milano 2007.
[20] Cfr. l’analisi tipologica effettuata per comparazioni planimetriche da Rodo Santoro, Spazio liturgico bizantino nell’architettura panormita, in Oriente cristiano XVII (1976): 41-69.
[21] G. Widengren, op. cit.: 475.
[22] Ho trattato la questione nel mio libro Liturgia secondo Gesù, Feeria, Firenze 2003: 360-361.
[23] G. Widengren, op. cit.: 478.
[24] J. Le Goff, Il cristianesimo medievale in Occidente dal Concilio di Nicea alla Riforma, in H. C. Puech (a cura di), Storia delle religioni, 9 voll., Laterza, Bari-Roma 1976, III: 47.
[25] J. J. Norwich, I Normanni nel Sud, op. cit.
[26] G. B. Quinci, La Cattedrale di Mazzara dalla sua fondazione fino ad oggi. Monografia letta addì 3 agosto 1914 per la riapertura della stessa, Tip. Giliberti, Marsala 1916: 37. Il Quinci riferisce della collocazione del gruppo scultoreo «in un finestrone del predetto campanile» e parla di «una iscrizione non più esistente» rimandando a La Mazara Sacra di Pietro Safina, Palermo 1900, 12, che così la riporta: D.O.M.H.&.G. ROGERIUS NORTHMANNUS MAGNUS SICILIAE COMES/ EXPULSIS SARACENIS HANC EPISCOPALEM ECCLESIAM FUNDAVIT/ CUI MARMOREUM HOC BERNARDUS GASCH HISPANUS EPISCOPUS MAZARIENSIS/ GRATUS EREXIT ANNO DOMINI M.D.LXXXIV. Neanche il Safina cita la fonte da cui ha attinto l’iscrizione.
[27] Archivio Storico Diocesano, Vol. XXII delle Sacre visite, foglio 25: «La facciata della porta maggiore è lavorata con sue colonne e cartocci di pietra palazzo, sopra della quale esprime di marmo bianco scolpito a rilievo il conte Rugiero a cavallo in atto vincente al saraceno Mokarta; era prima posta nel campanile antico».
[28] N. Govekar (a cura di), Il rosso della piazza d’oro. Intervista a Marko Ivan Rupnik su arte, fede, evangelizzazione, Lipa, Roma 2013: 70.
_____________________________________________________________
Leo Di Simone, teologo, scrittore, esperto di musica liturgica e di arte sacra, ha insegnato Antropologia culturale e Liturgia presso la Facoltà Teologica di Sicilia (Palermo), l’Istituto di Scienze Religiose di Mazara del Vallo e l’Istituto Teologico di Scutari (Albania). È presbitero della Diocesi di Mazara del Vallo e docente stabile di teologia presso la Scuola Diocesana di Teologia. Nella stessa Diocesi coordina il progetto “Operatori di pace” e dirige l’Ufficio Diocesano per i Migranti. Attualmente è Referente diocesano per il Sinodo dei Vescovi. Tra le sue pubblicazioni, si segnalano i seguenti volumi, editi da Feeria (Panzano in Chianti – Firenze): Liturgia secondo Gesù. Originalità e specificità del culto cristiano. Per il ritorno a una liturgia più evangelica (2003); Vexilla Regis. La croce dipinta di Mazara del Vallo. Icona pasquale della liturgia (2004); Beato Angelico. L’estetica del Verbo incarnato (2004); Le rotte dei Misteri. La cultura mediterranea da Dioniso al Crocifisso (2008); Liturgia medievale per la Chiesa postmoderna? La questione del “rito antico” nel racconto del “rito romano” (2013). Ha curato, per i tipi de Il Colombre, il volume Trasfigurazione. La Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo. Culto Arte e Storia (2006). L’ultimo suo volume è un saggio biografico su Thomas Merton: Il romanzo di Thomas Merton. Un umanista cristiano nell’era postcristiana, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani (2018).
_____________________________________________________________























