di Flavia Schiavo
I sistemi urbani sono tra i cardini del rapporto tra “soggetto” e “mondo”, rappresentano il pensiero, le teorie, le figure filosofiche, le credenze, i riti, le relazioni di potere, che prendono corpo nella città, luogo di affermazione, conflitti, incontri, di simbolizzazione e di socializzazione, in quanto luogo per antonomasia della scrittura.
Il paesaggio urbano, forma complessa di rappresentazione socio-culturale, può essere osservato decodificandone i segni, portatori di forza, debolezza, contraddizioni. Tale rappresentazione mette in luce alleanze, opposizioni, pulsioni, scrivendo il “luogo”, tra intenzioni e occasioni, attraverso elementi lineari, areali e puntuali, sovrapposti, intrecciati, affiancati e riconducibili alla relazione tra alcune macro-categorie, spesso lette come oppositive o antitetiche, ma tutt’altro che scisse: sacro e profano da un lato; natura e cultura dall’altro. “Ordini” di trasformazione, radicamento e controllo, nella città e nel territorio.
Ogni spazio urbano esprime il tempo incarnato della storia umana. È in tal senso che la città ha un corpo e porta, nel corpo, un dualismo e una duplicità. Ogni luogo, infatti, riferisce nel dialogo tensivo e nella commistione tra sacro e profano e tra natura e cultura: dicibile e indicibile; visibile e invisibile; prossimità e distanza; reale e immaginario; interiore ed esteriore. Lo spazio civico, materiale e immateriale, è espressione dei singoli e dei gruppi. E gli “oggetti urbani” (unitari o sistemici) sono le “cose” che traducono i concetti e le parole, il pensiero, le relazioni di potere in materia presente e storicizzata. Se si raccontasse lo spazio civico solo attraverso gli oggetti urbani, si potrebbe dire che, nel rapporto tra pieni e vuoti, la configurazione morfologica della città si avvale di pochi segni, “pieni” e “vuoti”, egualmente significanti e diversamente carichi di senso. Oggetti instabili, a volte di transizione, o permanenti, in altri casi. Oggetti sempre legati al radicamento e all’abitare inteso come atto stanziale, diffuso all’intero sistema urbano.
In sintesi si può esemplificarli, in base alla funzione: edifici/spazi-luoghi di culto [1], edifici/spazi-luoghi del potere istituzionale, edifici/spazi-luoghi relativi alla produzione, all’economia e al commercio, edifici/spazi-luoghi della socialità, del divertimento o dello spettacolo, edifici/spazi-luoghi residenziali, edifici/spazi-luoghi dell’attraversamento, edifici/spazi-luoghi relativi all’istruzione o alla ricerca, edifici/spazi-luoghi relativi alla “salute” o alla “morte”.
Elias Canetti, in Massa e potere (1960) esamina, partendo dalle memorie di A. Speer, l’architetto del Terzo Reich che tradusse in forma urbana il dominio di Hitler, la relazione tra città (e le masse controllate che la abitano) e potere totalitario. I Piani e l’architettura in toto di quella fase, furono un mezzo per manifestare la supremazia inequivoca del Führer e mantenere il potere (in altra forma) dopo la sua morte. Sia gli edifici che alcuni microsistemi urbani spesso da essi influenzati, sono segni del dominio, della presenza, della supremazia, della marginalizzazione o della resilienza, e sono segni mnestici. La città si organizza anche nella permanenza/scomparsa di essi, con una mutazione in progress, fatta di emergenze puntuali (edifici di differenti tipi e funzioni, come quelli per il culto) di aree, di variabili configurazioni strutturali, di avanzamenti del confine, di dispersioni. Elementi e dinamiche che funzionano, nel sistema urbano, come marcatori di intenzione politica (in senso ampio) e come punctum, così come suggerito da Barthes ne La chambre claire, del 1980.
Affrontando il tema dello spazio sacro in ambito urbano, quale luogo dell’incontro, si può dire che gli edifici deputati (insieme agli “altri” che rivestono una funzione caratterizzante [2]) esprimono due fondamentali pulsioni, una razionale, l’altra no, rispettivamente riconducibili al Diritto e alla Fede. Diritto di cittadinanza, diritto di appartenenza. Entrambi legati alla vita comunitaria. Anime presenti e persistenti, anche durante trasformazioni come la Rivoluzione Industriale, quando nelle città europee (come ci hanno mostrato M. Weber e G. Simmel) iniziava il processo di laicizzazione e la Società “uccideva” Comunità e Soggetto, quale parte di un sistema collettivo e comunitario precedente.
Ragionare sui luoghi di culto e sul loro ruolo, rispetto alla città, spinge ad affrontare alcune questioni attinenti la “vita urbana”.
1. Funzione e ruolo
I “templi”, qualunque fede esprimano, rimandano a tre aspetti: a) la militanza attiva della fede (quando essa non sfoci nel terrorismo, nel fondamentalismo o nel fideismo); b) l’azione sociale, il recupero, la “resilienza”, il sostegno alle minoranze con un ruolo che a volte afferisce a quello del “terzo settore”, (spesso avvalendosi di “volontari”); c) l’azione in seno a una società che, negli ultimi anni, soprattutto, ha virato verso un modello “laicizzato”. Tale fenomeno innesta nella funzione primaria (la fede) e in quella secondaria (l’azione sociale), anche un’ulteriore funzione che vede spesso i luoghi di culto trasformarsi in “assi culturali”, atipici Musei laici o luoghi in cui tenere concerti o rappresentazioni. In termini generali, tale laicizzazione vede il rinsaldarsi del potere secolare delle Chiese. Su tale nodo esiste un dibattito corposo e complesso che si può ricondurre, in estrema sintesi, alle riflessioni fatte da P.P. Pasolini [3], nel corso di tutta la propria vita (in letteratura, poesia e cinema), sul sacro anche in relazione al devastante ruolo del Capitale, durante il Novecento.
Il modello laicizzato si manifesta soprattutto nella contemporaneità e porta, se osservato insieme alla moltiplicazione degli effetti del melting pot e alla presenza dei migranti, alla formazione di comunità più porose che hanno una differente relazione con lo spazio e con i luoghi di fede. Da un lato questi perdono un po’ il ruolo avuto in precedenza, dall’altro sono in parte sostituiti da altri luoghi d’incontro che, esterni al dogmatismo religioso, si configurano come spazi più fortemente interculturali.
In una fase storica, come quella dell’esplosione urbana di città come NYC, per esempio, le chiese e i templi erano più che luoghi della fede e del misticismo incarnato, baluardi di accoglienza dei migranti e in alcuni casi “linee di confine”– in consonanza con i limiti dei “quartieri” [4]– “argini” di comportamenti e costumi, mantenendo fisse alcune “pratiche” sociali reputate immodificabili, e agendo indirettamente sulle dinamiche economiche intra ed extra comunitarie. Il ruolo dei luoghi di culto è, comunque, sempre a cavallo tra sociale e religioso, anche perché l’azione sociale muove proselitismo e garantisce il controllo dei comportamenti, tramite istituti quali “matrimonio” e “famiglia”, concepiti con le debite differenze nelle tre religioni monoteiste (Cristiana, Ebraica, Musulmana) che adottano criteri e modalità diversi.
2. Estetica, “consistenza” e percezione
I “templi” [5] sono oggetti chiave, “ombelichi” del paesaggio urbano, lo determinano e sono percepiti dagli abitanti, in termini differenti, a seconda della visibilità, dell’azione sociale, dell’impatto “simbolico” (rilevato anche in assenza di consapevolezza). Ne rileviamo alcuni aspetti: a) rapporto tra forma degli edifici e “sostanza” della fede; b) relazione tra fedi diverse, che avvicendandosi o confliggendo conducono, talvolta, alla trasformazione di alcuni edifici di culto o di interi territori; c) “traduzione” dei contenuti di ogni fede che si situano tra il campo religioso, simbolico, filosofico, culturale.
La forma di un edificio per il culto si rapporta con un “modello” (paradigma) dai caratteri ricorrenti e reiterati, connessi alla struttura intrinseca della fede. Se un tempio ha la pregnanza di un simbolo rivelato, il perseguire la bellezza architettonica e urbana è specchio di una ricerca d’ordine connessa alla Rivelazione: in tal senso il confine dello spazio sacro, che ha valore fisico e immateriale, marca la distanza con l’estensione illimitata dello spazio profano, cui si attribuisce un diverso significato. Allora lo spazio architettonico di un tempio è lo spazio ordinato e cosmico che si contrappone allo spazio disordinato e caotico. Le fedi traducono tale “fatto” in modo differente, con strutture geometriche proprie che hanno, però, alcuni elementi comuni: il centro, l’asse verticale e la tensione verso la verticalità, la croce e la ripartizione interna tramite i “bracci”, la circolarità, cui si aggiunge l’orientamento. Interni al fondamento teoretico della divinazione tali elementi sono in profondo dialogo con la fede, con le persone e con la città, basti pensare alla relazione tra il templum romano e il castrum; alla croce e al legame con i cicli solari, nell’architettura cristiana (e non solo); all’orientamento e alla “direzione” nelle Chiese cristiane o nelle Moschee.
La ricerca della “bellezza” in un edificio per il culto non è, quindi, un fatto meramente estetico, ma è questione simbolica e sociale, in termini diversi di quanto accada in altri edifici (come quelli istituzionali). Se esiste un patrimonio storicizzato di edifici per il culto che afferisce ai beni storico-artistici, la stragrande maggioranza delle chiese contemporanee non manifesta una qualità architettonica. Detto molto in sintesi, la “bruttura” diffusa delle chiese contemporanee è legata a una trasformazione della società, a partire soprattutto dalla Rivoluzione industriale, quando il luogo per il culto perde centralità e quando compaiono nuovi edifici e nuove funzioni (teatri; cinema, centri commerciali; ecc.). Ed è anche riflesso di un male che grava sulle città, nelle quali prolifera un’edilizia di bassa qualità, sia sul piano estetico che per quanto attiene i sistemi costruttivi. Esistono delle eccezioni connesse: a una comunità attiva che muova dal “basso” iniziative autoprodotte, alla vitalità economica e a un efficiente governo urbano, che propizi occasioni, mobiliti intersezioni tra capitali pubblici e privati, coinvolga con incentivi, sgravi, programmi o con concorsi internazionali, la comunità, gli architetti appartenenti allo star system, i giovani progettisti e i cittadini locali.
3. Economia urbana, politica e conflitti urbani
I templi e i luoghi di culto agiscono sul paesaggio urbano in termini di percezione e forma e inducono processi legati alle “politiche”, al mercato immobiliare, alla mobilità urbana. Inoltre muovono – anche se più debolmente rispetto ad altre dinamiche – capitali privati e azioni di alcuni soggetti, parte dell’élite culturale o economica o “semplici” abitanti della comunità insediata. Spesso i soggetti forti e i portatori d’interesse – anche grazie a finanziamenti pro costruzione o pro iniziative filantropiche, coinvolti nell’edificazione o nel recupero di alcuni edifici di culto – operano in ambito urbano, entrando nel network relazionale tra i diversi gruppi di gestione e governo, agendo sugli andamenti politici locali e, a volte, sovra locali. I templi in tal senso sono anche segni del potere religioso secolare, degli scontri tra fedi e in parte sono specchio della condizione politica e del “mercato”.
4. Condivisione. Presidi territoriali, interculturalità
Se in alcuni momenti storici si è assistito a una condivisione interreligiosa, come a Còrdoba o tramite la fondazione di recenti culti “trasversali” come la fede Bahá’í [6], va posto in evidenza che tale pratica è complessa e apre un fronte di ragionamento non solo filosofico o speculativo, ma umano, ponendo la questione nodale delle fedi, cioè il sussistere all’interno di ognuna di esse di una concezione assoluta, dogmatica. Che dovrebbe dialogare con il pensiero filosofico, tendenzialmente laico.
La questione dello “spazio comune” pone, almeno in termini teorici, ogni assolutismo in una feconda dimensione di ripensamento. Lo spazio pubblico – e un tempio lo è – è un bene comune e collettivo. E pertanto dovrebbe essere auspicabile concepire un luogo sacro d’incontro tra fedi e persone differenti, così che, nella complessa struttura delle democrazie contemporanee, le differenti religioni possano coabitare pacificamente e offrire contributi positivi alla convivenza civile. Sovente, però, i luoghi sacri sono presidio territoriale, sono confinati, selettivi e orientati ad accogliere solo gli appartenenti a una fede. Cioè agiscono come una sorta di deriva del Panopticon foucaultiano. Ciò si riflette in ambito territoriale, dove alcuni edifici mostrano il controllo, la contesa e i conflitti aperti, deboli o esacerbati. Il senso di appartenenza comunitaria di un tempio che ha valore difensivo rispetto ad alcune minoranze fragili e dalla cittadinanza critica, può presentare una delle facies più mostruose dell’assolutismo, spingendo anche a ragionare sul tema del confine, che dovrebbe essere fisicamente ammesso, ma misticamente e metaforicamente negato. Ma si riflette anche in ambito storico, quando si assiste alla cancellazione delle tracce pregresse di altri culti.
A prescindere dall’appartenenza e dal tempo storico, come hanno mostrato alcuni Grandi Iniziati (uno per tutti Gandhi), non dovrebbero esistere grandi differenze nelle fedi, essendo nella concezione religiosa uno solo il Dio possibile. Se Canetti ci mostra come “appropriazione” e “scrittura” dell’urbano possa avvenire in modo assoluto e massivo, in regimi totalitari (in termini laici e fondamentalisti) – nessuno è “straniero” a Berlino – sappiamo che tale processo è avvenuto anche in altro modo: in fasi storiche specifiche di fondazione o rifondazione urbana (gli interventi riformatori della civitas, di Haussmann o di Cerdà, nel XIX secolo a Parigi e a Barcellona) o in modo più sfumato e incoerente.
I segni del dominio e del potere, della resistenza e dei “contropoteri” si manifestano nel tempo e nello spazio attraverso dinamiche assai più temperate e meno assertive, a opera delle azioni dei cittadini e dei poteri religiosi e laici, anche con la costruzione o il recupero di un singolo edificio per il culto, che riarticoli un sistema territoriale e/o urbano o una sua parte o che abbia un grande valore sociale oppure percettivo (es. alcune chiese romane; Trinity Church a NYC; o Notre-Dame du Haut Ronchamp di Le Corbusier; la Moschea Blu a Istanbul) [7] oppure con la lenta stratificazione di un tessuto polisemico fatto di edifici che incidano socialmente, simbolicamente e percettivamente sul territorio. Essi rivestono, così come gli edifici o gli spazi istituzionali, o quelli aperti collettivi (le piazze) oltre a quella simbolica, un’ulteriore funzione normativa, tutt’altro che smaterializzata, attiva a livello dell’intera città, sono infatti dei “moral” e “social markers”.
Impianto giuridico, economico ed ecclesiastico non rappresentano l’intero, ma racchiudono la summa relativa alle organizzazioni delle “sovranità” che debbono farsi carico della gestione di un sistema caotico, come la città (intesa in senso lato). In tale chiave gli edifici per il culto possono essere guardati come parte di una più estesa traduzione sociale che abbia una predisposizione disciplinare e di controllo. Tali edifici hanno, o avrebbero avuto, se costruiti o se non demoliti, un ruolo sul sistema urbano. L’elenco potrebbe essere infinito e tre tra essi, un “nodo” per ognuna delle tre religioni monoteiste, possono esprimere l’impatto sui sistemi urbani in cui sorgono e sul livello globale. Una di esse non fu mai costruita, dimostrando come anche un’assenza rappresenti i processi urbani collegati agli edifici sacri.
Trinity Church (di confessione episcopale) a NYC – nel primo impianto, limitato da Wall Street, a opera dei coloni olandesi –- è un caso emblematico essendo una permanenza del paesaggio e tra i simboli urbani quasi quanto la Statua della Libertà, la Library sulla 5th, l’Empire, il Chrysler o il WTC prima della caduta.
Trinity fu edificata nel 1698 [8] su terreni acquistati dalla Chiesa di Inghilterra, mentre regnava William III, con un canone annuale pari a 60 quintali di grano. La chiesa ampliò la superficie del lotto nel 1705, per una donazione della Regina Anne, e nel 1709 venne fondata la Charity School le cui lezioni furono tenute nel campanile della chiesa. Nel 1754, dal re inglese George II, venne istituito in un edificio adiacente alla chiesa il King’s College (la Columbia University), dove otto studenti iniziarono il proprio corso di studi. Nel 1776, a conclusione della Guerra di Indipendenza, durante la quale NYC era stata base militare e politica delle operazioni in Nord America, divampò in città uno spaventoso incendio che lasciò migliaia di abitanti senza casa. Le fiamme, che distrussero la chiesa, infuriarono su Fighting Cocks Tavern, vicino Whitehall Slip, immediatamente a ridosso di Battery Park, in un lembo di terra che già i coloni olandesi iniziarono a riempire, avanzando la linea di costa, ampliando la porzione di Lower Manhattan e creando un territorio che poi sarebbe diventato conteso, quando la città iniziò il proprio incrementale sviluppo.
Ancora oggi l’ampio dominio territoriale di Trinity contempla ambiti esterni all’isolato che ospita l’edificio. Esistono, infatti, tre cimiteri legati alla chiesa, il primo è tra Wall Street e Broadway; il secondo sulla Riverside Drive all’altezza della 155th Street (in West Side), il terzo è il sagrato della vicinissima cappella di St. Paul. La chiesa inoltre, pur avendo venduto gran parte del terreno donato dalla regina Anne, ha un patrimonio immobiliare di 14 acri (circa 5,5 Ha) a Manhattan (una tra le maggiori proprietà nell’isola, dove lo spazio è davvero esiguo), tra essi 14 mln di piedi quadrati (circa 130 Ha) di spazio commerciale a Hudson Square (a nord di Canal Street, in West Side). Il fatturato annuale della parrocchia è stato nel 2011 di 158 mln di dollari, con un utile di 38 mln. La trasformazione di questo microcosmo urbano, riprende nel 1784, dopo l’incendio che non mandò realmente in fumo Trinity, quando fu ratificata la Charter della Church dalla New York State Legislature, sancendo l’indipendenza della chiesa dal Re d’Inghilterra. Alcuni patrioti del partito Whig [9] furono nominati fabbricieri e fu consacrato il primo Vescovo, della Diocesi di NY, appena formata.
La costruzione del secondo edificio iniziò nel 1788, dopo due anni la chiesa fu completata, ma fu demolita perché indebolita durante la nevicata del 1838-‘39. La terza costruzione, quella attuale, prese il via nel 1839 e fu conclusa nel 1846. Il campanile di 86 metri restò il vertice più alto dello skyline, sino al completamento del New York World Building, nel 1890.
La chiesa è un riferimento visivo dalla fondazione urbana, chiude la prospettiva di Wall Street ed esprime uno dei caratteri newyorchesi: l’eterogenea struttura di Downtown con le strade, ben più tortuose di quelle ortogonali del Grid del 1811, che hanno nel tempo aperto differenti prospettive di percezione del paesaggio, cambiando “senso” per l’insediarsi progressivo degli Skyscrapers, per la forma e per la relazione tra la larghezza delle strade e l’altezza degli edifici. Strade che avvolgono e stringono, spesso canali visivi potenti, sono nella relazione tra pieni e vuoti, solchi del paesaggio, che chiudono e aprono un racconto, quello della storia umana e dei radicamenti ibridi di chi abita e ha abitato la città.
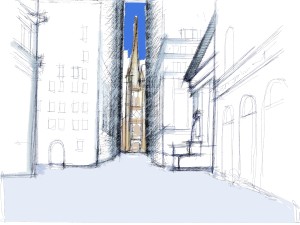
NY, Il canyon degli edifici e il cannocchiale ottico con il terminale di Trinity Church (dis. Schiavo)
La chiesa ha un enorme valore rappresentativo, più che strettamente connesso alla fede; infatti ospita iniziative, anche in connessione con le vicende urbane. Durante il settembre del 2011, al crollo della prima Torre del WTC molte persone si rifugiarono all’interno, un gesto apparentemente sconsiderato, per la prossimità di Trinity al luogo del disastro e per l’“età” della costruzione, un gesto che racconta paura e appartenenza, e che dà la misura del valore attribuito dai cittadini all’edificio. Durante Occupay Wall Street, a dicembre del 2011, lo staff di Trinity fornì assistenza pratica e morale agli occupanti, che manifestavano a Zuccotti Park, rifiutando, però, la disponibilità nell’utilizzo di un terreno di proprietà della Trinity (Juan Pablo Duarte Square) come accampamento. Tra gli arrestati, post manifestazione, tre sacerdoti episcopali e una suora cattolica.
La Sinagoga di Hurva, di Louis Kahn, il cui progetto era previsto vicino al Muro del Pianto [10], all’interno del compatto sistema urbano storico di Gerusalemme, non fu mai realizzata e – negando il rapporto che avrebbe avuto con un altro polo del sacro (la musulmana Cupola della Roccia [11]) non immediatamente adiacente, ma connesso alla Sinagoga da ragioni e “fratture” storiche – resta un “dolmen” immaginario, sarebbe stato potentissimo in una città che, dalla fondazione dello Stato di Israele, divenne uno spazio conteso. Una terra di troppi, che restituisse, dopo la Shoà, una casa agli Ebrei. E che dal 1948 divenne un’area di conflitti, guerre, massacri.
Uno degli elementi forti delle architetture di Kahn è la luce. Forte tanto quanto lo è qui, la simmetria biassiale dello spazio classico, ieratico, primario quasi, della sala. Quanto i monoliti che apparentemente la chiudono. Questa mai edificata Sinagoga, arcaica, uno spazio sacro in sé e sacro come sono sacre tutte le opere di Kahn, avvolge. Chi vi entri dentro sente quanto un luogo lo conforti e lo sposti via, e strappi da ogni certezza, illusoria, rotta dal non essere davvero presenti ma dall’essere abitanti dislocati di un mistero, il Sacro. Kahn inganna il tempo, quell’edificio ha un tempo trasversale in sé e rende reale l’idea del Tempio aperto. Luce e aria possono, come le persone, penetrarvi dentro. La sinagoga, come disse lo stesso Kahn, era composta di due edifici, uno esterno che assorbiva aria e luce e l’altro interno. La “pelle” avrebbe consentito, come in altri suoi progetti, l’accesso dagli angoli aperti, tra varchi stretti tra i pilastri in pietra di Gerusalemme, mentre lo spazio interno avrebbe potuto essere un’Agorà chiusa, la casa dell’assemblea.
Nel 1967 l’architetto Ada Karmi-Melamede, con Yaacov Salomon, proprietario del sito su cui era eretta la sinagoga distrutta nel 1948, andò a Philadelphia per affidare a Kahn l’incarico della ricostruzione del tempio, su mandato della città di Gerusalemme, dopo il rifiuto dell’architetto Ram Karmi, attivo in quegli anni, conscio che Kahn avrebbe portato avanti meglio un compito così importante. Furono elaborati tre progetti. Il primo vide la luce nel luglio del 1969. Dato che la sinagoga era stata distrutta due volte, l’ultima nel 1948 durante il conflitto arabo-israeliano, Kahn scelse di progettare l’edificio accanto alle rovine includendo esse nel disegno del memorial, un giardino della memoria. L’architetto si dedicò alla lettura di alcuni testi, tra cui The origin of Synagogue, di L. Finkelstein [12], cogliendo le suggestioni che derivarono dalla struttura del Tempio di Salomone, per la sequenza degli spazi ordinati da un asse coronato da celle perimetrali. Ed è da questo andamento ritmico che scaturisce la struttura della sinagoga, fatta da due edifici in uno.
L’opera non fu realizzata anche per le resistenze del sindaco Teddy Kollek che, in ansia per l’impatto che un edificio così moderno avrebbe avuto nella Gerusalemme storica, espresse alcune riserve: situata alla stessa quota altimetrica della Cupola della Roccia una struttura così grande come la Sinagoga di Kahn sarebbe stata in competizione con il santuario musulmano, rappresentando così un ulteriore elemento di tensione con le comunità arabe.
Se Trinity e Hurva rappresentano due landmarks interni a due sistemi urbani storicizzati (anche se la seconda non fu mai edificata), il terzo “nodo” costituito da Santa Sofia e dalla Moschea Blu a Istanbul (un’area metropolitana di 15 mln di persone), mostra come gli edifici religiosi pur essendo specchio di un palinsesto storico complesso, a tratti catastrofico, sappiano dialogare con il territorio geografico e geopolitico, anche a grandissima scala. Entrambe edificate sul Bosforo – un confine, uno snodo commerciale, un punto focale ottico e intimo a livello planetario e individuale –le due basiliche monumentali testimoniano, in un’area vitale, l’avvicendamento tra fedi diverse, non una vera e propria coesistenza di fedi nella città divisa in due dal canale che mette in relazione due continenti, come spiega Pamuk:
«ho trascorso la mia vita ad Istanbul, sulla riva europea, nelle case che si affacciavano sull’altra riva, l’Asia. Stare vicino all’acqua, guardando la riva di fronte, l’altro continente, mi ricordava sempre il mio posto nel mondo, ed era un bene. E poi, un giorno, è stato costruito un ponte che collegava le due rive del Bosforo. Quando sono salito sul ponte e ho guardato il panorama, ho capito che era ancora meglio, ancora più bello di vedere le due rive assieme. Ho capito che il meglio era essere un ponte fra due rive. Rivolgersi alle due rive senza appartenere” (Istanbul, 2003)
Santa Sofia, inaugurata nel 360, fu una cattedrale cristiana di rito bizantino sino al 1453, cattedrale cattolica (1204-1261), moschea e in ultimo museo dal 1935. Originariamente basilica con colonnato e gallerie, con un doppio nartece, fu distrutta da un incendio nel 404 e ricostruita nel 415, rovinando di nuovo durante la rivolta di Nika, nel 532, contro Giustiniano. Nello stesso anno l’imperatore decise di riedificare la basilica, la quale divenne un modello architettonico e tenne diecimila persone impegnate durante i lavori che diedero vita alla chiesa, inaugurata nel 537, in quella fase la più grande della cristianità. La chiesa fu saccheggiata nel 1453, durante la presa di Costantinopoli, quando i Turchi Ottomani si appropriarono della città. In quel caso la basilica fu teatro di una tragedia che vide i Turchi opprimere anche gli abitanti che si erano rifugiati nella basilica. L’edificio fu, dopo il cambio di mano politico, mutato in una Moschea, con interventi architettonici che ne modificarono la facies. Solo nel 1935 il primo presidente turco, Mustafa Kemal Atatürk, trasformò l’edificio in un Museo. La Moschea Blu, altro elemento chiave del cityscape, fu edificata nel 1597 e completata nel 1616, per sancire la fine di una fase di conflitti, con la pace (per certi versi fittizia) di Zsitvatorok (1606) termine alla lunghissima guerra tra l’Impero Ottomano e gli Asburgo. La Moschea fu edificata sul sito del Gran Palazzo di Costantinopoli di fronte a Hagia Sophia (Santa Sofia, in quel momento la maggiore moschea di Istanbul). Pareti e colonne, ricoperte dalle maioliche che vanno dal turchese al verde, imprigionano la luce all’interno di una struttura che ha un enorme impatto sul paesaggio anche per la presenza di sei minareti.
Interazioni
Con le debite differenze nell’ambito delle tre religioni monoteiste, i luoghi di culto hanno un diverso impatto sul sistema urbano e sociale. Possono essere cerniere, cardini, spazi contesi, elementi di conflitto, come la sinagoga di Kahn, secondo la confutabile visione del sindaco. Possono essere “riprogettati” in termini di culto e architettonici, come accadde in epoca storica, durante alcune dominazioni, a Istanbul, Gerusalemme o Còrdoba dove in una specifica fase, quella medievale, ebrei, arabi e cristiani crearono una forse controversa cultura della reciproca tolleranza e coabitazione. In quella fase gli ebrei – come pure i cristiani – furono trattati in modo diverso che nel resto dell’Europa occidentale ed ebbero, sotto il Califfato, occasione di praticare la propria fede e commerciare liberamente. Marìa Rosa Menocal in un volume del 2002 (The Ornament of the World: How Muslims, Jews, and Christians Created a Culture of Tolerance in Medieval Spain), pur sostenendo che la tolleranza sia un aspetto intrinseco della società andalusa (affermazione che rimanda, ovviamente, a NYC), ci ricorda che la posizione degli ebrei divenne più precaria dopo il 976, con la dissoluzione del Califfato. Pochi anni dopo, nel 1066, infatti, si assistette alla loro prima grande persecuzione, nota come il Massacro di Granada, che innescò un processo culminato nel 1492 con il Decreto dell’Alhambra emanato dai re cattolici spagnoli, con il quale diventava obbligatoria l’espulsione degli ebrei dai regni spagnoli e dai loro possedimenti.
Uno degli edifici rappresentativi di tale doloroso processo è la Moschea di Còrdoba, oggi Cattedrale dell’Immacolata Concezione. Il Tempio, edificato sul sito dove era la chiesa visigotica di San Vincenzo, fu utilizzato contemporaneamente da musulmani e cristiani, quando gli Arabi occuparono la città, nel 756. La chiesa cristiana venne poi demolita e fu edificata la grande Moschea che venne progressivamente ampliata. Quando la città fu riconquistata dai cristiani, la moschea fu “riconvertita” in Cattedrale, poi riprogettata nel XVI secolo. Nel sistema urbano della piccola città di Còrdoba, l’edificio ha un enorme impatto, per l’estensione e per l’eccezionalità del complesso. Esso, incluso in un tessuto tortuoso di matrice araba, definisce un vastissimo quadrilatero, a ridosso del fiume, e funge da cerniera tra un insieme di edifici rappresentativi e una porzione densa del tessuto antico. L’edificio che ha una struttura esternamente continua, quasi fosse un muro difensivo, porta al proprio interno un codice atipico di trasformazione (la nuova costruzione non nasce post demolizione della Grande Moschea) e contiene l’edificio della Cattedrale che si erge dentro il “corpo” stesso della Moschea, interrotto dal Patio degli Aranci; esso, incluso nell’edificio attuale, agisce come un chiostro, tipico dell’architettura di matrice medievale cristiana.
Chiese, Moschee e Sinagoghe manifestano una propria natura sociale e sacrale e un’architettura eterogenea in cui, come mostrato, si compongono stilemi provenienti da matrici diverse. Oltre agli effetti della storia che mostra come un edificio per il culto sia la rappresentazione di un “palinsesto” e pertanto sia un elemento nodale del paesaggio, può dirsi che le prime due (chiese e moschee) sono spesso monumentali, le seconde meno [13]. Ma in tutti i casi rivestono il medesimo impatto (anche se qualitativamente diverso) sul piano sociale e comunitario.
Come già affermato il sacro non ha una veste solo sacra, ma genera fenomeni secolari e, in certi casi, ha potenti ricadute sul piano sia dei comportamenti e delle pratiche sociali che delle economie, urbane e territoriali: anche solo l’insediarsi di un edificio per il culto risente e/o può avere ricadute sul mercato immobiliare.
A New York City la commistione tra il sacro e il sociale si è espressa con pienezza, per ragioni storiche, politiche e geografiche, per l’esiguità dello spazio dell’Isola di scisto (solo 87 kmq) e per la componente multietnica propria della città. La presenza di numerose etnie e di forze in opposizione (i gruppi di potere, il contropotere degli abitanti, il potere del “sottogoverno” e dei bosses) ha prodotto un sistema urbano che, pur mostrando una compagine coerente (ma non omogenea) riguardo agli edifici istituzionali e un network caratterizzato da un’enorme differenziazione economica, ha dato vita a un’aggregazione di luoghi diversi, i quartieri, che avevano, spesso e soprattutto durante la fase in cui la città cresceva grazie alle migrazioni (XIX e inizio del XX secolo), edifici di culto al proprio “centro” (non geometrico) che fungevano da poli sociali, sia in termini di assistenza, sia di regolazione dei comportamenti, sia come “formazioni a cuneo” di lotta o resistenza, come accadeva a Harlem dall’inizio del XX secolo fino agli anni ’60 del Novecento, nelle Chiese battiste attive per quanto attiene la questione razziale e la protezione delle minoranze afro-americane.
Tutti erano e sono “stranieri” a NYC, ma tutti, in veste di cittadini, vivono un progressivo radicamento nell’originaria differenza, rivendicando i propri diritti, e anche gravitando intorno ai luoghi di culto. Esempio cardine le sinagoghe, spesso non monumentali e quasi “invisibili” nel tessuto urbano, furono centri di potere e aggregazione della comunità ebraica che è quella che maggiormente, forse, ha declinato un duplice andamento: da un lato l’integrazione, dall’altro il mantenimento della matrice originaria. Se nel XIX secolo il cuore del popolo ebraico pulsava a Berlino e Varsavia, Vienna, Damasco, Alessandria e Bagdad, dopo la Shoà e la fondazione dello Stato di Israele, la presenza si manifestò a Gerusalemme e a Tel Aviv. Ma già sin dai primi del XIX secolo, i 5 boroughs di New York, insieme ad alcune contee limitrofe, e ai nuovi shtetl [14] di Monsey, New Square e Kiryas Joel, costituivano tra l’Hudson e l’East River un mondo in cui la tradizione e i costumi ebraici perduravano pur nella integrazione con la Nazione che li accoglieva. Ogni giorno, dopo la Yom Ha’Azmaut [15], lungo la 5th Avenue, sfilano migliaia di persone, ebrei che raccontano il legame forte che li unisce alla democrazia americana, con l’omaggio dell’Empire State Building, che si illumina di bianco e azzurro.
L’arrivo degli ebrei [16] a New York iniziò nel settembre 1654 quando pochissimi profughi sbarcarono a New Amsterdam, alla ricerca di un tessuto sociale e urbano tollerante. Fuggiti dal Brasile, dove i portoghesi avevano cacciato gli olandesi e introdotto l’Inquisizione, furono respinti dal governatore Peter Stuyvesant che li considerò portatori di usi, commerci e costumi in grado di corrompere i cristiani. Il diktat cadde nel 1655 in seguito a una richiesta della Compagnia delle Indie, che affermava quanto il veto del governatore fosse in contrasto con la tolleranza religiosa. Si aprì una stagione che vide gli ebrei in America vivere senza sostanziali persecuzioni, affrontando il nodo dell’integrazione con la democrazia americana e apportando a sviluppo e cultura americani una netta impronta (a tratti controversa), favorita da una vitalità economica e da iniziative culturali e finanziarie, che sostennero la stabile affermazione della comunità. L’antisemitismo presente in America, non assunse mai i connotati europei; anche per tale ragione, in un rapporto a volte tensivo, la comunità ebraica pur rimanendo legata alla propria tradizione si è solo in parte fusa con quella americana. I chassidim, prima in Polonia, Ungheria, Lituania, si trovano, infatti, nelle strade e nelle sinagoghe di Brooklyn, il borough che registra, oggi, il maggior numero di ebrei a NYC, dove vivono circa il 37% degli ebrei americani, stimati circa 5 mln. Un’area interna fortemente caratterizzata dalla presenza di ebrei chassidici della comunità di Satmar [17] è la parte sud di Williamsburg (Brooklyn), dove ci sono numerose sinagoghe e dove, nel 1947, fu inaugurata la prima scuola, per 7 alunni e 12 alunne. Dodici anni dopo, nel 1959, gli studenti erano 1.400, e nel 1974 ben 3.500. Oggi sono circa 60.000 gli ebrei chassidici che vi vivono, un decimo dell’intera comunità a livello mondiale. La forte crescita demografica è legata all’osservanza dei precetti che incoraggiano le famiglie ad avere un alto numero di figli.
La prima Congregazione a NYC e negli States fu fondata nel 1654, e la prima sinagoga fu edificata solo nel 1730, in Mill Street in Lower Manhattan. Nel 1872 fu costruita la Central Synagogue (copia di una sinagoga a Budapest), in un lotto d’angolo, tra la Lexington Ave e la 55th Street.
Ne seguirono alcune a metà del XIX secolo, in aree interne allo Stato di NY ma esterne a NYC, alcune in Lower East Side, poche a Midtown, un numero più consistente in Uptown e numerose a Brooklyn. Le sinagoghe sono diffuse ovunque, a volte assumono la denominazione di congregazioni, templi o Jewish center, e sono presenti anche in altri quartieri, come per esempio a Harlem Qui per circa cinquanta anni il rabbino Jacob Kretman tenne aperta e attiva la sinagoga di Old Broadway, tra la 125th e la 126th Street, in un piccolo edificio ottocentesco, dove la congregazione, proveniente da Lower East Side, si spostò nel 1923, inizialmente raccogliendo soprattutto gli immigrati russi e polacchi, oggi attraendo soprattutto una vasta compagine di giovani che praticano da anni un’esperienza d’integrazione con la comunità nera. Infatti proprio ad Harlem – dove gli ebrei di origine tedesca erano storicamente presenti, anche prima delle trasformazioni immobiliari dei primi del Novecento avviate da Philip A. Payton – è insediata una compagine, denominata Black Jews, un gruppo religioso che sposò il sincretismo tra teologia ebraica e cristiana e si caratterizzò per un deciso nazionalismo nero ispirato al movimento Back to Africa di Marcus Garvey. Il gruppo ha oggi una sede sulla 123rd Street in un edificio color mattone, con una stella di David, disegnato da Frank Smith, richiamandosi allo stile degli architetti McKim, Mead e White, una nota firma del XIX secolo.
Questa comunità è e fu attiva sia sul piano dell’integrazione sia su quello del recupero dell’ebraismo; infatti, la sinagoga Old Broadway era già negli anni ‘30 una tra le più importanti della città e aveva dato forza alla compagine ebraica a Harlem, arrivata nel quartiere a cavallo tra Ottocento e Novecento. Quando le famiglie ebree più benestanti lasciarono Lower East Side, dove vi erano molte sinagoghe di quartiere e dove si praticava un giudaismo ortodosso, per trasferirsi dove spazi, case e giardini erano più grandi. Il flusso aumentò quando la linea di metropolitana fu inaugurata (nei primi anni del Novecento esisteva già una rete estesa e attiva) e si arrestò momentaneamente con la I Guerra Mondiale, quando alcune difficoltà economiche che impedirono il rinnovamento immobiliare, spinsero la comunità verso Brooklyn, il Bronx, Washington Heights, Park Avenue, il West Side (con un incremento durante gli anni ’30) al di sotto della 97th Street [18].
I movimenti d’integrazione erano attivi anche internamente, tra le differenti comunità ebraiche. Le sinagoghe infatti nelle hevrah (organizzazione politica e culturale) perseguivano il compito di unificare i membri delle comunità in uno spirito di fratellanza, aiutando anche chi avesse difficoltà economiche, seppellendo i defunti secondo le leggi di Mosè e chiedendo una quota associativa per autofinanziare le iniziative sociali. Nel contempo le medesime sinagoghe rappresentavano un fronte di resistenza, soprattutto da parte delle famiglie borghesi, all’assimilazione.
Già nel 1914 a Brownsville (un quartiere residenziale a Brooklyn, fondato nel 1858, che dal 1880 sino al 1950 circa mantenne una forte componente ebraica) fu costruita una sinagoga – chiamata Ohev Sholom all’interno di un’area agricola di proprietà di un business man attivo nel campo del Real estate, Elias Kaplan – lontana dal modello dell’hevrah, dove si intendeva conservare gli elementi del giudaismo ritenuti più adatti al mantenimento di un’identità religiosa. All’interno c’era un club per uomini, una comunità religiosa e una congregazione giovanile, ma non erano previste le attività assistenziali richieste della working class costituita, spesso, da migranti. Fu questo lo start di un processo che portò alla cosiddetta “sinagoga-centro”, un’istituzione per le famiglie che intendevano coltivare le tradizioni integrando anche uno spirito laico, e desacralizzando la tradizione, riflesso della “laicizzazione” della società. Secondo le indicazioni del rabbino, Mordecai Kaplan, nel centro si sarebbero svolte quattro attività: culto, studio, servizio sociale, ricreazione, in un luogo che doveva essere l’espressione dell’identità ebraica intesa in integrazione con la cittadinanza americana.
Oltre che in seno alle sinagoghe, alle scuole e in politica, la comunità ebraica è stata assai reattiva e in certi casi rivendicativa, forte economicamente anche sul piano del Real estate e dei finanziamenti in ambito politico. In parte autogestita anche in rapporto con organi come la Kehillah che in Europa dell’Est era l’istituzione stabile in molte comunità israelite impegnata a far rispettare i decreti imposti dagli Stati ospiti, esisteva anche a NYC dove fu istituita nel 1909 dal rabbino della sinagoga Emanu-El di Manhattan [19].
Per quanto attiene Harlem e il ruolo della comunità nera per la conquista dei diritti civili e per le azioni antirazziali, va menzionata soprattutto la figura cardine di Martin Luter King, Nobel per la Pace nel 1964 unitamente alla presenza della Chiesa Battista (presente a NYC dal 1808, con la fondazione da parte di un piccolo gruppo, dell’Abyssinian Baptist Church in Lower Manhattan) [20], spesso sita in edifici ottocenteschi visibili e monumentali, anche se assimilati all’interno di cortine continue su Streets o Avenue, o a volte inclusi in altri corpi di fabbrica. Altre due chiese di rilevante importanza e ben oltre il peso percettivo, sono: la Cattedrale di Saint John the Divine [21], costruita nel 1892, tuttora incompiuta, in Amsterdam Avenue (112th Street), a Morningside Heights; e Riverside Church. Quest’ultima, tra 120th Street e Riverside Drive (in West Side), all’interno di una area caratterizzata dalla Columbia University, in Morningside Heights, fu voluta da John Rockefeller Jr. e dal reverendo Harry Emerson Fosdick (il più importante ministro “liberal” della Chiesa Battista). Completata nel 1930 ha un aspetto monumentale e un’intelaiatura in acciaio, in una fase in cui tale sistema costruttivo aveva quasi totalmente soppiantato le altre tecnologie prima in uso. Si tratta di una chiesa cristiana, interconfessionale fin dalla sua nascita (aperta a tutti coloro che professassero la fede in Cristo) e dunque associata alle Chiese Battiste. Ha avuto e ha un ruolo non trascurabile rispetto all’azione sociale, ed è stata recentemente descritta dal New York Times (4 agosto, 2008) «come una roccaforte dell’attivismo e del dibattito politico (…) influente sui passaggi politici e religiosi dell’intera nazione». La Congregazione comprende oltre 40 gruppi etnici e dal 2007, gestendo uno staff pagato di 130 persone, dispone di un budget superiore ai 14 mln di dollari.
È scritto nella memoria storica lo speech di Martin Luther King (contro la Guerra del Vietnam) tenuto a Riverside Drive Church il 4 aprile 1967, tanto quanto altri discorsi e commemorazioni come quella di Kofi Annan dopo il 11 settembre o come l’intervento di Dietric Bonhoeffer [22], il cui apporto fu determinante nella resistenza cristiana contro il Terzo Reich. La chiesa aggregò, dunque, molte forze progressiste pure connesse alla lotta dei neri e ad associazioni come quella dell’Afro-American Civil Rights Movement. La chiesa oggi continua a offrire servizi sociali tra cui una banca del cibo, corsi di formazione, distribuzione di abbigliamento, assistenza ai senza tetto, un Forum assistenza HIV. Schieratisi a favore di Occupay Wall Street, la Chiesa ha donato cento tende e si unì con altre chiese di NYC in uno sforzo coordinato, chiamato “Occupay Faith”. Impegnati contro la repressione e la pena di morte, attenti alle problematiche LGBT, alla riforma carceraria e alla questione “migranti”, ospitando un gruppo di sostegno per le persone che hanno familiari in prigione e fornendo loro assistenza, i ministri di Riverside Church cercano di favorire il dialogo tra le comunità insediate (ispanici e neri) con la polizia newyorchese, notoriamente dura, soprattutto con le minoranze.
Il rapporto del mondo islamico con NYC è assai più controverso, soprattutto dopo il 9/11. Terza religione dopo Cristianesimo ed Ebraismo (i musulmani sono stimati circa lo 0.6 %), l’Islam conta circa una settantina di centri, tra cui una trentina di moschee nella città.Per affrontare, purtroppo in sintesi, la relazione tra il mondo islamico e NYC è utile seguire l’irrisolta vicenda relativa al grande progetto denominato Park51 [23], sito a poca distanza dal WTC, il luogo dell’attentato del 9/11. Inizialmente noto come Córdoba House, il progetto assunse contorni precisi intorno al 2009. Mosso anche dalla volontà d’integrazione e miglioramento dei rapporti tra musulmani e Occidente, fu promosso dall’imam Faisal Abdul Rauf, voce di primo piano della tradizione Sufi dell’Islam e da un imprenditore immobiliare americano, Sharif El-Gamal, di origini polacche ed egiziane. L’Imam autore di alcuni testi, uno dal titolo esplicito, What’s Right with Islam IsWhat’s Right with America (2005), cercò di sostenere una linea mirata ad affermare quanto l’islamismo non fosse una religione omogenea, ma comprensiva di uno spettro di differenti interpretazioni religiose. Alcune di queste pongono al centro il rispetto per tutti i credenti, siano essi musulmani, indù, ebrei, cristiani, buddisti.
La prima denominazione, Córdoba House, indicava un centro (15 piani) che sarebbe dovuto sorgere in prossimità di Ground Zero, a due isolati dal WTC, sostituendo un edificio del 1857 costruito per un uso produttivo proprio del XIX secolo (store and loft) danneggiato durante l’attentato. Il progetto prevedeva un auditorium, un centro per le arti e lo spettacolo, attrezzature sportive, una zona di assistenza all’infanzia, una libreria, un memorial per le vittime dell’attentato, nonché uno spazio di preghiera per la comunità musulmana.
Il progetto – il cui linguaggio mirava a conciliare la cultura islamica con la contemporaneità, adottando soluzioni a basso impatto ambientale – esaminato dalla comunità locale, frenato da una campagna lanciata da una frangia di conservatori, sebbene non del tutto avversato dai residenti più progressisti di Lower Manhattan, innescò un dibattito a livello nazionale e internazionale. Difeso dagli estensori che – affermando quanto Córdoba House fosse concepito sul modello storico della città di Còrdoba e del Manhattan Jewish Center nella 92nd Street – fecero appello al Primo Emendamento, e sottolinearono che i musulmani erano già presenti in Lower Manhattan, con due moschee vicino al WTC. Con il nuovo Centro essi avrebbero avuto la possibilità di manifestare i valori islamici pacifisti, sostenendo l’impegno per la tolleranza e la coesistenza della diversità di fedi. Di contro, il progetto fu osteggiato da chi vi lesse una chiara volontà di affermazione dell’islamismo più fondamentalista, facendo peraltro perno sull’onda emotiva, comprensibilissima, post l’11 Settembre.
Gli iniziali investitori – la SoHo Properties di El-Gamal, acquirente (per 4.8 mln di dollari) dell’edificio ottocentesco danneggiato e ancor oggi proprietaria dell’area – che avevano intenzione di edificare un complesso residenziale, si fecero convincere dall’imam, attuando un partenariato tra l’imprenditore di fede islamica, con altri investitori, tra cui la Córdoba Iniziative, fondazione esente da tasse, e l’ASMA, l’American Society for Muslim Advancement, anch’essa organizzazione no profit. Il progetto, approvato a maggioranza nel 2010 dal Consiglio comunale della città (New York City Council), concepito esplicitando una visione progressista come un Centro per l’integrazione, fu registrato da gran parte della comunità locale e nazionale come un luogo invasivo e pervasivo, come emerge sia dalle interviste rilasciate da alcuni cittadini, sia soprattutto da un documentario di David Osit, Building Babel (2012) [24], in cui si analizza la controversa vicenda. Il Centro fu in parte aperto al pubblico nel 2011, una struttura di ridotte dimensioni, ben lontana dal progetto ambizioso, che conteneva uno spazio di preghiera e luoghi comuni da destinare a mostre e incontri culturali con l’idea di proseguire e ampliare il progetto, che non fu né completato né realizzato.
La vicenda estremamente contraddittoria, densa di inciampi e ripensamenti fu caratterizzata anche da una serie di indagini sui membri coinvolti. All’interno di essa ebbero un ruolo – a favore, e non solo della costruzione ma del dialogo interreligioso [25], o contro –- sia figure politiche come il sindaco M. Bloomberg, il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama [26], Bill Clinton, sino a gruppi politici conservatori legati all’ebraismo, sia dinamiche connesse alla politica internazionale (si pensi, andando indietro nel tempo, al ruolo di G. W. Bush). Tale babele condusse a scelte totalmente difformi dalla concezione originale. L’esito negativo del progetto, come spesso accade a NYC, vide il predominio delle logiche del Real estate, risoluzione naturale di molte controversie locali e tra i maggiori capitoli del bilancio urbano. Capitolo fortissimo e governato da una specifica categoria di stakeholders, anche se a volte posto in crisi da azioni della comunità insediata (che in questo caso era ed è appartenente all’élite sociale ed economica del Finacial District). In tale quadro lo stesso Sharif El-Gamal propose un altro disegno, mirato alla costruzione di un edificio residenziale per l’Upperclass nell’isolato destinato a Park 51 [27].
Patrie
Manhattan dunque manifesta e già in fase iniziale – più di altre città come Philadelphia, Boston o Chicago – una polisemia complessa entro cui le diverse etnie, le differenti credenze, i differenti riti, coesistevano e coesistono con una conflittualità ridotta. Ha edificato i propri luoghi di culto che, assumendo un ruolo rilevante in ambito sociale e “politico”, hanno polarizzato il territorio tanto da diventare oltre che marcatori sociali, anche markers territoriali e percettivi: come Trinity Church che, terminale e landmark di un asse focale, Wall Street, esprime la duplice polarità del potere secolare e sacro della chiesa e del potere laico e sacrale della finanza newyorchese. O come la Metropolitan Cathedral di St. Patrick, che ha una funzione rappresentativa, ed è un landmark potente, a Midtown. Principale luogo di culto cattolico a New York, sede vescovile dell’omonima arcidiocesi. Situata lungo la 5th Avenue nei pressi del Rockefeller Center, fu edificata tra il 1853 e il 1878 in stile neogotico su progetto dell’architetto James Renwick Jr., su modello delle cattedrali europee.
Il ruolo degli edifici per il culto e la loro distribuzione, in relazione alla compagine umana diversificata a NYC, è centrale e va inquadrata nel rapporto esistente tra l’organizzazione geografica del territorio metropolitano e lo “sviluppo” urbano, avvenuto nel tempo breve di due secoli e mezzo. Esigerebbe un inquadramento “storico” che osservasse la città prima dello sbarco dei coloni olandesi. Per ricordare – anche se in sintesi, riflettendo sull’incontro e sul conflitto tra fedi – che la fondazione di New Amsterdam, nel XVII secolo, coincise con la totale cancellazione (avvenuta in un periodo abbastanza breve) della presenza degli Indiani del Nord America, i quali avevano segnato il territorio anche con i propri markers “religiosi” connessi a un simbolismo astrale, fondato su ricorrenze numeriche e simboliche (come il 4 e il 7) e in intima relazione con il territorio [28].
New York City, pur essendo costituita da cinque distretti, alcuni dei quali hanno un’enorme superficie, si struttura intorno a un fulcro. Il “cardine”, Manhattan – non del tutto gerarchicamente sovraordinale – è fulcro dello sviluppo complessivo, della densità umana ed economica e della distribuzione (umana, di attività ed eventi), della macro-struttura fortemente differenziata al proprio interno, che costituisce una città di fluidi equilibri reciproci. Manhattan ha una superficie esigua e, anche se collegata con la foresta dei ponti agli altri quattro distretti con cui fa organico corpo, accoglie un’enorme quantità di fatti, fenomeni, persone, costumi e pratiche che rendono necessaria una risoluzione e un bilanciamento dei contrasti. Non si tratta della Città del Sole né del Migliore dei Mondi possibili (è, infatti, brutale, incoerente, sperequativa). Ed è, comunque, uno spazio votato e vocato al metamorfico Capitale, “primo cittadino” di una città che è patria di un enorme numero di “stranieri”. Le necessità di questo primo cittadino mettono le persone (i soggetti sociali ed economici) nella condizione di dover – creativamente – trovare un ordine nel molteplice e “inventare” una coesistenza non solo civile, ma tendenzialmente produttiva, che scatena una lotta per la sopravvivenza in uno spazio densissimo dove il conflitto incontrollato sarebbe causa di elisione del sistema. La Costituzione, il Capitale trasformista e “immortale”, nella città che fu ed è ancora la grande Porta dell’America del Nord, han fatto sì che i presidi sociali, quelli economici e quelli religiosi o culturali si misurassero senza troppo sangue (con alcune eccezioni), cercando una strada per la rivendicazione e la tutela delle “proprie” minoranze, un equilibrio e una limitazione delle lotte. Le differenti etnie, dunque, con le proprie fedi, tranne rari casi estremi dagli effetti planetari (uno per tutti l’11 settembre), hanno scelto la strada di una coabitazione belligerante, ma non totalmente catastrofica, radice non casuale, insita nella modalità tramite cui la città prese forma, nella metà del XVII secolo. La divisione del sistema di NYC è tutt’altro che quantitativa; i cinque distretti, infatti, contengono qualità fortemente differenziate: i quartieri (non solo a Manhattan), tutt’altro che omogenei, manifestano specificità che sono interdipendenti con le “culture” insediate. Nel tempo tale tessuto umano si è ibridato, e porta ancora le orme delle recenti matrici storiche, che segnavano i luoghi anche con gli edifici per il culto, veri “presidi antropologici”.
Essi – pur soggetti a spinte e pressioni, comprese quelle del mercato immobiliare che ha visto alcune etnie protagoniste (tra esse gli Ebrei, i Musulmani e i Neri) – in certi casi hanno manifestato una stabilità di posizione, simile a quella riscontrabile nei luoghi del potere finanziario: anche in un sistema urbano come Manhattan, soggetto a un continuum di trasformazione, gli edifici del culto mantengono a volte la propria localizzazione strategica fungendo da cardine di un aggregato urbano, dando vita a “filiere” analoghe nel modo, se non nei contenuti, a quelle legate ai processi di produzione, tanto quanto altri assi, aree o edifici, come quelli legati all’economia (Wall Street, la 6th, la 5th, alcune Banche, vari Headquarters, o alcune Insurances).
In tal senso, le chiese tenderebbero, anche nella mercuriale NYC, a essere una persistenza arcaica della “matrice” urbana, dando quindi “forma” a una città variabile e rivestendo in certi casi il ruolo di specifici luoghi pubblici entro cui non prevale l’eterogeneità delle presenze umane, quanto l’omogeneità di fede. E in cui sia inoltre presente una smaterializzazione della funzione spirituale con l’innesto di attività più connesse al sociale o alla spettacolarizzazione, in una commistione tra sacro e profano che a volte abiura il sacro. Cardine del disegno urbano, in certi casi, le chiese marcano connotazioni micro-identitarie che virano verso una sorta di giustapposizione (non un’integrazione reale dei culti) e sono comunque segno della vitalità dei singoli gruppi. Non esistono luoghi dove si pratichino più fedi. A parte il tentativo abortito, prima citato, di Còrdoba House. Al di là dei deboli risultati legati all’integrazione tra i monoteismi, la maggiore auto-organizzazione interna dei “gruppi” è uno tra gli elementi di resistenza a un governo autoritario, proprio dei regimi assoluti. E in tal senso è possibile avanzare l’ipotesi che anche i poli di culto siano stati e siano matrice della Community-Based Planning newyorchese.
In tale sorta di contro-altare al “monoteismo” fideistico hitleriano, una qualità emergente è l’ambiguità (nella struttura urbana) attribuendo a essa un’accezione positiva se, come nel linguaggio, libera livelli complessi di significato. Se l’architettura “pesante” del mostro bicefalo Hitler/Speer tende a eliminare l’ambiguità, intesa come ricchezza di senso, la trasformazione urbana “leggera” che nasce dall’incontro o dal conflitto, entro cui le forze (laiche o religiose) confluiscono, o si misurano, dà vita a un sistema elastico e polisemico. Gli oggetti urbani (le pratiche, gli eventi) hanno valore assertivo, come pure, parafrasando Barthes, valore emozionale, comunitario, di radicamento concreto, sociale e simbolico. Sono elementi di figurazione (come autori tra cui Mumford, Mondada, Choav, Lynch, hanno ampiamente dimostrato) e di ruolo. Gli “oggetti” urbani specifici (legati al culto) come li stiamo assumendo, influenzano e modificano la struttura, interferiscono e agiscono sulla vita quotidiana delle persone. Sono generatori di “confine” e/o di “porosità” e di “confluenza”: commistioni e coesistenza tra fedi differenti, eventi chiave [29], antitesi e invalicabilità di alcuni culti che diventano strumenti di conferma d’identità, e che tendono, anche in un ambito urbano ibrido, come NYC, a determinare aree compatte (o poco porose, come Chinatown) geograficamente e socialmente. Tale fenomeno fornisce un senso diverso alla dispersione e ai fenomeni di crescita e di esplosione urbana, dando vita a un tessuto dall’equilibrio differenziato in cui le micro-comunità agiscono sulle pratiche urbane di governo partecipativo e di auto-organizzazione.
Se i sistemi urbani sono caratterizzati da un mutamento continuo, e sono costituiti dall’intersezione tra pieni e vuoti, da dicotomie e duplicità, se i sistemi urbani dialogano con il concetto di confine (sia inteso in metafora, che concretamente), è ovvio che la ricaduta materiale non avvenga in forma pura. In tal senso è possibile affermare che il sacro sia presente in forma tutt’altro che smaterializzata, assumendo un “corpo” che è espressione di un potere secolare, veicolo di autorità, conflittualità, controllo sociale (sui gruppi ma anche sulle categorie umane e sociali) e, nel contempo, è potenziale di integrazione. Tanto quanto il potere politico è contemporaneamente vettore di elementi simbolici e immateriali, fortemente contraddittori, come la partecipazione democratica al governo della città e la possibile integrazione da un lato, opposta alla lotta e alla supremazia di gruppi o élite o al totalitarismo, dall’altro.
Le teorie sulla cultura urbana si sono interrogate, in termini teorici ed empirici, sul valore di una piazza, di una strada, di un giardino pubblico, di un Municipio, di una fabbrica, di spazi per così dire de-sacralizzati o laici, e sul senso dello spazio sacro, chiedendosi cosa sia un tempio, un percorso che abbia a che fare col divino o un “calvario”, dimostrando come tali forme differenti di declinazione del sacro, siano segni “altri” di appropriazione e di residenza, di trasformazione e d’identità, tra le matrici prime di ogni città, di ogni Heimat – oltre il concetto di appartenenza nazionale. E mostrando come i processi di costruzione del milieu culturale e dell’”ambiente”, siano sovrastrutturali persino a quelli dei macrosistemi territoriali, come una Nazione o un’aggregazione di Stati.
Si è, e prima di tutto, cittadini di una città. Anche se in potenziale transito, la città, resta il luogo dove si esprime l’appartenenza a una cultura, a un gruppo, a se stessi, dove le matrici culturali ricadono e si trasformano in spazio abitato, dove le differenti culture si integrano e confliggono, in diretta relazione. Lo spazio urbano è uno spazio concreto, dove i comportamenti sono visibili e dove persino il sacro prende forma, perché le “cose” a volte sono mezzi. Il progetto e l’intenzione danno a esse, nella città, quella carica di sacralità che trascende ogni religione o le comprende tutte. Un tramite con cui le persone possano scansare la morte, il conflitto senza risoluzione, la contrapposizione e possano, invece, abitare il rito collettivo del quotidiano, in cui sacro e profano si fondono, trascendendo i meri aspetti della fede e mostrando come la sinergia tra la sfera religiosa e le politiche d’integrazione possa condurre verso una identità plurale, intersoggettiva, interreligiosa, densa di dialogo democratico e comunicazione.
Dialoghi Mediterranei, n.22, novembre 2016
Note
[1] Edifici/spazi-luoghi. Descrivere in tal modo il sistema urbano, per segmenti funzionali (secondo una matrice che muove da Max Sorre) e partire dall’edificio è strumentale per comprenderne il ruolo, singolare e sistemico, all’interno dei sistemi urbani. Gli edifici considerati sono quelli di culto, visti in termini percettivi, simbolici, sociali, economici. In tale contesto ci si riferisce al termine spazio, che ha un’accezione geometrica, e al termine luogo, che ha un’accezione più esperienziale.
[2] Per esempio, gli Edifici Istituzionali.
[3] Una questione gigantesca che ha particolare rilevanza anche in considerazione dell’amore di Pasolini per NYC. In contraddizione apparente con il lavoro pasoliniano sul sacro in rapporto al Capitale e al potere secolare della Chiesa, oggetto di critica. Auspicando che la Chiesa stessa passasse «all’opposizione contro un potere che l’ha così cinicamente abbandonata, progettando, senza tante storie, di ridurla a puro folclore», Pasolini metteva in evidenza il contrasto tra la deriva del potere economico e il Sacro (es. in Scritti Corsari, del 1975).
[4] Per la densità della presenza umana e per l’enorme mole di migrazioni che s’intensificò nel XIX secolo, Manhattan e Brooklyn, soprattutto, si configurarono in una struttura complessa, eterogenea, fatta di quartieri limitati, spesso, da Avenue o Streets che, per ragioni variabili, agivano come confine; sebbene fossero limiti mobili o fittizi, tali bordi definivano delle “unità” sociali o economiche. I “quartieri” accoglievano le comunità insediate ed erano, spesso, diversamente caratterizzati dal punto di vista della produzione, ospitando specifici comparti, a Brooklyn più dichiaratamente industriali, a Manhattan più legati allo stoccaggio o a produzioni “soft” (come per esempio l’abbigliamento, in Garment District). La struttura urbana di Manhattan, in tal senso, è molteplice e può essere meglio compresa anche tramite alcune categorie “geografiche” come quelle di Downtown, Midtown, Uptown. Esse al proprio interno presentano altre sub divisioni, Est Side e West Side, per esempio. La loro comparsa è connessa a enormi fattori, alcuni geografici, altri storici, come la struttura allungata dell’Isola, che ha al proprio centro Central Park. Questo, dalla metà del XIX secolo, favorì la differenziazione urbana complessiva. Oltre a tale macro suddivisione per ampi settori urbani, vanno considerati i quartieri, tra essi Harlem, Meatpacking, Chinatown, SoHo, Lower East Side, TriBeCa. Oltre a tali aree esistono alcuni quartieri residenziali definiti già nel XIX secolo, e abbastanza omogenei al proprio interno, come Yorkville in Upper East Side. Limitato dall’East River, dalla 3rd Avenue e dalla 79th St. a sud e dalla 96th St. a nord (la 96th è un asse importante per sezione e ruolo e pertanto funge da bordo), il quartiere accolse una vasta compagine d’immigrati polacchi, irlandesi, soprattutto tedeschi. Negli anni ’30 il quartiere era la base del Fritz Kuhn Julius German American Bund, un gruppo filonazista che, tra l’altro, causò proteste tra gli altri residenti e un allontanamento da parte delle famiglie ebraiche, che si spostarono in West Side (in una sezione opposta e separata da Yorkville da Central Park). Le migrazioni interne erano dovute a moltissimi fattori, per esempio, la presenza tedesca a Yorkville è attribuibile anche a un disastro accaduto il 15 giugno del 1904, quando bruciò una nave a vapore, la General Slocum nelle acque dell’East River, proprio all’altezza del quartiere. La nave era stata noleggiata per portare i membri della Chiesa luterana evangelica di S. Marco a partecipare a un picnic organizzato dalla stessa chiesa. Si stima che delle 1.342 persone a bordo 1.021 perirono. Il disastro della General Slocum fu il peggiore accaduto, in termini di perdita di vite umane a NYC fino all’11 settembre. Gli immigrati tedeschi, molti dei quali vivevano in Lower Manhattan, si trasferirono a Yorkville per essere più vicini al luogo dell’incidente.
[5] I templi non sono gli unici edifici per il culto, ne esistono molti altri, qui non esaminati, perché la riflessione condotta riguarda soprattutto la città, quale luogo di espressione massima dei conflitti. Tra questi luoghi, per esempio, i Monasteri che hanno segnato interi territori extraurbani. E che andrebbero studiati con attenzione in quanto latori di valori, sia formali, sia sociali che funzionali (organizzazione interna, spesso a basso impatto ambientale ante litteram; multifunzionalità; aspetti connessi alla commercializzazione; tutela del territorio; bellezza).
[6] La citazione è riferita a una religione monoteista nata in Iran, nel XIX secolo. La fede sottolinea l’unità spirituale, in base a tre principi: l’unità di Dio, l’unità della religione, l’unità dell’umanità. Il principio fondamentale è che la rivelazione religiosa non sia assoluta, ma relativa e progressiva. La pratica di tale fede ha dato vita alla costruzione di numerosi templi aperti a tutti indipendentemente dal credo professato e senza distinzione di sesso, etnia o nazionalità. I templi, nei quali sono vietati sermoni o prediche di qualsiasi natura o fede, sono riservati alla preghiera, alla meditazione e alla lettura di testi sacri anche di altre fedi. I tempi si trovano nelle città di Aşgabat, Wilmette, Kampala, Sydney, Francoforte, Panamá, Tiapapata, Santiago, Haifa, Nuova Delhi (Il Tempio del loto).
[7] Sarebbe interessante approfondire l’argomento con un saggio dedicato al rapporto tra edifici per il culto e sistema urbano, scoprendo come il linguaggio e la forma dell’architettura influenzi la struttura della città, e viceversa, e come le teorie filosofiche (es. il Neoplatonismo) abbiano avuto un peso sulle strutture “fisiche” e come esse influiscano sulla percezione del paesaggio urbano e territoriale (Santa Maria del Fiore a Firenze; le due chiese a Piazza del Popolo a Roma). Spesso nei libri di storia dell’architettura gli autori si concentrano sull’edificio, tralasciando il tema dell’interazione tra pieni e vuoti, o meglio tra edificio e città. Non tutti gli architetti e i teorici hanno interpretato i luoghi secondo tale modalità, a mio parere debole. Giancarlo De Carlo, ad esempio in un bellissimo libro del 1995, Nelle città del mondo, legge e descrive le relazioni e i sistemi, ponendo gli edifici in uno spazio che ricusa la visione a volte castrante della geometria e sceglie l’attraversamento, per esempio raccontando il sacro del Tempio di Apollo a Bassae odi Santa Maria della Scala a Siena.
[8] Nel 1789 fu inaugurata St. Paul Church, un altro polo urbano, sempre sullo stesso fronte di Broadway, ma più a nord.
[9] Il Whig Party era un partito politico attivo nella metà del XIX secolo in America. Vi appartennero quattro presidenti. Insieme al partito rivale, quello Democratico, fu al centro del sistema politico, dal 1833 quando fu fondato, al 1854, data di scioglimento. Il partito era stato fondato in Inghilterra nel 1678 dove fu sciolto nel 1859.
[10] Il Muro occidentale, unico resto del Tempio di Gerusalemme, fu costruito nel X sec. a.C., riedificato da Erode nel IX a.C. e distrutto nel 70 d.C. dai Romani. Il Muro è il luogo più sacro per l’ebraismo; dopo la guerra del 1967, quando Gerusalemme fu posta sotto la sovranità israeliana, davanti al sito è stato realizzato un ampio spazio aperto, sede di raduni e manifestazioni religiose.
[11] In area più perimetrale, rispetto al sistema urbano storico, non è una esattamente una moschea, infatti non è provvista né di un mihrāb né di un minbar. È un santuario sorto per celebrare il mancato sacrificio del figlio da parte di Ibrahim, a riprova della totale ubbidienza del Patriarca alla disposizione divina.
[12] Un volume scritto tra il 1928 e il 1930, ristampato in The Synagogue: Studies in Origins, Archaeology, and Architecture, Joseph Gutmann, New York, Ktav, 1975.
[13] In una città come NYC o in altre città dove la componente multietnica è rilevante, si assiste oggi più che mai a una moltiplicazione e a una “polverizzazione” dei luoghi di culto che, spesso, per carenza di suolo o per ragioni economiche vengono allocati in spazi interstiziali o di risulta. Ovviamente in tal modo la funzione monumentale delle chiese viene meno. E cambia il senso dei markers territoriali, che sono percepiti diversamente. Nella città storica l’edificio di culto era concepito come un monumento e come tale era riconosciuto, anche in virtù della grandissima dimensione, dello sfarzo, dell’impatto formale sul sistema urbano e dell’esistenza di spazi aperti spesso associati agli edifici di culto e a quelli istituzionali.
[14] Temine equivalente al tedesco Städtlein “piccola città”, viene utilizzato per definire gli insediamenti con un’elevata percentuale di popolazione di religione ebraica.
[15] Festa dell’indipendenza israeliana, festeggiata il 5 di Iyar (VIII mese del calendario ebraico), giorno della proclamazione dello Stato di Israele nell’anno ebraico 5708, corrispondente al 14 maggio 1948.
[16] Il ruolo degli Ebrei a NYC non è affatto marginale. Per l‘impatto quantitativo (a NYC vi è la comunità più estesa a livello mondiale) e per la componente qualitativa sul sistema urbano e sociale, nel tempo. Nel mio volume in preparazione e tra breve in stampa, sullo sviluppo urbano di New York, l’argomento è affrontato in modo approfondito, in un capitolo a esso dedicato. Un riferimento bibliografico interessante e reperibile on line è la JewishEncyclopedia.com, specificamente la voce: “New York”, che restituisce in una prospettiva orientata – potrei dire attraverso un “Jewish gaze” – lo sviluppo della città in relazione alla presenza sociale, economica, culturale, religiosa della Comunità ebraica.
[17] Satmar è la città (originariamente in Romania, ora Ungheria) da cui molti dei primi membri della comunità fuggirono a seguito delle persecuzioni dell’Olocausto.
[18] Vedi nota 4.
[19] Tra la Madison Ave, la 5th Ave, tra la 66th e la 65th Street, prossimo al JewishMuseum, sempre sulla 5th tra la 92nd e la 93rd Street.
[20] Anche la storia dell’espansione delle Chiese Battiste a NYC è connessa alle attività di sostegno alla popolazione nera, soprattutto prima dell’azione determinante di Martin Luther King e delle lotte degli anni ’60. Con azioni continue, per esempio nel 1864 quando i profitti per la vendita di una proprietà in Downtown furono usati per iniziative a sostegno della comunità nera presente al Greenwich Village, che in quel momento era un “African-American hub”. Andrebbero citate alcune figure rappresentative, come il reverendo Adam Clayton Powell Sr. (1865-1953) che, nei primi del Novecento, dedicò la sua azione pastorale allo sviluppo spirituale e alla riorganizzazione della chiesa, promuovendo l’idea di una chiesa modello a Harlem che rispondesse ai bisogni religiosi e sociali degli afro-americani che, in quella fase dovevano affrontare, e più di adesso, razzismo e sperequazione e i pesantissimi retaggi dello schiavismo. Il suo “social gospel” integrava attivismo sociale con una leadership spirituale che pose la chiesa al servizio alla comunità. Numerosi i risultati che servirono da apripista alle azioni successive, a partire da quella fase, uno è legato all’edificazione di una chiesa Battista, con annessa una “Community House”, tra la 138th Street, la Lenox Ave (nota anche come Malcolm X Boulevard) e la 7th Ave. Altra figura di riferimento è il reverendo Adam Clayton Powell Jr. che fu (nel 1941) il primo afro-americano eletto nel New York City Council. Eletto al Congresso degli States, con azione determinante, elaborò e modificò quasi 60 leggi pubbliche a beneficio di neri, anziani, portatori di handicap, ispanici-americani, donne, e bianchi poveri in relazione alle sperequazioni sul lavoro, all’istruzione pubblica e allo sviluppo e alla formazione della manodopera, alla discriminazione nei confronti delle donne, all’aumento del salario minimo, e alla guerra alla povertà. Agì anche sull’attività della Congregazione sia in termini sociali, sia politici, quale parte vitale della “Black Revolution”. È evidente che in quella fase le chiese battiste si ponevano come “centri” nevralgici della resistenza e dell’azione della comunità dei neri. Negli anni recenti, invece, si è assistito alla spettacolarizzazione delle celebrazioni che attualmente (con le messe Gospel) sono tra le maggiori attrazioni turistiche della città.
[21] Un incarico, non portato avanti, per il completamento della chiesa, fu affidato a Calatrava. Egli, oltre ad aver progettato il World Trade Center Transportation Hub, a ridosso di Ground Zero, ha recentemente redatto il progetto per la ricostruzione di una chiesa ortodossa distrutta a causa del crollo della Torre Sud del WTC durante gli attacchi dell’11 Settembre, la Saint Nicholas Greek Orthodox Church, oggi a Est del nuovo Liberty Park, appena all’esterno di esso. Il sito originale si trovava al 155 di Cedar Street, di fronte a Liberty Street. L’edificio fu costruito nel 1832 come dimora privata, nel 1916 i greci-ortodossi presenti a New York si riunirono in una comunità religiosa e nel 1919 acquistarono l’edificio che sistemarono creando la loro prima chiesa nella città.
[22] Dietrich Bonhoeffer (Breslavia, 1906-Flossenbürg, 1945) è stato un teologo luterano tedesco, protagonista della resistenza al Nazismo.
[23] La vicenda di Park 51 a NYC, presenta alcune analogie con un progetto recente (2007-2012) anch’esso non realizzato, a Londra, che prevedeva la costruzione di un’enorme moschea, che estendesse l’Abbey Mills Mosque, nota anche come London Markaz or Masjid-e-llyas. Il nuovo progetto sarebbe stato in grado di ospitare fino a 70mila persone. Sita nei pressi del London 2012 Olympic Park, avrebbe dovuto essere costruita per iniziativa di Tablighi Jamaat, un movimento fondato nel 1927 con lo scopo di diffondere la fede e fare proselitismo lontano da qualunque affiliazione politica. Il progetto londinese suscitò grandi polemiche, inizialmente connesse ai rischi di contaminazione chimica associati alla scelta del sito. Ma sostanzialmente fu avversato per ragioni legate alla provenienza dei finanziamenti, ai presunti collegamenti dell’associazione Tablighi Jamaat con il terrorismo e con l’estremismo islamico. Anche il New York Times contribuì a tale campagna, affermando che l’FBI aveva trovato informazioni sul ruolo dell’Associazione nel reclutamento di persone, da parte di Al-Queda. Ken Livingstone, sindaco della città in quella fase, protestò vivacemente contro la campagna particolarmente feroce, che avversava il progetto.
[24] Il documentario segue un anno nella vita di Sharif El-Gamal, l’imprenditore immobiliare coprotagonista della vicenda. Il regista restituisce, con accesso illimitato alla casa e all’ufficio di Sharif, il ritratto dell’uomo d’affari americano, fervente musulmano, nato a Brooklyn. Questi porta avanti il progetto di Park 51 quale focus di un’identità individuale sia propria che collettiva, in special modo dopo l’11 Settembre. Sharif rappresenta, secondo la visione del regista, un Islam culturalmente estraneo alla maggior parte degli americani, reputata di enorme importanza, soprattutto in considerazione della polemica nata intorno al progetto di Park 51 e alla giustificata onda emotiva post attentato. Migliaia di americani, infatti, manifestarono contro l’edificazione di tale struttura, in prossimità di Ground Zero. Park 51 fu un simbolo discusso a livello internazionale relativo al rapporto tra l’Islam e il mondo occidentale, e il documentario ne segue lo sviluppo anche attraverso le esperienze quotidiane e le lotte degli uomini e delle donne che cercano di renderlo una realtà. Intervista all’autore: https://www.youtube.com/watch?v=awwsYSyv8K0; Il trailer: https://vimeo.com/37625798.
[25] Nel settembre del 2015 si svolse un incontro interreligioso al Ground Zero Memorial, al quale parteciparono il cardinale Timothy M. Dolan, il Rabbino, l’Imam Khalid Latif e Papa Francesco, che pronunciò un discorso, dopo la lettura di 5 meditazioni sulla pace (indù, buddista, sikh, cristiana, musulmana) e della preghiera ebraica per i defunti, mirato all’incontro pacifico tra le differenti fedi: «Nell’incontro ho potuto constatare ancora una volta come la distruzione non è mai impersonale, astratta o solo di cose; ma che soprattutto ha un volto e una storia, è concreta, possiede dei nomi. (…) Mi riempie di speranza, in questo luogo di dolore e di ricordo, l’opportunità di associarmi ai leader che rappresentano le molte religioni che arricchiscono la vita di questa città. Spero che la nostra presenza qui sia un segno potente delle nostre volontà di condividere e riaffermare il desiderio di essere forze di riconciliazione, forze di pace e giustizia in questa comunità e in ogni parte del mondo. Nelle differenze, nelle discrepanze è possibile vivere in un mondo di pace. Davanti ad ogni tentativo di rendere uniformi è possibile e necessario riunirci dalle diverse lingue, culture, religioni e dare voce a tutto ciò che vuole impedirlo. Insieme oggi siamo invitati a dire: “no” ad ogni tentativo uniformante e “sì” ad una differenza accettata e riconciliata».
[26] Durante l’annuale cena alla Casa Bianca per il Ramadan, Obama affermò (con chiaro riferimento all’art. 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo): «Let me be clear: as a citizen and as President I believe that Muslims have the same right to practise their religionase very one else in this country. That includes the right to build a place of worship and a community centre on private property in Lower Manhattan, in accordance with locallaws and ordinances. This is America, and our commitment to religious freedom must be unshakable» («Lasciate che io sia chiaro: come cittadino e come Presidente credo che i musulmani abbiano il medesimo diritto di praticare la loro religione come chiunque altro in questo Paese. Ciò contempla il diritto di costruire un luogo di culto e un Centro Comunitario in una proprietà privata a Lower Manhattan, nel rispetto delle leggi e delle ordinanze locali. Questa è l’America, e il nostro impegno per la libertà religiosa deve essere incrollabile»).
[27] L’imprenditore egiziano, che in fase successiva alla redazione del progetto acquistò altri tre lotti su ParkPlace, promosse il progetto del grattacielo di lusso anche in virtù delle dinamiche del mercato e, nel contempo, consapevole di quanto la costruzione dell’edificio potesse innescare un feedback positivo nel medesimo mercato in netto rialzo, malgrado i costi proibitivi degli appartamenti e dei lotti, nell’area: un attico nel vicinissimo Woolworth Building, ad es., viene attualmente valutato intorno a 110 mln di dollari.
[28] A. Snodgrass, Architettura, Tempo, Eternità, Bruno Mondadori, Parma, 2004.
[29] L’11 settembre ha rappresentato una frattura a livello planetario e locale. Ha generato un cambiamento macroscopico e non solo legato alla costruzione di Freedom Tower (niente affatto amata da molti tra i cittadini newyorchesi), i cui effetti moltiplicatori si leggeranno meglio tra qualche anno. Oltre alla modificazione del paesaggio urbano, l’11 Settembre ha cambiato il paesaggio sociale e la condizione dei musulmani a NYC e non solo in quella città. Ciò ha determinato, nel microspazio urbano, quanto nella percezione sociale della cultura e della fede islamica, forti modificazioni che rendono condivisione e incontri interreligiosi, estremamente più complessi.
________________________________________________________________________________
Flavia Schiavo, docente di Fondamenti di urbanistica e della Pianificazione territoriale presso l’Università di Palermo, ha pubblicato saggi, monografie e articoli su riviste nazionali e internazionali. Conduce attività didattica e di ricerca in Italia, Europa e America del Nord, dove è stata visiting presso la Columbia University. Tra le sue pubblicazioni, Parigi, Barcellona, Firenze: forma e racconto (Sellerio 2004); Tutti i nomi di Barcellona. Il linguaggio urbanistico (F. Angeli 2005).
______________________________________________________________________________



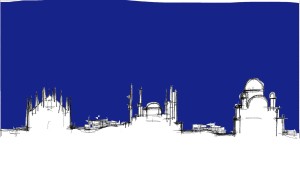
















It’s awesome to visit this web site and reading the views of all colleagues about
this piece of writing, while I am also eager of getting knowledge.