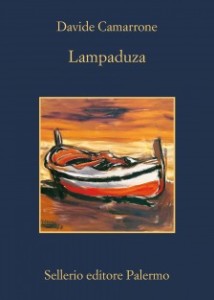Nel trionfo della globalizzazione contemporanea abbiamo assistito al processo di delocalizzazione e di indistinzione dei luoghi, di messa in crisi delle relazioni tra territorio e sovranità statale, di scompaginamento delle coordinate geografiche e delle categorie tradizionali di centro e periferia. Tuttavia a questo generale movimento di destrutturazione e decostruzione che ci fa abitare in un mondo che somiglia sempre più ad una città globale, una città-mondo, si è contestualmente accompagnata una riproduzione, riarticolazione e moltiplicazione di frontiere e confini, che si spostano e si rimodulano ma non collassano né si dissolvono.
Pur distinguibili solo sul piano analitico, in intellectu e non in obiecto, i confini separano gli spazi con una linea, un muro, una barriera che divide ed esclude; la frontiera, invece, crea uno spazio nuovo, una soglia mobile, una area in cui sono possibili l’interazione, la negoziazione e l’inclusione. Il confine è costruito per delimitare e segnare i limiti di un territorio, i cippi delle appartenenze. La frontiera esiste per essere attraversata, varcata, scavalcata. In astratto i confini sono rigidi, solidi e refrattari, le frontiere sono porose, duttili e perfino liquide. Confini e frontiere, siano essi materiali o simbolici, geopolitici o antropologici, sono comunque orizzonti incrociati: costitutivamente convivono, più spesso collidono, dialetticamente si intersecano, si compenetrano vicendevolmente, si sfidano in un corpo a corpo, in una tensione continua e dinamica tra spinte e traiettorie contrapposte, tra il disgiungere e il connettere, tra il discriminare e l’integrare, tra l’isolare e l’ibridare.
Su questa faglia che descrive un crinale incerto e ambiguo sembra prodursi e dispiegarsi un luogo cruciale del nostro tempo, una vera fabrica mundi, per usare la felice espressione rinascimentale di Sandro Mezzadra. Qui si consuma la violenza del potere ma anche la resistenza al potere, la capacità creativa di tradurre regole, diritti, sovranità, l’adozione di prospettive che tracimano il modello euclideo dello spazio e la dimensione dicotomica dell’organizzazione sociale e mentale. Nulla è più artificiale di un confine e nulla è più mobile della frontiera, dal momento che non siamo noi ad attraversarli ma – a guardar bene – sono loro che ci attraversano, essendo non soltanto sugli atlanti ma anche dentro le nostre stesse vite, nelle mappe che elaboriamo per orientarci e riconoscerci, paradigmi dell’oltranza, metafore dell’orizzonte che si sposta insieme a chi lo guarda.
Contrariamente a quanto si possa pensare, nei paesaggi contemporanei della globalizzazione lo spazio rimodellato e ripensato su scale di grandezza e latitudini cognitive profondamente diverse rispetto al passato continua a contare moltissimo, ad avere un valore ponderale determinante nell’equilibrio politico ed economico del potere e nella divisione internazionale del lavoro. Le stesse migrazioni, assimilabili per la loro dimensione transnazionale a una sorta di “deriva dei continenti” tale da investire alle radici confini e frontiere, hanno la potenza epifanica di disvelare le dinamiche complesse tra sociale e spaziale, tra locale e globale. In questo contesto geografico che eccede le storiche partizioni di Oriente e Occidente, il Mediterraneo è tornato ad essere epicentro gravitazionale dei sommovimenti planetari, crocevia dove tutto confluisce, si complica e si dipana, laboratorio a partire dal quale è possibile tentare di capire il presente e di immaginare il futuro.
Del Mediterraneo Lampedusa è qualcosa di più di un’isola, di un piccolo frammento di terra in mezzo al mare, ai margini di più continenti. È qualcosa di più di un luogo reale, di un atollo più vicino all’Africa che all’Europa, una meta turistica per bellezze naturali e insieme fata morgana per disperati migranti, un porto che è oggi una porta ma anche un avamposto militare, un mitico approdo che può trasformarsi in un severo centro di detenzione e di smistamento, un ponte che salva e accoglie ma anche una prigione che controlla e rinchiude. Un luogo per eccellenza ibrido, dunque, una realtà liminare, uno spazio simbolico e cruciale del nostro tempo, delle contraddizioni e virtualità della nostra contemporaneità.
La piccola isola frontiera del Mediterraneo è di questo universo icona esemplare, dal momento che qui convivono, senza conoscersi e senza riconoscersi, senza neppure guardarsi in faccia, il “turista” e il “vagabondo”, quelle due figure che Zygmunt Bauman considera «metafore della vita postmoderna». L’opposizione tra queste due immagini fisiche, l’una alter ego dell’altra, nel segno del viaggio da un lato e della fuga dall’altro, identifica la cifra antropologica più significativa dei percorsi umani che attraversano e segnano la società contemporanea. Turisti e migranti, le cui storie dissimili e pur complementari si sovrappongono senza intrecciarsi, contribuiscono in modi e forme diverse a rompere l’isolamento dell’isola, l’equilibrio della vita quotidiana, la routine del tempo ordinario. Da una parte l’esotico connesso alla dimensione delle vacanze e dall’altro il drammatico evocato dagli sbarchi più o meno rocamboleschi si approssimano e si sfiorano: irrompono nella cronaca locale, fanno di Lampedusa e della sua comunità lo scenario di un teatro mediatico, il palcoscenico di una rappresentazione eminentemente simbolica, che sembra voler celebrare nello stesso luogo, paradossalmente al centro della marginalità geografica, la bellezza folgorante della Natura e la forza cogente della Storia.
Qui il confine e la frontiera sono spettacolarizzati, magnificati, solennizzati. In bilico sul mare – che è ancora ma sempre meno lo spazio dei pescatori locali e sempre più quello degli stranieri, siano essi i turisti bagnanti o i migranti sopravvissuti – si giocano le identità e i destini di soggetti diversi, di individui e comunità, di stati nazionali e perfino di entità sovranazionali. Nella liminarità del loro essere isolani i lampedusani coltivano una qualche ambivalenza rispetto al sentimento di appartenenza alla nazione italiana, una storica tendenza ad adattarsi alle diverse influenze culturali, per effetto delle molteplici presenze di popolamento, essendo stata l’isola a lungo colonia dei domiciliati coatti provenienti da tutta la penisola. Da qui lo specifico della lingua parlata dagli abitanti. Ma anche lo spirito di solidarietà, di tolleranza e di apertura all’alterità che il respiro del mare incoraggia e seconda. Nella storia del santuario della Madonna di Porto Salvo, che accoglieva senza distinzioni i musulmani e i cristiani in transito nelle acque del Mediterraneo, si raccoglie la vicenda di un’isola e di una comunità costitutivamente permeabile alle varietà religiose e versata al dialogo interetnico.
Lampedusa – ha dimostrato con ampie argomentazioni Chiara Brambilla nell’ultimo numero di Dialoghi Mediterranei (n.8, luglio 2014) – è «un esempio di borderscape euro/africano tra i più significativi, per diverse ragioni climatiche, geologiche, geografiche, ma anche storiche e socio-culturali». In questo senso, è il laboratorio di osservazione più interessante per capire quanto questo piccolo lembo di terra sia confine e quanto sia frontiera, in che misura esclude e in quali forme include, quanto sia finis terrae e quanto soglia e passaggio verso altre terre. Vi convergono due opposte strategie, l’una militare e l’altra umanitaria, cui corrispondono le retoriche contraddittorie intorno al controllo dei corpi dei migranti dopo l’opera di salvataggio in mare. Caduta la barbarie dei respingimenti, attuati a seguito degli sciagurati accordi con Gheddafi, non si sono affatto sciolte le anomale dicotomie della governance del fenomeno. Se le pratiche dei soccorsi ad opera della Marina Militare sono visibilmente ostentate, i dispositivi di sicurezza e di segregazione all’interno dei centri di accoglienza sono occultati e interdetti allo sguardo dell’opinione pubblica. Si mette in scena, fino ai limiti della saturazione mediatica, lo spettacolo della “invasione” e della eclatante e solidale azione di recupero dei naufraghi, si reitera costantemente in una ossessiva contabilità il numero degli arrivi, si ricorre ad un ampio lessico di guerra, disseminato di ondate, battaglie, assedi e assalti, mentre si tiene nel più rigoroso segreto l’apparato d’ordine pubblico che identifica, seleziona, smista, arresta e sospende le vite nude di quei corpi estenuati e protesi ai fili spinati dei confini.
Relativamente all’immagine pubblica di Lampedusa politicamente costruita sulla narrazione enfatica dell’emergenza-sbarchi rinviamo alla lettura dell’articolo di Antonella Elisa Castronovo nel n. 7 (maggio) di Dialoghi Mediterranei. Su quel che più concretamente accade nelle dinamiche sociali e culturali dell’isola e nella vita quotidiana dei suoi abitanti getta luce il recente volume di Davide Camarrone, Lampaduza (Sellerio 2014): un racconto che ha gli accenti taglienti di un’inchiesta, un documento che possiede il ritmo narrativo della migliore letteratura. L’isola, «dal nome sghembo, scivoloso come un pesce di fondale» – così la chiamavano gli arabi in passato, così la chiamano oggi i migranti – si offre come luogo privilegiato per leggere lo stato di salute del nostro Paese, dal momento che «è dai confini, così come dalle prigioni, che si giudica uno Stato». L’immigrazione straniera, del resto, è per se stessa un formidabile test della tenuta democratica delle nostre comunità, cartina di tornasole dei punti di forza e di debolezza dei nostri sistemi di convivenza. Per questo, quando ci interroghiamo sugli immigrati, in realtà ci interroghiamo sulla nostra società e su noi stessi, poiché la loro stessa presenza ci costringe a ragionare sui nostri modi di vivere e di pensare, sul senso di ciò che facciamo, dei gesti che compiamo, delle parole che diciamo, delle identità che agitiamo o rivendichiamo. Ecco perché quando parliamo di loro, parliamo in verità di noi stessi. Quando gli abitanti dell’estrema periferia dell’Italia parlano dei profughi, «quattro volte scampati: al loro paese, al deserto, ai predoni, al mare», parlano in realtà di se stessi, delle loro paure, delle loro sofferenze, delle loro rabbie, delle loro speranze.
 Camarrone descrive di Lampedusa gli effetti perversi dell’abusivismo e di una crescita urbana sregolata e sgraziata: «una volta era verde e boscosa come l’Irlanda, ora è brulla e polverosa»; denuncia il degrado morale di certa classe politica locale, colpevole dei guasti prodotti dall’abbandono della pesca e dalla fine delle illusioni affidate al turismo selvaggio, «dall’improvvisa smobilitazione di un sogno di ricchezza, dal risveglio da un’ubriacatura di benessere». L’irruzione degli sbarchi coincide con la fase più acuta della crisi economica, ne accentua i costi e ne travolge e stravolge i processi. L’associazione dell’immagine dell’isola alla presenza dei migranti ha senza dubbio generato una sovraesposizione mediatica che sollecita i nervi scoperti della collettività e ne fa implodere contraddizioni e ambivalenze interne. Se serve per dare visibilità ai disagi dell’isolamento (difficoltà nei collegamenti, elevati costi dell’acqua, problemi nell’assistenza sanitaria e nella funzionalità dei servizi), si protesta contro ma anche con gli immigrati, si piega la volontà dei giornalisti all’esigenza di dare voce agli altri problemi locali.
Camarrone descrive di Lampedusa gli effetti perversi dell’abusivismo e di una crescita urbana sregolata e sgraziata: «una volta era verde e boscosa come l’Irlanda, ora è brulla e polverosa»; denuncia il degrado morale di certa classe politica locale, colpevole dei guasti prodotti dall’abbandono della pesca e dalla fine delle illusioni affidate al turismo selvaggio, «dall’improvvisa smobilitazione di un sogno di ricchezza, dal risveglio da un’ubriacatura di benessere». L’irruzione degli sbarchi coincide con la fase più acuta della crisi economica, ne accentua i costi e ne travolge e stravolge i processi. L’associazione dell’immagine dell’isola alla presenza dei migranti ha senza dubbio generato una sovraesposizione mediatica che sollecita i nervi scoperti della collettività e ne fa implodere contraddizioni e ambivalenze interne. Se serve per dare visibilità ai disagi dell’isolamento (difficoltà nei collegamenti, elevati costi dell’acqua, problemi nell’assistenza sanitaria e nella funzionalità dei servizi), si protesta contro ma anche con gli immigrati, si piega la volontà dei giornalisti all’esigenza di dare voce agli altri problemi locali.
Su questo scenario in cui si muovono soggetti diversi: dagli operatori umanitari alle forze dell’ordine, dagli attivisti politici ai rappresentanti della stampa, dai turisti infine agli stessi abitanti, Lampedusa è crocevia di naufragi e salvataggi, di accoglienza e di espulsione, di vita e di morte. Tre sono essenzialmente i luoghi attorno a cui gravitano le cronache degli eventi quotidiani: il porto, il Centro di permanenza temporanea e il cimitero. Nella banchina del porto giacciono accatastate le carcasse delle carrette del mare utilizzate dai migranti per raggiungere le coste, gli unici segni visibili e permanenti dei loro sbarchi, dichiarati inamovibili perché corpi di reato. Nel CPT, la cui gestione alimenta un enorme e assurdo flusso di finanziamenti, un giro d’affari scandaloso, «una grande truffa all’italiana» – scrive Camarrone – sono trattenuti i sopravvissuti dai naufragi, salvati dal precipizio degli abissi, sospesi da ogni diritto e improvvisamente sprofondati nel vuoto di un non-luogo e di un non-tempo. E infine di una non-vita, destinati a restare impigliati nelle trame di un’attesa non diversa da quella immaginata nella Fortezza Bastiani. L’isola-confine rischia così di tornare a trasformarsi nell’isola-confino del XIX secolo, quando ospitava una colonia penale. Poco distante è il cimitero ove sono sepolti i corpi senza nome dei tanti che, dopo aver inghiottito la sabbia del deserto faticosamente attraversato, sono annegati nell’ecatombe del Mediterraneo. Croci di legno si oppongono pietosamente all’oblio cui sono destinati gli uomini e le donne di altra fede. Il grottesco business foraggiato dalla macchina dell’accoglienza, cui attingono «affaristi di ogni risma, albergatori spregiudicati e cooperative senza scrupoli», non si arresta nemmeno davanti alla profondità della tragedia che ha trasformato il Canale di Sicilia in una nuova Fossa delle Marianne.
A pensarci bene, tutto il libro di Camarrone sembra permeato da un laico e profondo sentimento di morte, dal mesto e dolente presentimento che «i morti sono ovunque, sparsi nel letto del grande mare, sotto profonde lenzuola, a centinaia o migliaia di metri dalla superficie, o soltanto a pochi metri. Se ne ripesca qualcuno, di tanto in tanto. A pezzi». Nei sacchi neri che si allineano sulla banchina ad ogni naufragio, sono sigillati non solo i corpi dei migranti annegati ma anche la pietas di ciascuno di noi, le ragioni e le religioni della nostra storia di occidentali.
 A chi chiedeva se non avessero avuto paura a navigare su un barcone strapieno e inaffidabile, un giovane siriano scampato alla mattanza e arrivato a Lampedusa ha seccamente risposto che erano già morti prima di partire. Forse solo la verità nuda e drammatica di queste parole può farci intravedere il senso profondo di queste migrazioni che, senza valigie e senza protezioni, sono imprese individuali e sfide collettive lanciate per oltrepassare i confini e attraversare le frontiere. Forse solo partecipando al dramma di queste umane esperienze possiamo evitare che al naufragio delle loro sgangherate carrette si accompagni il naufragio delle nostre fragili coscienze civili.
A chi chiedeva se non avessero avuto paura a navigare su un barcone strapieno e inaffidabile, un giovane siriano scampato alla mattanza e arrivato a Lampedusa ha seccamente risposto che erano già morti prima di partire. Forse solo la verità nuda e drammatica di queste parole può farci intravedere il senso profondo di queste migrazioni che, senza valigie e senza protezioni, sono imprese individuali e sfide collettive lanciate per oltrepassare i confini e attraversare le frontiere. Forse solo partecipando al dramma di queste umane esperienze possiamo evitare che al naufragio delle loro sgangherate carrette si accompagni il naufragio delle nostre fragili coscienze civili.
Dialoghi Mediterranei, n.9, settembre 2014
____________________________________________________________________
Antonino Cusumano, ha insegnato nel corso di laurea in Beni Demoetnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo. La sua pubblicazione, Il ritorno infelice, edita da Sellerio nel 1976, rappresenta la prima indagine condotta in Sicilia sull’immigrazione straniera. Sullo stesso argomento ha scritto un rapporto edito dal Cresm nel 2000: Cittadini senza cittadinanza, nonché numerosi altri saggi e articoli su riviste specializzate e volumi collettanei. Ha dedicato particolare attenzione anche ai temi dell’arte popolare, della cultura materiale e della museografia.
_______________________________________________________________