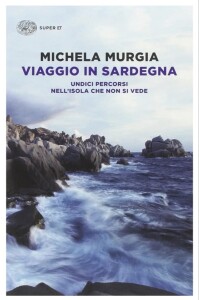di Nicolò Atzori
Alla memoria di Carlo Lugliè
Domenica 2 luglio, fra le onde del mare oristanese, suo più di ogni altra cosa, Carlo Lugliè si congedava eroicamente dal mondo nel tentativo di strappare un bambino all’impeto della burrasca. Un velo di sconforto e indicibile dolore calava sul mondo della cultura sardo, e l’Isola perdeva uno dei suoi più brillanti e appassionati studiosi, amorevole analista e divulgatore dei processi che ne hanno scandito il funzionamento fin dalle più remote epoche umane. Già professore ordinario di Preistoria e protostoria presso l’Università degli Studi di Cagliari, Lugliè era un profondo conoscitore dell’evoluzione culturale dei sardi antichi, da lui indagata precipuamente nei suoi circuiti materiali [1], e unica era la capacità di gravitare fra mondo accademico, comunità, scuole e luoghi del patrimonio, che frequentava con grande regolarità: le tracce del passato, come chi le custodiva, erano la sua casa, la dimensione nella quale pensare sé stesso e il suo posto nel mondo, noi partecipi.
Il ricordo di Carlo, insieme dolce e doloroso, risuona, fra queste righe che di Sardegna intendono ragionare, come un invito e un monito per chi intenda dedicarsi alla conoscenza della nostra Isola: la competenza è determinante, certo, ma senza amore la strada è breve.
Una passione, quella educata e metodica per l’oggetto del suo sforzo conoscitivo, la Sardegna, e quindi per il proprio mestiere, che Lugliè condivideva con Luciano Marrocu, autore di Storia popolare dei sardi e della Sardegna [2], appassionante viaggio lungo i percorsi culturali che, fin dall’arrivo dei primi uomini nell’Isola, verosimilmente fra 500 e 300 mila anni fa, hanno costruito il “senso geografico” dell’insularità e i suoi tratti essenziali, che lo storico cagliaritano si preoccupa di fare confluire in una delle più compiute e organiche trattazioni sulla storia della nostra Isola.
Non la si chiami ricostruzione di fatti, però. L’attenzione dell’autore, esperto navigatore nel mare magnum della fonte, è focalizzata non già verso l’avvenimento, spesso inconoscibile nel caso delle età protostorica ed antica, ma verso la dinamica e il processo culturale, della sintesi comunitaria e societaria di senso, quella linea continua ma multiforme che la storia cosiddetta evenemenziale ha il compito accessorio di supportare e “aggrappare” alla volontà narrativa e comunicativa di chi, come Luciano Marrocu, la storia studia, comprende e racconta.
Se l’opera di Marrocu può inserirsi pienamente nello sterminato filone della saggistica sulla Sardegna, ottiene di introdurre un elemento di novità che sembra dare avvio alla certamente fortunata stagione scientifica degli studi sull’attualità sarda, scandita da sfide inedite che l’Isola condivide non già col “continente” e il vasto Grande Mare, com’era stato fino al crepuscolo dell’età moderna, ma col mondo intero, come la pandemia e il conflitto russo-ucraino stanno dimostrando.
Marrocu, insomma, si spinge fino al racconto storiografico di una Sardegna globale, “finalmente” sconfinata, che nel rapporto-scontro fra stilemi storici auto-identificativi e appigli al processo globalizzante in atto scorge la dimensione all’interno della quale – soprattutto secondo la sua fenomenologia comunicativa – pensa sé stessa e l’idealità del suo dialogo col mondo (soprattutto secondo la politica moderna).
Nell’opera, però, la storica conflittualità isola-mondo [3] viene ridimensionata, e lo storico illustra al lettore l’esplicazione dei processi che, nella pure vivace diacronia isolana, hanno condotto le popolazioni che si sono succedute nella frequentazione del territorio a evolvere sempre gradualmente, secondo un farsi infinitamente multietnico e polisemico. Ricostruire e raccontare dei meccanismi non è certo cosa banale quando si pensa all’insularità sarda e alle sue alterne vicende, che in una stupenda orografia sono ammesse ora come valori e ora come disvalori. E se, dunque, i sardi e la Sardegna non fossero la stessa cosa?
I primi vagiti dell’identità sarda
Dell’isola di Sardegna cominciamo a scorgere qualche elemento di peculiarità con la cultura materiale, che Marrocu identifica, nella sua storia, con la ceramica “cardiale”, tipo di vasellame caratterizzato dall’impressione, mediante conchiglie, di elementi decorativi sull’impasto fresco. Sono le fasi, ancora remote, della cultura di Bonu Ighinu (V millennio a.C.) e dell’ossidiana del Monte Arci magistralmente studiata proprio da Carlo Lugliè, delle domus de janas (IV millennio) e della facies di Monte Claro. Dal II millennio a.C., però, nuovi segnali di dinamismo tecnico e intraprendenza sembrano configurare uno scenario culturale nuovo, segnato dalla capillare presenza, nel territorio isolano, delle strutture turrite note come nuraghi, dall’incerta etimologia.
Gli anni Cinquanta del secolo scorso sono il momento cruciale per la storia degli studi, incentivati dalla scoperta dell’imponente fortezza nuragica di Su Nuraxi (Barumini) da parte dell’archeologo Giovanni Lilliu, primo a parlare di una vera e propria “civiltà nuragica” e di forme riconoscibili e sistemiche del suo sviluppo. Qui, l’autore del libro ha il grande merito di informare circa l’ambiguità scientifica dell’espressione di unitarietà e identità “di cultura” riconosciuta ad una “età dei nuraghi”, non diversamente pensata e teorizzata per tutta la metà dello scorso secolo e solo recentemente messa in discussione da nuove e più approfondite indagini.
Non apparirà certo superfluo notare quanto i caratteri ideali di uniformità e unicità riconosciuti a questa fase abbiano contribuito a definire una narrazione permeante i processi di auto-identificazione del sardo contemporaneo, che vede radicalizzarsi le sue posizioni soprattutto davanti alle retoriche che il palinsesto comunicativo digitale mette in opera, giornalmente, nei suoi ingranaggi di uso e consumo di luoghi, suggestioni, leggende, dicerie e luoghi comuni particolarmente apprezzabili nel ring dell’utenza, una cui larga frangia risulta generalmente scettica davanti alle acquisizioni particolarmente accademiche [4]. Viceversa, tanti accademici prestano il fianco ad una importante nebulosità conoscitiva.
L’esito dell’assunzione arbitraria della fase culturale nuragica quale termine di confronto e interpretazione si declina da un lato nel linguaggio della selezione di temi e leitmotiv, per così dire, “caratterizzanti” e “comodi” per l’economia del dibattito, e dall’altro nell’astrazione da periodizzazioni successive automaticamente individuate come “limitanti” per la storia del riconosciuto e riconoscibile Popolo Sardo, che si ritiene corrotto dalle influenze successive ai millenni III e II a. C, unica fase in cui si ritiene possa avere espresso forme culturali irripetibili e gloriose.
In realtà, il “dopo” del periodo approssimativamente definibile come nuragico non corrisponde certo ad una fine o, peggio, come spesso si è udito, ad una “estinzione” della cultura dei nuraghi, che non cessano di esistere ma divengono simbolici, nell’immaginario delle popolazioni autoctone, di un periodo ormai concepito come trascorso ma di un bagaglio di valori incorruttibili.
Il fatto rilevante, a partire dal IX secolo, è il primo approdo dei fenici sulle coste sarde, presenza che andrà consolidandosi nei due secoli successivi. L’Isola non cessa certo di esprimere dei tratti cosiddetti “peculiari”, come correttamente si scongiura, ma tende indubbiamente ad assumere una posizione ancora più centrale nelle dinamiche mediterranee, sempre più nettamente al di là dei suoi confini e delle sue possibilità umane. Prima i fenici, pellegrini e mercanti del mare nel ritornello scientifico, e poi i cartaginesi, fenici di Cartagine, scrivono nuove pagine di storia insediativa innescando inedite dinamiche di territorializzazione.
Marrocu, accorto nel raccontare il cambiamento, non manca di segnalare i “nuovi promettenti sviluppi” da attribuire alla compresenza delle culture fenicia e nuragica, che per largo tempo coesistono in un reciproco processo di pacifico confronto e influenza, e non ad una osmosi unidirezionale dalla prima verso la seconda. Nei tofet, gli spazi cerimoniali fenici, non mancava la ceramica di entrambe le facies, deposta durante rituali che dovevano rispettare, come a Sulky, da essi rifondata[5] la partecipazione di una nutrita componente nuragica.
La storia della Sardegna punica non è però estranea a ben più invasive e decisive congiunture, com’è stata la guerra da queste genti condotta – nota l’autore citando lo storico romano Giustino (II d.C.) – per la vera e propria conquista, nel VI sec. a.C., della terra che fu «il prodotto della volontà cartaginese di arrivare a un pieno controllo sui commerci del Mediterraneo occidentale». L’inserimento dell’Isola nelle dinamiche belliche che videro protagonista la potente Cartagine, il cui vigore mantenne sotto scacco il Grande Mare per lungo tempo, sembra scontrarsi con l’atteggiamento delle genti fenicie che da diverso tempo percorrevano i litorali sardi, e che pure si opposero, con scarsi risultati, alla forza della “loro” colonia. A questi gruppi, prevalentemente dediti ad un commercio di diverso tipo, si deve infatti, verosimilmente, l’introduzione del primo alfabeto organico che abbia fatto capolino in Sardegna attraverso le indagini archeologiche, fatto che stride con le mire prevaricatrici e accentratrici dei più agguerriti cartaginesi e con le vicende che li hanno resi protagonisti.
Se da un lato la retorica identitaria più radicale è concorde nell’attribuire alla cultura protostorica isolana, specificamente nuragica, un carattere di civiltà tecnologicamente superiore e ridimensionata solo dalle descrizioni insufficienti e mistificatorie di tanta scienza ufficiale (ipse dixit), tacciata di feniciomania (cito testualmente), dall’altro la stessa sembra restia ad accettare l’idea stessa dei cambiamenti irreversibili che l’ingerenza alloctona – e particolarmente riferibile ai gruppi di navigatori delle coste di area cipriota – ha determinato nella società dei nuraghi, sicuramente unica nei suoi tratti essenziali ma che l’osservatore moderno deve considerare inserita in una vivacità culturale che nella linea del tempo sarda vede l’Isola stabilmente inserita, a partire almeno dal I millennio a.C., in un quadro territoriale di tipo ormai continentale.
Tanta parte ha avuto, nella definizione di un immaginario cosmogonico, anche il rapporto tra Sardegna e Roma, che la rese sua colonia nel III sec. a.C. come tramandatoci da Dione Cassio, lo storico greco da cui traiamo le informazioni sull’occupazione romana del nostro territorio. Quanto ha pesato, nella costruzione dell’identità popolare sarda, e quindi del lessico e addirittura della toponomastica [6], la rivolta antiromana guidata dall’eroico Hampsicora, già probabilmente distintosi durante il Bellum Sardum che oppose appunto, verso il 215 a.C., le città costiere sardo-puniche ai nuovi invasori romani?
Il cambiamento, insomma, si innesta nei frangenti dello scambio e della continuità culturale, come i nostri musei archeologici testimoniano in maniera ampia e precisa, ed è compito dello storico educare alla accettazione e alla comprensione del divenire umano inteso come costante negoziazione di modi e tempi di vita ed esistenza comune. Marrocu assolve il compito in maniera esemplare, riuscendo a smussare la spigolosità diacronica delle fasi più antiche della storia sarda, terreno fertile per lo sviluppo di una diatriba comunicativa apparentemente insanabile che, tra protagonismo nei social network [7] e continui scontri retorici, continua a ingenerare una nebulosa ambiguità nel moderno dibattito in materia di identità.
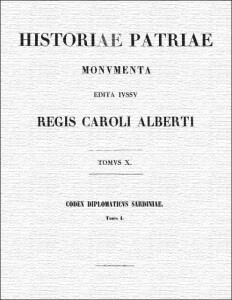 Coscienza di luogo, coscienza di popolo
Coscienza di luogo, coscienza di popolo
Nel ragionare dell’opera di Marrocu, ho scelto di basare il mio discorso sulle diverse “strutture dell’identità” che la storia sarda ha offerto a noi studiosi, lettori e fruitori moderni per pensare il nostro posto nel mondo e che credo che l’autore abbia distinto in maniera assolutamente puntuale già nell’organizzazione del volume. La peculiarità della cultura materiale preistorica, l’ accento sulla compresenza e non lo scontro tra nuragici e fenici, l’ingerenza di Roma, poi i rapporti con Pisa e Genova e la “guerra degli Arborea” (ci tornerò a breve), l’organizzazione della monarchia composita spagnola e il feudalesimo, giungendo fino alla Sardegna-laboratorio dei Savoia e ai sentori di “nazione sarda”, nel periodo dei primi grandi intellettuali “organici” quali Giovanni Spano e Giuseppe Manno e dei cambiamenti nel quadro della proprietà terriera – alla vigilia dell’Unità, ben diversamente percepita a queste latitudini – sono alcune delle sinapsi culturali che consentono il progredire della Sardegna reale e di quella che crediamo di vedere. Nel volume si fanno poi strada le “nuove energie intellettuali” a cavallo tra Otto e Novecento, con l’emergere di Grazia Deledda e dei primi contributi etnografici sulla Sardegna e, infine, la rinascita postbellica e la giungla partitica in campo durante la ricostruzione, dimensione nella quale il Marrocu si dimostra più a suo agio, scandagliando con asciutta precisione i meccanismi del confronto politico che ha posto le basi della contemporaneità che abitiamo.
Proseguendo un discorso sulle strutture elementari dell’identità sarda (parafrasando qualcuno), è necessario riferirsi nuovamente alla meccanica dello scontro armato, che, nell’immaginario di tipo comunitario, statuale e nazionale di area europea ha agito, stabilmente fino almeno dall’età classica, quale confine e patto sul quale fondare un proprio sistema di valori e prerogative non rintracciabili nelle omologhe entità del dettato geopolitico. A questo proposito, non sarà banale rileggere la definizione di identità curata da Alice Bellagamba e contenuta nel Dizionario di Antropologia di Fabietti e Remotti:
«Il discorso sull’identità a livello della persona come dei gruppi è strettamente connesso a una riflessione sulle differenze, siano esse culturali, di genere, o etniche. Questo sia che si considerino i contesti di comunicazione e contrapposizione fra il sé e l’altro, sia che si studino le diverse forme di raggruppamento da cui è costituita la realtà sociale: la dimensione dell’identità personale e il discorso sulle identità sociali e culturali sono strettamente correlati, poiché i modelli attraverso cui vengono interpretati i sé e gli altri possono essere considerati come espressioni simboliche della cultura. È inoltre implicito in questa tematica il problema della continuità, cioè l’analisi di quegli elementi costitutivi che, nel tempo, conferiscono alla persona o a una collettività le sue caratteristiche peculiari, permettendo di distinguerla dalle realtà che la circondano» [8].
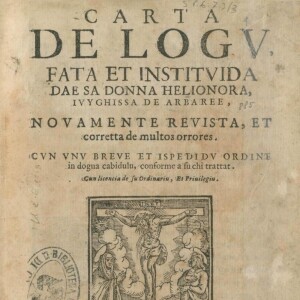 A ben vedere, il concetto di contrapposizione è ricorrente quando si dibatta di identità, che si fa strada inevitabilmente sullo sfondo dell’astrazione di un sé, di un noi o di un proprio rispetto a formazioni individuabili come esterne o dissimili. Gli elementi costitutivi [9] a cui allude Alice Bellagamba, dunque, particolarmente nel caso sardo riferiscono di momenti di scontro e aspra ostilità che hanno coinvolto gruppi umani più o meno autoctoni ed “invasori” o incursori d’oltremare. Nel tempo di Eleonora d’Arborea, ad esempio, quando prese piede – protagonista la stessa giudicessa – la cosiddetta guerra sardo-catalana [10], si situano tanti degli avvenimenti che hanno irrobustito il senso di appartenenza dei sardi moderni, evidentemente bisognosi, come tutti i popoli, di organiche cosmogonie per stimare sé stessi. Proprio nel Trecento, a partire dall’arrivo – nel maggio del 1323 – del primo contingente catalano-aragonese, Marrocu rintraccia i primi vagiti sentimentali di quella naciò sardesca il cui potere concettuale ha permeato la storia politica sarda, suggellata, se vogliamo, dalla nascita, nel 1921, del Partito sardo d’Azione (Psd’Az) e poi dal vivace indipendentismo sardo, che spesso utilizza, nei suoi partiti, l’immagine dell’albero eradicato, già simbolo del Giudicato d’Arborea che condusse la guerra contro i catalani comandato da Mariano IV e poi da sua figlia, la giudicessa Eleonora.
A ben vedere, il concetto di contrapposizione è ricorrente quando si dibatta di identità, che si fa strada inevitabilmente sullo sfondo dell’astrazione di un sé, di un noi o di un proprio rispetto a formazioni individuabili come esterne o dissimili. Gli elementi costitutivi [9] a cui allude Alice Bellagamba, dunque, particolarmente nel caso sardo riferiscono di momenti di scontro e aspra ostilità che hanno coinvolto gruppi umani più o meno autoctoni ed “invasori” o incursori d’oltremare. Nel tempo di Eleonora d’Arborea, ad esempio, quando prese piede – protagonista la stessa giudicessa – la cosiddetta guerra sardo-catalana [10], si situano tanti degli avvenimenti che hanno irrobustito il senso di appartenenza dei sardi moderni, evidentemente bisognosi, come tutti i popoli, di organiche cosmogonie per stimare sé stessi. Proprio nel Trecento, a partire dall’arrivo – nel maggio del 1323 – del primo contingente catalano-aragonese, Marrocu rintraccia i primi vagiti sentimentali di quella naciò sardesca il cui potere concettuale ha permeato la storia politica sarda, suggellata, se vogliamo, dalla nascita, nel 1921, del Partito sardo d’Azione (Psd’Az) e poi dal vivace indipendentismo sardo, che spesso utilizza, nei suoi partiti, l’immagine dell’albero eradicato, già simbolo del Giudicato d’Arborea che condusse la guerra contro i catalani comandato da Mariano IV e poi da sua figlia, la giudicessa Eleonora.
Lo storico cagliaritano è ancora preciso nel circoscrivere il problema, e nota nella preponderanza del concetto di logu (luogo) il termine geografico-amministrativo e giuridico-culturale della rigorosa gestione dello spazio che ai giudicati si attribuisce e particolarmente a quello di Arborea che, reggente prima Mariano e poi sua figlia Eleonora, ne sistema con quest’ultima una versione normativa che resterà in vigore fino addirittura al 1827 [11]: la Carta de Logu.
Se l’indipendentismo moderno parla agevolmente il linguaggio delle cancellerie giudicali, attinge tanti dei suoi ideali di riscatto nel sentimento maturato durante l’occupazione della Sardegna da parte dei Savoia, succeduta al già plurisecolare inserimento dell’Isola nei gangli della monarchia “composita” o “confederale” di matrice spagnola. Rispetto al tema di una Sardegna interamente autonoma, il secolo XVIII è cruciale nella storia dei sardi, e comincia a riferire di meccaniche economiche e sociali che, in parte esito del sistema amministrativo e feudale iberico (prima catalano poi spagnolo), sembrano acuirsi nel confronto e nella più netta separazione tra ceti popolari e nobiltà. E si ha la sensazione che a partire da questi tempi si sia più a nostro agio, da specialisti e non solo, nel parlare di una “storia popolare” sarda, espressa nel titolo, dove il sentire di quelle frange che abitano spesso dietro le quinte del dettato politico comincia a farsi strada nelle sedi più calde del dibattito. D’altra parte, la storia dei Savoia in Sardegna, cominciata ufficialmente nel 1720 con il Trattato dell’Aia, è sicuramente costellata di soprusi, come si lamenta, ma anche di possibilità e innovazioni, come puntualizza la più recente storiografia che segnala la collocazione dell’Isola in uno scacchiere, quello sabaudo, certamente composito e nutrito, scandito da meccaniche amministrative completamente diverse e più aggiornate rispetto a quelle isolane. “Europee”, se vogliamo.
Nel denso corpus delle opere che hanno trattato di Sardegna e Savoia, il contributo di Luciano Marrocu contenuto in questo volume, ancorché agile, è in grado di riferire, ancora una volta, di quegli aspetti che, debitamente assemblati, si propongono di fornire uno disegno veritiero della vita nell’Isola durante l’ingerenza sabauda. Non manca, il Marrocu, di soffermarsi sugli essenziali problemi linguistici dell’epoca, che la allontanano ulteriormente dalla già miope attenzione dei suoi amministratori, i quali cercheranno di mitigare questa condizione soltanto nel 1760, con l’introduzione di un piano relativo alle scuole primarie che prevedeva un corso di studio in sette classi, l’adozione di appositi manuali e l’uso dell’italiano nell’insegnamento.
Se la propensione riformista dei Savoia può dirsi comunque figlia, in parte, di un atteggiamento a tratti dispotico, assistenzialistico e “terapeutico” rispetto alla cosa sarda, profondamente scorretto si rivela un giudizio aprioristicamente negativo e giocato sulla dicotomia invasore-invaso della cui iniquità abbiamo prova anche nel momento storico che viviamo. Ad esempio, dopo i primi trent’anni di occupazione, l’avvento del reggente della Segreteria di Stato per gli affari della Sardegna Giovan Battista Lorenzo Bogino, nel 1759, determinò sicuramente una migliore coesione tra sardi e piemontesi, oltreché una maggiore attenzione verso le condizioni dei primi. Certamente, il Bogino seppe coordinare sforzi prima episodici o insufficienti, ed assegnare un peso finalmente preponderante alle regole ed alla loro stretta osservanza soprattutto da parte dei baroni e della nobiltà isolana, che il ministro si preoccupò di «riportare […] entro il recinto dello Stato e delle sue leggi».
Come non di rado accade in presenza di decisori risoluti, il senso comune tende a catalizzare un processo di assimilazione del personaggio che, assumendo spesso i contorni del mito e della leggenda, contribuisce alla costruzione del sapere proverbiale delle comunità, che in tal modo tramandano valori e principi regolatori. Parte di questo sapere sfocia in figure linguistiche e detti (dicius, in sardo) con valore di ammonimento e, in tal caso, malaugurio per chi commetta qualcosa di sgradevole o non propriamente consono al sistema morale riconosciuto: l’espressione ancu ti currat su buginu (che ti perseguiti il Bogino), ad esempio, ancora nota fra gli anziani, fa evidentemente riferimento all’eccesso di zelo del ministro tramandatosi quale carattere-relitto nell’immaginario collettivo dai tempi in cui esso disponeva e imponeva la sua visione politica.
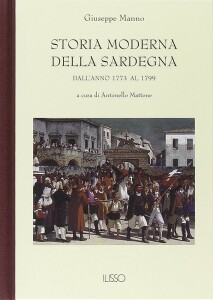 L’asprezza sociale vissuta durante la lunga stagione sabauda insinuò nei sardi il germe della tirannia patita, ed è su questo sostrato che, per alterne vicende, si consumò il triennio rivoluzionario 1793-1796, quando i patrioti isolani, stanchi dell’ennesima azione prevaricatrice contro la loro terra (stavolta per mano francese) e fra i quali emerse Giovanni Maria Angioy, si ribellarono al grido musicale di Procurad’e moderare, barones, sa tirannia (Cercate di frenare, baroni, la tirannia!), incipit di Su patriotu sardu a sos feudatarios, scritto nel 1795 da Francesco Ignazio Mannu e divenuto, nel 2018, inno ufficiale della Sardegna.
L’asprezza sociale vissuta durante la lunga stagione sabauda insinuò nei sardi il germe della tirannia patita, ed è su questo sostrato che, per alterne vicende, si consumò il triennio rivoluzionario 1793-1796, quando i patrioti isolani, stanchi dell’ennesima azione prevaricatrice contro la loro terra (stavolta per mano francese) e fra i quali emerse Giovanni Maria Angioy, si ribellarono al grido musicale di Procurad’e moderare, barones, sa tirannia (Cercate di frenare, baroni, la tirannia!), incipit di Su patriotu sardu a sos feudatarios, scritto nel 1795 da Francesco Ignazio Mannu e divenuto, nel 2018, inno ufficiale della Sardegna.
È un passaggio importante per più motivi. Se, da un lato, i Vespri sardi si rivelarono un deterrente per futuri abusi nell’esercizio del potere nobiliare, prima di allora asfissiante e capillare, dall’altro dettero l’avvio ad una stagione, quella ottocentesca, nella quale i sardi cominciarono a pensare e teorizzare sé stessi con sforzi letterari e scientifici sui quali in parte ancora imposta il nostro atteggiamento di studiosi. Il trauma della “rivoluzione imperfetta” fu rivelatorio soprattutto per lo sviluppo di una coscienza del sé (di stampo eminentemente storico) che il sardo, il patriota e lo studioso seppero mettere a frutto nella prima grande stagione di crescita e (ri)scoperta. L’autore della Storia popolare è preciso nell’illuminare le sfaccettature di questo fermento, che giustamente attribuisce allo stesso ambiente intellettuale ed editoriale torinese, dove poterono affermarsi i primi grandi pensatori di cose di Sardegna.
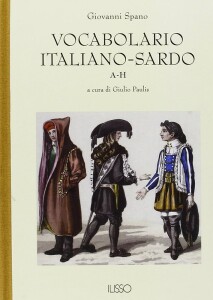 Nuovamente, Marrocu è bravo nel planare sulla fenomenologia evenemenziale più cruda per scorgere sinapsi e connessioni interculturali – immanentemente positive in quanto tali – che difficilmente si sarebbero potute scorgere nel marasma di opposizione e asprezza del dibattito politico e sociale. Pasquale Tola (1800-1874), primo di questi intellettuali, pubblicò proprio a Torino, capitale dello Stato sabaudo, prima il Dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna (1837) e poi il Codex Diplomaticus Sardiniae (1861-1868), sua opera più importante e comprendente documenti dall’XI al XVII secolo. A Giuseppe Manno (1786-1868), invece, che pure trovò a Torino condizioni favorevoli per le sue ricerche, si deve la pubblicazione di una prima Storia moderna della Sardegna dall’anno 1773 al 1799 (1842), motivata – puntualizza Marrocu – dall’«essersi sentito oltraggiato dalle affermazioni di alcuni stranieri sull’isola»; infine, è necessario citare il grande Giovanni Spano (1803-1978), tra i più eclettici e acuti intellettuali dell’epoca, già presbitero, linguista, archeologo e, mi sembra, etnologo ante litteram. Di lui si ricordi, fra le innumerevoli opere sul tessuto storico-archeologico della Sardegna, il Vocabolario sardo-italiano e italiano-sardo (1851-1852), opera fondativa della linguistica classica. In questa prima e fortunata stagione dell’intellettualismo scientifico sardo l’autore parlerà della «aspirazione ad offrire una rappresentazione del mondo sardo non come un prodotto residuale, ma come un’elaborazione all’altezza degli standard culturali italiani ed europei».
Nuovamente, Marrocu è bravo nel planare sulla fenomenologia evenemenziale più cruda per scorgere sinapsi e connessioni interculturali – immanentemente positive in quanto tali – che difficilmente si sarebbero potute scorgere nel marasma di opposizione e asprezza del dibattito politico e sociale. Pasquale Tola (1800-1874), primo di questi intellettuali, pubblicò proprio a Torino, capitale dello Stato sabaudo, prima il Dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna (1837) e poi il Codex Diplomaticus Sardiniae (1861-1868), sua opera più importante e comprendente documenti dall’XI al XVII secolo. A Giuseppe Manno (1786-1868), invece, che pure trovò a Torino condizioni favorevoli per le sue ricerche, si deve la pubblicazione di una prima Storia moderna della Sardegna dall’anno 1773 al 1799 (1842), motivata – puntualizza Marrocu – dall’«essersi sentito oltraggiato dalle affermazioni di alcuni stranieri sull’isola»; infine, è necessario citare il grande Giovanni Spano (1803-1978), tra i più eclettici e acuti intellettuali dell’epoca, già presbitero, linguista, archeologo e, mi sembra, etnologo ante litteram. Di lui si ricordi, fra le innumerevoli opere sul tessuto storico-archeologico della Sardegna, il Vocabolario sardo-italiano e italiano-sardo (1851-1852), opera fondativa della linguistica classica. In questa prima e fortunata stagione dell’intellettualismo scientifico sardo l’autore parlerà della «aspirazione ad offrire una rappresentazione del mondo sardo non come un prodotto residuale, ma come un’elaborazione all’altezza degli standard culturali italiani ed europei».
Le insegne del lutto hanno sventolato all’apertura di questo contributo, e temo non sia tempo di ammainarle. Il 10 agosto, infatti, mentre scrivevo, si è congedata da noi anche Michela Murgia, poliedrica e prolifica intellettuale sarda, di Cabras. Anche Michela ha saputo parlare della sua Sardegna; lo ha fatto, come Carlo Lugliè, con la scintilla dell’amore ardente negli occhi, e fino all’ultimo istante, sorridendo al male che l’ha portata via.
Anche Michela, come Carlo, era una “sarda di oggi”, che si riempiva lo sguardo della densa molteplicità che l’ha abbracciata, e alla quale – in ringraziamento – ha donato la sua acuta capacità di descriverne gli ancestrali e strenui ingranaggi e i più reconditi silenzi [12]. A ben vedere, è a noi, sardi e sarde viventi e instancabili, che Luciano Marrocu si rivolge nella sua opera, che affronta ben più del passato conosciuto di un’Isola, poiché comprende quell’attuale e contingente intercapedine della storia che chiamiamo presente, abitandolo e ignorandolo, e che interpretiamo distrattamente crogiolandoci nelle sue soporifere comodità, magari celebrandolo con urgenti “politiche di riscatto” e “sviluppo”, di crisi in crisi, ma mai ricordando o comprendendo appieno come potrebbe viversi, qui da noi. Marrocu ha cercato di abbracciare tutti quei sardi con raro vigore narrativo, attraversando lo Stige politico del Novecento, tra volenterosi, arrivisti e idealisti, e ricordando che la Sardegna è ancora qui, sempre, nella ferace compattezza della terra che calpestiamo e nell’infinità del cielo che ci sovrasta, ad attendere che qualcuno ci capisca qualcosa. Noi studiosi non siamo esenti da colpe.
Ho la sensazione, a volte, che parlare di Sardegna non serva più a nulla, tanto è stato detto ma non tentato, e che ogni ulteriore sforzo conoscitivo sia semplicemente destinato alle pompose prolusioni per le aule universitarie o, più democraticamente, per i cineteatri dei paesi, che magari da anni riposano inutilizzati, già spiritualmente vetusti sebbene di recente costruzione. Ma le tendenze storiografiche, gli specialismi e le indagini minute non devono assurgere a unici modelli precompilati per giustificare una sola ricerca possibile, e dunque distogliere l’attenzione dal bisogno, oggi più che mai, in tanta alterità, delle ampie narrazioni e degli anche sgarbati tentativi di più generali comprensioni, spesso osservate con sospetto. Chi scrive pensa che il professor Luciano Marrocu abbia saputo contribuire significativamente a questa ultima, bistrattata, causa.
Dialoghi Mediterranei, n. 63, settembre 2023
Note
[1] Già direttore del Museo dell’Ossidiana di Pau, Carlo Lugliè era soprattutto un esperto conoscitore di questo materiale e dei suoi utilizzi in età preistorica. Si segnala l’intervento questo intervento televisivo del professore (fino al minuto 13’15”): https://www.youtube.com/watch?v=CMqpYw6VwVo
[2] Il volume consultato ai fini del presente contributo è Marrocu L., Storia popolare dei sardi e della Sardegna, Laterza, Bari, 2021
[3] Oltre a quella, ben più percorsa, deducibile dal dualismo “isola-continente”, dove per “continente” intendiamo l’espressione popolare utilizzata in Sardegna per designare la penisola italiana.
[4] In relazione a questi ed altri aspetti, segnalo un mio precedente articolo comparso proprio su “Dialoghi Mediterranei”, n. 56 (07/2022): https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/fenomenologia-comunicativa-della-terra-di-nessuno/
[5] Luciano Marrocu è puntuale nell’ammonire circa l’utilizzo del termine “fondazione”, sicuramente improprio se riferito a diverse località ri-frequentate in età fenicia e già abitate nelle età culturali precedenti, come Cagliari, Nora, Bithia, Sulcis e Tharros. Allo stesso modo, e questo vale anche per fasi successive, va utilizzato con circospezione il termine “colonizzazione”, di cui troppo spesso tanti storici si servono.
[6]A Cagliari, ad esempio, nel 1923 è stato realizzato lo stadio Amsicora, impianto sportivo polivalente e fra i più amati e frequentati dai cagliaritani.
[7] Sulle dinamiche del protagonismo nei social network rimando, nuovamente, al mio articolo sopracitato, in cui parlo, fra le altre cose, di una forma di revanscismo digitale che ho notato innestarsi nel dibattito intorno al patrimonio culturale sardo.
[8] Identità in Dizionario di Antropologia, a cura di Ugo Fabietti e Francesco Remotti. Voce a cura di Alice Bellagamba, Zanichelli, Bologna, 1997.
[9] L’autrice è brava nel citare l’imprescindibile contesto di comunicazione attraverso i cui caratteri si sviluppa, in un modo o in un altro, un processo di costruzione del sé.
[10] Espressione qui utilizzata per comodità di comprensione, ma in realtà impropria. Nei termini della storia delle istituzioni medievali, infatti, i sardi erano, formalmente, i fautori della costruzione del Regnum Sardiniae ed Corsicae, quindi i catalani, mentre gli isolani veri e propri erano rappresentati dall’esercito arborense, ad essi opposto.
[11] Anno d’emanazione del Codice feliciano.
[12] Della compianta autrice si segnala Murgia M., Viaggio in Sardegna. Undici percorsi nell’isola che non si vede, Einaudi, Torino, 2014.
_____________________________________________________________
Nicolò Atzori, consegue una laurea triennale in Beni Culturali (indirizzo storico-artistico) con una tesi in Geografia e Cartografia IGM e una magistrale in Storia e Società (ind. medievistico) con una tesi in Antropologia culturale, presso l’Università di Cagliari, ottenendo in entrambe il massimo dei voti. Altresì, è diplomato presso la Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Cagliari. Dal 2017 lavora, per conto di CoopCulture, come operatore museale e guida turistica presso il Museo Villa Abbas e il sito archeologico di Santa Anastasia di Sardara (SU), luoghi dei quali, fra le altre cose, cura la comunicazione e, nel primo caso, gli aspetti museografici. Sta frequentando il master di Antropologia Museale e dell’Arte della Bicocca.
______________________________________________________________