“Tutto è politica, tutto è economia. E prima lo capirai, prima realizzerai quello che stanno combinando contro la nostra libertà”. Con queste parole si chiudeva una vera e propria Lectio Magistralis cui ebbi l’onore di assistere in un tiepido pomeriggio di fine estate, spettatore passivo di una dimostrazione che con grande acribia indiziaria mi spiegava pazientemente come va il mondo. Partendo dagli incendi in Australia di inizio 2020 e passando per la (finta) deforestazione dell’Amazzonia, l’inesistenza del global warming, i veri interessi di Greta Thumberg, la natura del Sars-Cov-2, il neo-fondamentalismo scientifico-sanitario, la deriva autoritaria della nostra società e la regia internazionale dietro i movimenti migratori, in una ventina di minuti appena avevo avuto accesso a una teoria omnicomprensiva in grado di spiegare, con dovizia di particolari e ricorso a fonti autorevoli, come la contemporanea situazione emergenziale altro non sia che l’esito di una strategia politico-economica pianificata dall’alto.
Ogni tanto, devo ammetterlo, mi perdevo nei meandri della riflessione del mio interlocutore; ogni tanto ripensavo a come la fine delle cosiddette grandi narrazioni abbia lasciato un vuoto interpretativo, acuito da un mondo che cambia a un ritmo impressionante, che in qualche modo deve essere riempito; ogni tanto provavo timidamente a intervenire manifestando il mio dissenso per un ragionamento che, a dispetto della sua sorprendente plasticità, mi appariva teleologico e tautologico. Soprattutto provavo un palpabile disagio: non tanto per il tenore delle tesi, spesso irricevibili, dell’uomo che avevo di fronte, quanto per la consapevolezza che tra me e lui non c’era, anche nel reciproco dissenso, alcuna possibilità d’intesa.
Non ci muovevamo, infatti, sullo stesso terreno e la nostra comunicazione era viziata da un problema di fondo: lui partiva dall’assunto di conoscere il “realmente reale” e che io, al contrario, dovessi essere disintossicato dalle scorie dell’informazione mainstream cui per troppo tempo ero stato esposto; io, d’altro canto, non riuscivo a liberarmi del ruolo che mi aveva cucito addosso e finivo per interpretare la parte dell’ingenuo difensore dello status quo. Ero preso cioè in una sorta di doppio vincolo batesoniano: quando, di fronte alle più palesi amenità, tentavo di opporre un’azione di debunking venivo trattato come un fondamentalista (“eh, ma credi ancora nella Scienza? Non lo sai che gli scienziati sono tutti pagati dalle multinazionali?”); quando tentavo di smarcarmi distinguendo tra critica legittima e sospetto elevato a Dogma finivo con l’essere compatito (“allora vedi che senza volerlo mi dai ragione? È solo che hai bisogno di tempo per vedere il disegno generale”). Non c’era via d’uscita, le posizioni si erano cristallizzate al limite della caricatura: da una parte un libero pensatore antisistema e dall’altra un confuso seguace dell’ideologia dominante. Non avevo mai parlato prima di allora con un “complottista” (uso il termine in modo molto circospetto, consapevole della sua scivolosità), ma avevo subito sperimentato come un rigido approccio normativo – vero/falso; razionale/irrazionale; logico/illogico – non funzionasse affatto.
Ho ripensato più volte a quell’incontro e con il tempo ho abbandonato la distanziante (e rassicurante) ironia con cui ho spesso rievocato l’episodio per interrogarmi su che cosa fosse andato storto in quel pomeriggio tardo-agostano. Il mio interlocutore, persona peraltro gradevolissima con cui avevo già conversato in altre occasioni, ostentava una sicurezza invidiabile; scovava nessi causali in grado di dare un senso ad eventi apparentemente lontani (per me, non certo per lui); vestiva alternativamente i panni della vittima del sistema e del cane sciolto in missione alla ricerca della verità. Per il sottoscritto, in ogni caso, si trattava di un vero e proprio enigma.
Lo stesso rompicapo che ritrovo oggi in quella parte di opinione pubblica che, oltre a contestare i provvedimenti varati per contenere l’epidemia da Covid-19, rivendica il proprio rifiuto della cosiddetta “Medicina ufficiale” e denuncia l’imminente instaurazione di una “dittatura sanitaria”. In molti degli slogan scanditi nelle piazze, al netto delle differenze tra i diversi gruppi di contestatori, ho ritrovato le tesi del mio interlocutore e, soprattutto, l’identica volontà di svelare l’autentica “finalità politica” della “narrazione pandemica”: la creazione di “corpi disciplinati” (leggi “vaccinati”) come viatico a una sempre più stringente limitazione delle libertà personali funzionale all’imposizione di una nuova fase dell’ethos capitalista transnazionale. In altre parole: una proiezione che, astraendosi dal concreto, sposta lo scontro politico in un altrove nascosto (ma più vero) in cui oscuri figuri tramano, ordiscono e congiurano.
I nodi sono tanti, gli stessi che avevo ingenuamente provato a sciogliere durante quella chiacchierata estiva: argomentazioni di questo tipo si collocano ancora sul piano della critica politica? Interloquire razionalmente con persone che negano alla radice l’esistenza del Covid (o quantomeno ne ridimensionano drasticamente la portata) è una strada percorribile? Si può dialogare con gente che rifiuta a priori la voce della comunità scientifica (di volta in volta definita “prezzolata” o “criminale”, o entrambe le cose…) e, nell’emergenza in corso, vede l’ombra di un intrigo globale? E più banalmente: di fronte a individui che paragonano le misure di contenimento della pandemia (con tutti gli errori, i difetti e le ingiustizie che inevitabilmente si portano dietro e sui quali è legittimo nutrire dei dubbi) alla Shoah, come perseguire l’ideale antropologico geertziano di «comprendere anche ciò che non si può accettare»?
Negli ultimi mesi un testo ha provato a rispondere a queste domande misurandosi, per sovvertirlo, con uno dei sottotesti della contemporanea postura complottista, “tutto è politica”, e provando altresì ad analizzare il legame esistente tra teorie del complotto e concezione dell’autorità negli attuali sistemi democratici. In Il complotto al potere, edito da Einaudi (2021), la filosofa Donatella Di Cesare sostiene che il complottismo, lungi dall’essere un delirio psicotico o un ingenuo “crampo mentale”, è piuttosto un vero e proprio problema politico del nostro tempo. Esso, infatti, non riguarda tanto, non solo, il regime di verità degli enunciati, bensì il rapporto con il potere in un’epoca, quella della tarda modernità, percorsa da una sostanziale crisi della rappresentanza democratica e da cambiamenti repentini cui è difficile, se non impossibile, tener dietro.
Di Cesare sviluppa una prospettiva lontana dalla vulgata anti-complottista (esemplificata dai cosiddetti Conspiracy Studies) che vede nel complottismo una patologia psichica o un’anomalia logica da smontare attraverso un rigido approccio diagnostico: rieducazione cognitiva e/o attività di serrato fact-checking, sostiene l’autrice, non spostano nulla. Anzi, con il loro piglio censorio, rischiano «di assecondare lo scarto tra “verità ufficiale” e “verità nascosta”» su cui si basa tutta l’impalcatura cospirazionista. Si allontana anche dalle posizioni di Carl Popper e Umberto Eco che insistono sull’affinità tra teorie del complotto e superstizione per affermare, al contrario, che il complottismo non è un «mero segnale di oscurantismo», bensì un «segnale oscuro»: un fenomeno che mette allo scoperto la crisi che agita la democrazia contemporanea e il rinnovato bisogno di senso che ad essa si accompagna.
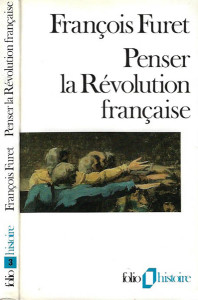 Da questo punto di vista, dunque, il proliferare delle post-verità è strettamente legato alla crescente complessità del mondo contemporaneo e a un concetto di comunità – quello nato nelle società occidentali con la piena modernità – sempre più sfilacciato e sostanzialmente inadatto a spazi politici, economici e culturali polverizzati e in perenne mutamento. Le verità alternative, infatti, offrono un pacchetto di informazioni in grado di adattarsi facilmente ai contesti più disparati dando l’idea (l’illusione) di una piena intellegibilità del corso della Storia.
Da questo punto di vista, dunque, il proliferare delle post-verità è strettamente legato alla crescente complessità del mondo contemporaneo e a un concetto di comunità – quello nato nelle società occidentali con la piena modernità – sempre più sfilacciato e sostanzialmente inadatto a spazi politici, economici e culturali polverizzati e in perenne mutamento. Le verità alternative, infatti, offrono un pacchetto di informazioni in grado di adattarsi facilmente ai contesti più disparati dando l’idea (l’illusione) di una piena intellegibilità del corso della Storia.
Per spiegare il successo delle narrazioni del complotto nella società odierna, non come mere sopravvivenze di un’arcaica “mentalità prelogica” alla Lévy-Bruhl, bensì come atti costitutivi e performativi del contemporaneo tessuto socio-politico, Di Cesare risale fino agli albori della modernità e rievoca uno dei suoi momenti fondanti: la Rivoluzione francese. Riprendendo le tesi dello storico François Furet, rintraccia nella fine della monarchia, e nell’apoteosi del popolo sovrano all’indomani dell’esecuzione di Luigi XVI, l’atto di nascita della democrazia occidentale. Questa circostanza, così decisiva per il corso della storia europea, ha innescato però un curioso caso di eterogenesi dei fini instillando un interrogativo destinato a restare inevaso: scomparsa la persona fisica del monarca, garante e incarnazione dell’autorità, dove va rintracciato adesso il potere? La risposta sembra facile: il potere risiede nella parola del popolo, nel suffragio (il rito con cui i cittadini, non più sudditi, sono chiamati ciclicamente ad esprimersi). Ma allo stesso tempo la risposta è sconcertante: tutto qui? Il potere del popolo, scrive Di Cesare, non ha sostanza, «è un enigma, un misterioso “vuoto” che, a ben guardare, si riempie presto di spettri […]: dietro l’apparenza del potere appena conquistato si nasconde il potere reale di forze occulte. Questo immaginario sopperisce all’idea del sovrano. È la stessa metafisica che, impedendo di congedarsi dal mito del potere, favorisce il complotto».
 La democrazia, dunque, fin dai suoi esordi ha a che fare col “vuoto” e, per converso, sconta un inesausto bisogno di “pienezza”. Allontanando l’assoluto senza averci mai fatto veramente i conti, essa ha conservato il desiderio di risalire a un archè sostanziale alimentando sotterraneamente il germe della macchinazione, ovvero l’idea che una cricca di agenti occulti, nascosta in un retromondo, possa reggere davvero le sorti della società e dello Stato. Tale tendenza, col tempo, non ha fatto che crescere nutrendosi dei piccoli-grandi fallimenti che la democrazia ha lasciato per strada – l’inevitabile tradimento del sogno della trasparenza e dell’eguaglianza assolute; la frustrazione di una parte della popolazione esclusa dai benefici del nuovo sistema e, soprattutto negli ultimi vorticosi decenni, lo smarrimento di fronte a un potere meno locale e, di conseguenza, sempre più lontano e senza volto.
La democrazia, dunque, fin dai suoi esordi ha a che fare col “vuoto” e, per converso, sconta un inesausto bisogno di “pienezza”. Allontanando l’assoluto senza averci mai fatto veramente i conti, essa ha conservato il desiderio di risalire a un archè sostanziale alimentando sotterraneamente il germe della macchinazione, ovvero l’idea che una cricca di agenti occulti, nascosta in un retromondo, possa reggere davvero le sorti della società e dello Stato. Tale tendenza, col tempo, non ha fatto che crescere nutrendosi dei piccoli-grandi fallimenti che la democrazia ha lasciato per strada – l’inevitabile tradimento del sogno della trasparenza e dell’eguaglianza assolute; la frustrazione di una parte della popolazione esclusa dai benefici del nuovo sistema e, soprattutto negli ultimi vorticosi decenni, lo smarrimento di fronte a un potere meno locale e, di conseguenza, sempre più lontano e senza volto.
Ecco allora che oggi, in un mondo interconnesso e retto da forze sempre meno intellegibili con le vecchie categorie stato-centriche e nazionali, la matrice del complotto torna in auge: non come rimosso non irrelato, ma come fiume carsico che all’occorrenza riaffiora. Come sostanza mitica, insomma. Anzi, per usare le illuminanti riflessioni di Furio Jesi, come vera e propria «macchina mitologica»: un dispositivo in grado di saldare indissolubilmente la fredda pervasività della tecnologia a un linguaggio fatto di «idee senza parole», astorico ed eterno. Un dispositivo utile a fornire risposte certe in uno spazio precario, in cui anche lo stesso Stato, sempre più compromesso con la tecnica e il capitalismo apolide, appare un teatro di marionette animate da perfidi burattinai.
Le narrazioni complottistiche nascono pertanto da problemi sociali concreti, terribilmente attuali, che hanno grande influenza sull’opinione pubblica dei Paesi occidentali. Il loro brodo di coltura è dato dalla crisi della partecipazione politica e dalle controfinalità del sistema democratico (dalle sue promesse tradite). I loro fruitori, allora, non sono (solo) sprovveduti creduloni e vittime di un ritorno al pensiero magico, bensì persone in larga parte disorientate, isolate e progressivamente escluse dall’arena pubblica. Figure, aggiungerei, che reagiscono alla demartiniana “crisi della presenza” eleggendo il dubbio a Principio e votandosi, paradossalmente, a una sorta di iper-razionalità indiziaria figlia di quella che Valentina Pisanty, in un fondamentale lavoro sul negazionismo filo-nazista, definiva «paranoia interpretativa»: l’ansia di colmare ogni vuoto, di spiegare tutto, di trovare un agente intenzionale, di ricorrere ossessivamente al principio di causalità e di fuggire come la peste ogni casualità.
 Ecco perché affrontare il complottista sul terreno della razionalità normativa e censoria non conduce a nulla, se non a polarizzare le posizioni: numeri, tabelle, fonti accreditate possono ben poco quando a monte non si riconosce alcun principio di autorità palese e si crede, piuttosto, che la vera trama si ordisca altrove.
Ecco perché affrontare il complottista sul terreno della razionalità normativa e censoria non conduce a nulla, se non a polarizzare le posizioni: numeri, tabelle, fonti accreditate possono ben poco quando a monte non si riconosce alcun principio di autorità palese e si crede, piuttosto, che la vera trama si ordisca altrove.
Impostando il problema da una tale prospettiva, Di Cesare dedica un’ampia sezione del suo lavoro al preoccupante legame oggi instauratosi tra complottismo e populismo: il vero nodo politico della questione e dell’intero suo ragionamento. Quel “vuoto di potere”, che secondo Claude Lefort è l’atto primo e rivoluzionario della democrazia, non può essere riempito da nessuno, nemmeno dal popolo «se non in senso simbolico, mai sostanziale e identitario». Tuttavia, continua Di Cesare, l’ansia connaturata al sistema democratico favorisce, soprattutto in certi momenti, tentativi di occupazione fisica di un luogo, quello del potere, che deve restare vacante, pena la fine della democrazia stessa.
Ecco che allora la finzione “popolo” si reifica: si chiude in un corpo comunitario a tenuta stagna, espelle all’esterno ogni alterità e si oppone, compatto e indivisibile come si rappresenta, a delle élite altrettanto compatte e indivisibili. Non è un caso che in questa epoca di crisi, segnata da incertezza, risentimento e progressivo distacco dalla politica, personaggi come Trump, Bolsonaro, Orbán, Salvini e Meloni abbiano ricoperto (o ricoprano) posizioni autorevoli; e non è un caso che queste figure abbiano, più o meno apertamente, flirtato con negazionisti e complottisti di varia estrazione. Così come non è un caso, infine, che abbiano potuto agire, di fatto indebolendo la democrazia, proprio in difesa della democrazia da agenti esterni:
«Demagoghi e agitatori, veri protagonisti del neopopulismo, mirano a un “ritorno al popolo” […] per coltivare la recriminazione e fomentare la protesta dei risentiti che, riscoprendo il buon senso popolare, la rude furbizia delle masse, le care vecchie abitudini del volgo, possono finalmente scaricare il loro risentimento contro l’élite, i “poteri forti”, i tecnocrati, gli esperti, gli intellettuali radical chic».
Si tratta di una strategia che, a dispetto degli slogan scanditi, realizza un vero e proprio meccanismo di depoliticizzazione in cui il conflitto sociale viene disinnescato e in cui lo scontro politico assume i tratti di una apocalittica lotta tra il Bene e il Male senza reale possibilità di vittoria. Una battaglia, fomentata da politici di professione e avvelenatori di pozzi, che per il seguace che si abbevera alle loro fonti è ambivalente: appagante per il perturbante brivido provocato dall’accesso al vero volto del potere e dal senso di appartenenza a una comunità di impavidi; frustrante perché senza fine e inevitabilmente votata allo scacco (al fondo di ogni complotto, infatti, c’è sempre un altro complotto). Uno scontro in ultima analisi velleitario, che trasformando progressivamente l’individuo risentito in “vittima” finisce per condannarlo all’apatia distogliendo la sua attenzione dal “qui e ora” e indirizzando il suo malcontento verso obiettivi irraggiungibili: il Deep State, il Capitale, la Finanza predatrice, i Poteri forti, la Medicina ufficiale, la Lobby LGBTQ, i Padroni dell’immigrazione e della sostituzione etnica; per non parlare, nelle frange se possibile più estreme, degli eterni ebrei e degli altri tradizionali capri espiatori.
 A prima vista queste affermazioni potrebbero lasciare più di qualche dubbio: in fondo non stiamo assistendo proprio in questi giorni al montare di una protesta che, partita dal cyberspazio, occupa ormai stabilmente le piazze reali? Non si potrebbe, cioè, essere tentati di affermare che le mobilitazioni contro le misure di contenimento della pandemia siano, indipendentemente dal giudizio che se ne può dare, la dimostrazione di una rinnovata partecipazione politica? Se la risposta a queste domande fosse affermativa, le riflessioni di Di Cesare ne uscirebbero in effetti depotenziate. Tuttavia, a ben vedere, le sue parole permettono di inquadrare uno degli scandali per me più grandi dei suddetti movimenti di protesta, non per nulla colonizzati dalle destre: il progressivo scivolamento del popolo che manifesta da démos a éthnos. Non più, come dice la stessa autrice, plebe o proletariato che con coscienza di classe si oppongono al capitale produttivo e al suo volto visibile (la fabbrica, l’imprenditore, le concrete misure socio-economiche governative), bensì “comunità d’origine e di destino” che spara a zero sulle ingerenze esterne ostentando un’identità tribale. Non più insieme di soggettività con rivendicazioni e interessi di parte, ma entità compatta e impermeabile, i cui membri non hanno pudore nell’accompagnarsi ai più sordidi gruppuscoli neofascisti e, non a caso, occultano ogni differenza trincerandosi dietro la mistica del corpo intangibile (vero e proprio spazio sacro).
A prima vista queste affermazioni potrebbero lasciare più di qualche dubbio: in fondo non stiamo assistendo proprio in questi giorni al montare di una protesta che, partita dal cyberspazio, occupa ormai stabilmente le piazze reali? Non si potrebbe, cioè, essere tentati di affermare che le mobilitazioni contro le misure di contenimento della pandemia siano, indipendentemente dal giudizio che se ne può dare, la dimostrazione di una rinnovata partecipazione politica? Se la risposta a queste domande fosse affermativa, le riflessioni di Di Cesare ne uscirebbero in effetti depotenziate. Tuttavia, a ben vedere, le sue parole permettono di inquadrare uno degli scandali per me più grandi dei suddetti movimenti di protesta, non per nulla colonizzati dalle destre: il progressivo scivolamento del popolo che manifesta da démos a éthnos. Non più, come dice la stessa autrice, plebe o proletariato che con coscienza di classe si oppongono al capitale produttivo e al suo volto visibile (la fabbrica, l’imprenditore, le concrete misure socio-economiche governative), bensì “comunità d’origine e di destino” che spara a zero sulle ingerenze esterne ostentando un’identità tribale. Non più insieme di soggettività con rivendicazioni e interessi di parte, ma entità compatta e impermeabile, i cui membri non hanno pudore nell’accompagnarsi ai più sordidi gruppuscoli neofascisti e, non a caso, occultano ogni differenza trincerandosi dietro la mistica del corpo intangibile (vero e proprio spazio sacro).
Un corpo che, nelle parole e nelle rivendicazioni dei capipopolo, diventa sinistramente affine al corpo inviolabile della nazione da difendere a tutti i costi contro i perfidi agenti stranieri e le loro quinte colonne. Il tema del colore dell’opposizione alle misure di prevenzione e contenimento della pandemia è oggi piuttosto discusso. Il collettivo Wu Ming (2021), ad esempio, ha rivendicato l’importanza di una critica da sinistra alla gestione dell’emergenza per evitare che il disorientamento della gente di fronte a un’azione governativa non sempre irreprensibile possa lasciare, come di fatto sta accadendo, il monopolio della piazza alla destra reazionaria. È necessario, continua Wu Ming, infondere dignità a un risentimento popolare basato su «nuclei di verità», ma che in mancanza di cultura politica spesso si indirizza a obiettivi fantasmatici arrendendosi al complottismo. Il punto di vista, che presenta talune affinità con il pensiero di Di Cesare, è interessante, ma non convince appieno. In discussione, infatti, non c’è l’adesione a una «pax pandemica» che, in nome dell’emergenza, rifiuti ogni dissenso, bensì la qualità del dissenso stesso: no vax e cospirazionisti possono essere interlocutori credibili? Come le reiterate, e spesso scomposte, prese di posizione di Giorgio Agamben e Massimo Cacciari, dunque, voci di questo tipo finiscono con il confondersi al pastiche populista/cospirazionista e con l’attizzare involontariamente un sentimento pre-politico che alimenta ideologie discutibili: dal rossobrunismo al comunismo non di sinistra, dal libertarismo di destra al sovranismo di sinistra.
C’è una sola parola, allora, per un atteggiamento di tal fatta, ed è populismo: «come il totalitarismo lo è stato nel XX secolo, così nel XXI il populismo complottista è la forma autoimmune e distruttiva che la democrazia ha assunto in un vorticoso autolesionismo». Esiste un antidoto? Di Cesare, come spero di aver mostrato, avanza l’ipotesi che la crisi della tenuta democratica nelle nostre società stia alla base del sempre più inquietante successo dei discorsi complottisti. Più la politica e la gestione del potere si fanno distanti, più si cercano risposte immediate (nel senso di rapide e non mediate), più il populismo e l’antipolitica crescono innescando un tragico circolo vizioso. L’autrice suggerisce allora una possibile via d’uscita: dopo aver difeso la teoria critica (decostruzionista, post-strutturalista, ermeneutica, post-modernista) dall’accusa di essere stata una cattiva maestra, auspica la ristrutturazione di spazi di autentica partecipazione politica e, soprattutto, una rinnovata educazione all’esercizio del dubbio che sfugga però ogni trappola reificante. Come sosteneva anche Marc Bloch, infatti, l’iper-scettico che ha innalzato il sospetto a Dogma finisce sempre con l’essere iper-credulo e, lo abbiamo visto, a condannarsi a una sostanziale inazione (funzionale alla perpetuazione del sistema cui a parole si oppone e strumentalizzabile da cinici demagoghi).
Proprio perché il complottismo è un’arma di depoliticizzazione di massa s’impone allora un suo studio approfondito e lontano da facili scorciatoie. Sono le dinamiche delle nostre società, dunque, che dobbiamo comprendere prima di giudicare senza alcuna indulgenza. Le argomentazioni dell’interlocutore con cui ho aperto questo scritto – portavoce scelto arbitrariamente (e provocatoriamente) per esemplificare lo spettro delle contemporanee post-verità – sono (anche) espressione di un disagio sociale che non può essere sottovalutato. Un risentimento che tuttavia non ha veri sbocchi, incapace com’è di avanzare una concreta visione alternativa; espressione, piuttosto, di una tensione metafisica (volta a scovare piani e inganni orditi in un retromondo) che perde contatto con la realtà (e le sue vere storture) e scivola inesorabilmente nella diversione politica.
Se in fondo ci riflettiamo un attimo, anche la difesa ossessiva da parte di no-vax e no-Green Pass della libertà individuale (calpestata, violata, negata dal Capitale che vuole avviare il Great Reset, dalla Medicina ufficiale che vuole imporre il controllo bio-politico dei corpi, dalle marionette al governo che seguono la rotta tracciata dal Nuovo Ordine Mondiale) non si fa mai critica sistemica, bensì involontario ventriloquio di categorie e concetti propri dell’attuale governance ultraliberista. E mi torna alla mente, allora, il commento di Ugo Fabietti a uno dei passaggi più dibattuti dell’opera di Claude Lévi-Strauss. Lo riporto integralmente perché, insieme alle tesi sviluppate da Donatella Di Cesare, mi sembra cogliere alla perfezione lo spirito dei tempi che stiamo attraversando:
«E c’è infine la questione della libertà. Come negare, oggi, la presenza di discorsi che pretendono di mettere al centro l’individuo con la sua dignità, i suoi diritti, le sue necessità […] contro teorie sociali e filosofiche accusate di astrattezza e autoritarismo? Ora, se questi “discorsi” possono inclinare verso una maggiore attenzione per la persona “concreta” come contrapposta a un individuo “astratto”, essi possono anche nascondere proprio ciò che di quell’idea astratta di libertà è il prodotto: una vecchia conoscenza, in fondo, l’homo economicus nelle sue molte sfaccettature. Un individuo “privato” in quanto (illusoriamente) “privo” di un contesto sociale […] e che inveisce contro le regole e le leggi viste come impedimenti al “diritto alla propria realizzazione”. Aveva forse torto Lévi-Strauss quando, allarmato, citava il paradosso di Montesquieu: “dopo essere stati liberi grazie alle leggi si vorrà essere liberi contro di loro?» (Fabietti 2010: 11-12).
Dialoghi Mediterranei, n. 53, gennaio 2021
Riferimenti bibliografici
Di Cesare D. 2021, Il complotto al potere, Einaudi, Torino.
Fabietti U. 2010, Claude Lévi-Strauss: profeta dei tempi moderni?, in I quaderni del CREAM, n, 10: 5-12.
Furet F. 2009, Penser la Rèvolution Française, Gallimard, Paris
Jesi F. 2011, Cultura di destra, Nottetempo, Milano.
Lefort C 2007, La questione della democrazia, in Id., Saggi sul politico. XIX-XX secolo, Il Ponte, Bologna
Pisanty V. 2018, L’irritante questione delle camere a gas. Logica del negazionismo, Bompiani, Milano.
Wu Ming 2021, Un’intervista sul green pass, le fantasie di complotto e le forme del conflitto sociale a venire, 19 novembre 2021,
https://www.wumingfoundation.com/Intervista_WM_Jungle_world_su_lotte_no_green_pass.pdf
_____________________________________________________________
Dario Inglese, ha conseguito la laurea triennale in Beni Demo-etnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo e la laurea magistrale in Scienze Antropologiche ed Etnologiche presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. Si è occupato di folklore siciliano, cultura materiale e cicli festivi. A Milano, dove insegna in un istituto superiore, si è interessato di antropologia delle migrazioni e ha discusso una tesi sull’esperimento di etnografia bellica Human Terrain System.
______________________________________________________________










