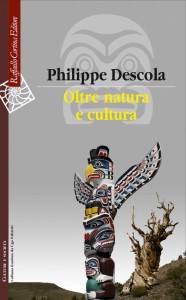Sono stati gli antichi Greci i primi a porre una netta separazione fra la natura, physis, e il logos, attività razionale dell’uomo e strumento di conoscenza, aprendo la strada di fatto al pensiero moderno dell’Occidente. A partire dal secolo XVII, quando Cartesio considerava la res extensa e la res cogitans come entità a sé stanti, un concetto che verrà poi sviluppato dall’idealismo hegeliano, erano già fissati i parametri di quel naturalismo scientifico che avrebbe posto l’uomo al centro dell’universo, in grado di controllare il mondo esterno con criteri oggettivi.
Da quel momento tutte le arti e le scienze occidentali sembravano convergere su una distinzione fra il mondo naturale e quello umano: sia nella pittura con l’elaborazione della prospettiva lineare che ricomponeva i paesaggi in uno spazio razionale e matematicamente costruito, sia nella scienza vera e propria con l’invenzione di dispositivi meccanici tali da sottoporre il reale all’osservazione e all’analisi dell’osservatore. Una natura ridotta a campo di ricerca e sperimentazione dove l’uomo arbiter è entità a parte, dotato non soltanto di istinti e pulsioni come gli animali, ma della capacità di elaborare il pensiero, di comunicare tramite il linguaggio entrando in relazione con gli altri. L’unico in grado di trasformare la natura creando un’organizzazione sociale attraverso le istituzioni, gli apparati simbolici e i rituali, i sistemi di parentela e tutto quello che gli antropologi definiscono cultura, una prerogativa squisitamente umana.
Il dualismo natura/cultura è stato, com’è noto, il principio fondativo e lo statuto epistemologico di tutta l’antropologia culturale del Novecento, disciplina nata in pieno clima positivista e nell’ambito di una politica coloniale. Già a partire dalla celebre definizione di Tylor del 1871 (la cultura è quell’insieme complesso…), l’organizzazione sociale delle varie comunità, pur considerata come stadio elementare di un percorso evolutivo più complesso, sembrava staccarsi dal referente naturale per assumere una dimensione propria.
Anche nella stagione successiva, quella del relativismo culturale e del funzionalismo anglosassone del Novecento, le culture potevano configurarsi come trame interdipendenti dalla natura. Sarà poi Lévi-Strauss e tutta la scuola dello strutturalismo francese a riconsiderare la cultura come uno schema astratto di tipo logico, una dimensione inconscia dello spirito umano che soggiace al divenire dei fenomeni, riportandone le diversità apparenti a poche regole combinatorie di opposizione e correlazione. Così i sistemi di parentela e il complesso dei miti nelle società primitive. Malgrado questi diversi approcci, restava ferma la convinzione che solo l’uomo è un produttore di cultura e può per questo trasformare la materia e renderla conoscibile.
A rimescolare le carte mettendo in discussione proprio quella radicale dicotomia natura/cultura è ora Philippe Descola, allievo di Lévi-Strauss, col suo libro Oltre natura e cultura, pubblicato nel 2005 e oggi in una nuova edizione a cura di Nadia Breva (Raffaello Cortina). Uno studio denso e consistente che fa riferimento ad un’ampia documentazione etnografica, frutto di lunghe permanenze dello studioso fra i popoli dell’Amazzonia. L’intento è quello di decostruire il principio di separazione fra l’uomo e tutte le altre specie viventi, dimostrando che il naturalismo dei popoli occidentali non è un fatto universale ma relativo, che nasce all’interno di una storia particolare del pensiero scientifico e sulla base di una determinata concezione della natura.
Considerare l’uomo come essere a sé stante, capace di elaborazione concettuale è una delle tante possibilità, ma non l’unica in assoluto, come si evince da una serie di esperienze vissute in aree geografiche lontane. Dove il confine fra l’uomo e le altre specie viventi è molto labile visto che anche gli animali e le piante condividono la facoltà del pensiero, della coscienza e della memoria. Presso gli Achuar, ad esempio, una popolazione della foresta amazzonica peruviana, le donne, i cacciatori e gli anziani considerano gli animali e le piante come loro pari e nessuno oserebbe dimostrare di essere superiore ad un giaguaro, a una scimmia lanosa o a un tucano. A differenza del punto di vista naturalista occidentale, umani e non umani non fanno parte di due mondi autonomi, impossibilitati a comunicare per le loro insormontabili diversità, ma vivono all’interno di una medesima ontologia dominata dall’animismo, in cui tutte le specie viventi sono dotate di un principio razionale che va al di là del loro aspetto fisico differente.
Sarebbe forse più opportuno a questo punto sostituire i termini natura/cultura con l’interiorità come coscienza di sé, della memoria e dei sentimenti, e l’esteriorità che è la dimensione fisica e corporea di ogni entità. Si tratta ora di capire con Descola come questi fattori costitutivi delle specie viventi entrino in gioco diversamente, dando luogo a varie ontologie: l’animismo, secondo cui vi è un’interiorità comune a tutti gli esistenti pur nelle diverse esteriorità; il totemismo, attraverso cui determinati segmenti sociali discendono da animali o piante, mettendo così in corrispondenza differenti interiorità e esteriorità; l’analogismo che frammenta l’insieme di umani e non umani in una molteplicità di forme e sostanze separate per ricomporle in una rete di analogie; il naturalismo, prodotto dalla società occidentale, che riconosce differenze di interiorità (attribuite solo agli umani) e somiglianze delle fisicità (natura). Queste diverse forme ontologiche sono frutto del principio di identificazione, uno schema cognitivo che insieme alla relazione dà vita a uno specifico modo di organizzazione del sistema degli esistenti. Da qui i collettivi, gruppi sociali che solo parzialmente corrispondono a quello che comunemente si intende per sistema sociale. Essi riuniscono in un destino comune i vari tipi di essere, rendendo possibile il loro agire nella vita pratica. In altre parole ciascuna di queste forme di identificazione definisce uno specifico rapporto col mondo.
Accade tuttavia che all’interno dell’animismo o del totemismo, ad esempio, è possibile imbattersi in collettivi molto diversi tra loro e non soltanto per la differenza delle istituzioni o della lingua, ma anche per la natura delle loro interazioni. La relazione è anch’essa, come l’identificazione, una struttura cognitiva e, fra le entità che popolano l’universo, Descola ne individua sei tipologie: lo scambio, relazione simmetrica fra due o più parti che implica l’obbligo di una reciprocità; la predazione e il dono, asimmetriche nel senso che non comportano il dovere della restituzione; la produzione, tipica forma di relazione del capitalismo occidentale che mette in opera una trasformazione della materia finalizzata al consumo; la protezione, come quella delle istituzioni nei confronti dei cittadini e infine la trasmissione che può essere morale, storica, immateriale o materiale come l’eredità dei beni testamentari dei defunti ai propri familiari .
A conclusione del suo lungo excursus presso i popoli extraeuropei, l’autore confessa di non avere alcuna pretesa valutativa, ma solo l’intenzione di mostrare
«modi diversi di analizzare i fenomeni sociali, non considerandoli come quella caratteristica che conferisce dignità alla nostra specie, ma sforzandosi di meglio comprendere i princìpi grazie ai quali gli umani schematizzano in modo così diverso le loro esperienze delle cose, accogliendo con maggiore o minore liberalità alcuni non umani all’interno dei loro collettivi e attualizzando o meno in sistemi di interazioni concrete le relazioni che essi riconoscono tra gli esistenti».
Rispetto alle costruzioni armoniose che il dualismo natura cultura ci aveva abituato a erigere, Descola pensa piuttosto a un cantiere aperto in cui il direttore dei lavori non ha alcuna fretta di accelerare la consegna. L’antropologo invita tutti a liberarsi da quei pregiudizi che la modernità ci ha indotti ad avere sullo stato del mondo: occorre infatti un ripensamento su nuovi modi di concepire la diversità, prima che sia troppo tardi. È auspicabile con una certa urgenza una riforma radicale dell’assetto internazionale delle società occidentali a capitalismo avanzato per impedire quelle lacerazioni dovute a un’enorme disparità delle condizioni di esistenza tra i Paesi del Sud e quelli del Nord o al degrado allarmante dei grandi equilibri della biosfera per effetto dell’azione umana.
La questione è complessa e non si risolve certo nella scelta di modello di vita ritenuto migliore di un altro e non è detto
«che gli Amerindiani dell’Amazzonia, gli Aborigeni australiani o i monaci del Tibet possano offrire soluzioni adeguate o dimostrare una saggezza più profonda rispetto a quella del naturalismo occidentale…Ogni tipo di presenza nel mondo – così nel suo epilogo finale – ogni maniera di legarsi ad esso e di farne uso costituisce un compromesso specifico tra dei dati dell’esperienza sensibile accessibile a tutti, ma diversamente interpretati e un modo di aggregazione degli esistenti adattato alle circostanze storiche: nessuno di questi compromessi, per quanto degni di ammirazione siano a volte, è in grado di offrire una fonte di insegnamento che sia adeguata a tutte le situazioni…Spetta a ciascuno di noi, là dove si trova, inventare e far prosperare modi di conciliazione e tipi di pressione capaci di condurre a una universalità nuova, al contempo aperta a tutte le componenti del mondo e rispettosa di alcuni dei loro particolarismi. Potremo allora sperare di scongiurare quel lontano punto di non ritorno a cui la nostra passività rischia di portare, passività che pagheremmo con l’estinzione della nostra specie, ma anche abbandonando al cosmo una natura diventata orfana dei suoi relatori per il fatto di non averle saputo concedere autentici mezzi di espressione».
La riproposta di questo volume giunge pertanto molto opportuna nell’attuale scenario contemporaneo in cui è necessario un ripensamento critico di quella fiducia smisurata nell’uomo e nelle sue potenzialità infinite di controllo e di sfruttamento della natura, che sorte in ambito naturalista e positivista, avevano offerto il braccio al sistema di accumulazione capitalistica e al liberismo dei popoli occidentali. Alla luce dei problemi insorti nel Terzo Millennio relativi ai disastri ambientali, alle pandemie, al terrorismo e alle fughe dei migranti da guerre e carestie con le stragi conseguenti, c’è da chiedersi infatti fino a quando potrà essere sostenibile quell’antropocentrismo che è stato il perno di tutta la nostra tradizione occidentale.
Dialoghi Mediterranei, n. 51, settembre 2021
______________________________________________________________
Orietta Sorgi, etnoantropologa, ha lavorato presso il Centro Regionale per il catalogo e la documentazione dei beni culturali, quale responsabile degli archivi sonori, audiovisivi, cartografici e fotogrammetrici. Dal 2003 al 2011 ha insegnato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo nel corso di laurea in Beni Demoetnoantropologici. Tra le sue recenti pubblicazioni la cura dei volumi: Mercati storici siciliani (2006); Sul filo del racconto. Gaspare Canino e Natale Meli nelle collezioni del Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino (2011); Gibellina e il Museo delle trame mediterranee (2015); La canzone siciliana a Palermo. Un’identità perduta (2015); Sicilia rurale. Memoria di una terra antica, con Salvatore Silvano Nigro (2017).
______________________________________________________________