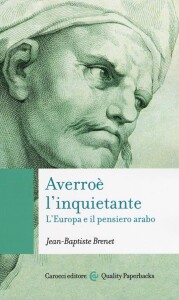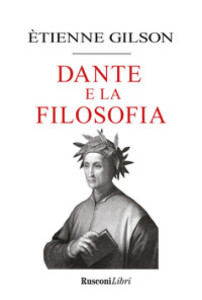Gli “smeraldi” di Beatrice
Nel trentesimo canto del Purgatorio Virgilio scompare, per cedere a Beatrice il suo ruolo di guida, dopo l’ingresso nel paradiso terrestre. E allora Dante si volge verso il “dolcissimo padre”, ma non lo vede più, e per il dispiacere piange (vv. 49-50). Ora è Beatrice che gli sta dinnanzi, e quasi lo rimprovera per quel suo pianto, e poi subito lo rincuora rammentandogli il senso stesso del suo viaggio, che l’ha condotto nel luogo in cui si compie la vera felicità umana: felicità purissima del cuore e della mente, che l’uomo può raggiungere solo liberandosi dal peccato (l’Inferno), e da tutte le sue scorie (il Purgatorio).
Ma perché Beatrice appare proprio sulla vetta del Purgatorio? E cosa accade più precisamente in quel momento? La risposta scaturisce tutta in pochi versi del canto trentunesimo (vv. 121-129), che non possono non lasciarci stupefatti. Accade, in sostanza, che Dante vive qui la sua prima estasi. È qui che si verifica la prima trasmutazione della sua anima, dapprima nella luce sfolgorante degli occhi di Beatrice (gli “smeraldi”), poi nella contemplazione gustativa del mistero della doppia natura del Cristo, simboleggiata dalla “doppia fiera”, il Grifone, che in quegli occhi si riflette in tutta la sua chiarezza:
Come in lo specchio sol, non altrimenti
la doppia fiera dentro vi raggiava,
or con altri, or con altri reggimenti.
Pensa, lettor, s’io mi maravigliava,
quando vedea la cosa in sé star queta,
e nell’idolo suo si trasmutava.
Mentre che piena di stupore e lieta
l’anima mia gustava di quel cibo
che, saziando di sé, di sé asseta…
 Dante realizza dunque il suo primo atto di conoscenza spirituale: la sua anima conosce la verità dal vivo, la gusta come un cibo, sperimentandola in un lampo d’intuizione luminosa e soprannaturale. Ed è solo il preambolo di quello che gli accadrà al culmine del suo viaggio, quando l’occhio del suo spirito penetrerà il mistero cosmico del Dio-Amore 1. Ma ora, qui, quello che a noi importa rilevare è che tutto questo teatro di simboli non è una messinscena di fredde, astratte allegorie. Nonostante il suo apparato dottrinale, la Divina Commedia non è un trattato di etica o di teologia mistica: è il poema di una vita, la vita di un uomo chiamato Dante Alighieri. Virgilio, Beatrice, Bernardo, che sono tre aspetti – o tre gradi di manifestazione – della stessa guida celeste, la divina Sapienza, sono in realtà idee-immagini che rappresentano le fasi del processo trasmutativo che avviene nella mente e nel cuore del poeta. Lo psicodramma della Commedia si svolge tutto in interiore homine. Dante dialoga con se stesso, e mette in scena la sua trasmutazione, come in un sogno grandioso, intessuto di tutte le nozioni, le suggestioni e i ricordi accumulati nella sua sofferta esperienza e nella sua immensa cultura.
Dante realizza dunque il suo primo atto di conoscenza spirituale: la sua anima conosce la verità dal vivo, la gusta come un cibo, sperimentandola in un lampo d’intuizione luminosa e soprannaturale. Ed è solo il preambolo di quello che gli accadrà al culmine del suo viaggio, quando l’occhio del suo spirito penetrerà il mistero cosmico del Dio-Amore 1. Ma ora, qui, quello che a noi importa rilevare è che tutto questo teatro di simboli non è una messinscena di fredde, astratte allegorie. Nonostante il suo apparato dottrinale, la Divina Commedia non è un trattato di etica o di teologia mistica: è il poema di una vita, la vita di un uomo chiamato Dante Alighieri. Virgilio, Beatrice, Bernardo, che sono tre aspetti – o tre gradi di manifestazione – della stessa guida celeste, la divina Sapienza, sono in realtà idee-immagini che rappresentano le fasi del processo trasmutativo che avviene nella mente e nel cuore del poeta. Lo psicodramma della Commedia si svolge tutto in interiore homine. Dante dialoga con se stesso, e mette in scena la sua trasmutazione, come in un sogno grandioso, intessuto di tutte le nozioni, le suggestioni e i ricordi accumulati nella sua sofferta esperienza e nella sua immensa cultura.
E allora, eccoci di nuovo a ripetere a noi stessi la domanda: perché Beatrice appare proprio sulla vetta del monte del Purgatorio? Perché i suoi “smeraldi” si accendono di splendore proprio qui, mandando il poeta in estasi? Che senso può avere questo avvenimento nel gran teatro della cultura di Dante? È a questo punto che può essere di decisiva importanza ricordare un fatto fondamentale: che quella cultura, soprattutto nei campi della scienza e della filosofia, è letteralmente impregnata di greco-arabismo. A cominciare proprio dalle nozioni di astronomia tolemaica – assolutamente centrali nell’universo mentale di Dante e nella struttura del suo poema – che il poeta apprese sostanzialmente dal Libro dell’aggregazione delle stelle dell’astronomo arabo Al-Farġānī 2. Ma anche da quelle che potremmo definire della cosmologia mistica, o filosofica – di Al-Fārābī, di Avicenna e di Al-Ġazālī – che Dante dovette conoscere soprattutto attraverso l’esposizione di Alberto Magno 3.
 Fedeli alla parola stessa di Dante, cerchiamo perciò la risposta nel suo poema. Ecco allora, nel secondo canto dell’Inferno, una terzina luminosa (vv. 76-78), che ci rischiara a giorno la via. È Virgilio che parla. Deve mettere in fuga i dubbi di Dante, che teme di non essere degno di esplorare da vivo i regni dell’oltretomba. E allora gli racconta di Beatrice, di quella donna “beata e bella” che lo chiamò per invitarlo a soccorrere un suo amico che s’era smarrito, promettendogli in cambio la lode perenne dinanzi al suo Signore. E a quell’invito, che egli prese per un comandamento, subito rispose iniziando con queste parole:
Fedeli alla parola stessa di Dante, cerchiamo perciò la risposta nel suo poema. Ecco allora, nel secondo canto dell’Inferno, una terzina luminosa (vv. 76-78), che ci rischiara a giorno la via. È Virgilio che parla. Deve mettere in fuga i dubbi di Dante, che teme di non essere degno di esplorare da vivo i regni dell’oltretomba. E allora gli racconta di Beatrice, di quella donna “beata e bella” che lo chiamò per invitarlo a soccorrere un suo amico che s’era smarrito, promettendogli in cambio la lode perenne dinanzi al suo Signore. E a quell’invito, che egli prese per un comandamento, subito rispose iniziando con queste parole:
O donna di virtù, sola per cui
l’umana spezie eccede ogni contento
di quel ciel ch’ha minor li cerchi sui…
Ma noi sappiamo che quella sfera celeste, che ha la circonferenza più piccola di tutte le altre, è la sfera della Luna. È quello il cielo che confina con il globo terrestre che sta immobile al centro dell’universo. Da quel cielo in su si susseguono i mondi delle sostanze incorruttibili, separate dalla materia, che di perfezione in perfezione ascendono, come mistica scala, verso l’Oltrespazio del Regno di Dio. Al di sotto di esso, sulla Terra, si agitano invece le creature soggette alla generazione e alla corruzione. È questa la struttura del cosmo aristotelico-tolemaico. Ma Dante aggiunge un tocco di formidabile fantasia a quell’universo già fantastico: è il monte del Purgatorio che di balza in balza sale fino a staccarsi quasi dall’orbita terrestre, e a sfiorare con la sua vetta il cielo della Luna. Ed è precisamente lì, su quella vetta, che Dante incontra Beatrice.
Dunque, consideriamo ora la terzina appena citata. Che cosa significano le parole che Virgilio rivolge a Beatrice? Parafrasiamole nel modo più chiaro:
O donna, che sola possiedi la virtù che mette in grado la specie umana di andare al di là di tutto ciò che è contenuto nella sfera di quel cielo (della Luna) i cui cerchi sono minori di quelli di tutti gli altri cieli.
Ora, com’è ben noto, nella cultura filosofica di Dante questa donna virtuosa altri non è che la Sapienza divina. Lei è infatti l’unica, ossia l’unico mezzo, che permette all’uomo di distaccarsi dalle realtà terrene, e di superarle per volare con la mente verso la conoscenza beatificante delle realtà e delle verità metafisiche. Se immaginiamo la Sapienza come un raggio di luce soprannaturale che illumina la mente umana, e se trasferiamo quest’idea nello scenario metaforico della cosmologia mistica, ecco allora giungerci chiarissima la visione della “donna di virtù”, della Beatrice (la Sapienza che rende beati) che scende dall’alto delle sfere celesti e va a incontrare Dante proprio nel punto in cui la sfera della Luna giunge quasi a sfiorare la vetta del monte del Purgatorio.
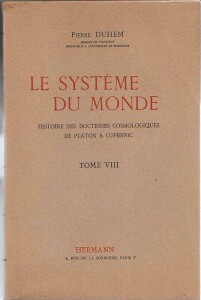 Ma quel raggio di luce divina, per Dante, non ha solo il nome di Sapienza. Nella sua mente non vivono solo gl’insegnamenti della Sacra Scrittura, di Paolo, di Agostino, di Bonaventura e di Bernardo. Dante è anche il filosofo aristotelico del Convivio e della Monarchia, imbevuto fino al midollo dei libri di Alberto Magno e di Tommaso d’Aquino, e di quel gran fiume dell’aristotelismo e del neoplatonismo islamico che, per conoscenza più indiretta che diretta, poté penetrare nella sua mente coi nomi e con le opere di quelli che lui chiamava Algazel (Al-Ġazālī), Avicenna (Ibn Sīnā), e Averoìs (Averroè, Ibn Rušd). E la Sapienza beatificante, per quei filosofi dell’Islàm, aveva il nome aristotelico di Intelligenza: l’Intelligenza attiva (al-ʽaql al-faʽʽāl, العقل الفعال) di natura divina, che irradiandosi dalle sfere celesti illumina l’intelletto degli esseri umani, che senza quella luce è solo un intelletto in potenza, ovvero una mera possibilità di possedere le idee astratte dalla materia. Per quei filosofi, il “ben dell’intelletto” era appunto un dono d’amore dell’Intelligenza attiva, e la felicità massima della vita umana, per loro, in altro non poteva consistere che nella realizzazione della nostra potenzialità intellettiva, ovvero nel congiungimento del nostro intelletto potenziale (“possibile”, dirà Dante) con la luce dell’Intelligenza attiva. Al-Fārābī, Ibn Sīnā e Al-Ġazālī erano andati anche oltre nell’immaginazione: avevano concepito l’Intelligenza attiva come l’ultima, e precisamente la decima, della gerarchia di intelligenze che – secondo i princìpi dell’emanatismo neoplatonico – davano la forma all’universo e lo governavano, associandola al cielo della Luna. Da quel cielo, essa irradiava direttamente la sua virtù sul mondo sublunare, dando forma e vita a tutte le creature – quindi, letteralmente, creandole come dator formarum, come Spirito Santo creatore – e illuminando (ossia attualizzando) l’intelletto potenziale (al-ʽaql bi-l-quwwa, العقل بالقوة) dell’uomo.
Ma quel raggio di luce divina, per Dante, non ha solo il nome di Sapienza. Nella sua mente non vivono solo gl’insegnamenti della Sacra Scrittura, di Paolo, di Agostino, di Bonaventura e di Bernardo. Dante è anche il filosofo aristotelico del Convivio e della Monarchia, imbevuto fino al midollo dei libri di Alberto Magno e di Tommaso d’Aquino, e di quel gran fiume dell’aristotelismo e del neoplatonismo islamico che, per conoscenza più indiretta che diretta, poté penetrare nella sua mente coi nomi e con le opere di quelli che lui chiamava Algazel (Al-Ġazālī), Avicenna (Ibn Sīnā), e Averoìs (Averroè, Ibn Rušd). E la Sapienza beatificante, per quei filosofi dell’Islàm, aveva il nome aristotelico di Intelligenza: l’Intelligenza attiva (al-ʽaql al-faʽʽāl, العقل الفعال) di natura divina, che irradiandosi dalle sfere celesti illumina l’intelletto degli esseri umani, che senza quella luce è solo un intelletto in potenza, ovvero una mera possibilità di possedere le idee astratte dalla materia. Per quei filosofi, il “ben dell’intelletto” era appunto un dono d’amore dell’Intelligenza attiva, e la felicità massima della vita umana, per loro, in altro non poteva consistere che nella realizzazione della nostra potenzialità intellettiva, ovvero nel congiungimento del nostro intelletto potenziale (“possibile”, dirà Dante) con la luce dell’Intelligenza attiva. Al-Fārābī, Ibn Sīnā e Al-Ġazālī erano andati anche oltre nell’immaginazione: avevano concepito l’Intelligenza attiva come l’ultima, e precisamente la decima, della gerarchia di intelligenze che – secondo i princìpi dell’emanatismo neoplatonico – davano la forma all’universo e lo governavano, associandola al cielo della Luna. Da quel cielo, essa irradiava direttamente la sua virtù sul mondo sublunare, dando forma e vita a tutte le creature – quindi, letteralmente, creandole come dator formarum, come Spirito Santo creatore – e illuminando (ossia attualizzando) l’intelletto potenziale (al-ʽaql bi-l-quwwa, العقل بالقوة) dell’uomo.
Una meravigliosa macchina cosmologica e gnoseologica, non c’è che dire. Di “rigorosa unità” e di “armoniosa bellezza”, per dirla con Pierre Duhem, che dei “sistemi del mondo” è stato forse il più grande conoscitore 4. Tanto bene architettata e tanto affascinante, che anche i sommi dottori della teologia cristiana, Alberto Magno e Tommaso d’Aquino, ne rimasero fortemente influenzati. Ne presero anche le distanze, certo. Per esempio, nella critica di Alberto all’idea che i cieli fossero dotati anche di un’anima5, o in quella di Tommaso che – contraddicendo anche Aristotele – negava l’idea che l’Intelligenza attiva fosse una creatura celeste, o, per usare correttamente i suoi termini, una forma sostanziale separata dall’anima umana 6.
Nulla di veramente drammatico, comunque, in quell’impatto della falsafa, la filosofia islamica, con il pensiero cristiano. Nulla, almeno, fino al giorno in cui, sulla scia del successo dei poderosi commenti di Averroè alle opere di Aristotele – successo che durava già da più di quarant’anni – intorno al 1265 cominciò a circolare alla Facoltà delle Arti dell’Università di Parigi una strana, inaudita teoria: gli uomini non pensano, ma sono pensati. Il pensiero non appartiene alle nostre menti, ma giunge a noi da un altrove, aggrappandosi in modo quasi inesplicabile ai fantasmi della nostra immaginazione. Ergo, l’intelligenza, quella scintilla divina, incorruttibile, immortale, non fa parte delle nostre anime. Ergo: le nostre anime non sono immortali. Ergo: l’intero edificio della fede rischiava di crollare.
Quest’idea – assai più della negazione della creatio ex nihilo e di altri dogmi teologici – scosse le menti dei dottori cristiani con la violenza di un terremoto. Era troppo pericolosa. Bisognava combatterla con ogni mezzo, perché in realtà non la si poteva liquidare come una semplice follia. Le ragioni messe in campo da Averroè erano chiare e potenti. Si trattava di una questione terribilmente seria e complicata, che rischiava di minare alle fondamenta il potere stesso della Chiesa. E un’autentica guerra filosofica stava dunque per scoppiare sulla riva sinistra della Senna, nelle vie del quartiere universitario che era allora la fucina, il cuore pulsante della cultura europea.
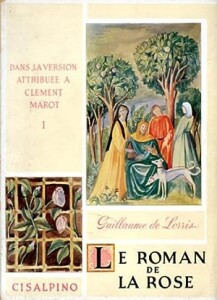 Un oscuro delitto alla corte del “Papa goloso”
Un oscuro delitto alla corte del “Papa goloso”
Nuovi e strani attori irrompono a questo punto sulla nostra scena, che nel tempo si sposta in avanti di quasi vent’anni, e nello spazio si trasferisce in Italia, a Orvieto, dove il 23 marzo del 1281 viene incoronato Papa il francese Simone de Brion, con il nome di Martino IV. Uno straniero, un granitico sostenitore dei sogni di potere di Carlo d’Angiò, un intruso per le famiglie potenti di Roma, che lo temono e lo odiano al punto da non permettergli mai di porre piede nella Città Eterna. Costringendolo, così, a stabilire la corte papale tra le mura di Orvieto. E poi ben sappiamo, da quei celebri versi di Dante (Purgatorio XXIV, vv. 20-24), di quella sua passione smodata per il vino e per la buona tavola:
… e quella faccia
di là da lui più che d’altre trapunta
ebbe la Santa Chiesa in le sue braccia:
dal Torso fu, e purga per digiuno
l’anguille di Bolsena e la vernaccia 7
Questo Papa goloso, politicante e bandito da Roma è il primo dei nostri strani personaggi. Il secondo è un attore ancora più bizzarro e imprevedibile, anche perché non appartiene alla storia, ma alla letteratura. Si chiama Falsembiante (Faus Semblanz nel francese duecentesco), ed è un’invenzione allegorica di Jean de Meun, il poeta francese che, riprendendo l’opera incompiuta di Guillaume de Lorris, terminò di scrivere il Romanzo della Rosa (Roman de la Rose) probabilmente intorno al 1278. Falsembiante è la falsità in persona, il religioso ipocrita, e in modo speciale il frate di un ordine mendicante – francescano o domenicano – che finge, appunto, di amare l’umiltà e la povertà, e invece ha sete di ricchezza, di potere e di piaceri mondani. Se approfondiamo l’analisi della sua figura, possiamo penetrare nelle vere radici storiche dell’intricata matassa politico-teologico-filosofica che stiamo qui per dipanare. Ed è ancora Dante che ci offre lo spunto per andare a fondo nella questione.
Il poeta fiorentino – sostengono alcuni, ma non tutti, perché la verità non è stata mai accertata con prove definitive – fu autore in gioventù, e forse mentre si trovava in Francia, se mai davvero vi si trovò, di un poemetto in endecasillabi intitolato Il Fiore, che egli siglò col suo nome esteso di Durante, e che altro non è se non una sorta di riassunto, parafrasi e libera rivisitazione del sopraddetto Roman de la Rose. Ed anche qui il bieco Falsembiante gioca un ruolo di tutto rispetto. Anima nera, traditore e talvolta assassino delle sue vittime, egli qui svela i suoi trucchi, racconta spudoratamente le sue malefatte, e non solo, ma pure si vanta del suo potere e delle sue vittorie. E a un certo punto (stanza XCII, vv. 9-14) confessa due delle malvagità più clamorose da lui commesse per volontà dei suoi adepti:
Mastro Sighier non andò guari lieto:
a ghiado il fe’ morire a gran dolore
nella corte di Roma, ad Orbivieto.
Mastro Guiglielmo, il buon di Sant’Amore,
feci di Francia metter in divieto
e sbandir del reame a gran romore.
Altri due personaggi si aggiungono così alla nostra storia. E benché sia la vicenda del primo, “Mastro Sighier” (ossia Sigieri di Brabante) quella che ben presto ci occuperà per intero, sarà comunque importante spendere qualche parola su quella del secondo: “Mastro Guiglielmo, il buon di Sant’Amore”, ossia il giurista e teologo Guillaume de Saint-Amour. E la ragione è semplice: il teatro dei due drammi è lo stesso, e i loro motivi di fondo presentano chiare analogie. Le due storie s’intrecciano e s’illuminano vicendevolmente, come del resto ben fa capire messer Durante accostandole in questi versi. Ma per dovere di cronaca, e di cronologia, ci tocca ora tornare a Parigi, nei chiostri e nelle vie dove i maestri universitari delle quattro facoltà (Arti, Medicina, Diritto canonico e Teologia) impartiscono i loro insegnamenti a una platea di studenti provenienti da varie parti dell’Europa.
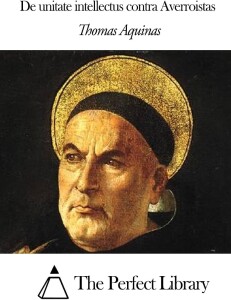 Tutto ha inizio intorno al 1220, quando sulle rive della Senna si assiste a un’inedita invasione di professori incappucciati. Il clero secolare, che fino a quel momento ha avuto il monopolio delle cattedre universitarie, ora si vede costretto a cedere prestigio e posizioni a una nuova generazione di docenti, tutti monaci, tutti appartenenti agli ordini mendicanti, domenicani e francescani. Di conseguenza, si creano tensioni, s’innescano a più riprese aspri conflitti. I secolari cominciano ad accusare i monaci di falsità, e perfino di eresia: «Il loro ideale di povertà evangelica è contrario alla dottrina di Cristo e minaccia di rovina la Chiesa», sostengono. «Si accaparrano gli studenti e ne volgono molti verso la vocazione monastica. Vivendo di elemosine non reclamano denaro in pagamento delle lezioni […] Tali sono le vere lamentele dei secolari»8. E si appellano ai pontefici nella speranza di arginare l’ondata di quei pericolosi concorrenti. Ma l’atteggiamento dei papi è oscillante, e fino a un certo momento l’esito della lotta rimane incerto.
Tutto ha inizio intorno al 1220, quando sulle rive della Senna si assiste a un’inedita invasione di professori incappucciati. Il clero secolare, che fino a quel momento ha avuto il monopolio delle cattedre universitarie, ora si vede costretto a cedere prestigio e posizioni a una nuova generazione di docenti, tutti monaci, tutti appartenenti agli ordini mendicanti, domenicani e francescani. Di conseguenza, si creano tensioni, s’innescano a più riprese aspri conflitti. I secolari cominciano ad accusare i monaci di falsità, e perfino di eresia: «Il loro ideale di povertà evangelica è contrario alla dottrina di Cristo e minaccia di rovina la Chiesa», sostengono. «Si accaparrano gli studenti e ne volgono molti verso la vocazione monastica. Vivendo di elemosine non reclamano denaro in pagamento delle lezioni […] Tali sono le vere lamentele dei secolari»8. E si appellano ai pontefici nella speranza di arginare l’ondata di quei pericolosi concorrenti. Ma l’atteggiamento dei papi è oscillante, e fino a un certo momento l’esito della lotta rimane incerto.
Poi, dopo il 1252, la situazione precipita. Il clamore della contesa supera anche il recinto dell’università, coinvolge la società civile e ispira perfino il repertorio della poesia: col già citato Jean de Meun, ma anche e soprattutto, in quel momento, con la satira corrosiva di Rutebeuf, autore tra il 1254 e il ‘55 della Discorde des Jacobins et de l’Université. Ed è allora che al centro della scena appare Guillaume de Saint-Amour. È un cinquantenne, originario della Borgogna, già docente di diritto canonico, e ora di teologia. In breve tempo egli diventa il capo della rivolta contro i frati invasori, finché, nel 1254, riesce a convincere il papa Innocenzo IV a ridurre il numero delle cattedre affidate ai maestri degli ordini mendicanti. Vittoria di breve durata, perché subito dopo Innocenzo IV muore, e al suo posto viene eletto papa Alessandro IV, che essendo protettore dei francescani non solo ribalta la situazione a favore dei frati, ma ordina un’inchiesta su Guillaume e nel 1255 lo fa sospendere dall’insegnamento.
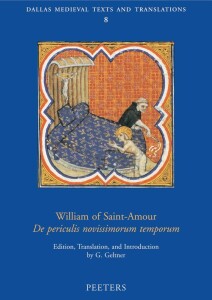 Guillaume però non si dà per vinto, e tenta l’ultima impresa disperata: scrive, e pubblica nel 1256, un feroce libello che intitola De periculis novissimorum temporum (Sui pericoli dei tempi nuovissimi), dove in toni da geremiade apocalittica si scaglia contro i mendicanti descrivendo i trentanove signa che a suo giudizio contraddistinguono la loro ipocrisia, i loro vizi e i loro abominevoli comportamenti: peccati di lussuria, di gola, di superbia e vanità, di avidità di beni terreni, disprezzo di Cristo e della vera fede, orgoglio e ostinazione, falsa profezia, sfruttamento del lavoro altrui, sentimenti di invidia, odio e vendetta, nepotismo, arroganza, boria razionalistica e naturalmente eresia, con chiaro riferimento all’indirizzo aristotelico imboccato dai domenicani che ormai dominano il campo della teologia (fedeli al neoplatonismo e all’agostinismo sono invece i francescani, il cui esponente più celebre è il mistico Bonaventura, teorico della “conoscenza gustativa”).
Guillaume però non si dà per vinto, e tenta l’ultima impresa disperata: scrive, e pubblica nel 1256, un feroce libello che intitola De periculis novissimorum temporum (Sui pericoli dei tempi nuovissimi), dove in toni da geremiade apocalittica si scaglia contro i mendicanti descrivendo i trentanove signa che a suo giudizio contraddistinguono la loro ipocrisia, i loro vizi e i loro abominevoli comportamenti: peccati di lussuria, di gola, di superbia e vanità, di avidità di beni terreni, disprezzo di Cristo e della vera fede, orgoglio e ostinazione, falsa profezia, sfruttamento del lavoro altrui, sentimenti di invidia, odio e vendetta, nepotismo, arroganza, boria razionalistica e naturalmente eresia, con chiaro riferimento all’indirizzo aristotelico imboccato dai domenicani che ormai dominano il campo della teologia (fedeli al neoplatonismo e all’agostinismo sono invece i francescani, il cui esponente più celebre è il mistico Bonaventura, teorico della “conoscenza gustativa”).
La misura è colma. A ribattere le accuse del “buon di Sant’Amore” scende in campo lo stesso Tommaso d’Aquino, che a trentun’anni ha già acquistato chiara fama e da quattro anni ha iniziato la sua carriera di docente alla facoltà delle Arti di Parigi. Il suo scritto Contra impugnantes è un colpo mortale per Guillaume, che nel 1257 subisce la scomunica da parte del papa Alessandro IV, e viene esiliato dalla Francia. E con questo ci ricolleghiamo ai versi poc’anzi citati del Fiore dantesco. Falsembiante ha vinto la sua battaglia. Anche se poi, dopo la morte di papa Alessandro, Guillaume riuscirà perfino a tornare a Parigi – mai più però come insegnante – e a morire in pace nella sua nativa Borgogna.
E “Mastro Sighier”? La fine di Sigieri di Brabante è molto più oscura e atroce. È un assassinio, che si consuma nella residenza pontificia di Orvieto, per mezzo di una spada o di un lungo pugnale (nella corte di Roma, ad Orbivieto, a ghiado, ossia con un gladio, dicono i versi del Fiore). Ma sulla data del crimine, sull’identità dell’assassino e sul movente dell’uccisione, il mistero è quasi totale. L’unica cosa che si sa con certezza – ma è un fatto di estrema importanza – è che il delitto avvenne non prima del 1281, e non dopo il 10 novembre del 1284, periodo che coincide con gli anni del pontificato di Martino IV, il “papa goloso” di Dante. A questa certezza s’aggiunge solo un’asserzione formulata alla fine del XIII secolo dal continuatore della Cronaca dei Papi e degli Imperatori di Martino Polono, e che fu convalidata nel 1911 dalla voce autorevole di Pierre Mandonnet e che per questo ancor oggi si cita regolarmente come una possibile spiegazione del mistero: «Sigieri fu condannato all’internamento nella Curia […] Egli morì nel periodo della sua residenza ad Orvieto, assassinato dal chierico mezzo pazzo che era al suo servizio» 9. Ucciso da un servitore impazzito? Così, senza un motivo? Tutto è possibile, anche se la storia è assai strana. Ma infine: chi fu Sigieri di Brabante? Perché fu condannato, e da chi, e perché finì ad Orvieto? E che rapporti potevano esserci tra lui e quel papa goloso e politicante che stava tanto antipatico a Dante?
L’amaro prezzo degli “invidïosi veri”
È venuto ora il momento di appellarci ai famosi versi del decimo canto del Paradiso, dove Dante, in modo quasi beffardo e irridente, spiazzando (apparentemente) con assoluta noncuranza la logica, la storia e il buon senso, propone un enigma che da secoli sconcerta i commentatori del suo poema. Asceso, con Beatrice sempre accanto, al cielo del Sole, il poeta è rapito da uno spettacolo meraviglioso: è una corona di spiriti luminosissimi, che cantano e danzano e per tre volte ruotano intorno a lui e alla sua guida. Sono dodici, e sono le menti più eccelse della sapienza biblica e cristiana, da Salomone a Dionigi l’Areopagita, da Severino Boezio a Tommaso d’Aquino. Ed è proprio Tommaso, il Dottore Angelico, che si rivolge a Dante e gli presenta, uno dopo l’altro, tutti gli spiriti di quella ghirlanda sfolgorante. Ma quando arriva all’ultimo, ecco la sorpresa (vv. 133-138):
Questi, onde a me ritorna il tuo riguardo,
è ‘l lume d’uno spirto che ‘n pensieri
gravi a morir li parve venir tardo:
essa è la luce etterna di Sigieri,
che, leggendo nel vico delli strami,
sillogizzò invidïosi veri.
 Eccolo qua di nuovo, quel Mastro Sighier, il Sigieri di Brabante che Falsembiante, stando ai versi del Fiore, fece uccidere a pugnalate nella corte del Papa a Orvieto. Ed è Tommaso d’Aquino a cantarne le lodi, a celebrare addirittura la “luce etterna” del suo spirito. Tommaso? Ma non era stato proprio lui quello che nel 1270 aveva lanciato una profonda e veemente critica contro il pensiero del giovane filosofo Sigieri10, che da almeno cinque anni, tenendo le sue lezioni a Parigi nel “vico delli strami” 11, diffondeva con impressionante abilità persuasiva le tesi più ardite di Averroè, il gran commentatore di Aristotele? Un eretico dell’Islàm ha contagiato un eretico cristiano, e Tommaso ora lo esalta? Tommaso parla di “invidïosi veri”, cioè di verità che Sigieri avrebbe dedotto “sillogizzando”, ossia ragionando sul filo di una perfetta logica aristotelica. Talmente perfetta, da suscitare invidia, e quindi odio, avversione, in chi pensava che quelle verità potessero ferire mortalmente l’organismo grandioso e fragile della fede.
Eccolo qua di nuovo, quel Mastro Sighier, il Sigieri di Brabante che Falsembiante, stando ai versi del Fiore, fece uccidere a pugnalate nella corte del Papa a Orvieto. Ed è Tommaso d’Aquino a cantarne le lodi, a celebrare addirittura la “luce etterna” del suo spirito. Tommaso? Ma non era stato proprio lui quello che nel 1270 aveva lanciato una profonda e veemente critica contro il pensiero del giovane filosofo Sigieri10, che da almeno cinque anni, tenendo le sue lezioni a Parigi nel “vico delli strami” 11, diffondeva con impressionante abilità persuasiva le tesi più ardite di Averroè, il gran commentatore di Aristotele? Un eretico dell’Islàm ha contagiato un eretico cristiano, e Tommaso ora lo esalta? Tommaso parla di “invidïosi veri”, cioè di verità che Sigieri avrebbe dedotto “sillogizzando”, ossia ragionando sul filo di una perfetta logica aristotelica. Talmente perfetta, da suscitare invidia, e quindi odio, avversione, in chi pensava che quelle verità potessero ferire mortalmente l’organismo grandioso e fragile della fede.
Tutto ciò sa di assurdo. Ma qui, ovviamente, il problema non è il Tommaso storico, che di sicuro mai avrebbe detto cose simili su Sigieri. Il problema è Dante, che come al solito usa i personaggi storici come simboli. Che cosa è accaduto nella mente del poeta fiorentino? Non sarà stato, per caso, anche lui un averroista, in incognito naturalmente? Un erede del pensiero più rivoluzionario e insidioso mai uscito dal seno della filosofia islamica? Sto ponendo domande su domande, me ne rendo conto. Ma è la stupefacente complessità della questione che mi obbliga a scendere nell’ipogeo delle ipotesi con cautela, come per esplorare una catacomba disseminata di biforcazioni e di trabocchetti. Compiendo, ahimè, un viaggio del tutto opposto a quello di Dante, che invece saliva beatamente di grado in grado per la sua scala celeste.
Verità invidiate, dunque, verità pagate a caro prezzo: la condanna, la messa al bando, e forse anche la morte, perché quel “ghiado”, quel pugnale, forse non fu brandito da un povero pazzo… Eccola, l’ho detta la cosa che forse era meglio tacere per non rischiare di scivolare nella fantasia di un “giallo storico”. Eppure Falsembiante lo dice chiaro: Sigieri fu una mia vittima. E in questo dato di fatto s’intravvede già una chiara concordanza tra i versi del Fiore e quelli del Purgatorio. Dante sapeva che anche Tommaso era caduto nei sospetti della Chiesa, a causa di certi aspetti del suo aristotelismo. E questo era accaduto a Parigi nel 1277, cioè tre anni dopo la sua morte 12. Dunque, ben difficilmente Tommaso poteva essere stato un adepto di Falsembiante. Uomo di fede ardente, egli era anche un pensatore libero. Non poteva essere stato lui, nonostante egli fosse un domenicano, e nonostante la sua lotta contro l’averroismo, il vero nemico di Sigieri. Tommaso aveva combattuto la sua battaglia lealmente, rispondendo a Sigieri con le sue stesse armi, nell’onesto duello dei sillogismi. E non può essere anche questa una prova del fatto che il Durante del Fiore, evidentemente innamorato del Roman de la Rose e di quel Jean de Meun che aveva difeso a spada tratta le ragioni del povero Guillaume de Saint-Amour, fu veramente il giovane Dante innamorato della filosofia? 13
Ma non corriamo troppo avanti, ora. Torniamo indietro, invece. Ma molto, molto indietro.
 De anima, III, 5: l’enigma di Aristotele
De anima, III, 5: l’enigma di Aristotele
Il punto di partenza è nell’Atene del quinto secolo avanti Cristo, nell’epoca di Pericle, quando il filosofo Anassagora formula un’idea rivoluzionaria, destinata per millenni a sviluppi straordinari. Il nostro mondo materiale, egli dice, sarebbe solo un caos informe se non vi fosse un principio immateriale che lo governa. E questo principio non può essere che una Mente ordinatrice, un Intelletto (Nous) capace di organizzare la materia separando e poi associando i suoi elementi (che egli chiama semi, spermata), in vista di un telos, ossia di un fine. Dunque: Intelletto come principio immateriale e teleologico.
Nel secolo successivo, sempre ad Atene, un altro filosofo fa tesoro di quell’idea. È Aristotele, colui che in seguito, per quasi due millenni, godrà la fama di Filosofo per antonomasia. Nella Metafisica (Λ, 9, 1075 a 5-10), lo Stagirita stabilisce una stretta similitudine tra l’intelligenza divina e l’intelligenza umana. Ma è nell’affrontare il tema dell’anima che egli, ricordando ripetutamente Anassagora14, propone un’idea – o meglio, un complesso di idee – che aprirà la strada nei secoli successivi a infinite discussioni e a numerose interpretazioni. Il suo intento è chiaro: Aristotele vuol dire che l’anima umana, al di là delle facoltà vegetativa, sensitiva e immaginativa, che l’uomo ha in comune con gli altri esseri animati, e che sono strettamente legate al mondo fisico, alla materia, possiede anche una virtù, la ragione, che chiaramente si stacca dalla materialità, appunto perché legata – oggi diremmo “connessa”, pensando a internet – a quell’intelligenza separata dalla materia, di cui già parlava Anassagora. Semplificando al massimo, potremmo dire che l’intelligenza è come una scintilla di luce divina, che si manifesta nell’anima umana attraverso la ragione, cioè grazie alla nostra capacità di pensare razionalmente.
Ora – ed è qui un punto essenziale della questione – nel lessico di Aristotele quella scintilla divina è la causa agente dell’intellezione, mentre la nostra capacità di pensare non è che una potenzialità, cioè una disposizione naturale della nostra anima ad accogliere quella luce intellettiva che la fa passare dalla potenzialità all’attualità, o meglio: dalla potenza all’atto. Aristotele usa anche i termini di forma e di materia: l’intelligenza agente è la forma che s’imprime nella “materia” (termine usato qui in senso puramente concettuale o metaforico) dell’intelletto potenziale, trasformandolo in intelletto attuale. Immaginiamo la mano dello scultore che trasforma il blocco di marmo in una statua: il marmo è la materia che è in potenza qualsiasi cosa, la mano dello scultore è la causa agente che attualizza quella potenza, dando una forma a quella materia. Proprio come il Nous di Anassagora che trasforma il caos primordiale della materia nelle varie forme definite della natura. Ma a questo punto è necessario che noi leggiamo almeno le frasi essenziali del terzo libro del De anima, dove Aristotele cerca di chiarire la natura e la differenza di questi due intelletti, l’agente (formale) e il potenziale (materiale):
C’è pertanto un intelletto analogo [alla materia] perché diventa tutte le cose, e un altro [analogo alla causa agente] perché le produce tutte, al pari di una qualità definita, come la luce, ché in certo senso anche la luce fa i colori in potenza colori in atto. E questo intelletto è separato, immisto e impassivo, per sua essenza atto: e, infatti, l’agente è sempre più eccellente del paziente, e il principio della materia. [...] Separato, esso è solo quel che realmente è, e questo solo è immortale ed eterno […] mentre l’intelletto che può essere impressionato è corruttibile e senza questo non pensa niente.
Il primo impatto con queste affermazioni può sembrare chiaro e tranquillo: da una parte abbiamo l’intelligenza attiva, separata dalla materia, eterna, perciò di natura soprasensibile e divina; dall’altra il nostro intelletto materiale-potenziale, che fa parte della nostra anima, ma è destinato a dissolversi insieme con il composto organico mortale del nostro corpo. L’anima dell’uomo, insomma, non è immortale, sembra voler dire Aristotele, però… però in fondo non del tutto, perché in un certo modo, indubbiamente, essa si eternizza e si divinizza quando entra in contatto con l’intelligenza eterna, che la inonda della sua luce e la rende simile a sé permettendole di “vedere i colori”, cioè le essenze degli intelligibili. Come se soltanto nell’atto dell’intellezione fosse dato all’uomo di superare la propria natura materiale e mortale, congiungendosi con l’eterno. Questo è ciò che (quasi) con certezza si può dire o arguire attenendosi con rigore al testo di Aristotele. Ma quello che ne dedurranno i filosofi nei secoli successivi, quando anche i dogmi delle tre fedi abramitiche accamperanno i loro diritti nel campo del pensiero, sarà tutta un’altra storia.
Ho rubato qui il titolo a un recente libro dello storico della filosofia islamica Jean-Baptiste Brenet15, perché è evidente che ora il nostro discorso deve tornare al suo punto di partenza, ossia a Sigieri, a Tommaso, a quella “guerra filosofica” che si scatenò nella seconda metà del tredicesimo secolo con l’irruzione sulla scena dell’averroismo, senza perderci nell’immane compito di descrivere anche solo sommariamente gli sviluppi storici della teoria aristotelica dell’intelletto 16. Sarà sufficiente ricordare quella che comunque – al di là delle dispute sulla natura più o meno razionale o mistico-gustativa della suprema conoscenza – fu l’idea generalmente accettata dai filosofi dell’Islàm che trasmisero agli scolastici latini le loro teorie dell’intelletto: e cioè che, come dichiara perfettamente Al-Fārābī in queste righe del suo Libro del governo politico, la massima felicità e la massima realizzazione dell’essere umano consistono nel congiungimento dell’intelletto potenziale che fa parte della nostra anima con la divina Intelligenza attiva che promana dalle sfere celesti:
E il compito dell’Intelligenza agente è il prendersi cura dell’animale razionale [l’uomo], e il cercare di fargli raggiungere il grado estremo della perfezione che all’uomo sia dato di raggiungere: ed esso è la felicità estrema, e questa è che l’uomo arrivi al grado della Intelligenza agente 17
Dove si vede che in fondo, a parte la concezione emanatistica dell’intelligenza, generata dalla fusione del neoplatonismo con l’aristotelismo, e a parte la complicazione del sistema degli intelletti, che ora comprendeva anche un intelletto “in atto” e un intelletto “acquisito”, il pensiero islamico era rimasto sostanzialmente fedele alla psicologia di Aristotele. Ma venne poi il giorno in cui tutto cambiò, e in cui il gran castello della teoria aristotelica di colpo si sbriciolò, e non per opera di un nemico di Aristotele, ma, paradossalmente, proprio di colui che addirittura nutriva per il Filosofo un’ammirazione quasi idolatrica, e che si era impegnato in un’opera immensa di commento ai suoi libri: Averroè. Che cosa era accaduto di così sconvolgente?
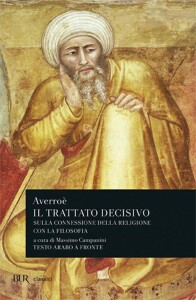 Il filosofo di Cordova, nel commentare il De anima aristotelico, e nell’affrontare il cruciale capitolo quinto del terzo libro, si era accorto di un’incongruenza logica nell’opinione di coloro che consideravano l’intelletto potenziale – che Averroè chiama sempre “materiale” – come “principio di individuazione” degli esseri umani, ossia come forma sostanziale dell’anima umana, ossia ancora, per dirla in modo più semplice, come parte costitutiva e proprietà dell’anima di ogni singolo uomo, quindi molteplice e legato alla corporeità degli individui. Ma, se è vero che l’intellezione consiste nella fusione dell’intelletto materiale con l’Intelligenza attiva, che è solo atto ed è unica ed è separata dalla materia, ed è perciò di natura spirituale e divina, come può una sostanza che è molteplice ed è legata alla materia corporea giungere alla fusione, ossia all’identificazione con quell’unica sostanza divina? E come può un’operazione immateriale, l’intellezione, aver luogo in un organo corporeo? E poi: potrà mai quella sostanza divina unirsi a una sostanza corporea senza entrare in contraddizione con se stessa? O senza inquinarsi, senza cadere in basso, per usare espressioni meno tecniche e più brutali? Quest’idea sembrò impossibile ad Averroè. Ecco le sue parole, in uno dei punti salienti del suo commento:
Il filosofo di Cordova, nel commentare il De anima aristotelico, e nell’affrontare il cruciale capitolo quinto del terzo libro, si era accorto di un’incongruenza logica nell’opinione di coloro che consideravano l’intelletto potenziale – che Averroè chiama sempre “materiale” – come “principio di individuazione” degli esseri umani, ossia come forma sostanziale dell’anima umana, ossia ancora, per dirla in modo più semplice, come parte costitutiva e proprietà dell’anima di ogni singolo uomo, quindi molteplice e legato alla corporeità degli individui. Ma, se è vero che l’intellezione consiste nella fusione dell’intelletto materiale con l’Intelligenza attiva, che è solo atto ed è unica ed è separata dalla materia, ed è perciò di natura spirituale e divina, come può una sostanza che è molteplice ed è legata alla materia corporea giungere alla fusione, ossia all’identificazione con quell’unica sostanza divina? E come può un’operazione immateriale, l’intellezione, aver luogo in un organo corporeo? E poi: potrà mai quella sostanza divina unirsi a una sostanza corporea senza entrare in contraddizione con se stessa? O senza inquinarsi, senza cadere in basso, per usare espressioni meno tecniche e più brutali? Quest’idea sembrò impossibile ad Averroè. Ecco le sue parole, in uno dei punti salienti del suo commento:
Se infatti ammettessimo che l’intelletto materiale è moltiplicato secondo il numero dei singoli uomini, dovrebbe essere qualcosa di individuale, o corpo o facoltà in un corpo. Se fosse tale, sarebbe un’intenzione intelligibile in potenza: questa sarebbe però il soggetto che muove l’intelletto ricettivo, non il soggetto mosso. Se dunque ammettiamo che l’intelletto ricettivo sia qualcosa di individuale, ne conseguirà che una cosa riceverà se stessa: il che è assurdo 18.
Da questa e da altre riflessioni, Averroè deduceva una teoria inaudita: anche l’intelletto materiale-potenziale è unico, ingenerato e separato dalla materia, come l’Intelligenza attiva. Quindi non appartiene all’anima umana, non è una parte sostanziale dei singoli individui, non fa parte del basso mondo della generazione e della corruzione. E chi crede che esso sia generato e tuttavia finalizzato alla congiunzione con le cose astratte, si invischia in insolubili contraddizioni. Scrive con chiarezza a tal proposito Guido de Ruggiero:
«All’anima dell’uomo non appartiene in proprio che una sorta d’intelligenza spuria meramente passiva, che corrisponde a ciò che gli scolastici latini chiamano vis cogitativa […] Ciò vuol dire che all’anima umana è fatta estranea l’intelligenza con cui essa pensa e che pur sente a sé interiore più che se medesima: l’intelligenza non le si comunica che temporaneamente, con una divina fulgorazione dall’alto, nell’atto in cui l’anima effettivamente medita e pensa […] Certo, col venir ricongiunti nella sfera della trascendenza i due intelletti, la dottrina si fa più coerente, perché si annulla una scissione ingiustificabile tra l’uno e l’altro, che nella funzione dell’intendere sono indissolubilmente congiunti ed anzi s’identificano. Ma l’uomo è reso un ricettacolo meramente passivo e quasi impersonale di un pensiero che non gli appartiene e che si pensa momentaneamente in lui per un inesplicabile mistero divino» 19.
 Quindi, niente più estasi, niente trasmutazioni dell’umano nel divino, niente mistiche nozze dell’anima con la divina Sapienza-Intelligenza attiva, niente auto-trascendimenti della ragione e niente delizie gustative nell’excessus mentis. L’antica diatriba islamica delle “due vie” della conoscenza – che Henry Corbin illuminò nella sua Histoire de la philosophie islamique – adesso s’era svuotata di senso. Averroè l’aveva totalmente spazzata via. E questo, perché il miracolo luminoso dell’intellezione aveva abbandonato gl’individui e s’era trasferito nell’aldilà ideale di una nuova ipostasi noetica: l’intelletto “acquisito” (al-ʽaql al-mustafād, العقل المستفا د) – idea sviluppata dai filosofi musulmani, a partire da Al-Kindī e poi da Al-Fārābī sulla scia dell’intellectus adeptus di Alessandro di Afrodisia – in cui si concentrano e si conservano le conquiste intellettuali dell’intera umanità. Un patrimonio comune, una luce inestinguibile che non divinizza gli individui, ma li nobilita in quanto membri della specie umana, essa sì eterna, elevandoli nell’oltre-umano dell’intelligenza divina. Una sorta di comunismo noetico e mistico, verrebbe quasi da dire. Il sogno di un paradiso in terra: unico, utopico aldilà concesso all’anima umana mortale. E vedremo tra poco come quest’idea dovrà affascinare anche Dante!
Quindi, niente più estasi, niente trasmutazioni dell’umano nel divino, niente mistiche nozze dell’anima con la divina Sapienza-Intelligenza attiva, niente auto-trascendimenti della ragione e niente delizie gustative nell’excessus mentis. L’antica diatriba islamica delle “due vie” della conoscenza – che Henry Corbin illuminò nella sua Histoire de la philosophie islamique – adesso s’era svuotata di senso. Averroè l’aveva totalmente spazzata via. E questo, perché il miracolo luminoso dell’intellezione aveva abbandonato gl’individui e s’era trasferito nell’aldilà ideale di una nuova ipostasi noetica: l’intelletto “acquisito” (al-ʽaql al-mustafād, العقل المستفا د) – idea sviluppata dai filosofi musulmani, a partire da Al-Kindī e poi da Al-Fārābī sulla scia dell’intellectus adeptus di Alessandro di Afrodisia – in cui si concentrano e si conservano le conquiste intellettuali dell’intera umanità. Un patrimonio comune, una luce inestinguibile che non divinizza gli individui, ma li nobilita in quanto membri della specie umana, essa sì eterna, elevandoli nell’oltre-umano dell’intelligenza divina. Una sorta di comunismo noetico e mistico, verrebbe quasi da dire. Il sogno di un paradiso in terra: unico, utopico aldilà concesso all’anima umana mortale. E vedremo tra poco come quest’idea dovrà affascinare anche Dante!
Che dire? Quando questa dottrina, insieme ad altre tesi di Averroè che si opponevano ai dogmi della fede, cominciò a diffondersi nell’Europa cristiana, lo sconcerto fu enorme20. Tanto più che dopo il 1265, come già s’è accennato, questa “folle idea” venne a configurarsi come la punta di diamante di una “nuova filosofia” professata a Parigi da un gruppo di giovani incuranti dell’ortodossia teologica. E tra questi giovani ve n’era uno in particolare, il nostro Sigieri di Brabante – nato intorno al 1240 – che per l’acume e l’energia del suo pensiero raggiunse ben presto la fama di guida della corrente intellettuale che di lì a poco, ossia nel 1270, l’indignato Tommaso d’Aquino avrebbe denominato “averroismo”. Ma c’è di più. Perché, a quanto pare, quei giovani non si limitarono a mettere a soqquadro il mondo delle idee. Dall’ardimento ideologico seppero passare facilmente ad altre forme di ribellione, se è vero che nell’estate del 1266, come attesta un documento dell’Università di Parigi, essi furono al centro di pericolose tensioni tra gruppi rivali di studenti e professori.
Ed è qui che si verifica un fatto che ci riempie di sorpresa. Il Papa Clemente IV affida a un suo legato la missione di indagare sui torbidi dell’ateneo parigino, e di mettere pace tra le fazioni in lotta. Il legato pontificio si chiama Simone de Brion… e sì, è proprio lui, l’uomo che quindici anni dopo diventerà Papa col nome di Martino IV, e che sarà ancora Papa quando Sigieri verrà assassinato nella residenza pontificia di Orvieto. E cosa viene a sapere Simone de Brion quando arriva a Parigi per svolgere la sua missione? Ecco:
«In quel documento [quello dell’estate del 1266, poc’anzi citato] Sigieri viene segnalato come uno dei responsabili di questi contrasti e gli vengono imputate due gravi accuse: quella di aver partecipato al rapimento e al sequestro di un maestro della fazione opposta, e quella di averne assaliti altri nel bel mezzo di una funzione liturgica, celebrata nel convento di Saint-Jacques. L’intrecciarsi del ritrovamento di opere filosofiche “audaci” e di documenti legati ai disordini universitari determina questo primo ritratto di Sigieri: egli doveva essere un sobillatore, addirittura il leader del movimento averroista, che agiva sia a livello filosofico che a livello, per così dire, politico» 21.
Viene da pensare: l’inquietudine generata dal pensiero di Averroè fu dunque così potente da generare anche problemi, diciamo così, di ordine pubblico? Certo, a voler sommare queste “notizie di cronaca” – vere o calunniose che fossero – con la carica sovversiva del pensiero di Averroè, l’idea che in quegli anni a Parigi si fosse scatenato una specie di terremoto non fa che rafforzarsi. Un terremoto culturale di quelli destinati a lasciare un segno epocale e profondo nella storia.
Sigieri lanciava dunque le sue idee come strali diretti al cuore dell’ortodossia filosofico-teologica. Tra il 1265 e il 1270, sillogizzando nel “vico delli strami”, porgeva ai suoi allievi il frutto proibito della dottrina di Averroè sull’intelletto 22. Ben sapendo che il punto debole di quella dottrina consisteva nella separazione dell’intelletto dall’anima umana – separazione che Brenet paragona a un accecamento, definendo Averroè un “cavatore di occhi” 23 – Sigieri si appellava all’idea che il mistero dell’intellezione si potesse spiegare grazie al contatto operativo dell’intelletto coi “fantasmi”, ossia con le immagini elaborate dall’anima sulla base dell’esperienza sensibile. In questo modo, e solo in questo modo, era possibile affermare l’esistenza di un legame, di una vera congiunzione, tra l’intelletto e l’anima, e quindi tra l’intelletto e il corpo, salvando al tempo stesso l’idea dell’assoluta incorporeità dell’intelletto stesso. Sarà utile leggere qui le parole di Sigieri nelle Questioni sul terzo libro del De anima, anche per avere un’idea della sottigliezza dei suoi “invidïosi veri”:
Perciò l’intelletto possibile [ossia l’intelletto potenziale-materiale], in quanto rivolto all’intelletto agente, pensa sempre ed è eterno e separato, tanto secondo questa operazione, quanto secondo la sua sostanza; ma lo stesso intelletto possibile, in quanto rivolto ai fantasmi, sebbene sia eterno e separato secondo la sua sostanza, tuttavia, secondo l’operazione, è corruttibile e congiunto al corpo 24.
Ragionamenti arditi e forse anche un po’ spericolati, ma terribilmente efficaci su una platea universitaria che, già precedentemente scossa dalla lunga lotta dei secolari contro i mendicanti, doveva certo essere incline ad accogliere con favore un’ondata di pensiero nuovo, sorprendente e libero dalle pastoie dei dogmi religiosi. Per queste ragioni, come s’è già accennato, la risposta della Chiesa non poteva farsi attendere. E il primo a scendere in campo fu il “pezzo da novanta” di allora: Tommaso d’Aquino 25. Ne nacque uno degli scritti filosofici più profondi, vibranti e famosi del Dottore Angelico: L’unità dell’intelletto contro gli averroisti. Lasciamo ora a lui la parola, per comprendere fino in fondo quale fosse il senso, e il peso, della posta in gioco. Nell’incipit Tommaso scrive:
Già da qualche tempo si è diffuso tra molti un errore sull’intelletto, originato dalle affermazioni di Averroè, il quale si sforza di sostenere che l’intelletto chiamato possibile da Aristotele, e da lui, con termine improprio, “materiale”, sia una sostanza separata nel suo essere dal corpo, e in alcun modo unita ad esso come forma; ed inoltre che questo intelletto possibile sia unico per tutti gli uomini. (De unit., I, 1) 26.
Nel secondo capitolo, dopo aver citato l’opinione di tutti gli antichi commentatori del De anima di Aristotele, greci e arabi, a sostegno dell’idea che l’intelletto sia facoltà dell’anima e forma del corpo, pronuncia un attacco molto aspro nei confronti di Averroè, padre della nuova eresia:
Abbiamo premesso queste citazioni, non come a voler confutare il predetto errore [l’errore degli averroisti, sostenitori dell’assoluta separazione dell’intelletto rispetto all’anima e al corpo] con le autorità dei filosofi, ma per mostrare che non soltanto i Latini, le cui parole ad alcuni non vanno a genio, ma anche i Greci e gli Arabi sono di questo parere, che l’intelletto sia una parte, potenza o facoltà dell’anima, la quale è forma del corpo. Onde mi chiedo con meraviglia da quali Peripatetici possano vantarsi di avere tratto questo errore, a meno che, forse, piuttosto che giudicare rettamente con gli altri Peripatetici, preferiscano errare con Averroè, il quale fu non tanto un peripatetico quanto un corruttore della filosofia peripatetica. (De unit., II, 59) 27
 Dopo aver poi dimostrato che la teoria della separazione dell’intelletto rende impossibile comprendere in che modo “questo uomo”, ossia ogni singolo individuo, possa essere il soggetto dell’intellezione, Tommaso capovolge addirittura la posizione averroista, dichiarandosi incline a pensare, o almeno a non escludere, che non solo l’intelletto possibile, ma anche l’intelligenza agente sia una facoltà insita in ogni singola anima. Una teoria, insomma, diametralmente opposta a quella degli averroisti.
Dopo aver poi dimostrato che la teoria della separazione dell’intelletto rende impossibile comprendere in che modo “questo uomo”, ossia ogni singolo individuo, possa essere il soggetto dell’intellezione, Tommaso capovolge addirittura la posizione averroista, dichiarandosi incline a pensare, o almeno a non escludere, che non solo l’intelletto possibile, ma anche l’intelligenza agente sia una facoltà insita in ogni singola anima. Una teoria, insomma, diametralmente opposta a quella degli averroisti.
Corre il 1270, quando Tommaso rende pubblica la sua critica agli averroisti. E proprio alla fine di quell’anno, in dicembre, accade un fatto nuovo e clamoroso: il vescovo di Parigi, Étienne Tempier, scaglia la sua condanna contro i nuovi eretici elencando le tredici tesi principali attribuibili al loro pensiero, e che si devono a tutti i costi estirpare, pena anche la scomunica per chi osi ancora insegnarle. Ecco la prima, la più esecranda: «L’intelletto umano è uno solo e identico per tutti». La seconda, complementare alla prima: «È falsa e impropria la proposizione: l’uomo intende (ergo: homo non intelligit)»28. Le altre riguardano l’eternità del mondo e dell’umanità, il libero arbitrio e l’onnipotenza-onniscienza divina. Ma sono certamente le prime due le più sconcertanti. E sono quelle che con tutta evidenza riguardano il “delirio” di Sigieri. È infatti lui il principale bersaglio della condanna. E una cosa è certa: che le critiche di Tommaso e la condanna del vescovo non lo lasciano indifferente.
 Turbato nel profondo, ma non intimorito, e comunque deciso a sostenere con coerenza il suo pensiero, Sigieri riconsidera la sua teoria sull’intelletto, l’approfondisce, la rimodula confrontandola con le acute osservazioni di Tommaso. E il frutto di questa profonda rielaborazione è un nuovo libro, il Trattato sull’anima intellettiva, che vede la luce fra il 1273 e il 74, in cui il filosofo brabantino, come osserva Antonio Petagine, in fondo: «trova un modo, forse ancor più convincente, per ribadire contro Tommaso che l’intelletto non è forma nel senso di forma sostanziale», e dove: «continua a dire che se si pone l’intelletto come immateriale e si ritiene che la materia costituisca il principio di individuazione di ogni specie, allora si deve concludere che esiste un unico intelletto per tutti gli uomini» 29.
Turbato nel profondo, ma non intimorito, e comunque deciso a sostenere con coerenza il suo pensiero, Sigieri riconsidera la sua teoria sull’intelletto, l’approfondisce, la rimodula confrontandola con le acute osservazioni di Tommaso. E il frutto di questa profonda rielaborazione è un nuovo libro, il Trattato sull’anima intellettiva, che vede la luce fra il 1273 e il 74, in cui il filosofo brabantino, come osserva Antonio Petagine, in fondo: «trova un modo, forse ancor più convincente, per ribadire contro Tommaso che l’intelletto non è forma nel senso di forma sostanziale», e dove: «continua a dire che se si pone l’intelletto come immateriale e si ritiene che la materia costituisca il principio di individuazione di ogni specie, allora si deve concludere che esiste un unico intelletto per tutti gli uomini» 29.
Sigieri, in sostanza, non è per nulla pentito della sua eresia. Nel frattempo, il 7 marzo del 1274, Tommaso muore. E il clima delle dispute, a Parigi, non fa che inasprirsi, fino a provocare l’ira del papa Giovanni XXI 30, e a sfociare, il 28 aprile del 1277, in un nuovo atto di condanna da parte del vescovo Tempier, preoccupato anche dal dilagare dell’averroismo tra gli studenti della facoltà delle Arti. Ma c’è di più, perché la condanna stavolta assume un aspetto “globale”: viene lanciata infatti contemporaneamente anche in Inghilterra, dall’arcivescovo di Canterbury Robert Kilwardby. Come se non bastasse, però, dire averroismo in quel clima infuocato vuol dire anche aristotelismo, perché le due filosofie sembrano legate indissolubilmente, come in un rapporto di causa ed effetto («Gli agostiniani tendevano a mettere in un fascio tutti i seguaci dell’aristotelismo», notava Bruno Nardi) 31. Ed ecco che allora, nella nuova condanna, che elenca stavolta addirittura 219 tesi eretiche, persino il pensiero di Tommaso viene coinvolto in una quindicina di suoi punti. Così s’avvera il paradosso: il defunto Tommaso e il vivo e vegeto Sigieri, i due grandi rivali, diventano ora per un momento due ideali compagni di sventura, nonostante sia sempre Sigieri, ovviamente, a essere considerato il vero e principale nemico della fede da colpire e da abbattere (senza dimenticare l’importanza di Boezio di Dacia, di cui presto ci rioccuperemo). E a tal punto il filosofo brabantino ne è consapevole, da temere per la sua libertà, e forse per la sua stessa vita, sì da scegliere – pare già dal 1276 – la via della fuga da Parigi, per sfuggire agli artigli dell’Inquisizione.
Per avere un’idea più ampia del putiferio ideologico scatenato dall’aristotelismo-averroismo – vero o presunto che fosse – basti scorrere soltanto una manciata delle tesi condannate. Eccole, nella breve selezione fatta da Jacques Le Goff nel suo saggio su Gli intellettuali nel Medioevo:
«Tesi 18: che la resurrezione futura non deve essere ammessa dal filosofo, in quanto è impossibile esaminare la cosa razionalmente. 152: che la teologia è basata su delle favole. 155: che non ci si deve preoccupare della sepoltura. 168: che la continenza non è in se stessa una virtù. 169: che l’astensione totale dal congiungimento carnale corrompe la virtù e la specie. 174: che la legge cristiana ha le sue favole e i suoi errori come le altre religioni. 175: che essa è un ostacolo alla scienza. 176: che la felicità si trova in questa vita, e non in un’altra» 32.
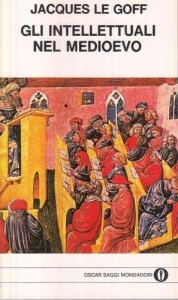 Stupefacente! Non echeggiano forse qui anche i temi della guerra che proprio in quegli anni il poeta Jean de Meun combatteva scrivendo il suo Romanzo della Rosa contro l’ipocrisia di Falsembiante, quindi non solo contro l’avidità dei falsi monaci mendicanti (tema caro a Guillaume de Saint-Amour e a Rutebeuf), ma anche a favore di una nuova concezione della vita, del sesso, della felicità terrena? Così appare sempre più chiaro che le due contese universitarie, quella che era culminata con l’esilio di Guillaume e quella che ora sta per concludersi con la condanna di Sigieri e dei suoi seguaci, non sono che i frutti di una stessa pianta. La loro radice comune sta nel rinnovamento della cultura europea fecondata dal pensiero greco-arabo e dalla riscoperta, già avviata nel secolo XII – la cosiddetta aetas ovidiana – dell’immenso patrimonio letterario e filosofico dei classici, da Aristotele a Cicerone (il Tullio di Jean de Meun e di Dante).
Stupefacente! Non echeggiano forse qui anche i temi della guerra che proprio in quegli anni il poeta Jean de Meun combatteva scrivendo il suo Romanzo della Rosa contro l’ipocrisia di Falsembiante, quindi non solo contro l’avidità dei falsi monaci mendicanti (tema caro a Guillaume de Saint-Amour e a Rutebeuf), ma anche a favore di una nuova concezione della vita, del sesso, della felicità terrena? Così appare sempre più chiaro che le due contese universitarie, quella che era culminata con l’esilio di Guillaume e quella che ora sta per concludersi con la condanna di Sigieri e dei suoi seguaci, non sono che i frutti di una stessa pianta. La loro radice comune sta nel rinnovamento della cultura europea fecondata dal pensiero greco-arabo e dalla riscoperta, già avviata nel secolo XII – la cosiddetta aetas ovidiana – dell’immenso patrimonio letterario e filosofico dei classici, da Aristotele a Cicerone (il Tullio di Jean de Meun e di Dante).
Dalla metafisica alla politica
Ma torniamo al 1277, l’anno della condanna delle 219 tesi eretiche. Meno di un mese dopo quell’evento Giovanni XXI muore, e dopo sei mesi di aspre lotte per la successione, il 25 novembre viene eletto al soglio pontificio il cardinale romano Gian Gaetano Orsini, con il nome di Niccolò III. Si tratta del papa ultranepotista e simoniaco, che ferocemente Dante (Inf. XIX, 31-87) scaglia nella terza bolgia dell’inferno, la testa conficcata in una buca e i piedi in fiamme, a tal punto smanioso di veder giungere al suo posto l’ancor peggiore di lui Bonifacio VIII, da credere che Dante sia appunto il pontefice che con l’inganno s’era preso il trono di Pietro inducendo il pio Celestino V al “gran rifiuto” (Inf. III, 58-60). Questo, tanto per ricordare in che clima sguazzava il clero in quei tempi di lotte spietate per il potere temporale e per il controllo spirituale delle anime. Niccolò III, a ogni modo, non doveva essere il tipo di papa appassionato alle dispute della teologia. «Grande politico, insuperabile diplomatico, Niccolò III, nei suoi tre anni e mezzo di governo pontificale, non fu quasi altro», come scrive Carlo Falconi nella sua Storia dei Papi 33. E fino alla morte di Niccolò III, pertanto – avvenuta nell’agosto del 1280 – si può ragionevolmente supporre che la vita di Sigieri non si sia svolta in uno stato di particolare apprensione.
Ogni cosa dovette però bruscamente cambiare dal 22 febbraio del 1281, quando, dopo un lungo periodo di lotte tra le famiglie romane degli Annibaldi e degli Orsini, finalmente fu eletto papa quel Martino IV, ovvero Simone de Brion, fedelissimo di Carlo d’Angiò, che ormai ben conosciamo: intrigante e goloso, sì, ma uomo abile e scaltro, tutto d’un pezzo, rigoroso e quasi fanatico nella difesa delle sue simpatie e delle sue idee 34. E la domanda che ci poniamo è: dove si trovava in quel momento Sigieri di Brabante? Era già in Italia? Era già ad Orvieto, là dove stava fissando la sua residenza il papa Martino, e dove incontrerà il pugnale del suo assassino? E dove e come aveva passato gli anni precedenti, dopo la sua fuga da Parigi, nel tempo del pontificato di Niccolò III? A tutte queste domande non v’è risposta sicura. Solo congetture. Così com’è una congettura l’idea che egli fosse finito ad Orvieto in veste di pericolo pubblico da tenere in custodia severa, oppure di penitente, a implorare perdono e rifugio presso un uomo che sicuramente lo vedeva come il fumo negli occhi, perché già da quindici anni conosceva assai bene la sua storia di agitatore universitario e di pensatore “sovversivo”.
 Ma forse è venuto il momento di staccarsi da questa oscura vicenda, che troppo facilmente si presta all’ipotesi estrema: quella, diciamolo, dell’omicidio su ordinazione, commesso forse da un servitore di corte, come racconta l’antica cronaca, ma per la volontà d’un fantomatico Falsembiante, come asserisce il messer Durante-Dante del Fiore. Sigieri era forse volontariamente caduto, o era stato costretto a cadere, proprio nelle mani di chi già da tempo sarebbe stato ben felice di eliminarlo? Ipotesi, congetture, romanzi… Magari un giorno salterà fuori da una segreta dell’antica Orbivieto un documento di sette secoli fa, che svelerà finalmente il mistero.
Ma forse è venuto il momento di staccarsi da questa oscura vicenda, che troppo facilmente si presta all’ipotesi estrema: quella, diciamolo, dell’omicidio su ordinazione, commesso forse da un servitore di corte, come racconta l’antica cronaca, ma per la volontà d’un fantomatico Falsembiante, come asserisce il messer Durante-Dante del Fiore. Sigieri era forse volontariamente caduto, o era stato costretto a cadere, proprio nelle mani di chi già da tempo sarebbe stato ben felice di eliminarlo? Ipotesi, congetture, romanzi… Magari un giorno salterà fuori da una segreta dell’antica Orbivieto un documento di sette secoli fa, che svelerà finalmente il mistero.
E tuttavia non è questo, ben lo sappiamo, il mistero che veramente a noi importa chiarire. La parabola di Sigieri è comunque quella: l’eresia averroista, il duello con Tommaso a colpi di sillogismi, la duplice condanna, la fuga da Parigi, la morte prima del novembre 1284. Quindi: perché Dante pone Sigieri in paradiso tra gli spiriti sapienti, e perché pone sulla bocca di Tommaso una lode così sperticata del filosofo che lo stesso Tommaso aveva combattuto con tanta passione e veemenza? That is the question. Confesso: dopo tanto studio e dopo tante riflessioni, una certa plausibile idea me la sono fatta. Lo dico senza timore, semplicemente perché solo di un’idea si tratta, di una supposizione molto elementare e in fondo niente affatto originale, ma totalmente fondata sui dati storici e letterari. Ma prima di arrivarci, dobbiamo naturalmente tornare ai testi di Dante.
Che cosa pensava Dante di Averroè? E qual era la sua opinione riguardo alla dottrina dell’intelletto possibile unico e separato? Sono tre i punti fondamentali nelle opere del Poeta che ci aiutano a rispondere a queste due domande. Il primo è il celebre verso 144 del quarto canto dell’Inferno, dove Dante vede il filosofo arabo in compagnia degli altri “spiriti magni” non battezzati, confinati nel nobile castello del Limbo, e lo definisce lapidariamente così: Averoìs che ‘l gran comento feo. Da cui si deduce senza ombra di dubbio che la sua stima nei confronti del Commentatore, cioè di colui che aveva fatto conoscere e comprendere le opere di Aristotele agli europei, doveva essere poco meno che immensa. Un giudizio, come più d’una volta sottolineò Bruno Nardi, notevolmente diverso da quello di Tommaso d’Aquino, che, come s’è visto, aveva definito Averroè un “corruttore” della filosofia peripatetica 35.
Il secondo punto, per tenerci ancora alla Divina Commedia, è quel passo del Purgatorio (XXV, vv. 34 e segg.), assai ben noto agli studiosi e molto meno agli studenti di liceo, dove Stazio – il poeta latino che Dante immagina convertito al Cristianesimo – impartisce al Fiorentino una lunga lezione di filosofia naturale, spiegandogli la teoria aristotelico-albertina 36 della generazione umana e dello sviluppo dell’anima nelle sue varie facoltà. Il discorso di Stazio fila liscio fino al verso 61, ma ecco che allora, quando egli deve affrontare il tema dell’infusione dell’anima razionale nel corpo, subito una preoccupazione lo assale: quella di ricordare l’errore commesso da Averroè nel separare l’intelletto possibile (potenziale) dall’anima:
Ma come d’animal divenga fante,
non vedi tu ancor quest’è tal punto,
che più savio di te fe’ già errante,
sì che per sua dottrina fe’ disgiunto
dall’anima il possibile intelletto,
perché da lui non vide organo assunto.
Prima ancora di spiegare a Dante la mirabile azione del “motor primo”, che spira/ spirito novo, di virtù repleto nel “cerebro” che ha raggiunto la sua perfezione (perché ormai da semplice “animale”, ossia da essere umano allo stadio fetale, è divenuto “fante”, ossia un essere favellante, dotato di parola e quindi di ragione) Stazio sente il dovere di sgombrare il campo dal grande equivoco, dal grande dubbio che tormentava ancora le menti filosofiche imbevute di aristotelismo. Quando Stazio dice: che più savio di te fe’ già errante, fa comprendere due cose di eguale importanza: la prima è che Dante s’inchina davanti alla superiorità intellettuale di Averroè, confermando l’icastica definizione che ne aveva dato nel Limbo; la seconda è che Dante, seguendo l’esempio di Alberto e di Tommaso, si rifiuta però di aderire alla teoria averroistica dell’intelletto unico e separato. Un colpo al cerchio e uno alla botte, si potrebbe dire. Su quel punto specifico, Dante prende nettamente le distanze da Averroè, ma senza rinunciare a esprimere ancora una volta la sua ammirazione per lui.
 Questi primi due punti hanno il vantaggio di essere molto chiari, e direi inequivocabili. Ma quando arriviamo al terzo punto, ecco che allora la questione si fa complessa e per certi aspetti sconcertante. Stavolta è il Dante filosofo-politico che parla, nel trattato sulla Monarchia (I, 3, 4). Seguiamo il suo ragionamento, perché è bellissimo e importante, di tono solenne nella sua conclusione, che esalta l’ideale della pace universale. Dice Dante: «Bisogna ora vedere in che cosa consista il fine ultimo di tutta l’umana società» 37. Perché? Perché ogni essere nel cosmo dantesco viene concepito come ordinato a un fine (ricordiamo che kósmos in greco vuol dire “ordine”). Lo vuole la natura, e lo vuole Dio. E non v’è cosa che sfugga a questa legge: il pollice ha il suo fine, la mano ha il suo, il braccio pure, e così via. L’uomo, l’individuo ha un fine. E ogni fine viene concepito come inferiore a un altro che nella visione divina ha maggiore importanza. Tanto che in ultima analisi è l’umanità intera l’essere il cui fine è superiore a quello di ogni altro.
Questi primi due punti hanno il vantaggio di essere molto chiari, e direi inequivocabili. Ma quando arriviamo al terzo punto, ecco che allora la questione si fa complessa e per certi aspetti sconcertante. Stavolta è il Dante filosofo-politico che parla, nel trattato sulla Monarchia (I, 3, 4). Seguiamo il suo ragionamento, perché è bellissimo e importante, di tono solenne nella sua conclusione, che esalta l’ideale della pace universale. Dice Dante: «Bisogna ora vedere in che cosa consista il fine ultimo di tutta l’umana società» 37. Perché? Perché ogni essere nel cosmo dantesco viene concepito come ordinato a un fine (ricordiamo che kósmos in greco vuol dire “ordine”). Lo vuole la natura, e lo vuole Dio. E non v’è cosa che sfugga a questa legge: il pollice ha il suo fine, la mano ha il suo, il braccio pure, e così via. L’uomo, l’individuo ha un fine. E ogni fine viene concepito come inferiore a un altro che nella visione divina ha maggiore importanza. Tanto che in ultima analisi è l’umanità intera l’essere il cui fine è superiore a quello di ogni altro.
Già, ma allora, in cosa consiste questo fine di tutti i fini? In altre parole: qual è il fine dell’umanità? Perché Dio l’ha creata? Dice Dante: «Di che si tratti, diverrà manifesto se chiariremo qual sia la potenza specifica dell’intera umanità». Ecco il punto. Se la potenzialità specifica della mano, per esempio, è quella di toccare e di afferrare gli oggetti, e se il suo fine si realizza appunto in quelle operazioni, anche l’umanità dovrà avere una potenzialità specifica da realizzare. Ecco che Dante ci avvia verso la soluzione del problema: egli usa il termine potentia. Realizzare quella potenzialità non vuol dire altro che attualizzarla, ossia tramutare in atto la potenza del genere umano. E in cosa consisterà questa potentia? Certo non nel puro e semplice essere, perché tutte le cose hanno un essere, e quindi non è l’essere in sé che distingue l’uomo dagli altri esseri, inanimati o animati che essi siano. E non è nemmeno l’essere capace di apprendere, perché anche i cani e i cavalli posseggono un certo grado di apprendimento. Dunque, conclude Dante, questa potentia può consistere solo nella facoltà più elevata che l’uomo possiede, ed essa: «è l’essere capace di apprendere per mezzo dell’intelletto possibile, capacità che invero non compete a nessun altro che all’uomo, né al di sopra né al di sotto di lui». L’intelletto possibile è un’esclusiva dell’uomo, è la scintilla divina che vive in lui e che fa parte della sua anima, e che fa partecipe l’uomo dell’immortalità divina.
Fin qui, si direbbe, nulla da eccepire. Dante sta confermando, a quanto pare, con perfetta coerenza la sua concezione dell’intelletto possibile come forma e parte dell’uomo, in opposizione alla teoria averroista della separazione dell’intelletto. Ma all’improvviso, ecco che il suo discorso prende come il volo verso un’altra direzione. Dante insiste con decisione sul concetto che gli sta a cuore, che non è quello dell’uomo come individuo, ma quello dell’uomo come umanità, come genere umano. E qui accade l’imprevisto, qui Dante sviluppa un discorso che lo fa deviare bruscamente dalla scolastica cristiana e lo conduce fatalmente verso quello che poc’anzi avevo definito il “comunismo mistico” di Averroè. Conviene leggere le frasi centrali di questo brano della Monarchia, tale è la loro importanza:
Risulta chiaro pertanto che la potenza specifica dell’umanità è la capacità o virtù intellettiva. E poiché questa potenza non può tutta quanta essere ridotta contemporaneamente in atto da un solo uomo […] è necessario che il genere umano sia costituito da una moltitudine, per opera della quale questa potenza possa essere pienamente attuata, così come è necessaria una moltitudine di cose generabili perché la potenza della materia prima sia sempre tutta quanta in atto, altrimenti bisognerebbe ammettere una potenza separata, il che è impossibile. E con questa affermazione concorda Averroè nel suo Commento al “De anima”.
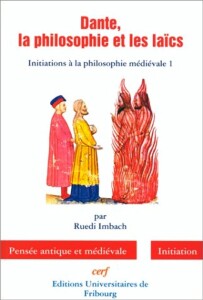 Ora possiamo ben comprendere perché sul pensiero di Dante sia spesso aleggiato il sospetto di un cripto-averroismo. Con grande onestà intellettuale, il cattolico Gilson aveva affrontato la questione nel 1939, ammettendo che l’ultima frase ora citata della Monarchia (“E con questa affermazione concorda Averroè nel suo Commento al De anima”): «Letteralmente intesa, significherebbe che Dante si accorda su questo punto con la dottrina dell’unità dell’intelletto possibile, ossia con la dottrina che non ammette che un solo intelletto possibile per tutto il genere umano, così come Averroè la teorizza nel suo commentario sul De anima» 38. Poi, però, cercando di dare un senso a questa ipotesi che evidentemente contrasta con la condanna dell’errore di Averroè espressa da Dante-Stazio nel Purgatorio, Gilson s’imbarca in un ragionamento fin troppo sottile; sottile al punto da rovesciarsi alla fine quasi nel suo opposto. «Dante – dice Gilson – ha trasposto (transposé) la tesi di Averroè, prendendo il genere umano, ossia la collettività degli individui esistenti in ogni istante sulla terra, come un equivalente dell’intelletto possibile unico di Averroè» 39. In altre parole: con un trucco da prestigiatore, Dante avrebbe utilizzato l’errata ma suggestiva teoria di Averroè trasponendola, ossia – se il significato di questo verbo mi è chiaro – trasportandola, trasferendola, mutandone o addirittura invertendone la dislocazione e la finalità, dalla pura idea (teoretica) dell’intelletto possibile unico di tutti gli uomini, all’idea pratica, politica, sociologica verrebbe da dire, di un’utopica concordia universale – di volontà, ideali, intendimenti – di un’umanità ansiosa di ristabilire il giusto equilibrio e la giusta separazione tra i due poteri, i “due soli” (Purg. XVI, 106-108): il Papato e l’Impero.
Ora possiamo ben comprendere perché sul pensiero di Dante sia spesso aleggiato il sospetto di un cripto-averroismo. Con grande onestà intellettuale, il cattolico Gilson aveva affrontato la questione nel 1939, ammettendo che l’ultima frase ora citata della Monarchia (“E con questa affermazione concorda Averroè nel suo Commento al De anima”): «Letteralmente intesa, significherebbe che Dante si accorda su questo punto con la dottrina dell’unità dell’intelletto possibile, ossia con la dottrina che non ammette che un solo intelletto possibile per tutto il genere umano, così come Averroè la teorizza nel suo commentario sul De anima» 38. Poi, però, cercando di dare un senso a questa ipotesi che evidentemente contrasta con la condanna dell’errore di Averroè espressa da Dante-Stazio nel Purgatorio, Gilson s’imbarca in un ragionamento fin troppo sottile; sottile al punto da rovesciarsi alla fine quasi nel suo opposto. «Dante – dice Gilson – ha trasposto (transposé) la tesi di Averroè, prendendo il genere umano, ossia la collettività degli individui esistenti in ogni istante sulla terra, come un equivalente dell’intelletto possibile unico di Averroè» 39. In altre parole: con un trucco da prestigiatore, Dante avrebbe utilizzato l’errata ma suggestiva teoria di Averroè trasponendola, ossia – se il significato di questo verbo mi è chiaro – trasportandola, trasferendola, mutandone o addirittura invertendone la dislocazione e la finalità, dalla pura idea (teoretica) dell’intelletto possibile unico di tutti gli uomini, all’idea pratica, politica, sociologica verrebbe da dire, di un’utopica concordia universale – di volontà, ideali, intendimenti – di un’umanità ansiosa di ristabilire il giusto equilibrio e la giusta separazione tra i due poteri, i “due soli” (Purg. XVI, 106-108): il Papato e l’Impero.
Che ingegnosa trovata! Dante, conclude Gilson, dimostra veramente un genio originale e creativo nel trasporre sul piano politico il discorso metafisico di Averroè. E non contento, aggiunge: «Certo, egli deve qui qualcosa alla filosofia di Averroè. Gli deve esattamente l’idea, d’altronde magnifica, di un’unità del genere umano in cui l’umanità tutta intera raggiungerebbe in ogni istante il suo fine specifico, che è quello di possedere la conoscenza intellettuale totale di cui è capace» 40. Frase che per la verità sembra riportarci indietro alla casella di partenza, come nel gioco dell’oca, o come in quello del cane che si morde la coda. Gilson se ne rende ben conto, e infatti poco dopo arriva alla conclusione che quello della Monarchia sarebbe sì una sorta di averroismo, ma in forma benigna, un grave errore teoretico riutilizzato però a fin di bene e solo come metafora, per via della sua bellezza e del suo indubitabile potere suggestivo. E questo fin di bene, ovviamente, non sarebbe altro che il sostegno al predetto ideale politico della concorde separazione dei due poteri, il Papato e l’Impero, il sole spirituale che guida l’uomo alla beatitudine celeste, e il sole temporale che lo conduce alla beatitudine terrena.
Le riflessioni di Gilson ci stanno avviando alla conclusione del nostro discorso. Perché è proprio da questa sua interpretazione “politica” dell’averroismo di Dante, che lo studioso francese trae la soluzione del mistero della santificazione di Sigieri nella Divina Commedia. Respingendo quasi con sdegno l’opinione (veramente assurda) di Mandonnet, il quale pensava che Dante si fosse semplicemente sbagliato, perché in realtà non sapeva un bel niente di Sigieri e delle sue teorie averroiste, ma non volendo e non potendo al tempo stesso immaginare che il Poeta fosse un profondo conoscitore o addirittura un seguace di quelle teorie, Gilson concentra tutta la sua attenzione su un’unica idea che gli appare sicura e fondamentale: «Dante sapeva di Sigieri almeno questo, che egli era uno dei rarissimi maestri contemporanei che si potevano eleggere come simboli della filosofia pura, ossia di un aristotelismo estraneo a ogni preoccupazione teologica» 41. Ecco allora trovata la chiave magica: la separazione tra la filosofia e la teologia! Ma a cosa corrisponde quest’idea, se non a quella della separazione tra il potere temporale e quello spirituale? Il gioco allora è fatto: Dante glorifica Sigieri in quanto strenuo e perfino eroico difensore dell’autonomia della ragione rispetto alla fede, e quindi dell’unica teoria che può sorreggere ideologicamente l’ideale politico dell’autonomia dell’Impero rispetto al Papato. E lo fa, ponendo logicamente la lode di Sigieri in bocca a Tommaso, cioè al teologo che, insieme ad Alberto, aveva infranto la barriera del sospetto nei confronti della filosofia pura, ossia del razionalismo aristotelico, e che proprio per questo aveva – seppure post mortem – subìto l’onta della condanna della Chiesa, finendo così paradossalmente “in compagnia” di quegli stessi averroisti, Sigieri e Boezio di Dacia, che pure egli aveva (lealmente, pacificamente) combattuto usando la loro stessa arma filosofica.
Questa è in sintesi la soluzione che Gilson propone per togliere il velo a quello che certamente è uno dei punti più oscuri e incomprensibili della Divina Commedia. Si fonda, come abbiamo visto, sull’ipotesi di una “trasposizione” di significati che ha tutto l’aspetto di un gioco di prestigio, ma il cui risultato finale lascia quasi sbalorditi per la coerenza logica e il perfetto incastro dei riferimenti storici. Con questo suo colpo di genio Gilson, nel 1939, spalanca una porta e indica una via. Sgombrando il campo dalle ipotesi curiali, di chi immaginava che la santificazione dantesca di Sigieri derivasse da un “pentimento”, da un cambiamento di rotta manifestato dal brabantino dopo le condanne del 1270 e del 1277, Gilson conclude le sue riflessioni mettendo in evidenza l’aspetto morale della personalità di Sigieri: «San Tommaso non loda Sigieri per il fatto ch’egli avesse ritrattato degli errori, ma perché egli aveva sofferto per delle verità » 42. Ossia proprio a causa di quegli “invidïosi veri” che gli erano costati l’odio, le condanne, l’esilio, e infine anche la miseranda morte sotto il pugnale di un sicario.
E il messaggio lanciato da Gilson non cade nel vuoto. Prontamente viene recepito ed elaborato dal nostro grande dantista Bruno Nardi, che già da decenni s’era inerpicato, in solitaria e pionieristica impresa, sulle scoscese pareti del mistero dantesco-sigieriano e dell’influsso di Averroè e dell’averroismo sul pensiero di Dante. In un lungo articolo-recensione pubblicato nel 1940 sugli “Studi danteschi” diretti da Michele Barbi, Nardi elogia il saggio di Gilson, ma al tempo stesso ne prende le distanze proprio riguardo alla soluzione gilsoniana del misterioso elogio di Sigieri. Nardi taglia corto sul rapporto Averroè-Monarchia: «Il Gilson s’è posto altresì il problema, se sulla dottrina dantesca della Monarchia sia da vedere un’influenza averroistica. A me pare che una simile influenza sia palese anzi tutto nel primo libro, là dove si vuol provare che fine ultimo dell’umanità, presa nel suo complesso, è quello d’attuare tutta e sempre la potenza dell’intelletto possibile» 43. Evidentemente non gl’interessa affatto discutere di “trasposizioni” di senso o altre sottigliezze del genere; tant’è vero che, subito dopo, introduce senza tante storie la questione sigieriana con queste parole: «Interpretando esattamente il pensiero di Averroè, Sigieri di Brabante aveva detto che v’è un legame essenziale fra l’intelletto e la specie umana, sì che quello non può mai separarsi totalmente dagl’individui ai quali è unito da un rapporto necessario nell’atto dell’intendere. Allo stesso modo l’averroista Giovanni di Jandun afferma, come fa Dante, che il desiderio umano di sapere è soddisfatto in ogni momento dalla collaborazione di tutti gli uomini presi collettivamente» 44.
Ma ciò che veramente non convince Nardi, è il modo assertivo con cui Gilson fa derivare la glorificazione di Sigieri dalla sua difesa dell’autonomia della ragione rispetto alla fede, dimenticando che in realtà nella Divina Commedia la divina Sapienza (Beatrice) prende infine il sopravvento sull’umana ragione (Virgilio), vanificando così la teoria averroistica su cui Dante s’era attestato nella Monarchia:
«L’unità della sapienza cristiana, che la Monarchia aveva infranta, è ristabilita con l’esplicita confessione di Virgilio, ch’egli e tutti gli altri saggi raccolti sui verdi smalti, entro le mura del nobile castello, intorno ad Aristotele, son tormentati per l’eternità da un desiderio che la loro scienza fu incapace di appagare; e coll’affermazione di Dante stesso, che la “sete naturale” di sapere mai non sazia, se non con l’acqua della parola rivelata che sgorga dal fonte della vita eterna. E Ulisse, che impersona in sé la brama di sapere della ragione umana insofferente del limite ad essa segnato da Dio […] ha provato a sue spese, come Prometeo, quanto sia vano lo sforzo per mandare a vuoto gli eterni decreti della Provvidenza» 45.
 Non so. Rinunciare alla bella e ingegnosa argomentazione di Gilson non è facile. Ma non v’è dubbio che anche l’obiezione di Nardi abbia solide basi. E d’altra parte, non mi pare che dopo le analisi serie ed equilibrate di questi due studiosi la questione sigieriana abbia compiuto dei significativi passi in avanti, considerando per esempio la tesi estrema di Ruedi Imbach, che (assurdamente, a mio parere) accomuna la figura di Dante a quelle degli aristotelici radicali 46. Giustificare l’elogio di Sigieri da parte di Tommaso in base alla semplice supposizione che Dante fosse stato un averroista, a me pare semplicemente inconcepibile. Dante poteva pretendere tutto dall’angelico Tommaso, ma non di commettere un simile insensato harakiri intellettuale. E non mi pare affatto, leggendo con attenzione le parole di Nardi, che il grande dantista fosse incline appunto ad avallare una tesi del genere, come invece ha creduto recentemente il compianto islamologo Massimo Campanini 47.
Non so. Rinunciare alla bella e ingegnosa argomentazione di Gilson non è facile. Ma non v’è dubbio che anche l’obiezione di Nardi abbia solide basi. E d’altra parte, non mi pare che dopo le analisi serie ed equilibrate di questi due studiosi la questione sigieriana abbia compiuto dei significativi passi in avanti, considerando per esempio la tesi estrema di Ruedi Imbach, che (assurdamente, a mio parere) accomuna la figura di Dante a quelle degli aristotelici radicali 46. Giustificare l’elogio di Sigieri da parte di Tommaso in base alla semplice supposizione che Dante fosse stato un averroista, a me pare semplicemente inconcepibile. Dante poteva pretendere tutto dall’angelico Tommaso, ma non di commettere un simile insensato harakiri intellettuale. E non mi pare affatto, leggendo con attenzione le parole di Nardi, che il grande dantista fosse incline appunto ad avallare una tesi del genere, come invece ha creduto recentemente il compianto islamologo Massimo Campanini 47.
Come uscire dunque dall’impasse? Dicevo, all’inizio di questa analisi, che una certa plausibile idea me la sono fatta. Non voglio girarci troppo intorno: l’intera questione, a mio parere, dovrebbe essere depurata da ogni intento o sottofondo ideologico, e perciò ricondotta e incentrata non sull’averroismo, o sul tomismo, o su qualsiasi altra teoria a cui avesse fatto riferimento Sigieri. Molto più semplicemente, invece, si dovrebbe puntare sul significato storico di quella classe di “nuovi intellettuali” affermatisi – anche in modo turbolento – nel corso del secolo XIII grazie alla ventata rinnovatrice della cultura filosofica e scientifica greco-araba, che insieme alla riscoperta dei classici poneva in Europa le basi dell’età umanistica. Di quella classe, sicuramente Dante faceva parte, anche se la sua mente aperta e il suo spirito universalista lo ponevano, per così dire, al di sopra di tutte le parti, impegnato in un’opera grandiosa di valorizzazione e di sintesi di tutte le tradizioni e di tutte le correnti culturali del suo tempo.
Ed è qui che, a mio giudizio, diventa necessario allargare il discorso a quella concezione etica della magnanimità e della nobiltà d’animo, che fu un po’ la bandiera ideale dei nuovi intellettuali, al di là della loro aderenza o meno alle idee cardine dell’aristotelismo o dell’averroismo. Lo dice con chiarezza Jacques Le Goff, nel commentare appunto l’enigma dantesco del Sigieri in paradiso:
«Gli è che Sigieri, male conosciuto, rappresenta un gruppo anch’esso mal noto che, a un dato momento, fu l’anima stessa dell’Università di Parigi. Egli esprime infatti l’opinione della maggioranza della Facoltà delle Arti la quale, checché se ne sia detto, fu il sale e il lievito dell’Università e le impresse spesso il proprio sigillo […] L’ideale più rigoroso dell’intellettuale si elabora nell’ambiente averroista della Facoltà delle Arti. Spetta a Boezio di Dacia affermare che: “i filosofi – questo è il nome che si danno gli intellettuali – sono naturalmente virtuosi, casti e temperanti, giusti, forti e liberali, dolci e magnanimi, magnifici, sottomessi alle leggi, indifferenti all’attrazione dei piaceri […] Magnanimi: ecco pronunciata la grande parola […] Essa è una spiritualità tipicamente laica, fatta per uomini che restano impegnati nel mondo, e cercano Dio non più immediatamente come la spiritualità monastica, ma attraverso l’uomo e attraverso il mondo»48.
A quegli stessi ideali, espressi da Boezio di Dacia nel De summo bono sive de vita philosophi, e da Sigieri nelle Quaestiones morales, fanno riferimento Nardi nell’articolo già sopra citato, e Augusto Illuminati nella Introduzione all’antologia degli scritti di Averroè sull’anima, da lui curati 49. Ma come non pensare a questo punto all’ideale etico della nobiltà d’animo, che della magnanimità è gemella, e che ci riconduce a quelle pagine fondamentali del Convivio in cui Dante invita a giudicare gli uomini non dalle loro apparenze, non dalle loro ricchezze materiali ed esteriori, ma dal valore delle loro azioni e dalla sincerità dei loro pensieri: quella è la vera “nobilitade”, che altro non è che grandezza dell’anima, magnanimità. Basti pensare all’elogio del nobile Saladino, che Dante, appunto, tesse esplicitamente nel Convivio (IV, 11), e implicitamente nella Commedia (Inf. IV, 129), a dispetto del fatto che il sultano fosse stato il supremo nemico della Cristianità! E ora quella storia viene a collegarsi, e quasi a coincidere con quella di Sigieri in una perfetta simmetria di significati. A ben pensarci, ecco, due nemici della fede cristiana, il musulmano sterminatore di crociati, e l’eretico averroista, accomunati nel benevolo giudizio di Dante, entrambi in virtù della loro innegabile grandezza d’animo.
E non è forse superfluo rammentare qui ancora una volta la stretta affinità dello spirito dantesco, insofferente delle apparenze, delle falsità, delle ipocrisie – massime di quelle dei finti religiosi, come i papi simoniaci o golosi o avidi di potere temporale – con lo spirito che domina la seconda parte del Roman de la Rose. Falsembiante è il vero nemico, il vero bersaglio di Jean de Meun. Ed è lui nel Fiore il vero assassino di Sigieri. Immortali sono i versi che Jean de Meun dedica alla descrizione della vera nobiltà:
Nasce la nobiltà da un grande cuore,
perché la nobiltà ereditaria
non è una nobiltà di valore
se a chi la possiede manca un grande cuore 50
 E di gran significato è il fatto che, subito dopo, Jean de Meun proponga la figura ideale del “chierico”, cioè proprio dell’intellettuale, studente o professore universitario, uomo libero, dall’animo onesto e sincero, esente dai vizi, come emblema della vera nobiltà, vera anticipazione dell’homo pro se di Erasmo. Questo era anche l’ideale di Sigieri, e di Boezio di Dacia. E non era forse questo anche il modello etico di Dante? E non poteva essere forse questa una buona ragione, anzi ottima, per riabilitare solennemente la memoria dello sventurato filosofo brabantino? In fondo, mi pare che anche Nardi abbia pensato più o meno questa stessa cosa, a giudicare dalla conclusione che egli trae dalle sue riflessioni sul “caso Sigieri”:
E di gran significato è il fatto che, subito dopo, Jean de Meun proponga la figura ideale del “chierico”, cioè proprio dell’intellettuale, studente o professore universitario, uomo libero, dall’animo onesto e sincero, esente dai vizi, come emblema della vera nobiltà, vera anticipazione dell’homo pro se di Erasmo. Questo era anche l’ideale di Sigieri, e di Boezio di Dacia. E non era forse questo anche il modello etico di Dante? E non poteva essere forse questa una buona ragione, anzi ottima, per riabilitare solennemente la memoria dello sventurato filosofo brabantino? In fondo, mi pare che anche Nardi abbia pensato più o meno questa stessa cosa, a giudicare dalla conclusione che egli trae dalle sue riflessioni sul “caso Sigieri”:
«Se si pone attenzione a tutto questo e alla circostanza che l’elogio di Sigieri è posto in bocca al suo più temibile avversario, Tommaso d’Aquino, l’unica soluzione del problema riesaminato dal Gilson mi pare ancora quella che proposi ventotto anni fa, aver voluto il poeta fiorentino rialzare la memoria d’un onesto pensatore, grandemente stimato dai suoi contemporanei, la quale giaceva sotto il peso dei colpi inferti dall’invidia, e mostrarci riconciliati nel cospetto della verità eterna due grandi pensatori a lui cari, senza settarismo di scuola» 51.
Francamente, non credo che si possa immaginare qualcosa di più sensato di queste parole.
Dialoghi Mediterranei, n. 63, settembre 2023
Note
[1] Preambolo, sì, ma da non confondere, qui, con quella che Tommaso d’Aquino definisce beatitudo imperfecta, e che Dante dice “perfetta quasi”, come appare evidente da questa osservazione di Gilson: «Per situare Dante in rapporto a san Tommaso, basta comparare ciò ch’egli dice a ciò che aveva scritto il Dottore Angelico, nella Somma Teologica, circa la classificazione delle beatitudini: La beatitudine ultima e perfetta (perfecta: Dante dice “somma”) attesa nella vita futura consiste interamente nella contemplazione come nel suo principio; quanto alla beatitudine imperfetta (Dante dice “perfetta quasi”), quale la si può ottenere in questo mondo, essa consiste in verità, in primo luogo principalmente nella contemplazione, ma secondariamente nell’operazione dell’intelletto pratico che mette ordine nelle azioni e nelle passioni, com’è detto nel Libro X dell’Etica [Nicomachea di Aristotele], capitoli 7 e 8.» É. Gilson, Dante et la philosophie, Paris 1972: 138.
[2] Latinizzato in Alfraganus o Alfarganus, citato da Dante in Convivio II, 13 come Alfagrano; si tratta di Abū l-ʻAbbās al-Farġānī, vissuto nel IX secolo. Il suo compendio di astronomia tolemaica fu tradotto in latino nel sec. XII col titolo di Liber de aggregationibus scientiae stellarum da Gerardo da Cremona e da Giovanni di Siviglia. Per Alfragano in Dante si veda: P. Duhem, Le Système du Monde, tome IV, Paris 1973: 222-229.
[3] P. Duhem, Le Système, cit., tome V: 440-450.
[4] P. Duhem, Le Système, cit., tome IV: 493. La meravigliosa macchina delle dieci intelligenze era in realtà di una complessità sconcertante. Nel trattato della Città virtuosa (Al-madīna al-fāḍila) Al-Fārābī ne dà una descrizione rigorosamente basata sul principio neoplatonico secondo cui dal supremo Uno, che è Dio, non fit nisi unum, ossia non può scaturire – emanare – altro che un solo essere. La prima creatura di Dio non è dunque il mondo nella sua molteplicità, ma è un essere singolo e puramente intellettuale, una intelligenza che si pone in rapporto di dipendenza diretta dall’Uno-Dio. Semplificando al massimo – perché in realtà il meccanismo è ancora più complicato – il processo emanativo si sviluppa così: questa prima intelligenza non ha che due possibilità di intellezione: può contemplare il suo creatore, e può contemplare se stessa. Questi due atti di intellezione danno luogo a due nuove emanazioni: nel primo caso, dalla prima intelligenza emana una seconda intelligenza – che sarà la prima delle nove intelligenze cosmiche –; nel secondo caso emanerà da essa la prima e la più elevata delle sfere celesti, in arabo il falak al-aflāk, la sfera delle sfere, il cielo superiore del cosmo tolemaico, motore immobile, entità invisibile e priva di corpi celesti. E da qui in poi la processione delle intelligenze e delle sfere procede, con lo stesso meccanismo della doppia contemplazione, sviluppando in tutto nove sfere dotate di intelligenza, di anima, e di un corpo etereo incorruttibile: dopo la sfera vuota e immobile viene la sfera mobile delle stelle fisse, seguita dalle sette sfere planetarie che s’arrestano in basso con il cielo della Luna. (Abū Naṣr al-Fārābī, Kitāb ārā’ ahl al-madīna al-fāḍila, Bayrūt 1986; e per una estesa esposizione: ʻA. Badawi, Histoire de la philosophie en Islam, II, Les Philosophes purs, Paris 1972: 538-543).
[5] A. Magno, Scriptum in secundum librum Sententiarum, dist. XIV, art. VI. P. Duhem, Le Système, cit. tome V: 447-448. La questione fu naturalmente discussa anche tra i pensatori musulmani. Si veda: Averroè, L’incoerenza dell’incoerenza dei filosofi, Torino 1997: 438-447: “Quattordicesimo problema: sull’incapacità dei filosofi a dimostrare che il cielo è un animale che obbedisce nel suo movimento circolare a Dio benedetto ed eccelso”.
[6] T. d’Aquino, Quaestio disputata de immortalitate animae, 5-6. De unitate intellectus contra averroistas, IV, 83.
[7] Dante lo chiama “Torso” sbagliando, perché credeva che Papa Martino fosse originario di Tours.
[8] J. Le Goff, Gli intellettuali nel Medioevo, Milano 1984 (19591): 103-104.
[9] P. Mandonnet, Siger de Brabant et l’averroïsme latin au XIIIme, siècle, Louvain 1911; Première partie: 262-286. La data del 10 novembre 1284, fissata come terminus ante quem per la morte di Sigieri, si spiega col fatto che la sua uccisione viene riferita in una lettera del teologo francescano John Peckham recante appunto quella data.
[10] Si tratta del celebre “opuscolo filosofico” De unitate intellectus contra averroistas, di cui si dirà tra breve.
[11] Il dantesco “vico delli strami” corrisponde alla Rue du Fouarre, che al giorno d’oggi prosegue verso sud cambiando (giustamente) il nome in Rue Dante. Gli strami erano i mucchi di paglia (in francese antico feurre o fouarre, da cui l’attuale termine fourrage, analogo all’italiano “foraggio”) che gli studenti universitari usavano come cuscini a terra per assistere alle lezioni. Questo fatto curioso ha una spiegazione storica precisa: fu il papa francese Urbano IV a obbligare gli studenti: «ad ascoltare le lezioni seduti per terra per spirito di abnegazione, per allontanare dalla loro gioventù ogni tentazione di orgoglio» (Nouveau Dictionnaire Historique de Paris, Gustave Pessard, 1904).
[12] Si tratta della condanna delle 219 tesi eretiche emanata dal vescovo di Parigi Étienne Tempier nel marzo del 1277, di cui si riparlerà tra breve.
[13] E qui è giocoforza che la fantasia possa mettersi a galoppare. E non sto alludendo agli autori di bestseller, ma agli studiosi più seri. Gilson citava, per esempio, il caso dello storico Salomon Reinach, il quale sostenne (L’énigme de Siger, “Revue historique”, t. CLI, 1926), che Dante conobbe personalmente Sigieri in Italia nel 1282, e che da lui fu avviato alla conoscenza della filosofia e all’apprezzamento del pensiero di Alberto Magno, di Tommaso d’Aquino, e naturalmente di Aristotele e di Averroè. (É. Gilson, Dante et la philosophie, Paris 1972(1939): 260, nota.
[14] «Soltanto Anassagora sostiene che l’intelletto è impassivo e non ha niente in comune con nessuna delle altre cose […] Di qui è necessario che l’intelletto, poiché pensa tutte le cose, sia non mescolato, come dice Anassagora.» De anima, I (A), 2, 405 b/ III (Γ), 4, 429 a. (Traduzione di Renato Laurenti, Bari 1973: prendo da qui ogni altra citazione del De anima di Aristotele).
[15] Jean-Baptiste Brenet, Averroè l’inquietante. L’Europa e il pensiero arabo, Roma 2019 (Paris 2015).
[16] Classici studi sull’argomento: Octave Hamelin, La Théorie de l’intellect d’après Aristote et ses commentateurs, Paris 1953; É. Gilson, Les sources gréco-arabes de l’augustinisme avicennisant, Paris 1981 (1929-19301). B. Nardi (a cura di) in S. Tommaso d’Aquino, Trattato sull’unità dell’intelletto contro gli averroisti, Firenze 1947.
[17] Abū Naṣr al-Fārābī, Kitāb as-siyāsa al-madaniyya, Bayrūt 1964: 32.
[18] Grande commento al Libro terzo del De anima di Aristotele, in Averroè e l’intelletto pubblico, a cura di Augusto Illuminati: 138-139. Per il testo latino nella versione di Michele Scoto: F. Stuart Crawford, Averrois Cordubensis Commentarium Magnum in Aristotelis De anima libros, Cambridge-Philadelphia 1953. Questo testo è stato riprodotto anche da Badawi, in Histoire de la philosophie en Islam, II, Les Philosophes purs, Paris 1972: 835-849.
[19] G. de Ruggiero, La filosofia del cristianesimo, Bari 1967, vol. II: 526-527.
[20] Troppo lungo e complesso sarebbe qui il discorso sulla vexata quaestio della cosiddetta “doppia verità”, ossia sulla teoria che erroneamente un tempo fu attribuita ad Averroè, e che dichiarava opposte e inconciliabili le verità di fede e quelle di ragione. Per Averroè le “favole” della religione non erano falsità opposte alla ragione, ma verità propedeutiche rispetto alle verità razionali, ispirate da Dio ai profeti per guidare sulla retta via le menti più semplici, incapaci di elevarsi al grado del superiore raziocinio. Si veda per questo: Averroè, Il trattato decisivo sull’accordo della religione con la filosofia, a cura di Massimo Campanini, Milano 1994.
[21] Dalla Introduzione di Antonio Petagine a: Sigieri di Brabante, L’anima dell’uomo, Milano 2007: 8.
[22] Frutto di quelle lezioni fu il trattato Quaestiones in tertium De anima (Questioni sul terzo libro del De anima di Aristotele). In seguito, per ribattere alle critiche espresse contro il suo pensiero da Tommaso d’Aquino nel De unitate intellectus contra averroistas, scriverà il Tractatus de anima intellectiva. Entrambi questi libri di Sigieri andarono perduti per secoli, e furono ritrovati solo alla fine dell’Ottocento da Pierre Mandonnet, e da lui pubblicati a Lovanio agl’inizi del Novecento.
[23] «L’intelletto così separato è come l’occhio, sì, ma come un occhio tranciato, reciso dai filetti nervosi […] Averroè non attacca l’epidermide, va dritto alle viscere. È un cavatore d’occhi.» (J.-B. Brenet, Averroè l’inquietante, cit.: 30).
[24] Questioni sul terzo libro del De anima, in: Sigieri di Brabante, Anima dell’uomo, Milano 2007: 209. Da notarche questa idea dell’intelletto unico estraneo all’anima, e che tuttavia “opera” nell’anima, unendosi ad essa mediante l’immaginazione, può anche far pensare, come nota Brenet riferendosi ad alcune formulazioni di Tommaso, a un’azione demoniaca dell’intelletto averroista, che ridurrebbe perciò l’uomo allo stato di “posseduto” e di “energumeno” nel senso etimologico del termine: dal greco en, che vuol dire “in”, e da ergon che significa “lavoro”. (J.-B. Brenet, Averroè l’inquietante, cit.: 48).
[25] In precedenza anche Robert Kilwardby (nel 1252), Bonaventura da Bagnoregio (nello stesso anno), e Alberto Magno (nel 1256), avevano attaccato la dottrina di Averroè sull’intelletto. Ora però il pericolo vero non era più tanto Averroè, quanto l’averroismo di Sigieri e di Boezio di Dacia.
[26] L’unità dell’intelletto contro gli averroisti, in: T. d’Aquino, L’ente e l’essenza. L’unità dell’intelletto, a cura di Abelardo Lobato, Roma 1998: 85.
[27] Ibid.: 116.
[28] Averroè e l’intelletto pubblico. Antologia di scritti di Ibn Rushd sull’anima, a cura di Augusto Illuminati, Roma 1996:10-11.
[29] Sigieri di Brabante, Anima dell’uomo, cit.: 61.
[30] Giovanni XXI fu quel Pietro Ispano che Dante colloca nel cielo del Sole (Parad. XII, 134), lo stesso cielo – ironia della sorte – in cui si trova Sigieri accanto a Tommaso e agli altri spiriti sapienti. Ironia su ironia: è anche l’unico Papa che Dante pone in paradiso. Ma nel cielo del Sole accade di tutto! Perfino la presenza dell’Abate Gioacchino (“il calavrese abate Giovacchino/ di spirito profetico dotato”, Parad. XII, 140-141) accanto a San Bonaventura che in realtà lo aveva combattuto giudicandolo un falso profeta.
[31] B. Nardi, L’averroismo di Sigieri e Dante, in “Studi danteschi” diretti da M. Barbi, XXII, 1938: 93.
[32] J. Le Goff, Gli intellettuali nel Medioevo, cit.: 119.
[33] C. Falconi, Storia dei Papi e del Papato, vol. III°, Roma-Milano, 1970: 372.
[34] «In campo religioso non fece parlare di sé che per una funesta parzialità per gli ordini mendicanti. Già da cardinale aveva dimostrato questa tendenza […] ma da papa superò ogni limite con la bolla Ad fructus uberes del 13 dicembre 1281, ampliando sconsideratamente i privilegi di predicazione e confessione loro conferiti […] Ciò significava che i frati mendicanti non dovevano più rendere conto ai vescovi e ai parroci della loro attività pastorale.» (C. Falconi, Storia dei Papi e del Papato, cit.: 378).
[35] B. Nardi, L’averroismo di Sigieri e Dante, cit.: 112; Dante e la filosofia, in “Studi danteschi” diretti da M. Barbi, XXV, 1940: 32.
[36] «Ora la tesi sostenuta da Alberto Magno nel De natura et origine animae e combattuta da Tommaso […] è, senz’ombra di dubbio, quella accolta da Dante nel Convivio e nel Purgatorio.» «Secondo questa teoria, l’intelletto non è una seconda anima che coesista con quella vegetativo-sensitiva e diversa sostanzialmente da questa; ma s’unisce intimamente e, per così dire, si salda con essa in modo da formare un’anima sola, la quale è tutta intera forma del corpo umano» (Nardi, L’averroismo di Sigieri e Dante, cit.: 110-111). Su questo tema, ancora Nardi: Sull’origine dell’anima umana, in “Giornale dantesco”, XXXIX (1938): 15-28 (Lo stesso articolo è contenuto nel libro: Nardi, Dante e la cultura medievale, Bari 1985: 207-224). Da notare che nel lungo passo del Convivio rammentato da Nardi (IV, 21), Dante nomina Algazel, Avicenna, Aristotele, Agostino, e perfino Tullio (Cicerone), ma si guarda bene dal citare Averroè.
[37] Seguo qui la versione italiana di Luigi Blasucci, in: Dante Alighieri, Tutte le opere, Firenze 1965; Monarchia I, 3,4: 250-253.
[38] É. Gilson, Dante et la philosophie, Paris 1972(1939): 169.
[39] Ivi: 171.
[40.] Ivi: 172.
[41] Ivi: 263.
[42] Ivi: 324.
[43] B. Nardi, Dante e la filosofia, cit.:29.
[44] Ivi: 30.
[45] Ivi: 38-39.
[46] R. Imbach, Dante, la philosophie et les laics, Paris 1996: 144-148.
[47] «Il non-tomismo di Dante era stato, peraltro, ben prima di Imbach, sostenuto, ancora una volta, da Nardi, il quale proprio perciò connetteva Dante all’averroismo e così spiegava l’anomalia della collocazione di Sigieri in Paradiso.» (M. Campanini, Dante e l’Islam. L’empireo delle luci, Roma 2019: 139).
[48] J. Le Goff, Gli intellettuali nel Medioevo, Milano 1959: 121-122.
[49] Averroè e l’intelletto pubblico. Antologia di scritti di Ibn Rushd sull’anima, a cura di Augusto Illuminati, Roma 1996: 13. B. Nardi, Dante e la filosofia,cit.: 33-34.
[50] Roman de la Rose, vv. 18.589-592.
[51] B. Nardi, Dante e la filosofia, cit.: 41.
_____________________________________________________________
Massimo Jevolella. Si laurea in filosofia nel 1974 con Remo Cantoni con una tesi sull’utopia surrealista. Fin dal 1979 si dedica allo studio del pensiero islamico ed ebraico medievale. Negli anni ‘80 collabora con la rivista “Studi cattolici” e con l’Istituto di Storia della Filosofia dell’Università Statale di Milano. Pubblica articoli sulla rivista “Acme” della Facoltà, traduce testi filosofici dall’arabo (come il Libro dei cerchi di Ibn As-Sid al-Batalyawsi, Arché Editore), ed entra in contatto con i professori Giuseppe Sermoneta e Shlomo Pines dell’Università Ebraica di Gerusalemme (dove nel 1985 partecipa a un convegno internazionale su Maimonide, con uno studio sulle fonti arabe della profetologia nella Guida dei perplessi). Negli anni ‘90 dirige la collana di libri “Spazio interiore” della Red di Como. Nel 1991 pubblica il libro di saggistica-narrativa I sogni della storia (Mondadori Oscar). Seguono i saggi: Non nominare il nome di Allah invano (Boroli 2004, con postfazione di Franco Cardini); Le radici islamiche dell’Europa (Boroli 2005); Saladino eroe dell’Islàm (Boroli 2006); Rawà, il racconto che disseta l’anima (Red 2008); la traduzione dall’arabo e curatela del Collare della colomba di Ibn Hazm (Apogeo-Feltrinelli-Urra 2010); l’antologia coranica Corano, libro di pace (Apogeo-Feltrinelli-Urra 2013). La traduzione integrale in prosa e curatela del Romanzo della Rosa di J. De Meun e G. De Lorris (Feltrinelli UE 2016). Torna sul tema dell’utopia con uno studio sulla “città ideale” dei filosofi arabi, pubblicato nel 2012 sui “Quaderni di studi Indo-Mediterranei”. Intensa la sua attività di conferenziere, fin dai primi anni ‘80 e in molte città d’Italia, indirizzatasi sempre più sul versante del dialogo interreligioso e interculturale. Di recente, ha fatto dono degli oltre 700 volumi della sua biblioteca di cultura islamica ed ebraica alla Biblioteca del Seminario Vescovile di Mazara del Vallo (Fondo Jevolella).
_____________________________________________________________