di Sergio Todesco
L’etnocentrismo critico di cui sessant’anni fa ci parlava Ernesto de Martino si proponeva certamente l’allargamento della coscienza culturale dell’Occidente di fronte alle sfide costituite dall’incontro etnografico con culture diverse, attraverso l’acquisizione di una consapevolezza critica dei limiti della propria. La formula metteva infatti in discussione «le stesse categorie di osservazione di cui lo studioso dispone all’inizio della ricerca». Con questa tensione etico-speculativa si poteva realizzare, secondo l’etnologo napoletano, quell’umanesimo etnografico che implicava un’opera di storicizzazione di sé e della propria cultura, e di riflessione critica sul proprio télos. Tale posizione non comportò mai però per lo studioso la rinunzia a credere in un primato della civiltà occidentale, i cui modelli più avanzati, costruitisi faticosamente attraverso una lunga e sofferta storia culturale che dai filosofi greci al diritto romano, dal Cristianesimo all’Umanesimo e al Rinascimento, dall’Illuminismo al Socialismo, all’Idea liberale (nei loro motivi di verità), e finanche – si potrebbe oggi aggiungere – al voto alle donne, al Sessantotto, al movimento ecologista e alla teoria della decrescita felice, era giunta a riconoscere il valore centrale della persona umana.
Il modello della civiltà “europeo-occidentale” appariva a de Martino, in questo senso, più avanzata non tanto sul piano del sapere scientifico, della tecnologia e dello sviluppo culturale, quanto su quello dei diritti umani e della scoperta della origine e destinazione integralmente umane di tutti i beni culturali.
«Che si debba mantener fede alla ragione, come télos dell’umanità rappresentato in modo eminente dall’Occidente, o che si debba invece abdicare davanti all’irrazionale e tornare a fare di esso il tema fondamentale della vita: questa alternativa si chiama Europa, poiché noi europei la stiamo vivendo con una drammaticità che non ha l’eguale in nessuna altra civiltà del nostro pianeta. Che il viver civile debba essere ordinato secondo le forme di una democrazia socialista o debba sostanzialmente muoversi nel margine di scelte possibili per entro la democrazia borghese, anche questa alternativa si chiama Europa, perché in Europa ebbero le loro radici le condizioni sociali e la tensione di pensiero che prepararono questi due messaggi, che oggi polarizzano intorno a sé le altre umanità dell’ecumene. Il prodigioso sviluppo delle scienze e la attuale prospettiva della conquista degli spazi cosmici si chiama ancora Europa, da Galileo a Einstein: le altre civiltà non ci propongono a questo riguardo nulla di radicalmente nuovo e più alto, ma, se mai, scelte per noi improponibili come, per esempio, il viaggio psichico degli sciamani asiatici verso i superi e versi gli inferi, o la sapienza dei Veda, o quella di Confucio, o lo Yoga o il Buddhismo Zen, per tacere dei vari occultismi europei, cui indulgono le anime stanche e i cervelli deboli. Senza dubbio il naturalismo e il tecnicismo costituiscono per noi un pericolo mortale, in quanto perdono l’uomo nel mondo delle cose e ne compromettono il ritorno a sé, la presa di possesso di sé, lo scoprirsi come margine oltre la natura, insomma tutto quanto fonda l’umanità occidentale come ethnos operativo. Ma contro questo pericolo la difesa sta nella storia interna dell’Occidente, cioè nel far progredire la “ragione” oltre i limiti storici in cui sinora l’Occidente ne ha avuto coscienza. Abbandonare la ragione e abbracciare sistemi di scelte estranei al suo télos, non diremmo che l’Europa non possa, ma certo non deve: e non deve perché le scelte culturali non sono arbitrarie, permutabili a piacere, ma formano coerenze e fedeltà che comportano anche rinunzie definitive».
Povero Ernesto! Sessant’anni fa si illudeva ancora che l’Occidente avesse sviluppato in tal grado una sua forte identità razionale e democratica da potersi porre come metro per misurare il tasso di Zivilisation raggiunto dal resto del mondo!
Allora proviamo, così per gioco, a modificare aggiornandolo un aureo passo di Carlo Marx tratto dall’Ideologia Tedesca:
«Le narrazioni della classe dominante sono in ogni epoca le narrazioni dominanti; cioè la classe che è la potenza materiale dominante della società è in pari tempo la sua potenza spirituale dominante. La classe che dispone dei mezzi della produzione materiale dispone con ciò, in pari tempo, dei mezzi della produzione intellettuale, cosicché ad essa in complesso sono assoggettate le narrazioni di coloro ai quali mancano i mezzi della produzione intellettuale. Le narrazioni dominanti non sono altro che l’espressione ideale dei rapporti materiali dominanti, sono i rapporti materiali dominanti presi come narrazioni: sono dunque l’espressione dei rapporti che appunto fanno di una classe la classe dominante, e dunque sono le narrazioni del suo dominio…».
Se al termine “idee” sostituiamo “narrazioni” ci rendiamo conto di come, nel generale flusso comunicativo nel quale siamo oggi immersi e che ci avvolge come placenta, sia ormai regola invalsa e da tutti subìta quella di scambiare la realtà con le sue innumerevoli e assai spesso fallaci rappresentazioni. In realtà nel tempo che viviamo si è imposto l’uso di un linguaggio malato. Purtroppo un linguaggio malato se reiterato diventa contagioso (la madre delle spugne è sempre incinta) e sortisce pian piano l’assuefazione alla malattia, in breve una società malata e per di più inconsapevole di esserlo.
Nel mese di novembre dell’anno scorso mi sono recato, insieme ad altri messinesi, ad altri italiani che la pensano come me, a Riace per rendere omaggio e manifestare solidarietà a quell’eroe dei nostri tempi che è Mimmo Lucano. Una solidarietà che ha visto radunarsi in questo paesino un migliaio di persone, poeti artisti musicisti, e che ha registrato la presenza di Alex Zanotelli, di Luigi De Magistris, di Gad Lerner, oltre che di una nutrita rappresentanza di persone e comunità resistenti provenienti da varie parti d’Italia, non ultimo – per quanto riguarda la Sicilia – l’ex sindaco di Messina Renato Accorinti.
Ho scritto eroe, ma forse avrei fatto meglio a scrivere martire. È proprio infatti dei martiri andare incontro a sofferenze per aver testimoniato una verità che agli occhi del potere dominante appare eretica, scomoda in quanto potenzialmente in grado di scardinare i comodi, tranquillanti equilibri sui quali si regge l’esercizio e il mantenimento del potere stesso. L’eresia di Mimmo Lucano è stata ed è tuttora quella di ritenere che i migranti, la massa di disperati e di emarginati che in gran numero abbandonano i propri angoli di mondo e lasciano la vita nel Mare Nostrum (mare mostrum/male nostrum), costituiscano per il languido, crepuscolare e pavido Occidente una ricchezza e una risorsa piuttosto che un problema e un pericolo. Credendo in ciò, egli ha anteposto a una legge farraginosa e spietata la pietà e la verità, agendo da uomo giusto che obbedisce alle leggi del cuore e della ragione prima ancora che a quelle dei codici e degli egoismi.
Mimmo Lucano è un tipo che ha compreso, molto meglio di tanti politici e uomini di pensiero, che se alla globalizzazione delle merci non si accompagna la globalizzazione dei diritti, il nostro pianeta è condannato alla conflittualità senza fine dell’homo homini lupus. Ha compreso che se avere una vita normale o averne una orrida altro non sono che delle variabili dipendenti dal destino che assegna a caso l’angolo di mondo in cui si nasce, allora è diritto di tutti poter scegliere in libertà in quale angolo di mondo vivere.
Sono stati recentemente resi disponibili, con dolore e strazio di molti che hanno avuto modo di vederli, alcuni documenti video sulle spose bambine afghane (bambine, ripeto, di 8, 9 anni), che vengono vendute per pochi soldi dalle loro misere e miserabili famiglie a vecchi sporcaccioni bavosi che non vedono l’ora di violare i loro fragili corpi per soddisfare il proprio io malato. Quelle famiglie si privano delle loro creature con uno strazio mille volte maggiore di quello da me provato, ma lo fanno per disperazione, perché sono ridotte a una miseria totale che non lascia scampo e non permette loro di vivere neanche al grado infimo della dignità umana. Quelle bimbe, vendute per pochi denari, sono loro il Cristo dei nostri giorni.
Qualche benpensante osserverà che queste sono cose che non ci riguardano, che se gli Afghani sono oggi costretti a subire il ritorno dei talebani tali orrori sono una conseguenza della loro scelta politica sciagurata (ammesso e non concesso che tale scelta essi siano stati messi in condizione di farla). Bene, Mimmo Lucano non la pensa allo stesso modo, per lui, come per il poeta John Dunne (come, ai nostri tempi, è stato per Gino Strada), la campana che suona a morto suona sempre anche per ognuno di noi, in quanto nessun uomo è un’isola e tutti noi umani non siamo altro che emergenze di un unico planetario continente sommerso.
Da qui la rivoluzione, l’utopia divenuta realtà della Riace di Lucano, che combattendo contro mafie e istituzioni si è affermata in tutto il mondo come un modello di società nuova, dinamica, accogliente, multietnica, meticcia, volta all’abbattimento di qualunque muro reale o simbolico più che alla creazione di barriere reali e simboliche tra esponenti dell’unica razza plausibile, quella umana. Mimmo Lucano ha realizzato tutto ciò creando lavoro, ripopolando spazi demograficamente desertificati da migrazioni e false promesse di sviluppo, ridotti per decenni a non-luoghi e restituiti alla gioia di un’esaltante esperienza comunitaria. Lo ha fatto non aggirando o violando le norme, ma leggendo e mettendo in pratica queste stesse norme secondo il loro più intimo motivo di verità costituzionale, quello secondo cui tutti gli esseri umani sono uguali e hanno, devono avere, eguali diritti.
Se tale fedeltà allo spirito delle regole piuttosto che alla loro mera camicia burocratica è potuta apparire agli occhi di una giustizia distratta e altalenante (la Procura di Locri – uno dei territori maggiormente interessati dall’azione della ’Ndrangheta – che si accanisce contro una persona impegnata da una vita a contrastare le mafie) un cumulo di reati, di “ribellioni” contro l’autorità costituita, bene, nessun motivo di sorpresa. Mimmo Lucano altri non è che l’ultimo eroico esponente di un folto gruppo di ammutinati che conta tra le sue fila, tra gli altri, Antigone, Socrate, Giordano Bruno, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Don Milani, Danilo Dolci, Erri De Luca, e come capostipite ideale quel giovanotto nazareno a detta del quale «il sabato è stato fatto per l’uomo, e non l’uomo per il sabato».
Per tenere fede a tale principio, a tale valore superiore a qualunque codicillo, Mimmo Lucano ha speso energie, e oggi possiamo dire l’intera sua vita, sforzandosi di riconferire dignità di persone e speranze di futuro a “dannati della terra”, come li chiamava Frantz Fanon con ciò intendendo ridefinire l’identità di un pezzo di umanità sottratta al giogo coloniale. Identità! Ecco ritornare sempre questo concetto, che un tempo designava realtà in genere “nobili”, sensi di appartenenza che si nutrivano di contenuti in genere umani, non escludenti, tendenti a marcare diversità e non esclusione. Com’è agevole oggi notare, le forme di identità che più frequentemente nel nostro tempo si determinano sono viceversa quelle “costruite”, in genere per finalità ideologiche o addirittura trivialmente populistiche.
Il “prima gli italiani” giornalmente sbandierato da politici che qualche decennio fa non avrebbero potuto estendere il proprio raggio d’influenza oltre quello di un tavolo da bar, non costituisce altro che una furbesca strategia di distrazione di massa volta a creare una rappresentazione della realtà diversa e mistificata rispetto alla sua effettuale natura. Una realtà nella quale chi viene da fuori toglie il lavoro a quelli che stanno (asserragliati) dentro, ozia, abitualmente delinque (ennesima declinazione di un lombrosianesimo che periodicamente ritorna nell’immaginario italiano), è portatore di oscure e devastanti malattie (con buona pace delle stragi etniche perpetrate – anche a livello virale – dall’Occidente presso i cosiddetti popoli primitivi).
Mi pare allora che l’esigenza, sacrosanta, di poter disporre di forme plausibili di identità non possa essere perseguita e soddisfatta se non attraverso un nuovo approccio ai meccanismi della trasmissione ereditaria, sottratti alla logica chiusa della cultura autoreferenziale, e debba pertanto costruirsi attorno alla ricerca di nuove percezioni, più ampie e allargate, del concetto di eredità. Se giungessimo infatti a riconoscere che la coesistenza umana non può fondarsi su rapporti di diffidenza e di ostilità repressa ma sull’approfondimento della conoscenza reciproca, unica via per raggiungere consapevolezza sulle radici comuni di una comune umanità, non ci rimarrebbe che promuovere sempre maggiori e non banali occasioni di incontro, scambio e trasmissione “ereditaria” tra le diverse tribù di questo nostro pianeta.
Il campo più efficace su cui misurare la possibilità di sperimentare nuove forme di “eredità” è probabilmente quello offerto dal viaggio. Ogni viaggio, sia esso frutto di un’esigenza migratoria (oggi dolorosamente presente nelle nostre giornate storiche) ovvero riconducibile a finalità conoscitive (dal turista, al geografo, all’antropologo, al flaneur), comporta in egual misura tanto una – sia pur parziale e provvisoria – “prudente sospensione” della propria cultura, messa per così dire in crisi dall’incontro con sistemi culturali diversi (e spesso oltremodo diversi) dal proprio, quanto il bisogno di ri-negoziare secondo forme nuove e nuovi equilibri, la propria identità, che nel nuovo contesto territoriale ed esistenziale richiede perentoriamente di essere declinata in maniera differente che nelle forme già note.
All’interno di tale – spesso drammatica – dialettica si giocano i meccanismi sottesi alla trasmissibilità dei saperi, dei tratti culturali, delle esperienze, della memoria dei luoghi; in una parola, la stessa “eredità culturale” si scompone e ricompone innumerevoli volte e finisce con lo smarrire il carattere monolitico e un po’ ottuso che la nostra tradizione culturale gli ha di solito assegnato.
Viaggiatori sono stati i migranti che hanno avuto la fortuna di approdare a Riace, luogo in cui un’Amministrazione consapevole e illuminata ha sperimentato e attuato con successo un modello di integrazione tra popoli e culture divenuto esemplare anche fuori dei confini nazionali. Nella comunità creatasi a Riace in questi anni gli orizzonti comunitari avevano determinato memorie condivise e nuove “tradizioni”. Oggi quella Amministrazione, nella persona del suo coraggioso sindaco, viene punita per aver voluto attivare una strategia di rianimazione del territorio attraverso il mescolamento di persone, saperi, esperienze esistenziali, orizzonti culturali diversi ma – laddove ravvicinati da un incontro, da un reciproco sguardo d’intesa – destinati a trovare nuovi equilibri, nuovi orizzonti, nuove eredità. Sogni rinnovati.
Chi crede che il Pianeta sia patria comune a tutti gli uomini, non può che indignarsi e reagire civilmente a tale repressione. Il mondo falsamente opulento difeso da chi condanna Lucano crede che la propria sopravvivenza sia legata alla continua disperata costruzione di argini contro gli ultimi. Già, gli ultimi. Ormai siamo abituati a considerarli quasi una categoria metastorica, come nell’antichità, quando Aristotele sosteneva che «un essere che per natura non appartiene a se stesso ma a un altro, pur essendo uomo, questo è per natura schiavo» e la povertà, la condizione di paria, si riteneva fossero state stabilite da un destino cieco. Adesso che questo mondo si trasforma sempre più rapidamente in una sorta di Torre di Babele, in cui riesce sempre più difficile sillabare un discorso elementarmente umano, a me pare che “ultimi” siamo ormai divenuti tutti, ammaliati da una coazione a permanere ognuno nel rispettivo stato di avidità, egoismo, ferocia, paura, pigrizia, disperazione, solitudine.
Francesco Remotti ci ricorda invece che le forme di umanità e le varie fogge che esse assumono non sono mai date una volta per tutte, che le aperture e i confini tra l’una e l’altra sono sempre labili, porosi, passibili di sconfinamenti. Sconfinare comporta quasi sempre smarrire a tratti i propri punti di orientamento, proprio come avvenne al vecchio pastore calabrese narratoci da de Martino, che portato in auto fuori dal suo paese del quale non riusciva più a scorgere il campanile aveva iniziato a manifestare un’angoscia sempre maggiore, avendo perduto il punto di riferimento «del suo estremamente circoscritto spazio domestico».
Stiamo parlando della stessa Regione in cui oggi si consuma il dramma della comunità di Riace, strappata da una sentenza ingiusta a un assetto territoriale e sociale che comportava l’inizio di nuovi stili di vita, nuove utopie, il riconoscimento di una nuova patria. Nuovi campanili. L’angoscia del vecchio pastore di Marcellinara, il sentimento di “perdita della presenza” era, in qualche modo, la medesima angoscia di questi migranti accolti da Mimmo Lucano, che avevano perso i riferimenti ai luoghi domestici in cui sentivano di avere senso, e che nella Riace di Lucano ritrovavano un senso nuovo, diverso certamente ma utile a riconferire orientamento ai propri percorsi di vita, laddove in contesti divenuti irriconoscibili era la propria stessa identità a entrare in crisi.
 Gli episodi calabresi mostrano plasticamente come la perdita degli ancoraggi culturali (in senso antropologico) sottragga senso al mondo. Come il pastore non ritrovava più il suo campanile, così oggi i migranti avvertono di avere smarrito il proprio spazio esistenziale, costruito sulla consuetudine quotidiana di scambi, di incontri in una situazione di comunanza e familiarità. L’esperienza di spaesamento ai nostri giorni è infatti in larga misura rappresentata dal viaggio forzato e dal conseguente perdersi per le strade del mondo. La privazione di un “centro del mondo” crea spaesamento e squilibrio. Heimweh è il termine tedesco che indica la nostalgia di chi si trova lontano da casa, ma in senso lato anche la condizione di chi soffre di spaesamento esistenziale, sentendosi privato di una casa comune cui rapportarsi. Michele Risso, etnopsichiatra, utilizza la metafora della mezza parete a proposito della condizione di anomia culturale e psichica cui vanno incontro i migranti. L’allusione è all’alpinista che si trova in parete e, rimasto bloccato, non sa più in che direzione andare.
Gli episodi calabresi mostrano plasticamente come la perdita degli ancoraggi culturali (in senso antropologico) sottragga senso al mondo. Come il pastore non ritrovava più il suo campanile, così oggi i migranti avvertono di avere smarrito il proprio spazio esistenziale, costruito sulla consuetudine quotidiana di scambi, di incontri in una situazione di comunanza e familiarità. L’esperienza di spaesamento ai nostri giorni è infatti in larga misura rappresentata dal viaggio forzato e dal conseguente perdersi per le strade del mondo. La privazione di un “centro del mondo” crea spaesamento e squilibrio. Heimweh è il termine tedesco che indica la nostalgia di chi si trova lontano da casa, ma in senso lato anche la condizione di chi soffre di spaesamento esistenziale, sentendosi privato di una casa comune cui rapportarsi. Michele Risso, etnopsichiatra, utilizza la metafora della mezza parete a proposito della condizione di anomia culturale e psichica cui vanno incontro i migranti. L’allusione è all’alpinista che si trova in parete e, rimasto bloccato, non sa più in che direzione andare.
A me personalmente è capitato tanti anni fa di osservare il comportamento di alcuni anziani abitanti della Gibellina ricostruita, che ripercorrevano attraverso i bianchi cunicoli del Cretto di Burri lo spazio perduto del vecchio paese, alla ricerca del luogo in cui prima del terremoto sorgeva la loro abitazione. Attraverso tale “pellegrinaggio” essi, in qualche modo, riguadagnavano uno spazio simbolico che li riscattava dell’assenza di quello realistico ormai non più disponibile. Esaminando gli attuali, epocali, trasferimenti di enormi masse di persone dal loro originario contesto territoriale e culturale nell’Occidente massificato, il fatto che tutti i rifugiati abbiano perduto la casa, la madrepatria, i Lari domestici che di quel consistere erano garanti, fa sì che essi esprimano un profondo senso di struggimento nostalgico e che desiderino riparare tale condizione di perdita, senza peraltro avere ormai dei sistemi di “difesa immunitaria”.
Nostalgia è il termine usato per descrivere l’intero fascio di tutti quei sentimenti, reazioni, speranze, timori, sogni espressi da chi non possiede più una patria culturale. In quest’ottica la nostalgia non può essere separata da ciò che la “casa” rappresenta soprattutto a livello simbolico. In particolar modo per i rifugiati, il disorientamento deriva dall’impossibilità di stabilire con esattezza la causa reale di una perdita che non si limita a quella tangibile di una casa tout court, intesa nella sua materialità, ma si allarga alla perdita di tutte le relazioni che il soggetto intrattiene con il proprio oikos, con il prossimo e con l’ecosistema in cui egli è inserito.
Migrazione e malattia mentale si pongono dunque come nodi critici irrisolti, proprio in quanto la loro genesi ha luogo all’interno di un sistema sociale come il nostro, meccanicistico e cinicamente votato al profitto come unico fine. Esilio e memoria sono i temi attorno ai quali si sviluppa la tematica dello spaesamento. Per chi è costretto a lasciare la propria terra, il tempo e lo spazio cessano di essere coordinate domestiche, tramutandosi in realtà ignote e perturbanti. Sparigliato dal viaggio, il corpo del migrante si trasforma quindi in una cartografia confusa che ha smarrito la propria funzione di mappa, veicolando viceversa un grumo esistenziale destinato a tradursi in enigma identitario, in cibo mal digerito assai arduo da metabolizzare. Sotto i colpi delle vicende umane anche i punti cardinali e i riferimenti geografici si sgretolano e si fanno elusivi. Il viaggio, trasferimento di corpi da un luogo all’altro, scava solchi profondi, dischiude l’esperienza di universi irrelati e disgiunti. Ripropone drammaticamente l’eterna domanda sul senso del proprio essere nel mondo.
Ciò che è desolante, in questo desolante quadro che investe nodi cruciali del nostro tempo ma coinvolge e permea in modo più o meno distorto le menti deboli di migliaia di italiani, è constatare come negli ultimi decenni la paura dell’altro abbia finito con l’occultare i problemi reali del Paese, dell’Europa, del Pianeta. Nell’attuale sistema neoliberista (come pare ormai evidente, un capitalismo finanziario egemone a livello planetario) il venti per cento dell’umanità consuma l’ottantacinque per cento delle risorse disponibili nel pianeta. All’ottanta per cento restante, la parte più grande tanto in termini numerici quanto sotto il profilo della terra occupata, rimane quel quindici per cento di briciole, destinato a diminuire sempre più.
Ci sono dunque segmenti di umanità che ritengono, et pour cause dal loro egoistico punto di vista, che il proprio sia il migliore dei mondi possibili. E viceversa dannati della terra per i quali soltanto vige, crudelmente, quella che Martin Heidegger riteneva fosse la cifra costitutiva della condizione umana, un “essere scagliati nel mondo” (Geworfenheit) privo di qualunque speranza di riscatto. Cosa farebbe ognuno di noi al posto di questi dannati della terra? Rimarremmo buoni a subire pazientemente guerre, malattie, carestie, persecuzioni, fame (si badi bene, tutte realtà prodotte, indotte, favorite, finanziate, “esportate” da quel famelico venti per cento)? O non cercheremmo, piuttosto, di trovare nuove terre e nuovi contesti umani entro cui iniziare una nuova e meno tribolata esistenza?
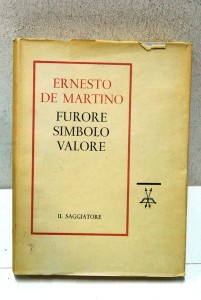 Il problema è tutto qui. E qui risiede, anche, l’enorme ipocrisia dei muri, degli steccati, degli “aiutiamoli a casa loro”. Casa loro, e casa nostra, è il mondo, e se noi pensiamo che il mondo da noi abitato – apparentemente civile e sereno – ci appartenga esclusivamente perché ci siamo nati e cresciuti, ebbene è giunto il momento di prendere coscienza che questo universo così ordinato, questa Aufklärung, si è costruito sul sangue degli abitanti di tanti Cuori di Tenebra sparsi per il pianeta.
Il problema è tutto qui. E qui risiede, anche, l’enorme ipocrisia dei muri, degli steccati, degli “aiutiamoli a casa loro”. Casa loro, e casa nostra, è il mondo, e se noi pensiamo che il mondo da noi abitato – apparentemente civile e sereno – ci appartenga esclusivamente perché ci siamo nati e cresciuti, ebbene è giunto il momento di prendere coscienza che questo universo così ordinato, questa Aufklärung, si è costruito sul sangue degli abitanti di tanti Cuori di Tenebra sparsi per il pianeta.
Anche ai cittadini nomadi di Riace, costretti oggi a subire una nuova diaspora, possono quindi bene adattarsi le parole che, da intellettuale disorganico del Mezzogiorno d’Italia, Ernesto de Martino dedicava settant’anni or sono alle povere ed emarginate plebi rustiche lucane:
«Dinanzi a questi esseri mantenuti a livello delle bestie malgrado la loro aspirazione a diventare uomini, io – personalmente io intellettuale piccolo borghese del Mezzogiorno – mi sento in colpa. Altri, forse, ravviserà nel fondo di questa situazione una testimonianza del peccato originale: si libererà così del peso di un’analisi incomoda, trasfigurando in cielo la responsabilità interamente umana di questa condizione umana. Ma io trovo qui solo la responsabilità della mia colpa, non della colpa. Io non sono libero perché costoro non sono liberi, io non sono emancipato perché costoro sono in catene. Se la democrazia borghese ha permesso a me di non essere come loro, ma di nutrirmi e di vestirmi relativamente a mio agio, e di fruire delle libertà costituzionali, questo ha una importanza trascurabile: perché non si tratta di me, del sordido me gonfio di orgoglio, ma del me concretamente vivente, che insieme a tutti nella storia sta e insieme a tutti nella storia cade. Io provo anzi vergogna del permesso concessomi di non essere come loro, e quasi mi sembra di avere rubato solo per me ciò che appartiene anche a loro».
Colpevole dunque Mimmo Lucano? Attendiamo fiduciosi gli ulteriori gradi di giudizio. In ogni caso sarà la storia, il mondo di domani alla cui costruzione ognuno di noi è chiamato a lavorare, a dire da che parte risiedeva il diritto, da che parte la colpa. Spero che questa triste segregazione planetaria da virus possa indurci a valutare con maggiore apertura e senza pregiudizi qualunque altra società fatta da uomini e donne che, come noi il nostro, ricercano – ognuno a suo modo – i propri angoli di mondo.
Dialoghi Mediterranei, n. 54, marzo 2022
Riferimenti bibliografici
Aristotele, Politica, voll. I-II, Milano, Fondazione Lorenzo Valla-Mondadori, 2014-2015.
Roberto Beneduce, Frontiere dell’identità e della memoria, Milano, FrancoAngeli, 1998
Giordano Bruno, De l’infinito universo e mondi, Stampato in Venetia, Anno 1584.
Erri De Luca, La parola contraria, Milano, Feltrinelli, 2015.
Ernesto de Martino, Promesse e minacce dell’etnologia, in Id., Furore simbolo valore, Milano, Il Saggiatore, 1962: 65-103.
Id., Note lucane, in “Società”, 6 (1950), n. 4: 650-667, poi in Id., Furore simbolo valore, Milano, Il Saggiatore, 1962: 107-121.
Id. La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, a cura di C. Gallini, Torino, Einaudi, 1977 (nuova ed. a cura di G. Charuty, D. Fabre, M. Massenzio, Torino, Einaudi, 2019).
Danilo Dolci, Esperienze e riflessioni, Bari, Laterza, 1974.
John Dunne, Meditazioni XVII, in Devozioni per occasioni d’emergenza, Roma,
Editori Riuniti, 1994: 112-113.
Frantz Fanon, I dannati della terra, Torino, Einaudi, 1961.
Delia Frigessi Castelnuovo, Michele Risso, A mezza parete. Emigrazione nostalgia malattia mentale, Torino, Einaudi, 1982.
Mahatma Gandhi, La mia vita per la libertà (a cura di B.V. Franco), Roma, Newton Compton, 1991.
Heidegger, Essere e tempo (a cura di P. Chiodi), Torino, Utet, 1986.
Nelson Mandela, Lungo cammino verso la libertà. Autobiografia, Milano, Feltrinelli, 1995.
Martin Karl Marx, Friedrich Engels, L’ideologia tedesca (tr. F. Codino), Roma, Editori Riuniti, 1972.
Don Lorenzo Milani, La scuola della disobbedienza, Milano, Chiarelettere, 2015.
Platone, Apologia di Socrate (tr. G. Reale), Milano, Rusconi, 1993.
Francesco Remotti, Prima lezione di antropologia, Bari, Laterza, 2007.
Sofocle, Antigone (tr. E. Romagnoli), Bologna, Zanichelli, 1924.
Vito Teti, Nostalgia. Antropologia di un sentimento del presente, Torino, Marietti, 2020.
Vangeli di Marco (2, 23-28) e di Luca (14, 1-6).
________________________________________________________
Sergio Todesco, laureato in Filosofia, si è poi dedicato agli studi antropologici. Ha diretto la Sezione Antropologica della Soprintendenza di Messina, il Museo Regionale “Giuseppe Cocchiara”, il Parco Archeologico dei Nebrodi Occidentali, la Biblioteca Regionale di Messina. Ha svolto attività di docenza universitaria nelle discipline demo-etno-antropologiche e museografiche. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni, tra le quali Teatro mobile. Le feste di Mezz’agosto a Messina, 1991; Atlante dei Beni Etno-antropologici eoliani, 1995; Iconae Messanenses – Edicole votive nella città di Messina, 1997; Angelino Patti fotografo in Tusa, 1999; In forma di festa. Le ragioni del sacro in provincia di Messina, 2003; Miracoli. Il patrimonio votivo popolare della provincia di Messina, 2007; Vet-ri-flessi. Un pincisanti del XXI secolo, 2011; Matrimoniu. Nozze tradizionali di Sicilia, 2014; Castel di Tusa nelle immagini e nelle trame orali di un secolo, 2016; Angoli di mondo, 2020; L’immaginario rappresentato. Orizzonti rituali, mitologie, narrazioni (2021).
______________________________________________________________












