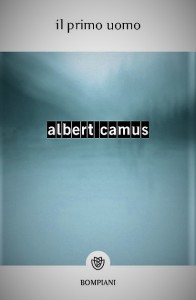Ci sono visioni a cui dobbiamo tutto ciò che siamo. Nel nostro mondo le tecnologie della parola sono talmente inafferrabili da ridurre talvolta le parole stesse e gli immaginari che creano a polvere, resti leggeri del lavorìo del tempo che passa. Ci sono vite, soggetti e personaggi da cui ci facciamo accompagnare, altri che erigiamo a sacchi da box contro cui scagliarci all’infinito e senza subire contraccolpi, altri ancora che, una volta iniziato il dialogo quello vero, quello pericoloso, quello che ci riduce tutti a entità uniche e peculiari, tutti inequivocabilmente irripetibili nella storia dell’essere, ci respingono e non si sa per qualche ragione. E poi ci sono gli idoli, gli eroi, i punti di riferimento, le figure ispiratrici che non fanno parte carnalmente del nostro mondo reale di ogni giorno, che esistono dietro uno schermo, in un file compresso o fra le righe di un libro, la scena di un film.
Immagini e parole, immagini di parole, parole che immaginano, immagini che ci parlano e nessuna scienza o pseudo scienza che riesca a sviluppare un modello funzionante che ti sappia dire “ok, frequenta questo o quello e sentirai, saprai, capirai quelle cose lì”. Il punto è che dietro lo schermo o dietro la l’ultima pagina di un libro o dietro qualsiasi altro supporto che suoni, parli, mostri, illustri e rappresenti, non c’è niente di concreto – torniamo sempre da dove eravamo partiti – ma c’è un surplus (ovviamente, se no non staremmo qui dove siamo adesso). È il peso imponderabile dei sogni. È l’afflato senza estensione dell’immaginazione. È la lucida consapevolezza di esistere, si dice. Dovremmo lavorare su questo e non per dire che noi umani siamo più di altre entità viventi ma per dire per chi non può dire. Non è una questione di capacità, altrimenti si ridurrebbe tutto nuovamente a un problema tecnologico (io dico perché ho le facoltà cognitive e le architetture anatomiche per farlo). È una questione di necessità. È una questione di sopravvivenza.
Possiamo leggere tutte le pagine del Il primo uomo di Camus (edito da Bompiani, 2013, pubblicato postumo per la prima volta solamente nel 1994 da Gallimard, grazie al lavoro editoriale di Catherine Gallimard, figlia di Michel Gallimard, sopravvissuta assieme alla madre all’incidente d’auto che causò la morte del padre che era alla guida e di Albert Camus, nel 1960; ci sono state voci di una manomissione del veicolo da parte di agenti segreti sovietici), o meglio, le pagine che è arrivato a scrivere prima della morte, e commuoverci o stupirci o annoiarci nelle descrizioni dei giochi di infanzia per le slums di Algeri.
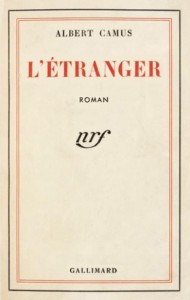 Possiamo esaltarci nel riconoscere una voce unica della modernità, quella di Camus, cogliendo l’evoluzione del suo sentire dallo Straniero fino ai suoi ultimi lavori. Ma caso vuole che nel dramma della sua morte, che ci ha privato forse troppo presto di questa voce, appunto, importantissima interprete dei tempi e dell’uomo, proprio l’ultimo romanzo a cui stava lavorando viene pubblicato per forza di cose – per completezza, per darci un’idea di cosa questo romanzo voleva essere e poteva essere – insieme a qualche foglio di appunti sparsi fra le carte del manoscritto e di appendici dove sono raccolte altre annotazioni.
Possiamo esaltarci nel riconoscere una voce unica della modernità, quella di Camus, cogliendo l’evoluzione del suo sentire dallo Straniero fino ai suoi ultimi lavori. Ma caso vuole che nel dramma della sua morte, che ci ha privato forse troppo presto di questa voce, appunto, importantissima interprete dei tempi e dell’uomo, proprio l’ultimo romanzo a cui stava lavorando viene pubblicato per forza di cose – per completezza, per darci un’idea di cosa questo romanzo voleva essere e poteva essere – insieme a qualche foglio di appunti sparsi fra le carte del manoscritto e di appendici dove sono raccolte altre annotazioni.
Il dialogo con i nostri eroi psicopoietici quante volte può oltrepassare le opere attraverso cui essi si manifestano? Sì, possiamo costruire interiezioni oniriche, scambi epistolari immaginari, possiamo immaginare di essere seduti a un tavolo o di camminare su una spiaggia ventosa, il sole accecante che ci costringe ad abbassare la testa, la spuma salmastra delle onde sui vestiti e il nostro eroe che ci cammina accanto e ci manifesta la sua visione sulla natura del mondo e delle persone e noi siamo pieni allora delle sue parole, delle sue immagini, delle sue rappresentazioni, del suo dramma.
Possiamo ricavare una nicchia interiore in cui rifugiarci e circondarci di questi personaggi della storia, fari della nostra ispirazione oppure possiamo costruire fantasmi con le loro fattezze che ci accompagnano, che ci indicano la strada. Così, in questo modo che si sta affacciando con tutta la sua fragilità di equilibri ecosistemi e biologici che non siamo in grado di comprendere e neanche immaginare nella sua cosmica interezza, capita che la visione di un uomo lontano nel tempo, neanche troppo, ci tocchi così da vicino da sentirci improvvisamente nudi e avvolti da quelle onde che prima percepivamo solo accanto e dentro quel vento e riscaldato da quella sabbia e respirare nel flusso di quel camminare che abbiamo scelto di fare giusto per stare un po’ da soli con i nostri idoli e i nostri carnefici.
E allora non deve stupire che fra le parole de Il primo uomo c’è un segreto così vicino a noi e al nostro mondo. Che pur essendo Camus un uomo di un altro mondo, così vicino nel tempo ma così lontano nella visione delle cose e del futuro, anche lui avrà camminato con i suoi guardiani immaginari e anche lui avrà raccolto il segreto che allora ci si mostra per quello che è: il più antico gesto dell’umanità. Il ‘primo uomo’ appunto. Lui aveva capito. Lo stesso segreto che è stato cuore di una militanza senza sosta spesso contro tutti. Proprio nell’ultimo romanzo incompiuto Camus si immerge completamente nelle rive di quella dimensione fuori dal tempo e di dischiuderci così quel segreto. Con le sue parole, con la sua poetica, con la sua visione, dire per chi non può dire. Essere voce per chi non ha voce.
Dopo aver letto 144 pagine manoscritte (290 nell’edizione Bompiani) scritte di getto, dopo essersi immersi in questa storia semi autobiografica in cui il protagonista bambino vive nella miseria con una madre quasi completamente sorda, mezza muta, completamente analfabeta e ignorante del mondo eppure così bella e di una forza vitale e di un’essenza, la tragedia umana senza tempo, proprio perché del tempo della storia e di se stessa lei non ne ha concezione; dopo essere scesi grazie alla narrazione così pura in quel tritatutto sociale che era l’Algeria agli albori della rivoluzione e aver intuito che il racconto avrebbe seguito il protagonista fino all’età adulta (punto di vista dal quale la storia viene raccontata); dopo aver affrontato la fine brusca del testo causa morte dell’autore a circa metà (apprendiamo dalle note) del romanzo pensato; dopo aver sofferto e gioito e provato pietà, dopo aver sentito sulla pelle quella sabbia di Algeri ad agosto, quel sole cocente fra le lamiere e i cortili e le fabbriche e le case minuscole, quell’aria lercia e salmastra di sogno e rassegnazione che abita l’infanzia di ogni individuo di tutte le periferie del mondo quando è ancora troppo piccolo per rassegnarsi e abbastanza grande per immaginarsi altrove; dopo aver fatto i dovuti ponti fra il nostro qui muto e cieco di fronte ai disastri a venire; in una delle note raccolte nell’appendice leggiamo:
Voglio scrivere qui la storia di una coppia legata da uno stesso sangue, con tutte le differenze. Lei simile a tutto ciò che c’è di meglio sulla terra, lui tranquillamente mostruoso. Lui scaraventato in tutte le follie della nostra storia; lei che attraversa questa stessa storia come se fosse di ogni tempo. Lei quasi sempre silenziosa e con un patrimonio di poche parole per esprimersi; lui che parla senza sosta e in migliaia di parole non riesce a trovare ciò che lei poteva dire con uno solo dei suoi silenzi … La madre e il figlio
Sarebbe stata questa la missione dell’opera così fortemente autobiografica. È il segreto che anima l’umanità e che dà corpo alla sua visione. Dire l’indicibile. Il tempo dell’uomo, non soltanto il tempo della modernità. Perché per quanto allora il nostro dialogo immaginario con Camus possa essere articolato nella forma o profondo perché della sua produzione conosciamo tanto, la sua visione sul destino delle cose del mondo si compie per necessità nel momento in cui la sua stessa vita arriva al compimento (casuale, consequenziale, cosa cambia?).
Il primo uomo non è solo il primo uomo di quel mondo lì, il mondo di Camus uomo e di Camus autore di un mondo evocato. Poiché quel mondo lì è anche il nostro, in qualche modo, anche se il nostro è completamente distante per angosce, paure, timori e speranze. Ma il mondo di Camus è il nostro poiché entrambi vivono dello stesso segreto. Dare la voce a chi non ce l’ha per far esistere ciò che non può altrimenti sopravvivere. A cosa può valere il tempo dell’uomo se non a imprimere nel lungo tempo del mondo l’esistenza delle cose del mondo, dando “corpo” a questa esistenza attraverso il proprio (umano) dire (raccontare)?
Dare la voce allora non c’entra nulla con lo stile, con la scrittura del romanzo o del libro, non c’entra nulla con ciò che riguarda la tecnologia della parola. Dare la voce alla madre senza tempo, senza memoria e senza storia, dare la voce al figlio stracolmo di storia, ricordi e parole e all’intreccio di queste storie e raccontare così il segreto del tempo e del mondo e dell’uomo, il primo uomo che è insieme l’ultimo e uno dei tanti. Dare la voce a un legame che sarebbe altrimenti indicibile nella sua potenza creatrice, per farlo esistere e insieme far sopravvivere il tempo-senza-tempo del legame. Qualsiasi madre e qualsiasi figlio sono questo: immersi nella creazione, un legame che è esso stesso il tempo e che si tramandano nello spazio del mondo; il segreto indicibile della vita che produce il tempo, la relazione, i legami, le connessioni necessarie e vitali che generano l’esistenza nel suo dispiegarsi nella storia del mondo prima che dell’uomo (è sempre difficile immaginare la storia del mondo senza di noi, senza l’uomo, ma è questo ciò che il nostro mondo oggi ci chiede di fare per riuscire a immaginare il futuro, comprendere il peso dell’umanità nell’ordine del mondo).
Qualsiasi madre e qualsiasi figlio, qualsiasi silenzio, qualsiasi incommensurabile gesto nel tempo che esiste. Così come il legame della terra con le piante, delle piante con gli alberi e gli uccelli e gli insetti, delle mandrie addomesticate, delle malattie con i corpi feriti, lo stesso legame della terra con gli uomini, della guerra con gli uomini e con le vedove e gli orfani, i protagonisti concettuali del romanzo, esseri privati del tempo poiché privati di una storia e dalla storia.
Il mondo del Primo uomo è un mondo di lotta e ostinazione e di afone vite che si susseguono ai margini. Con il primo uomo, nella sua incompiutezza, nella sua nudità di visione che rimane, riscopriamo l’antico segreto dell’umanità e dei suoi eroi ancora una volta: dire l’indicibile. Perché a scomparire nel nostro mondo sono le storie di chi vive ai margini di ciò che viene detto – gli ecosistemi che scompaiono, gli animali che si estinguono, le culture annientate. Nel mondo, il nostro, dove il passato e il futuro collidono sempre più verso un presente macellaio che annichilisce le voci di chi non ce l’ha, riscoprirsi primi cioè primariamente portatori di storie è essenziale per la sopravvivenza, riscoprirsi dotati di voce per sé e per chi non ce l’ha per dare corpo alle storie che fanno il mondo e che facendo il mondo fanno noi. Storie che ci animano dagli albori dei tempi, storie che vengono a noi anche dal futuro, storie di chi non può parlare, storie ai margini della grande storia. Tutte queste saranno le storie di cui avremo bisogno.
Dialoghi Mediterranei, n. 42, marzo 2020
______________________________________________________________
Giuseppe Sorce, laureato in lettere moderne all’Università di Palermo, ha discusso una tesi in antropologia culturale (dir. M. Meschiari) dal titolo A new kind of “we”, un tentativo di analisi antropologica del rapporto uomo-tecnologia e le sue implicazioni nella percezione, nella comunicazione, nella narrazione del sé e nella costruzione dell’identità. Ha conseguito la laurea magistrale in Italianistica e scienze linguistiche presso l’Università di Bologna con una tesi su “Pensare il luogo e immaginare lo spazio. Terra, cibernetica e geografia”, relatore prof. Franco Farinelli.
______________________________________________________________