Nel grappolo di parole sopravvissute al presunto collasso delle ideologie e delle grandi narrazioni c’è senz’altro il vocabolo “innovazione” che nel tempo ha cumulato plurimi significati e prodotto innumeri illusioni. Totem e tabù, luogo di miti salvifici, di romantiche utopie ma anche di orizzonti più o meno luminosi, l’innovazione è crocevia concettuale e progettuale di altre parole e di altre idee. Muove geneticamente dal processo di invenzione tecnologica e s’intreccia con le complesse dinamiche economiche e sociali. Ha a che fare con «l’atto creativo attraverso cui un’idea assume la forma di un oggetto reale», come afferma il direttore del Musée des Conflueces di Lione, Bruno Jacomy, citato da Marc Augè (2012: 80). Dal paradigma dell’invenzione a quello della creatività il nesso sposta l’accento in tutta evidenza dal piano economico a quello culturale. E oggi come non mai, nel tempo della cosiddetta “economia della conoscenza” e nel lessico del dibattito culturale più avvertito, l’innovazione sembra essere tema centrale e eminentemente attuale.
Da qui l’incrociarsi di più chiavi di lettura e molteplici prospettive che associano all’innovazione parole e concetti riconducibili a discipline e saperi diversi. Un grumo di teorie e pratiche trasversali che sconfinano e migrano da un campo di applicazione ad un altro, entro una variegata fenomenologia che non articola più l’innovazione in radicale opposizione alla tradizione ma, uscendo da questa sterile dicotomia, recupera gli elementi di continuità e di interdipendenza, le relazioni e le influenze reciproche, iscritte – direbbe Paolo Toschi (1945: 25) – in quel «libro mastro sempre aperto di dare e di avere». Negli ultimi anni – quelli attraversati dall’irruzione del digitale e dagli imprevedibili sviluppi dell’intelligenza artificiale – nuove parole hanno fatto irruzione nella letteratura delle scienze sociali, in gran parte di origine anglosassone, come agency, capability, resilience, generativity, etc. Dal vocabolario dell’economia sono transitate nel dibattito politico e culturale, nella più ampia riflessione sul futuro sociale, sui modelli di organizzazione degli spazi urbani, sui modi non solo di produrre ma anche di pensare, di abitare, di agire.
Chiarito che l’innovazione non è eruzione improvvisa ed epifanica di singole scintille o di estemporanee invenzioni ma è l’esito di costruzioni e interazioni sistemiche di tipo collettivo, di ibridismi creativi tra esperienze individuali e culture condivise, si desume che il suo luogo di germinazione e di progettazione non è separato o isolato all’interno di laboratori di ricerca e istituzioni deputate ma è invece incorporato nella vita quotidiana, nel tessuto sociale, nel contesto dei legami ambientali e territoriali del lavoro e del tempo libero, della produzione e del consumo. Nessuna tradizione sopravvive eguale nel tempo senza la spinta e l’adeguamento al mutamento né alcuna innovazione può fare a meno dell’eredità del passato, delle stesse macerie di ciò che si è distrutto. Jean Pouillon prima e poi Gerard Lenclud (2001: 131) – come è noto – hanno dimostrato che ciò che chiamiamo tradizione è sempre una “retroproiezione”, per cui «non sono i padri a generare i figli, ma i figli che generano i propri padri. Non è il passato a produrre il presente, ma il presente che modella il suo passato. La tradizione è un processo di riconoscimento di paternità». Fino al punto – come hanno scritto Eric J. Hobsbawm e Terence Ranger – da essere una vera e propria invenzione, una inedita reinterpretazione del passato.
 Frutto del capitale sociale e del patrimonio culturale, l’innovazione sta dunque alla tradizione in un rapporto non di passiva filiazione ma di attiva rigenerazione, in continuità con il passato e in discontinuità con le sue forme, i suoi contenuti, i suoi linguaggi. In dialogo col futuro che sta preparando, con le speranze che sta generando. «Il futuro è un fatto culturale», ci suggerisce Arjun Appadurai, e «la speranza è l’equivalente politico del lavoro dell’immaginazione, perché è soltanto tramite una qualche sorta di politica della speranza che una qualunque società o gruppo può raffigurarsi il tragitto verso un auspicabile cambiamento dello stato delle cose» (2014: 402). L’antropologo di origine indiana ci invita a coniugare aspirazione e immaginazione e a connettere entrambe le facoltà in un progetto etico-politico che renda possibile l’innovazione e sostenibile lo sviluppo delle società. «Le aspirazioni non sono mai semplicemente individuali» (ivi: 257). Cultura e futuro, da certa letteratura artificiosamente tenuti a lungo separati e addirittura in antitesi, vanno ricongiunti e ripensati in un medesimo orizzonte di senso, in un destino comune, disegnato dalle «capacità di immaginare delle possibilità anziché arrendersi alle probabilità di cambiamenti imposti dall’esterno» (ivi: 292).
Frutto del capitale sociale e del patrimonio culturale, l’innovazione sta dunque alla tradizione in un rapporto non di passiva filiazione ma di attiva rigenerazione, in continuità con il passato e in discontinuità con le sue forme, i suoi contenuti, i suoi linguaggi. In dialogo col futuro che sta preparando, con le speranze che sta generando. «Il futuro è un fatto culturale», ci suggerisce Arjun Appadurai, e «la speranza è l’equivalente politico del lavoro dell’immaginazione, perché è soltanto tramite una qualche sorta di politica della speranza che una qualunque società o gruppo può raffigurarsi il tragitto verso un auspicabile cambiamento dello stato delle cose» (2014: 402). L’antropologo di origine indiana ci invita a coniugare aspirazione e immaginazione e a connettere entrambe le facoltà in un progetto etico-politico che renda possibile l’innovazione e sostenibile lo sviluppo delle società. «Le aspirazioni non sono mai semplicemente individuali» (ivi: 257). Cultura e futuro, da certa letteratura artificiosamente tenuti a lungo separati e addirittura in antitesi, vanno ricongiunti e ripensati in un medesimo orizzonte di senso, in un destino comune, disegnato dalle «capacità di immaginare delle possibilità anziché arrendersi alle probabilità di cambiamenti imposti dall’esterno» (ivi: 292).
Sul potere performativo dell’immaginario sociale molto in questi anni si è scritto e si è ampiamente documentato. Resta illuminante la definizione data da Charles Taylor, citato da Crapanzano (2007: 17): «Non è una serie di idee, ma è piuttosto ciò che rende possibili le pratiche sociali, dando senso ad esse. Penso ai modi in cui la gente immagina la sua esistenza sociale, a come si percepisce come comunità, a come funzionano le cose tra loro e tra i loro simili, alle attese che vengono normalmente rispettate e alle nozioni e alle immagini profondamente normative che sottostanno a queste aspettative». Come l’irrealtà dell’immaginario possa paradossalmente incidere sulla realtà effettuale e profondamente innovarla dipende dalla spinta collettiva ad anticipare e prevedere quanto è funzionale all’azione, dalla «configurazione di ciò che è realizzabile prima che venga realizzato», per usare le parole di Starobinski (1970: 174); da quel futuro «che entra in noi, per trasformarsi in noi, molto prima che accada», come scrive nella Lettera ad un giovane poeta del 1904 Rainer Maria Rilke (1980: 55). In fondo, è lo spazio occupato dall’agency, dalla resilienza, dalla generatività e dalla cosiddetta metacapacità o ‘capacitazione’ (come si preferisce con una brutta traduzione), da quanto si muove in tensione e in condivisione nella dialettica della vita di relazione, negli interstizi del mondo produttivo, spesso ai margini dei centri economici e politici decisionali.
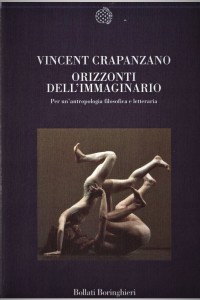 Il dibattito che si è aperto nel nostro Paese su queste questioni ruota essenzialmente intorno alle strategie e alle forme inedite di innovazione sociale in grado di rappresentare una via di uscita dalla crisi dei modelli economici e culturali della modernità. Vi sono impegnati geografi, urbanisti, economisti, demografi, sociologi ed ecologisti. Ma anche antropologi come Pietro Clemente che, muovendo da una frase di Walter Benjamin, invita a «porre il centro in periferia», a ribaltare l’ordine convenzionale del guardare e del pensare, dell’abitare e del vivere, scommettendo sulla rivitalizzazione dei piccoli paesi che costituiscono l’ossatura e l’orditura dell’ampia e policentrica trama urbana dell’Italia. Una nuova «coscienza di luogo», «una battaglia di generazione», un ambizioso progetto culturale che – ospitato all’interno delle pagine di questa rivista – mette in dialogo e in rete virtuale e fattuale le diverse esperienze delle microcomunità di questo formidabile mosaico di realtà periferiche a forte radicamento territoriale. Interrogarsi sull’impatto che le emigrazioni e lo spopolamento hanno prodotto nei luoghi fragili e marginali del nostro Paese non significa certo illudersi di restaurare quanto è anacronistico e ormai incompatibile con tecnologie e bisogni della contemporaneità. Significa piuttosto comprendere e stimolare le ragioni della resilienza, della “restanza”, del recupero dei saperi locali, delle relazioni e delle pratiche del passato che ri-ambientate nel presente possono contrastare l’emorragia demografica e l’omologazione culturale.
Il dibattito che si è aperto nel nostro Paese su queste questioni ruota essenzialmente intorno alle strategie e alle forme inedite di innovazione sociale in grado di rappresentare una via di uscita dalla crisi dei modelli economici e culturali della modernità. Vi sono impegnati geografi, urbanisti, economisti, demografi, sociologi ed ecologisti. Ma anche antropologi come Pietro Clemente che, muovendo da una frase di Walter Benjamin, invita a «porre il centro in periferia», a ribaltare l’ordine convenzionale del guardare e del pensare, dell’abitare e del vivere, scommettendo sulla rivitalizzazione dei piccoli paesi che costituiscono l’ossatura e l’orditura dell’ampia e policentrica trama urbana dell’Italia. Una nuova «coscienza di luogo», «una battaglia di generazione», un ambizioso progetto culturale che – ospitato all’interno delle pagine di questa rivista – mette in dialogo e in rete virtuale e fattuale le diverse esperienze delle microcomunità di questo formidabile mosaico di realtà periferiche a forte radicamento territoriale. Interrogarsi sull’impatto che le emigrazioni e lo spopolamento hanno prodotto nei luoghi fragili e marginali del nostro Paese non significa certo illudersi di restaurare quanto è anacronistico e ormai incompatibile con tecnologie e bisogni della contemporaneità. Significa piuttosto comprendere e stimolare le ragioni della resilienza, della “restanza”, del recupero dei saperi locali, delle relazioni e delle pratiche del passato che ri-ambientate nel presente possono contrastare l’emorragia demografica e l’omologazione culturale.
 Un appello ad invertire lo sguardo «dalle città alle zone interne, dal mare ai piccoli paesi di montagna o di campagna in crisi» è contenuto nel libro Riabitare l’Italia, a cura di Antonio De Rossi, un’antologia di riflessioni sulle nuove opportunità che si offrono a/da queste aree marginali del nostro Paese, non «una parte residuale ma anzi uno dei terreni decisivi per vincere le sfide del prossimi decenni» (2018: 7). Alle istanze del ripopolamento, della riattivazione di mestieri tradizionali e dell’invenzione di nuovi, agli esperimenti economici e sociali come le forme del welfare di comunità rimodulato sulla prossimità o i modelli originali di ospitalità diffusa, alle imprese intellettuali anche d’avanguardia di tipo artistico, museale o teatrale, si accompagnano dunque questioni connesse ai paradigmi fondamentali della democrazia e della convivenza, della qualità della vita e dell’etica pubblica, della riappropriazione del sentimento di coesione territoriale e del diritto di cittadinanza. Tutti temi che investono le categorie della politica e della cultura, ovvero l’agenda di una politica culturale capace di progettare la trasformazione in spazi di innovazione in quei luoghi che abbiamo pensato fossero irrimediabilmente destinati al declino e all’abbandono.
Un appello ad invertire lo sguardo «dalle città alle zone interne, dal mare ai piccoli paesi di montagna o di campagna in crisi» è contenuto nel libro Riabitare l’Italia, a cura di Antonio De Rossi, un’antologia di riflessioni sulle nuove opportunità che si offrono a/da queste aree marginali del nostro Paese, non «una parte residuale ma anzi uno dei terreni decisivi per vincere le sfide del prossimi decenni» (2018: 7). Alle istanze del ripopolamento, della riattivazione di mestieri tradizionali e dell’invenzione di nuovi, agli esperimenti economici e sociali come le forme del welfare di comunità rimodulato sulla prossimità o i modelli originali di ospitalità diffusa, alle imprese intellettuali anche d’avanguardia di tipo artistico, museale o teatrale, si accompagnano dunque questioni connesse ai paradigmi fondamentali della democrazia e della convivenza, della qualità della vita e dell’etica pubblica, della riappropriazione del sentimento di coesione territoriale e del diritto di cittadinanza. Tutti temi che investono le categorie della politica e della cultura, ovvero l’agenda di una politica culturale capace di progettare la trasformazione in spazi di innovazione in quei luoghi che abbiamo pensato fossero irrimediabilmente destinati al declino e all’abbandono.
L’attenzione crescente verso questa cosiddetta Italia minore, per lo studio della cultura materiale e immateriale dei piccoli paesi, per la conservazione e salvaguardia della memoria dei saperi locali e del palinsesto patrimoniale, ovvero dei valori simbolici che sono inscritti nella storia del territorio, si incrocia dunque con le strategie di sviluppo delle potenzialità e delle risorse che il nostro Paese custodisce in questi laboratori di rigenerazione economica e di innovazione sociale. A questo processo di ripopolamento e di riscatto demografico e produttivo contribuiscono gli immigrati stranieri e i profughi che si insediano in questi centri di aree interne e assicurano il rilancio di attività lavorative e di tecniche artigianali dismesse, il riuso di immobili vuoti e di spazi degradati, la cura e la manutenzione delle terre e dei terrazzamenti, le prestazioni di servizi nei comparti dell’assistenza familiare e del terziario.
Fuori delle direttrici urbane e metropolitane e dalle retoriche ideologiche intorno ai discorsi sulla crescita e sul progresso, c’è un mondo pulviscolare e marginale che conosce inedite esperienze di partecipazione civica, di alleanze intergenerazionali e di ibridismi culturali. Fra l’attivismo locale e la costruzione di una rete globale si articolano nuove e antiche forme di mutualità, dinamiche economiche che connettono – come in un originale ordine paratattico, una felice contaminazione, un sorprendente bricolage – profitto e solidarietà, interesse e gratuità, l’utilità sostenibile con il valore simbolico della condivisione dei beni comuni. Nello spazio strappato tra lo Stato e il mercato s’inventano e si inverano terze vie tra pubblico e privato che non coincidono con le pratiche del “terzo settore”. Scrive Mauro Magatti (2017: 126-127):
«Nell’economia di domani ciò che sta tra lo Stato e il mercato è destinato a divenire una componente decisiva per gli equilibri economici complessivi. Beninteso, complementare e non sostitutiva, rispetto a quelle canoniche: mercato individuale, spesa pubblica, export. (…) Sarà proprio questo l’ambito principale per la sperimentazione e l’innovazione, dove i nuovi consumatori e i nuovi beni potranno far nascere, in forme che oggi non riusciamo nemmeno a immaginare, le cose più interessanti del mondo che ci aspetta».
 L’innovazione su cui ragiona Magatti, che riprende le tesi di Erickson sulla generatività, ha nella dimensione umana e culturale dei legami sociali il suo punto di forza, l’architrave strutturale e infrastrutturale di un sistema di relazioni ispirate alla combinazione e compenetrazione «tra la creatività del singolo e l’integrazione della comunità, tra le necessità della crescita economica e le esigenze dello sviluppo sociale, tra innovazione tecnica e nuove esperienze istituenti» (ivi: 151). Se la logica della produzione deve fare i conti con la sostenibilità e quella del consumo con le istanze della socialità, occorre tornare a riflettere sul ruolo delle collettività nelle responsabilità verso il territorio e delle soggettività nei processi di cambiamento e di innovazione della società. È l’interrogativo che si pongono Filippo Barbera e Tania Parisi, autori del volume edito da Il Mulino, Innovatori sociali. La sindrome di Prometeo nell’Italia che cambia (2019).
L’innovazione su cui ragiona Magatti, che riprende le tesi di Erickson sulla generatività, ha nella dimensione umana e culturale dei legami sociali il suo punto di forza, l’architrave strutturale e infrastrutturale di un sistema di relazioni ispirate alla combinazione e compenetrazione «tra la creatività del singolo e l’integrazione della comunità, tra le necessità della crescita economica e le esigenze dello sviluppo sociale, tra innovazione tecnica e nuove esperienze istituenti» (ivi: 151). Se la logica della produzione deve fare i conti con la sostenibilità e quella del consumo con le istanze della socialità, occorre tornare a riflettere sul ruolo delle collettività nelle responsabilità verso il territorio e delle soggettività nei processi di cambiamento e di innovazione della società. È l’interrogativo che si pongono Filippo Barbera e Tania Parisi, autori del volume edito da Il Mulino, Innovatori sociali. La sindrome di Prometeo nell’Italia che cambia (2019).
Sgombrato il campo dagli equivoci del «liberalismo compassionevole amico del mercato» e dalle ingenue rappresentazioni di tipo funzionalista e meccanicista, il libro pone l’innovazione nell’ottica performativa dei movimenti di idee e di azioni collettive che maturano e si organizzano dal basso, sulla spinta di tensioni civiche, di aspirazioni all’emancipazione economica, di imprenditorialità e creatività culturali. L’agency che muove gli innovatori sociali travalica l’angusto perimetro costi/benefici, sconfina oltre le potenti virtualità tecnocratiche, oltre le legittime motivazioni assistenzialiste, e si qualifica per la costruzione di reticoli di cittadinanza inclusivi, di processi combinatori che mettono insieme pragmaticamente profit/non profit, imprese sociali e cooperative di comunità, la sharing economy e il convivialismo, la nuova ecologia politica e l’economia circolare. La connessione, la commistione e la sovrapposizione di più e diversi modi di produrre, distribuire e consumare i beni e i servizi nelle nostre società sono generate da una popolazione di agenti del cambiamento, veri e propri «brokers o organizzatori di comunità», come scrive Tania Parisi (2109: 184).
«Nuovi cooperatori, artigiani digitali, designer di servizi, imprenditori sociali, gestori di piattaforme di crowdfulding, rappresentanti delle comunità delle seconde generazioni (i nuovi cittadini) rappresentano gli ufficiali di collegamento tra comunità (territoriali e professionali) e policy makers».
La figura degli innovatori è assimilata a quella di Prometeo, e come l’eroe del mito greco sfida i rischi potenziali nell’uso della tecnica per aprire nuovi orizzonti di conoscenza e conseguire il bene comune. Sono soprattutto i giovani, che sono abitanti dell’universo digitale ed esperti nell’impiego dei mezzi di comunicazione, a trasformare la precarietà intellettuale in cui vivono in «dinamismo, possibilità di accrescere competenze e relazioni», in formidabili leve e occasioni per attraversare territori inesplorati, per promuovere quella cittadinanza attiva sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, dell’etica pubblica, della responsabilità civica. Sono i community hub, i centri di co-working, i laboratori del volontariato, le start-up, la rete dei social, sono gli incubatori multifunzionali delle innovazioni, i luoghi di produzione di nuovi mercati e nuove professioni, ma anche della trama rizomatica delle relazioni, della condivisione orizzontale di scambi, progetti, imprese, saperi, dei «modelli combinatori tra mercato, civismo e tecnologia» (ivi: 170).
 Il nesso, quel trait-d’union che unisce fattori diversi e mondi anche lontani, sia sul piano spaziale che temporale, quel bettween-ness, è dato antropologicamente denso di significati, dal momento che contribuisce a dissolvere ogni rappresentazione culturale duale e oppositiva e pertanto assolutizzante a favore di modelli euristici processuali, ibridi, rapsodici. Ad assemblare, connettere e a significare soggetti molteplici, fenomeni con storie differenti e pratiche sociali eterogenee «con formule organizzative adattive e flessibili», è l’idea collettiva di dare risposte e soluzioni al grave problema della frammentazione delle relazioni a partire dalla forza negoziale degli agenti del cambiamento, dalla capacità di “fare rete”, dal radicamento territoriale dei progetti e dei servizi. Nel passare in rassegna le diverse tipologie esperienziali di innovazione sociale, Barbera e Parisi ne spiegano le caratteristiche (in verità, con un eccessivo e fastidioso ricorso alle denominazioni di lingua anglosassone), ne descrivono i profili di rilevanza e di diffusione in Italia alla luce di indagini sul campo e di rapporti elaborati da centri di ricerca, ne illustrano gli ambiti d’investimento e i diversi settori di intervento. Con stime, grafici e tabelle è disegnato l’identikit dell’innovatore, il percorso professionale, le motivazioni, la cultura civica. Ne emerge il quadro che così lo riassume: «L’innovatore è soprattutto colui che si fa veicolo di un’azione pratica in cui si combinano istanze imprenditoriali e tensione creativa di utilità sociale a ridosso di vecchi e nuovi mercati, prodotti, tecnologie e modelli organizzativi che riposizionano il campo dell’imprenditorialità sociale. Collaborare/condividere/cooperare è la forma che qualifica il processo innovativo, da cui anche l’ostentata demarcazione tra saperi aperti e logiche proprietarie» (ivi: 140).
Il nesso, quel trait-d’union che unisce fattori diversi e mondi anche lontani, sia sul piano spaziale che temporale, quel bettween-ness, è dato antropologicamente denso di significati, dal momento che contribuisce a dissolvere ogni rappresentazione culturale duale e oppositiva e pertanto assolutizzante a favore di modelli euristici processuali, ibridi, rapsodici. Ad assemblare, connettere e a significare soggetti molteplici, fenomeni con storie differenti e pratiche sociali eterogenee «con formule organizzative adattive e flessibili», è l’idea collettiva di dare risposte e soluzioni al grave problema della frammentazione delle relazioni a partire dalla forza negoziale degli agenti del cambiamento, dalla capacità di “fare rete”, dal radicamento territoriale dei progetti e dei servizi. Nel passare in rassegna le diverse tipologie esperienziali di innovazione sociale, Barbera e Parisi ne spiegano le caratteristiche (in verità, con un eccessivo e fastidioso ricorso alle denominazioni di lingua anglosassone), ne descrivono i profili di rilevanza e di diffusione in Italia alla luce di indagini sul campo e di rapporti elaborati da centri di ricerca, ne illustrano gli ambiti d’investimento e i diversi settori di intervento. Con stime, grafici e tabelle è disegnato l’identikit dell’innovatore, il percorso professionale, le motivazioni, la cultura civica. Ne emerge il quadro che così lo riassume: «L’innovatore è soprattutto colui che si fa veicolo di un’azione pratica in cui si combinano istanze imprenditoriali e tensione creativa di utilità sociale a ridosso di vecchi e nuovi mercati, prodotti, tecnologie e modelli organizzativi che riposizionano il campo dell’imprenditorialità sociale. Collaborare/condividere/cooperare è la forma che qualifica il processo innovativo, da cui anche l’ostentata demarcazione tra saperi aperti e logiche proprietarie» (ivi: 140).
Tra tutte le parole chiave associate all’innovazione è senza dubbio la ‘condivisione’ quella che più ricorre, a segnare e sottolineare quel nesso relazionale che giustifica e identifica l’ibridazione tra Stato, mercato e società, tra bene pubblico, iniziativa privata, associazionismo e terzo settore. Un tessuto patchwork che è spesso l’esito di forme creative e sincretiche di produzione, scambio e consumo, al di fuori delle categorie patrimoniali di proprietà e di acquisto dei beni, e in coerenza ai princìpi dell’economia solidale e della politica di produzione e valorizzazione dei legami sociali e dello spirito di cittadinanza. All’immagine della rete, che se non è soltanto virtuale «non è una somma di parti ma un nodo vitale di relazioni» (Dotti 2018: 60), si può ricondurre il modello di condivisione nella fenomenologia dell’innovazione e nella nuove forme di welfare. E, d’altra parte, non si può non richiamare alla memoria il discusso istituto del dono che, per quanto decostruito alla luce di nuove riletture critiche, è ancora un paradigma “buono da pensare” per «esplorare l’esistenza di una possibile quarta logica da affiancare alla massimizzazione dell’utile, alle leggi e alle norme delle istituzioni, nonché agli obblighi morali che creano relazioni», per interpretare cioè «quei fenomeni contemporanei che non rispondono ai moventi del mercato e alle regole della redistribuzione statale», per comprendere «quella spinta a condividere che, valorizzando un sé relazionale diffuso, costruisce, conferma o consolida un gruppo e una comunità» (Aria 2015: 63).
 Come il dono anche l’atto d’innovazione sembra farsi spazio negli interstizi delle micropratiche sociali, nella cultura quotidiana dell’informale, tra le maglie aperte da quelle che De Certeau (2009: 16) ha metaforicamente definito “tattiche” ovvero forme di invenzione e di resistenza dal basso, di «rivincite del debole contro il più forte (i potenti, la malattia, la violenza delle cose o di un ordine eccetera), tiri mancini, abili mosse, astuzie da cacciatore, capacità di manovra, simulazione polimorfe, trovate ingegnose, poetiche quanto bellicose». Arti e tecniche della cultura popolare, che confutano la presunta passività dei consumatori e ne rivalutano, invece, l’agency, la soggettività di quanti sanno fare uso delle risorse di reciprocità e mutualità, ovvero di sussidiarità tra cooperazione, associazionismo e istituzioni pubbliche. Così è nelle esperienze dei nuovi agricoltori e dei nuovi montanari che nelle aree interne e nelle terre alte del nostro Paese stanno attuando importanti innovazioni nel campo dei servizi socio-sanitari, delle filiere agro-alimentari e soprattutto nella gestione del welfare. Si tratta di processi esogeni che dall’esterno immettono nuova linfa agli insediamenti e alla cultura dei luoghi, ma si tratta anche di recuperi e riappropriazioni di modelli endogeni di vita e di lavoro tradizionale, del riciclo e della rigenerazione di tecniche e materie dismesse, di convivenza di pratiche tradizionali e ingegneria ambientale ad alta tecnologia.
Come il dono anche l’atto d’innovazione sembra farsi spazio negli interstizi delle micropratiche sociali, nella cultura quotidiana dell’informale, tra le maglie aperte da quelle che De Certeau (2009: 16) ha metaforicamente definito “tattiche” ovvero forme di invenzione e di resistenza dal basso, di «rivincite del debole contro il più forte (i potenti, la malattia, la violenza delle cose o di un ordine eccetera), tiri mancini, abili mosse, astuzie da cacciatore, capacità di manovra, simulazione polimorfe, trovate ingegnose, poetiche quanto bellicose». Arti e tecniche della cultura popolare, che confutano la presunta passività dei consumatori e ne rivalutano, invece, l’agency, la soggettività di quanti sanno fare uso delle risorse di reciprocità e mutualità, ovvero di sussidiarità tra cooperazione, associazionismo e istituzioni pubbliche. Così è nelle esperienze dei nuovi agricoltori e dei nuovi montanari che nelle aree interne e nelle terre alte del nostro Paese stanno attuando importanti innovazioni nel campo dei servizi socio-sanitari, delle filiere agro-alimentari e soprattutto nella gestione del welfare. Si tratta di processi esogeni che dall’esterno immettono nuova linfa agli insediamenti e alla cultura dei luoghi, ma si tratta anche di recuperi e riappropriazioni di modelli endogeni di vita e di lavoro tradizionale, del riciclo e della rigenerazione di tecniche e materie dismesse, di convivenza di pratiche tradizionali e ingegneria ambientale ad alta tecnologia.
Per questa sorta di “riterritorializzazione” e di rilocalizzazione delle produzioni – operazioni che si pongono in antitesi alla tendenza alla delocalizzazione di capitali e imprese e si iscrivono nel solco delle tradizioni autoctone, nella valorizzazione dei saperi e delle attitudini preesistenti – più che di innovazioni si parla di “retroinnovazioni”, di dinamiche agropastorali ma anche relazionali che si connettono al sistema comunitario del mondo contadino del passato. Da qui la costruzione di reti informali di protezione e di inclusione, di un welfare di prossimità che surroga i vuoti nei servizi pubblici e nelle strutture assistenziali. Da qui l’importante contributo degli immigrati che garantiscono le soglie per la sostenibilità degli squilibri demografici e degli obblighi di cittadinanza. Una presenza che rimette in movimento territori ai margini che stereotipi e pregiudizi considerano immobili e arretrati. Gli stranieri nel ruolo di soggetti innovatori rappresentano, in tutta evidenza, l’immagine di una imprenditorialità sociale e di un protagonismo culturale che tende a rovesciare le retoriche politiche dominanti. Gli interpreti di una sfida che dalla complessità della globalizzazione e dalle contraddizioni della crisi cercano e trovano inedite vie di uscita nell’immaginare e nel progettare il futuro attraverso nuovi modi di produrre, di investire, di abitare, di organizzare la vita di relazione.
 Che lo straniero sia figura liminare, di confine, ai margini dei margini, e in quanto tale metafora dell’innovatore, «ovvero di colui che introduce novità, provoca mutamenti e trasformazioni che modificano radicalmente o provocano comunque un efficace svecchiamento in un ordinamento politico o sociale», è definizione che ritroviamo nel libro di Giovanni Carrosio, I margini al centro (Donzelli, Roma 2019), pagine che dialogano in consonanza con quelle di Barbera e Parisi e di queste sembrano costituire una ideale integrazione. Nel nostro Paese che vive una condizione strutturale di sofferenza, legata all’invecchiamento della popolazione, al cronico indebitamento pubblico, alla storica inefficienza degli apparati burocratici, alla fragilità infrastrutturale e alla progressiva rarefazione degli investimenti nel sistema del welfare, l’autore individua nelle aree ai margini «tracce di emancipazione che passano per soggettività in movimento», «spazi di critica e di sperimentazione sociale», «i luoghi nei quali è possibile comprendere dal punto di vista analitico le crisi, e allo stesso tempo dove prendono corpo pratiche innovative, capaci di adattare in modo sostenibile il contesto locale ai cambiamenti, talvolta di trovare soluzioni alle contraddizioni dentro le quali le crisi prendono forma» (ivi: 33).
Che lo straniero sia figura liminare, di confine, ai margini dei margini, e in quanto tale metafora dell’innovatore, «ovvero di colui che introduce novità, provoca mutamenti e trasformazioni che modificano radicalmente o provocano comunque un efficace svecchiamento in un ordinamento politico o sociale», è definizione che ritroviamo nel libro di Giovanni Carrosio, I margini al centro (Donzelli, Roma 2019), pagine che dialogano in consonanza con quelle di Barbera e Parisi e di queste sembrano costituire una ideale integrazione. Nel nostro Paese che vive una condizione strutturale di sofferenza, legata all’invecchiamento della popolazione, al cronico indebitamento pubblico, alla storica inefficienza degli apparati burocratici, alla fragilità infrastrutturale e alla progressiva rarefazione degli investimenti nel sistema del welfare, l’autore individua nelle aree ai margini «tracce di emancipazione che passano per soggettività in movimento», «spazi di critica e di sperimentazione sociale», «i luoghi nei quali è possibile comprendere dal punto di vista analitico le crisi, e allo stesso tempo dove prendono corpo pratiche innovative, capaci di adattare in modo sostenibile il contesto locale ai cambiamenti, talvolta di trovare soluzioni alle contraddizioni dentro le quali le crisi prendono forma» (ivi: 33).
Come l’Italia dei margini promuova percorsi di resistenza e di autosviluppo delle comunità nell’affrontare le tre crisi, fortemente intrecciate e correlate – quella ambientale, quella fiscale e quella migratoria – è l’obiettivo che si è posto Carrosio nell’analisi delle cause delle diseguaglianze territoriali e delle precarietà offerte dal mercato. Tanto più che accade spesso che i disagi e le ingiustizie producano reazioni regressive di ripiegamento identitario, di chiusura, di risentimento, materie prime dell’azione politica del populismo. A partire da esperienze personali che lo hanno visto partecipare all’elaborazione del piano della SNAI (Strategia Nazionale per le Aree Interne) promosso da Fabrizio Barca, l’autore ragiona sulla vitalità di quei piccoli paesi che alla mancanza dei presidi sanitari e dei servizi di assistenza suppliscono con l’invenzione dell’infermiere e dell’ostetrica di comunità, della badante di borgo, di agro-asili e sistemi di mobilità a chiamata no-profit. Esempi di «modelli di domiciliarità allargata», di network di attori che agiscono all’interno di un «neowelfare municipale di comunità», secondo principi di sussidiarità orizzontale. Prove virtuose di innovazione che mostrano e dimostrano paradigmi di sviluppo alternativi, modelli di economia circolare, di coesione sociale e di effervescenza culturale.
«Le aree interne – scrive Carrosio nelle conclusioni – ci pongono di fronte all’urgenza di un pensiero nuovo, alto e radicale. Capace di tenere insieme lo sguardo sul mondo e l’attenzione ai luoghi. Ci richiedono più studio e ricerca sulle interdipendenze tra problemi che concorrono a generare e alimentare la crisi. Ci chiedono di rimettere in moto domande antiche, che devono trovare soluzioni inedite: chi è cittadino; di chi è la terra; quali istituzioni e confini di policy bisogna costruire per reincorporare l’ambiente nell’economia; come aprire il processo di costruzione del sapere dominante alle conoscenze contestualizzate; come rendere appropriate le tecnologie ai fabbisogni dei luoghi; come disegnare istituzioni nuove per economie civili e pre-distributive, che nei margini trovano nicchie di incubazione; come ricostruire il welfare, contemperando la domanda di mutualismo che nasce dal basso con il ruolo di garanzia dello Stato, perché nelle diversità i diritti siano garantiti in modo effettivo a tutti» (ivi: 148).
Domande cruciali che muovono da una nascente coscienza dei luoghi, dall’inversione della prospettiva che dai margini guarda alle politiche pubbliche, capovolgendone il paradigma di sviluppo urbanocentrico. Domande che invitano a risanare le frammentazioni territoriali, a rimarginare le faglie tra ambiente ed economia, a ricondurre la produzione dei beni alla loro condivisione. Domande che riconnettono il mondo all’identità dei luoghi, le speranze di un futuro ancora possibile alla creatività delle innovazioni sociali. Il destino del nostro Paese a quello dei piccoli paesi.
Dialoghi Mediterranei, n. 40, novembre 2019
Riferimenti bibliografici
A. Appadurai, Il futuro come fatto culturale, Raffaello Cortina, Milano 2014
M. Aria, Condivisione, in AM, 34-36, 2015: 62-64
M. Aria, F. Dei (a cura), Culture del dono, Meltemi, Roma 2008
M. Augè, Futuro, Bollati Boringhieri, Torino 2012
F. Barbera, T. Parisi, Innovatori sociali. La sindrome di Prometeo nell’Italia che cambia, Il Mulino, Bologna 2019
G. Carrosio, I margini al centro, Donzelli, Roma 2019
P. Clemente, Piccoli paesi decrescono. Una rete per una battaglia di generazione, in “Dialoghi Mediterranei”, n. 27, settembre 2017
V. Crapanzano, Orizzonti dell’immaginario, Bollati Boringhieri, Torino 2007
M. De Certau, L’invenzione del quotidiano, Ed. Il lavoro, Roma, 2001
A. De Rossi (a cura), Riabitare l’Italia, Donzelli, Roma 2018
J. Dotti, Condividere, Luca Sossella editore Bologna 2018
B. Jacomy, Innovation, in “Rivista del Musée des Confluences”, Lione, luglio 2011
G. Lenclud, La tradizione non è più quella di un tempo, in P. Clemente, F. Mugnaini (a cura), Oltre il folklore, Carocci, Roma 2001: 123-133
M. Magatti, Cambio di paradigma, Feltrinelli, Milano 2017
R. M. Rilke, Lettera del 12 agosto 1904, in Lettere a un giovane poeta, trad. di L. Traverso, Adelphi, Milano 1980
A. Sen, La libertà individuale come impegno sociale, Laterza, Roma-Bari 2007
J. Starobinski , La relation critique, Gallimard, Paris 1970
C. Taylor, Modern social immaginaries, in “Public Culture”, 14, I, 2002: 91-124
P. Toschi, Saggi sull’arte popolare, Edizioni Italiane, Roma 1945
______________________________________________________________
Antonino Cusumano, ha insegnato nel corso di laurea in Beni Demoetnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo. La sua pubblicazione, Il ritorno infelice, edita da Sellerio nel 1976, rappresenta la prima indagine condotta in Sicilia sull’immigrazione straniera. Sullo stesso argomento ha scritto un rapporto edito dal Cresm nel 2000, Cittadini senza cittadinanza, nonché numerosi altri saggi e articoli su riviste specializzate e volumi collettanei. Ha dedicato particolare attenzione anche ai temi dell’arte popolare, della cultura materiale e della museografia. È autore di diversi studi. La sua ultima pubblicazione è la cura di un libro-intervista ad Antonino Buttitta, Orizzonti della memoria (2015).
_______________________________________________________________








