 di Pietro Clemente, Federico Fastelli, Zelda Alice Franceschi, Luciano Giannelli & Uršula Lipovec Čebron, Ernestina Pellegrini, Diego Salvadori
di Pietro Clemente, Federico Fastelli, Zelda Alice Franceschi, Luciano Giannelli & Uršula Lipovec Čebron, Ernestina Pellegrini, Diego Salvadori
Claudio Magris racconta guidato dalle stelle australi della Croce del Sud
di Pietro Clemente
Un incrocio, un intrico tra Ottocento e Novecento, tre vite e tre strade
In un incontro su Zoom dedicato a Croce del Sud mi sono trovato a un trivio. Cosa interessante dal punto di vista narrativo. Che strade avevo davanti? C’era la strada di Zelda Franceschi, antropologa, esperta per ricerche sul campo nel Chaco argentino, con le sue pianure e le sue pampas. Zelda era in risonanza con le atmosfere tristi quasi desolate con le quali Magris raccontava quel Sud del mondo che diventa un nord capovolto. C’era la strada di Luciano Giannelli, glottologo, ma anche ricercatore sul campo del mondo Mapuche. Luciano rivendicava la necessità di essere precisi sulle lingue e sulle storie locali, e segnalava la distanza enorme tra le pagine ‘araucane’ di Magris e la sua esperienza di quelle popolazioni negli ultimi decenni. Metteva in evidenza il rischio, anche se a fin di bene, di offuscare (ancora una volta) la voce specifica delle comunità native. La strada di Ernestina Pellegrini, ‘magrisologa’ e curatrice delle Opere di Claudio Magris per I Meridiani (Mondadori 1° vol. 2012, 2° vol. 2021) è una strada letteraria, ma sorprendente e ricca di panorami inediti. Ernestina segue l’autore, la letteratura di riferimento, le predilezioni, i giochi di rimando, il confronto tra diverse opere, e ci mette di fronte alla straordinaria forza immaginativa dell’opera, al suo continuare un viaggio dentro la creatività testuale pur cambiando rotta e facendo nuovi incontri. Fa sentire gli antropologi un po’ come gente che sta a pesare con la bilancia i grammi di verità nativa che si possono trovare in un’opera. A mio parere in questo trivio la strada più attraente è quella di Ernestina: è la strada fatata della narrazione, che si fa seguire per fascinazione. Ma il mio spirito critico che ho incorporato quasi come un habitus mi dice che in questo libro la scrittura di Magris è un po’ ripetitiva e stranamente ridondante. Che questo suo ri-transitare viaggi altrui strani e insieme capaci di rompere i limiti dell’Occidente disorienta.
Viaggi di viaggi di viaggi, in tre episodi, come in certi film, i cui protagonisti non si incontrano ma idealmente si intersecano e diventano attori di un comune teatro di occidentali in America latina tra Ottocento e Novecento. Una suora piemontese (1854-1914), un ‘operaio’ austro-slavo (1883-1950) nutrito di studi universitari, un avvocato avventuriero francese un po’ folle che si volle re di Araucania e Patagonia (1825-1878) ci accompagnano per le 122 pagine del libro, ricche di varietà, di scarti, di parentesi, di percorsi ad albero, di giochi testuali.
Il primo Ivan Benigar ci accompagna per 50 pagine, il secondo Orélie Antoine de Tounens per le successive 18 pagine, e suor Angela Vallese per le ulteriori 37. Essendo tre ‘outsider totali’ rispetto all’Occidente capitalistico in sviluppo è interessante vederne insieme l’occidentalità libertaria tenace o l’occidentalità pedagogica (tra Leopardi e Rousseau, ma già da tanto prima era stato detto molto di occidentale su quelle popolazioni), lo spirito di adattamento che non nasconde la tenace insistenza nelle loro idee. Sono bei soggetti di racconto, leggendari. Forse Magris li voleva collocare in una storia leggendaria e buona rispetto ad altre, in un Occidente austro-ungarico ricco di riscontri nella letteratura, nell’immaginario, nell’antropologia. Come un raccontatore da osteria nel porto della Tortuga (anche il Corsaro Nero era un ligure che visse, alla fine del Seicento, gran parte della sua vita in America latina), Magris li dipinge assumendo la parte del Vecchio Marinaio della Ballata di Coleridge, e racconta infine che questi tre esempi di Occidente buono sono pur sempre tracce della non biodegradabilità dello spirito occidentale. Far intuire la presenza dei nativi dietro queste voci franco-austroungarico-piemontesi che parlano di loro, che li amano, che li vogliono liberare, suggerisce la radicale estraneità dei nativi a questi ‘matti gentili’ che se li sposano (Benigar si sposa due volte con delle native e ha diversi figli), o che li vogliono guidare per amore di qualcosa di poco evidente ad essi e di più chiaro a noi europei. Ma tutta l’America contemporanea è fatta di questo paradossale incontro, come suggerisce la Piazza delle Tre Culture a Città del Messico: la cultura nativa, la cultura spagnola, la cultura moderna in una mescolanza centrata su potere, guerra, stragi di nativi, meticciati, trasformazioni, ibridazioni culturali, sogni di mondi migliori. Negli ultimi decenni è emersa la consapevolezza che le religioni native sono rimaste imbricate dentro il cattolicesimo, vincendo così, a modo loro, la battaglia contro la loro eliminazione da parte della Chiesa cattolica. C’è in fondo tutta la storia dell’antropologia latinoamericana.
La suora e l’antropologo sui generis (‘operaio’ per l’immigrazione e diventato Cacique e Sabio) hanno vissuto la grande parte della loro vita laggiù. L’avvocato avrebbe voluto vivere come re, se gli fosse stato concesso. Troppo attraente per uno scrittore questo strano pezzo di Europa che si dedica a quello strano pezzo di America meridionale. Spesso i grandi conflitti intellettuali nei mondi periferici che Magris narra fanno pensare ai racconti di Luis Borges, che sono riferimento esplicito quasi obbligato, dati i luoghi e dati gli autori. Ma in generale è il racconto dell’Occidente che si allarga anziché essere il mondo amerindiano ad affacciarsi e a raccontarsi. Anche se sono al centro di tutto [1], non si vede molta vita di fuegini o altri indigeni. Così era per il mondo dell’Europa emergente nei due secoli delle scoperte, del colonialismo e dell’imperialismo. I nativi erano oggetti di racconto e di dominio ma, in questi tre casi, anche compagni di vita e amati possibili sudditi.
Buridano e il Patagone
Ma infine quale strada ho scelto tra quelle di Zelda, di Ernestina e di Luciano? Forse mi sono fermato all’ingresso dell’incrocio di strade. Un po’ prima di dover scegliere. Forse ho pensato di restare lì senza fare passi ulteriori. L’asino di Buridano doveva scegliere tra due balle di fieno ed io fra tre strade. Ma credo che sarebbe morto anche se avesse avuto tre fasci di fieno davanti e non due. Io non morirò di fame, ma mi fermerò sulla soglia. Voglio solo fare un esempio della difficile decidibilità di un percorso critico, perché Magris mette nelle sue pagine, traversando le tre storie una quantità tale di riferimenti e di possibili percorsi, da rendere quasi impossibile imboccare tutte le strade che apre: non è un labirinto, è una ragnatela, un patchwork, una piccola Babele messi insieme. Il testo che mi ha più incuriosito è quello di Benigar nel capitolo dal titolo Gringo sloveno, criollo araucano, dove si sottolinea il forte meticciato simbolico identitario del personaggio-Magris che apre una grande parentesi a pagina 52:
«Quando Benigar, sia pure di sfuggita, dice che una parte del territorio araucano è un pezzo dell’antica Lemuria, non sprofondato insieme con essa nel grande cataclisma del Pacifico, indulge anch’egli per un momento alla fascinazione del mondo perduto, inabissato non solo nelle profondità marine ma anche e ancor di più in quelle del tempo, di un tempo non misurabile».
E da qui una connessione con Thomas Mann per cui ‘il pozzo del passato è imperscrutabile’, con Howard P. Lovecraft e i suoi racconti del mistero, ma anche con la morte perché i ‘lemuri’ della mitologia romana erano fantasmi, ma secondo qualcuno i lemuri intesi come scimmie dai grandi occhi sarebbero all’origine dell’umanità, per arrivare infine a mettere in scena il proto batterio Luca (dove Luca sta per Last universal common ancestor) come idea di antenato biologico remoto.
Insomma una rete di reti che si dipana incessantemente nel testo, aprendo porte, corridoi, paesaggi di cui non è facile venire a capo. Rompicapi della cultura occidentale che si innestano nelle intercapedini delle storie narrate. La storia del Re di Araucania e Patagonia mi ha incuriosito meno, anche se mi ha impietosito di più. Perché in fondo Benigar è diventato un pezzo riconosciuto di storia locale, mentre Orélie sembra proprio un insensato, che fa parte di quell’Elogio della follia, aperto da Erasmo da Rotterdam, come pezzo rappresentativo dell’Occidente. Forse Orélie meritava una analisi clinica di Freud, perché in lui ci sono insieme l’idea del possesso e della liberazione, del regno e dell’anarchia. Penso che gli Araucani non abbiano perso molto con la sua assenza.
La suora è una figura simpatica nelle sue oscillazioni tra mondi e nella sua tenace devozione espressa senza mai capire nulla dei bisogni dei nativi e della loro diversità culturale. Penso che ancora oggi i tanti missionari che danno amore, dedizione, tenace presenza dimostrano una totale incomprensione dei popoli nativi. Anche se ci sono stati missionari grandi antropologi come il protestante francese Maurice Leenhardt (1878-1954), fondatore degli studi melanesiani.
I Patagoni sono, per me, un punto di mezzo tra un romanzo di Salgari [2] e il Museo di Etnografie ed Antropologia di Firenze, fondato da Paolo Mantegazza [3], che viaggiò da antropologo ma anche da potenziale cercatore di terre e di ricchezze, in Argentina, Paraguay e Bolivia. Il Museo si apre al visitatore con una statua in legno di dimensioni giganti [4]: si tratta del ‘Patagone’, uno di quelli tenuti per mano da suor Angela. Un documento museale tra il mito e l’avvio allo stupore della diversità.
Ma, come vedete, per evitare di scegliere uno dei tre percorsi sto facendo come Magris quando apre cento strade, vicoli e pertugi. Devo perciò dare la parola all’investigatore Gideon Fell:
«C’è una buona e vecchia frase per descrivere me, e la frase è: colui che si scervella. Il mio vecchio cervello schizza qua e là. Io sono come il cacciatore strabico che sparò un po’ qua e un po’ là e non lasciò selvaggina per nessuno. Sono come l’uomo di quella vecchia storiella che cercava affannosamente a Piccadilly uno scellino perduto in Regent Street perché là c’era più luce. Ma spesso c’è da dire molte cose a favore del fatto di cercare un indizio nel luogo dove si sa che non c’è. Si vedono cose che altrimenti non avremmo mai notato» [5].
Mi sono reso conto che se accosto le date di nascita e di morte dei protagonisti dei racconti di Croce del Sud, a quelle di Mantegazza e Salgari, mi trovo tra i tempi di vita di Carlo Marx e di James Frazer, ma anche – in sequenza – tra quelli di mio nonno e di mio padre. Si vede un nesso tra gli autori che ho più letto in varie età (Emilio Salgari prima e Karl Marx poi), le generazioni, la storia d’Europa. Quella che Magris racconta è una storia culturale che è anche una genealogia dell’immaginario europeo.
Note
[1] Forse anche perché Benigar aveva una formazione scientifica e non raccontava la sua vita in mezzo ai nativi. Per me è stata una lettura etnograficamente ricchissima quella di Frederick E. Maning, Vecchia Nuova Zelanda. Memorie della vita selvaggia, a cura di Valerio Fusi, Palermo, Sellerio, 1996 (ed. orig. 1876)
[2] C’è in effetti II tesoro del Presidente del Paraguay del 1910 (Salgari 1862-1911), da citazioni indirette vedo che Claudio Magris ha apprezzato Salgari, considerato Salgari un produttore di Atlanti dell’immaginario della diversità.
[3] Paolo Mantegazza (1831–1910)m fondatore di tanti campi del sapere e della museografia, milanese, medico, viaggiatore e poligrafo, una delle personalità più rappresentative dell’epoca che Croce del Sud racconta
[4] È una scultura risalente al Seicento raffigurante un leggendario abitante della Patagonia.
[5] J. Dickson Carr, Delitti da mille e una notte, Milano, Mondadori, 1984, ed.or.1936
di Federico Fastelli
Vorrei iniziare questa mia breve riflessione su Croce del sud soffermandomi sul sottotitolo, “tre vite vere e improbabili”. L’intento è di riferire l’operazione magrissiana agli indirizzi conoscitivi di una peculiare idea di letteratura, cui lo scrittore mi pare tenda progressivamente nel corso degli anni, sino a questo libro, che per certi versi ne rappresenta il compimento. Più in generale, però, ci si potrebbe riferire al complesso reticolo che allaccia, proprio in quell’idea di letteratura, le dimensioni del vero, del falso e del finto, per riprendere un eccellente titolo di Carlo Ginzburg [1]. Potrebbe infatti sembrare à la page, per così dire, ricondurre l’opera di Magris all’ambito della cosiddetta letteratura non-finzionale: il recente successo di scrittori di grande valore come Sebald o Carrère, o meno grande, anche, volendo, come Lethem negli Stati Uniti o Saviano in Italia, ha sdoganato ormai un’idea per molti versi confusa secondo la quale la narrativa non-finzionale sarebbe una via non pregiudicata attraverso la quale riemergere dalle astrazioni e dai distaccati disimpegni della cosiddetta letteratura postmoderna, ormai al tramonto. Peccato che Rodolfo Walsch, che di questa corrente letteraria è l’inventore moderno [2], abbia scritto ben prima che di postmoderno si potesse compiutamente parlare, e peccato che il maggior alfiere del genere, Truman Capote [3], fosse un contemporaneo di John Barth e Thomas Pynchon. Peccato anche che, in altro senso, la letteratura non-finzionale esiste da molto molto tempo prima, penso per esempio ad alcune opere tra reportage giornalistico e narrazione romanzesca di Hemingway, oppure, andando più indietro, al celebre Diario dell’anno della peste (1722) di Defoe. E forse potremmo addirittura dire che tale declinazione letteraria esiste da sempre. Al di là delle questioni storico tassonomiche, su cui la critica dibatte molto alacremente negli ultimi anni, interessa qui che a negare l’equazione scrittura non-finzionale uguale ritorno alla realtà sia in fondo lo stesso Magris, improvvidamente annoverato da qualche catalogo critico in improbabili tavole di lettura, accanto a colleghi diversissimi, prima, paradossalmente, come esponente del postmoderno (per esempio relativamente a Danubio), e poi di ciò che postmoderno non sarebbe più. Ecco: per dimostrare quel che dico, devo ricominciare dall’inizio. Quando Aristotele – Poetica libro I e poi libro III – riconosce il valore conoscitivo proprio e peculiare del fatto letterario, lo fa, come sappiamo, in deroga all’approccio pedagogico e ideologico che il maestro Platone aveva messo in bocca al suo Socrate – ovviamente Repubblica libro III e, rincarando la dose, libro X – e per il quale ai poeti, imitatori inaffidabili e pericolosi, non poteva che venir revocato il diritto di cittadinanza nella polis: «la tecnica dell’imitazione è lontana dal vero, e […] riesce a produrre tutte le cose per questo: coglie una piccola parte di ognuna, e si tratta di un simulacro». E ancora: «l’artefice del simulacro, l’imitatore, non conosce nulla della realtà ma solo l’apparenza […]. Non ha corrette opinioni circa la bellezza e i difetti di ciò che imita». E infine: «Omero è grandissimo nella poesia e primo fra i tragici; ma occorre poi sapere che in una città si deve accogliere solo quel tanto della poesia che consiste negli inni agli dèi e negli encomi degli uomini buoni. Se invece tu vi accogliessi la Musa piacevolmente addolcita dalla lirica o dall’epica, il piacere e il dolore regneranno nella tua città invece della legge e del principio razionale». Al contrario, nella Poetica lo Starigita scrive notoriamente: «il compito del poeta non è dire le cose avvenute, ma quali possono avvenire, cioè quelle possibili secondo verosimiglianza o necessità. Lo storico e il poeta non si distinguono nel dire in versi o senza versi […]: l’uno dice le cose avvenute, l’altro quali possono avvenire […]. Perciò la poesia è cosa di maggiore fondamento teorico e più importante della storia, perché la poesia dice piuttosto gli universali, la storia i particolari». Ora, entrambe queste posizioni contengono per Magris un briciolo di verità. Lo sappiamo bene dai suoi interventi in Letteratura e ideologia (2012), in La letteratura è la mia vendetta (2012), e più in generale dalla lettura di Alfabeti (2008). Ma è già in Utopia e disincanto (1999) che la questione, da un punto di vista teorico-critico, emerge con tutto il suo davvero epocale precipitato: è chiaro che lo scrittore ha un potere e che questo potere può essere corruttivo. Certi scrittori, come capita per i “nichilisti nordeuropei” e per gli esponenti di quell’“anarchismo reazionario” passato in rassegna nell’Anello di Clarisse (1984), possono assolutizzare la loro battaglia contro i propri fantasmi, smarrendo qualsiasi afflato sociale, facendo dei propri spettri il motivo unico e universale dell’esistenza. È altrettanto chiaro, però, che la letteratura è a tutti gli effetti una forma di conoscenza della realtà il cui mandato, indipendentemente dall’intentio politica o etica dell’autore, è quello di mostrare, non per via di spiegazione ma con la “potenza tipica dell’identificazione”, “abissi e contraddizioni” della vita, e cioè esplorare ciò che altre forme di conoscenza – la storia, la critica, il diritto – non possono per definizione e per statuto. Così aspirazione alla verità e traviamento nell’errore, ragione e delirio, esigenza di giustizia e colpevole trasgressione devono convivere nel testo letterario, il cui azzardo è esattamente una discesa infera, senza istruzioni per l’uso e senza mappa: strumenti che, eventualmente, uno scrittore può, se ne sente la necessità, fornire ex-post, in altro luogo, attraverso un’altra scrittura, attraverso un controllo razionale e diurno della potenza delle parole, ma che, comunque, non sono letteratura. E in questa catabasi propria di ogni grande opera letteraria risiede anche il mandato peculiarmente utopico della letteratura, il suo “imperterrito e serissimo” gioco che consente di continuare a pensare la bacinella del barbiere come l’elmo di Mambrino, per usare un’immagine che Magris trae dal Chisciotte. Se di norma alla finzione, appunto perché la letteratura non racconta ciò che è avvenuto, ma ciò che sarebbe potuto avvenire o ciò che potrebbe ancora avvenire, si delega il compito primario di moderare, rallentare, eludere il disincanto della realtà, ovverosia l’inflessibile cammino della storia, che, hegelianamente, rende razionale ciò che è avvenuto, e spiega che ciò che è avvenuto non poteva non avvenire, pure esistono dei casi eccezionali in cui tale compito è già stato assunto nella storia dagli sconfitti, dai folli, da utopisti perdenti e improbabili. E allora ecco che di fronte ad una realtà che fa concorrenza alla letteratura, secondo il celebre motto di Mark Twain per cui la verità è più strana della finzione, la letteratura si rovescia, e invece di raccontare ciò che sarebbe potuto avvenire, racconta esattamente ciò che è successo, facendosi supplemento della memoria e parergon della storiografia, per riscattare ancora una volta dall’avvenuto disincanto, l’utopia che ispirò alcune vite vere e assai poco verosimili, per l’appunto improbabili.
Si spiega così, a mio avviso, il cammino della scrittura non-finzionale di Claudio Magris che conduce a Croce del sud per una via sideralmente distante dall’onesto e sfacciato egocentrismo, poniamo, di un Carrère, o dall’aspirazione ad una letteratura d’impegno nell’epoca del disimpegno di un Saviano: non vi è in Magris alcuna necessità di dichiarare la buona fede della propria testimonianza, di porre il proprio io come parametro unico e irrevocabile di affidabilità di quel “non” che specifica la “fiction”. Il riscatto della memoria, infatti, passa da un’idea ancora universale di storia, ed anzi forse mira a reimpostarne i parametri. In Croce del sud, in particolare, tale riscatto riconosce l’istanza utopica nella realtà senza ricrearne figuralmente una nuova, ma ricordandone l’assurda fattualità, ovvero intrecciando nuovamente i fili di tre figure eccezionali come Janez Benigar, gringo sloveno diventato criollo araucano; Orélie-Antoine de Tounens, re autoproclamato di un regno che non esiste; e Suor Angela Vallese, suora-pinguino piemontese che, come scrive Magris, «sfida con tranquilla semplicità l’abnorme mistero della natura» [4] nella terra del fuoco. Figure accomunate, nella sostanza, da tre aspetti: l’afflato utopico, di cui le rispettive, paradossali esistenze sono la più vera, per quanto improbabile, manifestazione; l’ambito geo-spaziale dell’estremo sud, quell’assoluto laggiù, ultimo confine del mondo, come lo chiamò Thomas Bridges, che è sfondo certo fisico ma anche allegorico dei tre racconti; e, infine, l’incidenza di un caso che, attraverso la penna dello scrittore, si fa necessità. Come dichiara lo stesso Claudio Magris, infatti, egli si è imbattuto per accidente in queste tre figure. Ma quell’accidente si è fatto subito, per accostamento e giustapposizione dei tre protagonisti e attraverso la scrittura, possibilità di affrancamento delle loro vite e dello scarto dal disincanto che rappresentano, quasi un emergere del rimosso della e dalla storia, e dunque occasione, che certo Magris non si lascia sfuggire, per risemantizzare la storia con la letteratura e attraverso la letteratura.
In questo senso, Croce del sud appare piuttosto distante dai ricorsi non-finzionali adoperati da Magris nella sua produzione letteraria precedente. Se in Illazioni su una sciabola (1984) lo scrittore mirava non alla ricostruzione della verità ma a quella delle “ragioni di una contraffazione della verità”, e se molti dei suoi personaggi successivi erano costruiti sopra modelli reali ma restavano creature ibride, innestate dalla letteratura sulla storia reale o dalla storia reale nella letteratura, come il Toio Zorzenon di Un altro mare (1991), o il Salvatore Cippico di Alla cieca (2005), declinazioni romanzesche, per esempio, di quei cantierini monfalconesi che, dopo la seconda guerra mondiale abbandonarono l’Italia per la Jugoslavia, finendo poi reclusi in campi di concentramento antistalinisti creati da Tito; se, insomma, la dimensione finzionale e quella storica si compenetravano di modo che una sopperisse all’altra, oppure in maniera tale da provocare un cortocircuito tra verità storiografica e memoria individuale o di alcune piccole comunità, in Croce del sud capita qualcosa di diverso. Anzitutto la raccolta manomette in maniera dichiarata ogni meccanismo dialettico: mentre la struttura narrativa della produzione precedente era spesso gestita da complesse e quasi invisibili, ma pur presenti relazioni dialettiche – possibilità versus fattualità, per esempio in Illazioni su una sciabola; oppure l’est rifiutato temuto e disprezzato versus l’ovest vittorioso e disincantato in Alla cieca e anche, in parte, in Non luogo a procedere (2015), per fare giusto un paio di esempi – questa volta i tre racconti centralizzano e sovrappongono due poli normalmente in opposizione tra loro. Rimanendo alle stesse coordinate prese come esempio: la fattualità in Croce del sud ricopre ogni istanza potenziale. L’assoluto sud non è pensato (né sarebbe pensabile) in rapporto al nord, ma come dimensione metafisica che da spazio si fa tempo, «laggiù del tempo» [5], scrive Magris, che però, avverte poco più avanti, non è una metafora poetica. «La Storia – il passato, il tempo – è scritta nel ghiaccio. Le cosiddette carote di ghiaccio che si possono estrarre dal profondo sono archivi cosmici di un milione di anni fa, nove cicli di glaciazione compresi e documentati, leggibili» [6].
Contemporaneamente, quell’assoluto che è insieme spazio e tempo, è anche immagine palese della scrittura, e in generale, della creazione letteraria, perché, dice Magris citando Borges, è solo la letteratura a non temere anacronismi: in essa, come nelle carote di ghiaccio, si spegne ogni potenzialità facendosi atto, facendosi storia (con la s minuscola) cristallizzata, ghiaccio che blocca e conserva, doppio in qualche modo della morte e della finitudine umana, che per affermarsi ha necessità di dare forma, fissità, alle cose, disegnandole come fa il gelo sul vetro. In questo, e in molti altri momenti dei tre racconti, mi pare evidente una sorta di senso elegiaco per una tradizione orale ed esperienziale premoderna, nella quale il racconto si risemantizzava, si arricchiva e variava ogni qual volta un oratore lo avesse rinarrato. Un mondo prescientifico in cui realtà ed illusione erano fermamente intrecciate, nella quale il fantastico, insomma, non era scarto irrazionale, appannaggio di bambini, di folli e di sognatori, ma scarto dal senso comune che i viaggiatori in mondi lontani potevano contrapporre, senza possibilità di essere smentiti, all’autorità degli anziani e dei cantastorie, e nel quale l’esperienza percettiva non era sostituita dalla misurazione infallibile del metodo galileiano. Citando implicitamente il Goethe della Teoria dei colori, Magris ci spiega infatti che il rosso e il blu non potevano essere sostituiti dalle frequenze d’onda di cui Newton ci ha, direi irreparabilmente, svelato il meccanismo. Il tempo compresso, lo spazio infinito, l’orizzonte nostalgico rilanciano perciò le istanze inesauste, ma sostanzialmente impossibili nella nostra realtà, dell’avventura, ridotta troppo spesso a quête o a indagine sherlockolmsiana di indizi e tracce che sembra debbano avere sempre una spiegazione razionale, una soluzione consolatoria ai nostri dubbi epistemici ed esistenziali.
Così, rievocare alcune storie che di sensato hanno ben poco, improbabili, proprio, è come fendere la coltre troppo esatta del meccanismo per il quale l’insopportabile Reale lacaniano è tradotto in una rispettabile, ordinata e innocua realtà. Viaggiare nell’assoluto laggiù significa ripercorrere la forza utopica, liberatoria, pericolosa ma vivificante, chiarificante della grande letteratura d’avventura, una sorta di atto resistenziale che rilancia il valore veridittivo dell’esperienza, fattuale o finzionale che sia, riscattandola dalla sfera squisitamente moderna della mera fantasticheria. Le avventure vere e improbabili di Benigar, di De Tounes, di suor Angela, ma anche di scrittori viaggiatori come il Bruce Chatwin di In Patagonia, come il Daniele Del Giudice di Orizzonte Mobile, sono come sovrapposte a quelle inventate, ma altrettanto cariche di avventura e di verità, degli eroi del Poe di Gordon Pym, di Maelstrom, del Manoscritto trovato in una bottiglia, o del Verne della Sfinge dei ghiacci e del Viaggio al centro della terra, del Melville di Moby Dick, del Lovecraft delle Montagne della follia, dell’amato Salgari del ciclo dei Romanzi tra i ghiacci. In questo senso la misura della verità prescinde dal suo essere avvenuta: per puro paradosso, Magris nega, narrando storie vere, la differenza narrativa tra fiction e non-fiction, ma rinnova un patto che lega da millenni i narratori di storie a chi li ascolta, una verità di altra natura, che non può essere misurata, nel suo gioco ingenuo ed essenziale, con i numeri, con gli algoritmi, con le lunghezze d’onda.
Note
[1] Ovviamente Il filo e le tracce, Milano, Feltrinelli, 2006.
[2] Cfr. R. Walsh, Operación Masacre, Buenos Aires, Ediciones Sigla, 1957.
[3] Come è noto, In Cold Blood esce a puntate sul «New Yorker» nel 1965, e in volume l’anno seguente, per l’editore Rando House. Nel 1966 escono anche The Crying of Lot 49 di Thomas Pynchon e Giles Goat-Boy, or, The Revised New Syllabus di John Barth.
[4] C. Magris, Croce del sud, Milano, Mondadori, 2020: 91.
[5] Ivi: 110.
[6] Ibidem.
 Etnografia e letteratura: tre vite vere
Etnografia e letteratura: tre vite vere
di Zelda Alice Franceschi
Quando ho letto il racconto della vita di Janez Benigar mi sono fermata. Prima di leggere le altre storie volevo mettere a fuoco che cosa mi aveva colpito.
Magris aveva colto nel segno. Aveva scelto come protagonista un “gringo, sloveno, criollo, araucano” e descritto quel pezzo di mondo con i suoi occhi, quelli di un “avventuriero sloveno nato a Zagabria […] uomo posato e abitudinario, incline ad una pedanteria tutta austriaca” (p.10). Ma non solo: aveva intuito che per raccontare la complessa stratificazione di quei luoghi era necessario avere sguardi trasversali, consultare fonti eterogenee, unire storia e microstoria, quella petite histoire, aneddotica e spesso screditata. E ancora poesia e letteratura, etnografia e proto-etnografia.
Siamo nell’Argentina delle province Río Negro e Neuquén, nella macro-regione della Patagonia, con i suoi indigeni di cui si evocano, forse a volte in modo un po’ maldestro nomi (mapuche, tehuelches, patagoni), habitus culturali, caratteristiche sociali e linguistiche (wigwam, machi). Certo è, che nel panorama amerindio le medesime fonti etno-storiche ed etnografiche spesso si rincorrono con etnonimi, eponimi, toponimi e grafie diverse e con contrastanti interpretazioni. Allo stesso modo anche quelle fonti aneddotiche, preziose, proprio perché minori e locali, descrivono la storia degli indigeni sommariamente, con un paternalismo romantico che li ha definiti nel tempo come vera e propria “alterità radicale” portandoli ad essere i primi indiscussi nella loro posizione della scala evolutiva: il grado zero dell’umanità.
Benigar filtra, accoglie, cuce, scarta e ricuce e con lui Magris. Vuole scrivere la “sua” storia, forse proprio come lui gliela avrebbe raccontata. Tutto laggiù è spurio, così vero da sembrare falso, tanto amaramente squallido e impregnato di irreale fascino che lascia il cuore intorpidito e scosso. In questa parte di mondo gli indigeni sono stati e rimangono spesso parte del paesaggio. Scompaiono e ritornano, per poi di nuovo svanire. Sono evanescenti, vivi, fragili e potenti. Si mescolano ma rimangono ai margini di immigrazioni minori e poco conosciute, spesso eroiche, vendute come magnifiche e piene di magnificenze, in terre feroci, che hanno prodotto poveracci, spesso esiliati senza patria. Criollos che si confondono con gauchos. Missionari e missionarie le cui vite si spendono con un amore, tenero e ottuso, nutrito da comprensione e incomprensioni. Una volontà spassionata di armonia “dell’essere, del cuore, del pensiero”. La fede.
In questo libro troviamo “vite vere e improbabili” che si insinuano tra Europa, mitteleuropa, Cile e Argentina. Nell’interno però, nelle province e nei piccoli paesi, incrociando città a volte con lo sguardo di intellettuali conosciuti, altre con le parole di antropologi autodidatti sempre in bilico “tra la scienza e il dilettantismo” (p. 28) autori di “compiti scolastici, temi di liceo […] scritti con la tenacia del dilettante appassionato” (p. 29-30).
L’etnografia asciutta e senza sbavature non sempre riesce a cogliere, in una descrizione “densa” [1], ‘la carne e il sangue’ di queste vite vere. Non riesce per i limiti imposti di una disciplina che deve (o ha dovuto) ascoltare un paradigma rigido e costretto in regole senza scorciatoie. Ma l’etnografia a ben pensarci è arrivata a cogliere, delle persone, i loro moti del cuore. Gli scritti privati degli antropologi sono giunti tardi però e per vie traverse in accademia: diari, lettere dal campo, storie di vita indigene e racconti autobiografici, dove la voce dell’antropologo e quella del nativo andavano sovente all’unisono, come in un gioco di sguardi che rendeva quelle storie così appassionanti e vere da risultare poco credibili. Penso ai conosciuti diari di Bronislaw Malinowski e a quelli, meravigliosi, pubblicati postumi, di Alfred Métraux o ad alcune bellissime etnografie di donne, prima fra tutte la afro-americana Zora Neale Hurston.
Per questo la storia di Janez Benigar mi ha colpito. Se fosse stata il resoconto di viaggio di un etnografo avrebbe doverosamente presentato note capaci di risolvere le incongruenze evidenziate da Giannelli e Lipovec. Ma non è questo il punto o almeno non lo è per me. La scrittura è asciutta e poetica. Asciutta e secca (come dice Ernestina Pellegrini) perché forse quel “Far west”, quell’altrove così poco esotico, squallido e sorprendente, altro stile non permette. Poetica perfino nel descrivere la potenza del “capitalismo selvaggio”. Quella “neghittosità” dei luoghi e degli indigeni che aveva portato alcuni antropologi europei a dedicare la loro vita a indagare le cause di tale inoperosa indolenza che tutto ha investito, alimentandosi della loro forzata sedentarietà. Indigeni trasformati in pigri peones malpagati, miserabili nelle loro terre, accanto ai nuovi vicini di casa: immigrati, criollos e gauchos. I più sono estinti, altri hanno perso la loro lingua materna, altri ancora sono diventati indigenisti e alcuni tra i più giovani sono scrittori capaci che si confrontano con gli antropologi e che controllano, loro, con pignola pedanteria la correttezza delle traduzioni.
Mentre leggevo questa storia mi veniva in mente un bel libro, L’idioma di Casilda e Moreira [2]. Adrian Bravi, argentino di nascita e bibliotecario per tutta la vita a Recanati, racconta la incredibile storia di Bartolo e Casilda ultimi parlanti la lingua dei günün a yajüch, da alcuni chiamati anche tehuelches settentrionali. I due custodi di quella lingua non si parlano più; dopo una lite amorosa avuta da giovani vivono lontani, solitari e silenziosi. Così il giovane Annibale Passamonti cresciuto nel paesaggio dei Monti Sibillini, ascoltata questa incredibile storia dal suo professore di glottologia, parte alla ricerca dei due anziani. Percorre i medesimi luoghi descritti da Magris tra la Pampa e la Patagonia; vuole studiare quella lingua, capirla, ma soprattutto desidera salvarla. Una lingua che “non è tanto l’espressione del vissuto, quanto il vissuto stesso” (p. 37). Piccole e magnifiche storie, inventate e vere.
Nella storia di Benigar la sensibilità letteraria del suo griot diviene l’ingrediente che riesce a cogliere la sua stupefacente vita, un sigillo di “autenticità etnografica”. Ma noi antropologi sappiamo che la storia dell’autenticità e della verità etnografica è un po’ una truffa, pur continuando a crederci e facendo del nostro meglio per mascherarla. Dobbiamo convincere i nostri lettori che siamo stati là, che abbiamo capito quello che loro pensano, quello che i “nostri indigeni” sentono e fanno, nel quotidiano e nella loro più intima spiritualità. Dedichiamo giorni a scrivere diari e note etnografiche e quando torniamo a casa ci improvvisiamo “autori” e “scrittori”. Clifford Geertz lo aveva scritto chiaramente e senza mezzi termini. Dobbiamo autorizzare “una teoria, una tradizione, o una disciplina in cui altri libri e autori troveranno alternativamente un posto” [3], essere in grado di promuovere la nostra autorialità, ma anche e soprattutto convincere. Siamo anche noi prodotti spuri di una giovane scienza.
Ho apprezzato di questa testo la libertà dello scrittore che non nasconde la difficoltà nel maneggiare le più diverse fonti e anzi po’ ci gioca con eleganza e poesia, non celando le ambiguità dei suoi interlocutori, ingenui o furbi che siano. Ripercorriamo brevemente le tre storie.
Benigar arriva a Buenos Aires con la nave Oceania, è il 1908. Trascorre poi la maggior parte della sua vita nella zona di Aluminé, anche se in Argentina la sua vita è nomade. Era davvero il Deserto quello che vide Benigar appena arrivato? Il termine, di origine letteraria era stato ripreso da Domingo Faustino Sarmiento nella sua opera El Facundo (1845) e indicava un territorio vuoto, “senza civilizzazione”. Recuperato poi nelle campagne di conquista del Chaco e della Patagonia, riprendeva il significato di quello inglese di wilderness: un luogo dove vivono esclusivamente animali selvatici. In quelle distese desolate si fecero strada con inaudita violenza criollos e gauchos. Come Benigar si mescolarono, fra loro e con gli indigeni. Uomini creoli con donne indigene; valeva infatti (e vale) l’ipergamia femminile: il matrimonio di una donna di un gruppo “inferiore” con un uomo appartenente a quello “superiore”. Alcuni lo fecero con forza, altri anche con tenerezza. Una volta “conquistati” gli indigeni e diventati i loro territori parte integrante della nazione argentina, iniziano (siamo a cavallo fra Ottocento e Novecento) le fiammanti campagne di colonizzazione. Giungono immigrati da ogni dove: “panettieri, operai tessili, vinicoltori, fabbricanti di mattonelle […] e in Patagonia arrivano dalla Mitteleuropea tedesca ed ebraica e da ogni paese” (p. 15). Possono essere poveracci in cerca di fortuna così come “spregiudicati uomini d’affari” (Ibidem).
I luoghi diventano sempre più indicibili e inauditi, teatri di “abbietto sfruttamento e sanguinose repressioni” (p.16). Si trasformano allora in un vero e proprio deserto umano. Benigar arriva, si innamora e si sposa due volte con donne indigene. Impara la loro lingua e inizia a vedere quel pezzetto di mondo con altri occhi. Apprende il quotidiano di quella terra, ne conosce gli abitanti. Diventa uno di loro e si dimostra consapevole della propria forza e intelligenza per denunciare, condannare e lasciare una testimonianza. Il poeta e scrittore argentino Octavio Prenz lo fece in maniera superba da lontano, a Trieste, dove visse molti anni dopo il suo esilio e dove raccontò la terra che aveva lasciato. Benigar lo fece là, in quelle Terre del sud che lo avevano accolto immigrato. Lo fece in modo più artigianale, ma senza timore di scontrarsi con l’antropologo José Imbelloni, egregio e impavido classificatore delle razze amerindie.
Il secondo racconto è più breve, quasi una specie di intervallo. Orélie-Antonie de Tounens nacque il 12 di maggio del 1825 a La Chèze, località del comune di Chourgnac, nel Périgord, Dordogna. “Il 17 novembre 1860 […] annuncia al mondo la nascita o rinascita del Regno di Araucania, cui più tardi darà il nome di Araucania e Patagonia, proclamandosene re” (p. 63). Quella che descrive Magris è la storia un po’ rocambolesca di questo “eroe ottocentesco da melodramma, teatrale e caricaturale incline al pathos e ai grandi gesti, sul confine tra il dramma e le operette” (p. 66). Orélie vuole essere un re di un regno lontano, i suoi sudditi gli indigeni mapuche, stretti nella morsa dei loro vicini, indigeni anche loro. Si intravvede in queste pagine un popolo mapuche che individuò nella persona di Orélie-Antoine uno strumento perfetto per difendere il proprio territorio ed imporsi – alla maniera europea – nel contesto indigeno del Cono Sur. Fu, al di là delle vicende di questo “re senza corona”, un momento di partecipazione attiva di diversi toki (cacique) come Quilapan, Mañil e Kalfulkura (alcuni tra questi citati nel libro). La politica di conquista dei governi repubblicani nei confronti degli indigeni li indusse ad affidarsi al quel futuro re e alle sue teorizzazioni monarchiche.
Non è facile muoversi fra fonti complesse e un po’ ingarbugliate. Quelle originarie sono ridotte ai testi scritti e lasciati dallo stesso de Tounens, letti e interpretati successivamente, oltre alla documentazione ufficiale del governo cileno. Lo scrittore e giornalista Enrique Oliva, conosciuto con lo pseudonimo di François Lepot descrive Tounens come un uomo preda dei propri deliri di onnipotenza, teso nella sua utopica e improbabile impresa di creazione della Nuova Francia [4]. Non saprei (come invece scrive Pietro Clemente) se i mapuche non abbiano effettivamente perso molto con la dipartita del loro mancato re, di certo dopo quello di Benigar, questo breve racconto apre la strada ad un’altra dimensione, forse più suggestiva, quasi onirica, visionaria e un po’ surreale.
Questa ultima è la storia di Angela “la suora-pinguino” (p. 91) che da Lu, nel Monferrato dove faceva “la sartina” arriva nella Terra del Fuoco. La descrizione di questi incantati paesaggi si incrocia con quelli descritti da Daniele del Giudice in Orizzonte Mobile (2009); diventano “arabeschi disegnati dal gelo sul vetro” (p. 112) e aprono un dialogo a distanza tra i due scrittori a tratti intimo e quasi metafisico. Con Magris e del Giudice ci sono altre voci: Poe, Melville, Chatwin e soprattutto Salgari. Si viaggia nell’altrove più assoluto, straniamento glaciale. Se dunque in questo ultimo racconto la dimensione letteraria prende il suo spazio più pieno, tuttavia la vita di questa suora, “spavalda e temeraria” (p.116) così come il lavoro della comunità salesiana di Don Bosco, è ritratta con la stessa pugnace maestria delle avventure di Benigar. E come per il primo racconto ho pensato a un testo. Si tratta del diario di un etnografo, artista e fotografo, talentuoso, audace, originale, amico di Gabriele D’Annunzio: Guido Boggiani, uno dei più importanti americanisti del Novecento [5]. Pochi anni dopo l’arrivo di Angela, anche il giovanissimo Guido si trova in Argentina. Inizia il suo viaggio in Patagonia dal bacino del Río Negro. La campagna militare di Julio Argentino Roca si era appena conclusa e il paesaggio era quello desolato del dopoguerra, con i militari a controllare gli indigeni che non erano riusciti a scappare nell’interno e, stremati, cercavano dimora in accampamenti provvisori. Avevano già iniziato a lavorare per i nuovi proprietari terrieri, spregiudicati uomini d’affari e futuri latifondisti.
La prima tappa di Boggiani è proprio Carmen de Patagones, villaggio fondato nel 1779 dove visita le scuole e le chiese salesiane. Quella salesiana è una congregazione la cui storia fondativa costituisce un importante tassello nei piani dei colonizzatori argentini. I salesiani erano giunti nel 1879 e la pietra angolare di questa impresa fu proprio la parrocchia di Carmen de Patagones che vide la presenza del presbitero Giovanni Cagliero (1838-1926) e Monsignor Fagnano (1844-1916). Boggiani nei suoi diari non nomina nessuno dei due ma traspare la “instancabile opera” (p. 99) di questi preti e suore, testimoni di una fine prossima di molti fra quegli indigeni che vestivano e nutrivano. La descrizione di Carmen de Patagones di Boggiani e quella riportata da Magris (immagino tratta dalla biografia di suor Angela scritta da Miela Fagiolo D’Attili [6]) hanno rimandi e affinità che sorprendono. Le storie di Boggiani e Angela sono accomunate da un episodio. Il giovane artista aveva provato a portare con sé nella seconda parte del suo viaggio [7] un ragazzino chamacoco; aveva sedici anni e sapeva qualche parola di spagnolo. Dal diario non traspare se le sue intenzioni fossero quelle di portarlo in Italia. É un dato prezioso leggere del viaggio della giovane, indigena ona a cui era stato dato il nome di Luisa Peña e che “ripulita, rivestita, curiosa e diffidente” (p. 98), incontra Don Bosco in un breve viaggio di ritorno fatto con Suor Angela. Sono storie che si rincorrono quelle di giovani e giovanissimi indigeni che da queste terre arrivano in Italia [8]. Per compiere una morte serena o per essere esposti come trofei della barbarie.
Se tutto in Angela è “concreto, tangibile, netto”, questo libro lascia aperti spazi di riflessione: sulla maniera di raccontare, testimoniare e fare conoscere anche ad un pubblico più vasto la storia di queste terre, dei suoi indigeni, dei missionari e dei tanti avventurieri.
Note
[1] CLIFFORD GEERTZ, Interpretazioni di culture, Bologna, Il Mulino, Bologna, 1987.
[2] ADRIÁN N. BRAVI, L’idioma di Casilda Moreira, Roma, Èxórama, 2019. Si tratta della popolazione günün a küna il cui ultimo rappresentante fu intervistato da Rodolfo Casamiquela nel 1960.
[3] CLIFFORD GEERTZ, Opere e vite. L’antropologo come autore, Bologna, Il Mulino, 1988, p.25.
[4] FRANÇOIS LEPOT, El Rey de Araucanía y Patagonia, Buenos Aires, Corregidor, 1995.
[5] GUIDO BOGGIANI, Un artista en la América meridional. Diario de los viajes por Argentina, Paraguay y Brasil (1887-1892) a cura di F. Bossert, Z. A. Franceschi, J. A. Braunstein, Buenos Aires, Rumbo Sur.
[6] MIELA FAGIOLO D’ATTILIA, Angela della Terra del Fuoco. Pioniera delle missioni salesiane, Torino, Edizioni Paolini, 2002.
[7] La prima parte del viaggio fu da Buenos Aires a Carmen de Patagones nell’estremo sud della provincia di Buenos Aires fino ad arrivare a Choele Choel. Nella seconda parte del viaggio Boggiani ripartì da Buenos Aires risalendo il fiume Paraná e giunse ad Asunción del Paraguay per poi arrivare a Puerto Casado e raggiungere l’alto Paraguay.
[8] Cfr. il saggio di ISABELLE COMBÈS che descrive il viaggio a Torino di Doroteo Giannechini del Colegio de Propaganda Fide de Tarija (Bolivia) con tre giovani chriguanos per la Exposición de arte sacra, de las misiones y de las obras católicas» (Turín, 1898), in Boletín Americanista, año lxx, 2, n.o 81, Barcelona, 2020, pp. 135-153.
di Luciano Giannelli & Uršula Lipovec Čebron
La recente opera di Claudio Magris, Croce del Sud si segnala certamente per il pregio di parlare di cose di cui nessuno parla. A cominciare dalla persecuzione dei mapuche (ben richiamata alle pp. 68-69), ad oggi ininterrotta, salvo la troppo breve pausa durante il governo Allende.
Comunque, mapuche e altri, popoli nativi diversi del Cono Sud – che invero non son loro i protagonisti di un libro dedicato a personaggi europei, sloveni, francesi, italiani –si vedono poco o poco chiaramente. Sono uno sfondo un po’ sbiadito, tanto i mapuche nelle due prime parti che – ancor di più – i concretamente evanescenti alakaluf e siona nella terza parte. Per competenza, ci concentreremo comunque sulla prima parte, dedicata alla vicenda singolare di Juan (o Ivan, Janez, Janko) Benigar, nella zona argentina pedemontana di Aluminé, ben nota ad ambedue [1].
Certamente Croce del Sud è un testo di letteratura e non di saggistica; ma leggendo dei mapuche d’Argentina si pone subito una domanda: quali sono le fonti di Magris? Forse – e fino a che punto – Benigar stesso? O piuttosto, in forma sommaria, fonti di seconda mano come Irene Mislej [2] e Iliana Lascaray [3], che sono state tra le prime a ricercare il patrimonio intellettuale di Benigar? Ci sono comunque cose che stupiscono un po’. Stupirebbero – offenderebbero? – un mapuche, geloso della sua cultura e sospettoso, com’è normale tra i popoli indigeni americani.
“Vivrà molto tempo nei wigwam, le tende del popolo indio divenuto anche il suo” (pp.10-11); ora, cos’è il popolo indio, tanto più per quello che segue? II termine wigwam, in sé, è di provenienza remota, algonchina (oggi USA, Canadà). L’impiego finisce poi per esser meno sorprendente se si tien conto del fatto che un uso diciamo ‘ampio’ del termine, estensivo e generico è presente (così almeno Wikipedia, s.v. [4]); o che comunque Magris non è solo in questa confusione. Non conta tanto quindi che per la fine XIX secolo, il Museum für Völkerkunde di Amburgo serbi le foto di toldos (“Toldos in der Pampa Argentiniens”, recita la didascalia), a p. 34 di Helmut Schindler, Bauern und Reiterkrieger, Hirmer, Monaco di Baviera, 1990, dedicato ai mapuche, con molte altre foto di quelle che definiremmo capanne (pp.12-13, 16, 27, in questa in disegno) certamente nella forma non troppo dissimili – la Schilfhaus di p. 154, che comunque non è una tenda – dai wigwam algonchini, spesso appunto a cupola come questi, se non case – p. 16 – e ancora capanne in cartoline serbate alla Biblioteca dei Cappuccini di Monaco di Baviera (p. 51), p. 55 foto del Museum für Völkerkunde di Friburgo 95-96, queste più che probabilmente moderne, ma ancora palizzate (pp.158-9) e case di legno e capanne e vie di mezzo come a p. 163, case (così definite, Haus) del 1983 a p. 160 non più miserabili dei ranchos paraguaiani; l’uso di tende (i toldos di cui sopra) è di natura provvisoria, eccezionale, episodicamente strumentale. Certo che sull’asse sintagmatico tenda e indigeno americano (prototipicamente sioux?) tendono a cooccorrere.
Colpisce poi l’incrocio “boschi e rocce delle montagne” a p. 19, con quanto scritto a p. 11: “insegnare agli Indios una agricoltura razionale” (il soggetto è Benigar, che non avrebbe condiviso – per come lo si conosce – questa presupposizione di una locale agricoltura irrazionale; ma poniamo si parli solo di migliorie tecniche, sempre possibili); lasciando da parte questa sensazione – forse ingenerosa – di eurocentrismo, quello che vogliamo dire è che non può esser chiaro al lettore di che cosa si parli in relazione ai mapuche, e ai loro territori e attività. Certamente comunità mapuche, almeno in Argentina, si sono anche ritirate, di fronte all’avanzata della guerra del deserto che Magris opportunamente evoca, sui monti e nei boschi – dove per altro comunità pewenche ‘cilene’ sono anche sempre state – ma i mapuche moderni sono essenzialmente gente di collina e di campagna.
Sul piano storico (e etnografico), si fa notare a p. 25 “i Mapuche, gli Araucani, avevano vinto nella terra del Sud, i Tehuelches, i Patagoni”. Cos’è la Terra del Sud? Dove i cosiddetti tehuelche avevano penetrato il territorio oggi cileno? Ma i tehuelche (nome mapuche non chiaro) non sappiamo bene chi sono o fossero, gli aonek’enk o termini analoghi, o i teushe, o altri ancora, comunque a est, confusi con quei mapuche o mapuchizzati che sono i puelche, la gente dell’est. La confusione su questi popoli è tanta, come attesta lo stesso Consejo Nacional de Investigaciones Culturales y Técnicas argentino, incluso il vecchio nome di patagoni, invenzione europea [5]; non a sud si svolsero comunque i conflitti maggiori, fino infine alla mescolanza (tehuelche che si spacciano per mapuche e comunità mapuche-tehuelche) [6]. Del resto torna frequentemente l’approssimazione: a p. 16 si parla di Patagonia e Araucania, termini spesso qui confusi (e passi “terre patagone e/o araucane” che s’intenderà appunto in senso dinamico).
Sul piano poi più strettamente antropologico-etnologico, quando a p. 28 si definisce la machi come una sciamana, così come si fa in tanti dizionari e repertori, si avverte il bisogno di un’idea chiara (che non pretendiamo fornisca Claudio Magris) di cos’è uno sciamano, improbabilmente designato con una parola che ha migrato tanto ma è d’origine sanscrita. Riguardo al pantheon mapuche si fa riferimento (p. 29) a “ordinate gerarchie degli dèi araucani”, come (p. 33) di “scala gerarchica di mondi sottili” ed ancora “Dei benevoli e maligni”, tutti assetti non riconoscibili nella teologia mapuche. E infine, quando si legge a p. 25 “Il canto Tayil si presenta come un canto della natura stessa; degli uomini, del giaguaro, della pietra, dell’ossidiana” sembra si confonda la realtà mapuche con quella ben lontana della Mesoamerica (il giaguaro, l’ossidiana, localmente non presenti).
A p. 35 il mapuzugun (leggasi [mapuθu’nuŋ]; comunemente detto mapuche, secondo un malvezzo statunitense) viene definito “lingua agglutinante che aggiunge alcune parti alle singole parole unendone una a un’altra e unendo altresì diverse proposizioni in una sola.” Il mapuzugun è – come tante lingue amerindiane – incorporante, incorpora l’oggetto e non solo [7] – ma ci sono studi che fanno vedere come questo carattere sia greco classico, tedesco, inglese – babysitter, babysitting – e anche italiano a modo suo, ben oltre formazioni come pescivendolo, fruttivendolo [8]. Per altro, non esistono lingue che uniscano in una parola più proposizioni, poniamo pure volessero essere frasi (Wortsatz); ma pare che si parli di lingue (nordamericane) di ben diversa configurazione. Ancora, “Le parole assumono significati elastici” (ib.), succede per alcune in tutte le lingue si pensi a carta in italiano, ma sono facili qui i controesempi: si prenda mawiza, che indica un bosco collocato su una pendice, con una precisione tale che non si traduce in italiano, ché ‘pendice boscata’ (che è però un sintagma) non rende il senso. Può venire malignamente il sospetto che la fonte sia non negli scritti linguistici di Benigar ma forse in un libro ben diffuso che l’autore potrebbe magari avere in libreria, vale a dire Franz Boas, Introduzione alle lingue d’America, Bollati Boringhieri, Torino 1979, a cura di Giorgio Raimondo Cardona, in realtà introduzione al primo numero dell’International Journal of American Linguistics.
Va rilevato d’altro canto che le imprecisioni biografiche – e non solo – su Benigar sono molte: dal collocarlo come operante a Lubiana (pp. 12, 20, 53), dove in realtà non ha mai vissuto; dall’errore sulla data del suo matrimonio, posta al 1932 (p.10) mentre esso è avvenuto nel 1939. Di più, a p. 25 Benigar – sulla base invero di una poesia di Octavio Prenz [9] – è indicato come capo di una tribù (il termine tribu è di Prenz, per fortuna): esistono i logko ([‘loŋko]) dei lof, ma Benigar non è mai stato qualcosa del genere né comunque un ‘capo’, magari sovraordinato. Infine, per gli scritti di Benigar, indicati come “quasi sempre in spagnolo” (p.10), e invece scritti in molte lingue (come la sua grammatica bulgara che però è scritta non in sloveno – pp.11-12 – ma in serbo-croato, appunto Bulgarska slovnica sa čitankom) e indicati come fatti confluire a Lubiana, il che non è avvenuto. Ma soprattutto colpisce la contraddizione tra la definizione incomprensibilmente sminuente dei saggi antropologici di Benigar (“Più che saggi, compiti scolastici, temi di liceo”, p. 29) e l’asserzione di p. 50 “le sue osservazioni dimostrano una vasta conoscenza delle teorie antropologiche”.
Considerando e scontando il fatto che tanto ci saremo ormai resi assolutamente antipatici, tanto da non poter far crescere ulteriormente il biasimo, ci permettiamo di insistere in ‘pignolerie’, fino al fastidio – segnatamente della coautrice – per il mancato rispetto dell’ortografia slovena [10]. A parte poi sbavature nella grafia di toponimi spagnolo-mapuche [11], su un piano di contenuto, a p. 27 il Diccionario de la lengua araucana si definisce “il suo [di Benigar] capolavoro […] dizionario sloveno-spagnolo-araucano”, mentre l’opera non fa affatto riferimento allo sloveno.
Ci fermiamo e – in conclusione – torniamo a riconoscere a Claudio Magris il merito di aver prodotto un libro che rappresenta un mondo spesso dimenticato; di aver messo in campo personaggi notevoli dei quali di solito non si parla, di aver sottolineato le ingiustizie perpetrate ai danni anche di questi popoli. Spiace però, anche in considerazione della levatura dell’autore, che si debba qui cogliere un approccio di una qualche sufficienza e di notevole e non lodevole approssimazione. Non ci piacciono i piagnistei e i vittimismi, ma crediamo che il germanista Magris avrebbe avuto un approccio più attento su altre culture e situazioni.
Note
[1] La coautrice, docente presso l’Università di Lubiana (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska Fakulteta), ha trascorso tra il 2003 e il 2005 alcuni mesi nella città di Neuquén, dove ha ricercato il patrimonio intellettuale di Benigar e ha rivisto la sua collezione dei testi inediti. Nello stesso periodo ha fatto ricerche di antropologia medica in Aluminé e Ruca Choroi, dove ha potuto intervistare alcuni membri della famiglia di Benigar e visitare il luogo dove questi ha vissuto fino alla sua morte. Si cfr. Uršula Lipovec Čebron, Juan Ivan (Janko Benigar, Janez Benigar), in Barbara Šterbenc Svetina (a c. di), Novi Slovenski biografski leksikon, Lubiana, Založba ZRC, 2017: 273-276. Il coautore, già docente di Linguistica all’Università degli Studi di Siena, dopo precedenti esperienze tra i mapuche cileni (cfr. ad es. Luciano Giannelli e altri, “Sulla lingua dei mapuche. Un’indagine sociolinguistica”, Thule 12/13, 2002: 255-295; Luciano Giannelli, “Percezione mapuche del bosque austral”, Quaderni di Thule 8, 2008: 415-420) ha svolto indagine sociolinguistica in varie comunità mapuche d’Argentina, cfr. Luciano Giannelli, Massimiliano Canuti e Alex H. Vallega, “Un ensayo de investigación entre los mapuche de la Argentina”, Anclajes 8.8, 2004: 21-78.
[2] Storica dell’arte e pubblicista di origine slovena, nata e vissuta per la prima parte della sua vita in Argentina, poi tornata in Slovenia e per lunghi anni direttrice della galleria d’arte Veno Pilon (Ajdovščina). Ha pubblicato una collezione di testi di Benigar tradotti in sloveno già nel 1988; è stata sicuramente una delle prime persone a scrivere di Benigar in lingua slovena. Cfr. Irene Mislej. Janez Benigar: zbrano gradivo. Lubiana, Znanstveni Inštitut Filozofske Fakultete, 1988.
[3] Argentina, antropologa (benché a Neuquén spesso definita storica) e giornalista/pubblicista (viene indicata anche come scrittrice), ha lavorato alla Dirección Provincial de Educación y Cultura del Neuquén, è stata direttrice del Museo Regional Daniel Gatica; viene indicata nelle varie bibliografie anche come direttrice dell’Archivo Histórico Provincial a Neuquén, ma probabilmente è stata soprattutto direttrice del menzionato museo. Cfr. Iliana Lascaray, “Presentación de los trabajos de Juan Benigar”, La Patagonia piensa, 1978: 115–117. Dopo la morte di Benigar, Iliana Lascaray ha trasportato nel Museo Daniel Gatica i testi inediti di Benigar, dove li aveva conservati per molti anni (senza pubblicarli o, che si sappia, analizzarli) finché i membri della famiglia di Benigar si sono ripresi il suo patrimonio intellettuale.
[4] “L’uso di questi termine [wigwam] da parte dei non Nativi americani è in qualche misura arbitrario e può riferirsi a molti tipi distinti di strutture dei Nativi americani, indipendentemente dalla localizzazione o dal gruppo culturale”.
[5] Antonio Pigafetta riporta in “Navegação e descobrimento da India Superior”, in Neves Águas (a c. di), Fernão de Magalhães. A primeira viagem á volta do mundo contada pelos que nela participaram, Estudos e documentos 224, Publicações Europa-América, Mem Martins, Sintra 1986, pp. 27-131: “O nosso capitão chamou a este povo Patagões”: 42
[6] Cfr. Antonio Álvarez, Crónica de la Patagonia y tierras australes desde el descubrimiento hasta la colonización, Zagier y Urruty, Ushuaia 2000 e Ana Fernández Garay, El tehuelche. Una lengua en vías de extinción, Universidad Austral de Chile, Valdivia 1990.
[7] Cfr. Adalberto Salas, El mapuche o araucano, Madrid, Collecciones Mapfre 1492, 1992; Bryan Harmelink, Manual de aprendizaje del idioma mapuche, Temuco, Edicciones Universidad de la Frontera, s.d., Arturo Hernández Sallés e altri, Gramática básica de la lengua mapuche, Editorial UC, Temuco,2006.
[8] Cfr. André Martinet, Sintassi generale, Laterza, Roma-Bari 1988; Janusz Stopyra, Inkorporation in der deutschen Worbildung, Verlag Dr. Kovač, Amburgo 2019; Iørn Korzen L’articolo italiano fra concetto e entità, Museum Tusculanums Forlag, Copenhagen 1996.
[9] Juan Octavio Prenz (1932-2019) poeta, scrittore, traduttore e critico letterario, nato in Argentina da una famiglia di origini istriane e poi vissuto a Trieste fino alla sua recente scomparsa. Tra le sue opere sono tradotte in italiano La favola di Innocenzo Onesto, il decapitato, Marsilio, Venezia 2001, Antologia poetica, Hammerle, Trieste 2006; Il signor Kreck, Diabasis, Parma 2014; e per La nave di Teseo, Milano, Solo gli alberi hanno radici (2017) e Figure di prua (2019).
[10] Sulcic invece di Sulčič, Ruza Jelasic-Benigar per Ruža Jelašić-Benigar.
[11] Fino al sospetto che a p. 20 si confonda Poi Pucón, località di Aluminè, con il vulcano Pucón, in “poi Pucon”.
 Nota di lettura di Croce del Sud
Nota di lettura di Croce del Sud
di Ernestina Pellegrini
Croce del Sud, uscito nel settembre del 2020 è un libro non inquadrabile in un genere ben definito. Sono molto curiosa di conoscere cosa ne pensano i due antropologi e lo studioso di linguistica, con cui noi comparatisti dialogheremo, perché in questo testo si affrontano questioni di loro pertinenza. È un libro composito, prismatico, non esauribile in un ambito letterario, anzi le molteplici e diverse dimensioni costitutive, i diversi tasselli del mosaico (delle tappe biografiche dei tre protagonisti, del quadro storico, degli affondi antropologici, delle notazioni linguistiche e vocabolaristiche, della esibizione delle fonti storiche e bibliografiche etc.) si illuminano reciprocamente, creando in qualche modo degli effetti di frattura all’interno del tessuto narrativo. Sono come le frecce in certi quadri di Pau Klee, portano fuori dal recinto del puro racconto. A questo riguardo ho una mia ipotesi: che Magris con Croce del Sud abbia voluto fare una specie di auto-da-fè letterario. Come ha ripetuto nelle tante interviste radiofoniche o giornalistiche, citando Marck Twain: “«Truth is stranger than fiction», cioè “la verità, la realtà è più bizzarra della finzione”, è più creativa. Il sottotitolo, Tre vite vere e improbabili, è una spia. Infatti, cosa fa lo scrittore? Impedisce ai tre protagonisti di diventare personaggi letterari, li priva di ogni seduzione illusionistica. C’è un libro intramontabile di Arrigo Stara, L’avventura del personaggio, dove a un certo punto si dice che il personaggio letterario è un cuneo tra l’esistenza e l’inesistenza [1].
Continuo a chiedermi: che cosa è questo libro? Non è una risposta facile. In maniera sbrigativa si potrebbe dire che Magris in Croce del Sud ha scritto tre biografie bizzarre di eccentrici migranti, sulla scia (per la figura di Benigar) di Enrico Mreule, il protagonista di Un altro mare, fuggito in Patagonia, o (per la figura di Orélie Antoine) sulla scia dell’avventuriero settecentesco Jorge Jorgersen di Alla cieca, che si proclama re d’Islanda e poi finisce ai lavori forzati in Tasmania. Voglio dire che questo libro, che sembra un frutto anomalo nella produzione dell’autore, ha degli antecedenti, ha una genealogia interna. Per esempio vedrei la prima pietra miliare di un interesse di Magris per queste figure transnazionali in un suo studio del 1965 sulle Robinsonaden [2], cioè quelle imitazioni del romanzo di Daniel Defoe, iniziate sin dal 1719 e mai cessate, fino alle riscritture novecentesche.
Con Croce del Sud, Magris ha voluto mettere in scena tre «vite vere e improbabili» – quella del Gringo sloveno, criollo auracano Janez Benigar; quella del Re di Auracania e Patagonia, Orélie-Antoine che si autoproclama re di un regno che non c’è; e infine, nel terzo capitolo, intitolato Suore e pinguini, la storia di suor Angela Vallese, una temeraria e spavalda missionaria salesiana nella Terra del Fuoco – alludendo a una possibile filiazione diretta della sua scrittura da certi romanzi di avventure di Salgari, di Melville e di Stevenson, rimandando qua e là anche alla tradizione dei viaggi veri e immaginari in quei luoghi situati ben oltre le Colonne d’Ercole, in zone che appartengono all’inumano o al pre-umano, citando opere che vanno dal Gordon Pym di Poe a La sfinge dei ghiacci di Verne, per arrivare a Montagne della follia di Lovecraft, al Nowhere is a Place di Chatwin, fino al capolavoro “terminale” di Daniele Del Giudice, Orizzonte mobile. L’autore si serve anche di tanta letteratura secondaria, di fonti storiche minuziosamente consultate in archivi di mezzo mondo che vengono sul testo sistematicamente esibite.
Cosa voglio dire? Che Croce del Sud è anche un libro di libri nonché il regesto di una ricerca, ed ha al suo interno una trama saggistica, fitta di rimandi letterari, storici, archivistici, bibliografici, rimandi che si mescolano e interrompono il flusso narrativo. Credo che questo procedimento antinarrativo sia voluto, sia strategico. Il bagaglio erudito e quello della ricerca storica non viene relegato nel retrobottega. Magris qui non allontana la res ruvida ed extraletteraria delle fonti archivistiche e bibliografiche trovate e utilizzate, anzi le esibisce. Le porta in primo piano. Così come aveva fatto in Polene, che a tratti sembra assumere la forma di un trattato di marineria. Voglio dire che l’autore fa di tutto per evitare l’effetto iperletterario del romanzesco.
In occasione del Festivaletteratura2020 di Mantova, l’11 settembre, intervistato in streaming da Alberto Rollo, Magris ha presentato il nuovo libro dichiarando: «mi affascinano le storie vere che fanno concorrenza alla letteratura. In questo libro non c’è niente di inventato». Le lunghe ricerche bibliografiche e d’archivio, che vengono ampiamente documentate nel testo, si insediano strategicamente come scogli in una scrittura che, come Alberto Rollo osserva nella medesima occasione, «vuole andare all’origine delle origini o alla fine di tutte le fini». Come dire, che il racconto tenta di toccare le nude ossa di tutto ciò che vive, facendo percepire comunque il lato esaltante, biologicamente ed eticamente forte, il fascino irriducibile dell’avventura umana. Forse è questo il vero nucleo del libro, una interrogazione quasi metafisica sull’“origine delle origini e sulla fine di tutte le fini”, una interrogazione metafisica implicita nel quadro storico amplissimo cha fa da sfondo in maniera per certi versi anacronistica alle vicende dei tre protagonisti, un mosaico di geografie e tempi lontani fra loro, dove si affastellano, in una logica di contiguità e non di linearità cronologica, tante vicende storiche, tanti eccidi, tante violenze delle dittature latinoamericane, dei Conquistadores spagnoli, delle rivolte degli indios e delle loro repressioni, e anche le vicende tragiche dei contadini, degli operai e dei desaparecidos.
Lo scrittore aveva bisogno di queste storie di tre sradicati in tempi e con motivazioni diverse per mettere in scena quelle che, con una bella immagine, Furio Colombo su “Il Fatto Quotidiano” del 28 settembre ha definito le sue “fiabe migranti”, parlando anche con efficacia, di “un linguaggio di poesia senza pace” che arriva sulla pagina come lo sbattere delle onde. Io aggiungerei un’altra osservazione, e direi che non ritroviamo più lo stile o gli stili avvolgenti e labirintici tipici della grande narrazione romanzesca di Magris, da Alla cieca a Non luogo a procedere, qui lo stile è secco, paratattico e asciutto, è uno stile non firmato. Quasi da resoconto etnografico. È come se lo stile venisse regolato da più sottili mosse di nascondimento autoriale. Lo scrittore evita qualsiasi forma di intensificazione espressiva, così come parallelamente preferisce la laconicità nelle descrizioni paesaggistiche che – vista la particolarità e la bellezza dei luoghi – sarebbero potute essere invece strabilianti. Sceglie una corda anti-figurativa, sceglie il “sottinteso” come tratto costitutivo del testo, per abbassare ai minimi termini la temperatura letteraria. Magris ha inserito le sue figure vere in un bassorilievo, o se volete, in un retablo senza firma (anche se ci sono qua e là, piccoli gong autobiografici. Magris fa come Alfred Hitchcock che si intravede come fuggevole comparsa nei suoi film) [3].
Se nelle sue precedenti “biografie imperfette”, lo scrittore si metteva nella pelle del personaggio e gli prestava i propri stati d’animo (fino a soluzioni monologanti, come ne Il Conde, il pescatore di cadaveri o coabitava nella mente surriscaldata dell’irriducibile compagno comunista Salvatore Cippico di Alla cieca), qui evita qualsiasi psicologismo, ritrae i suoi personaggi dal di fuori, li circoscrive semmai nella dimensione del “cuore semplice” flaubertiano, e preferisce tentare un perfetto deficit di soggettività.
Siamo radicalmente agli antipodi di un romanzo come Alla cieca, dove il delirio di Salvatore Cippico diventa stilisticamente una tromba d’aria che tira su tutto: il crollo del Comunismo, i campi di concentramento nazisti, il lager titino di Goli Otok, le prigioni dei forzati della Tasmania, la cella dell’ospedale psichiatrico triestino in cui l’uomo, che crede di essere il clone di un avventuriero settecentesco, è rinchiuso. In Croce del Sud è abolito qualsiasi psicologismo, e si descrive, si rappresenta un mondo dominato dal pathos della concretezza e dalla sensualità, una maniera narrativa evidente anche in certi testi patagonici di Chatwin o del poeta Dino Campana. Probabilmente perché qui, in Croce del Sud, le vicende raccontate avvengono in un quadro antropologico nel quale la fisicità prevale sulla psicologia. C’è anche un’altra cosa che mi preme sottolineare, che Suor Angela, scambiata dagli Ona per un pinguino per i suoi abiti di color bianco e nero, viene descritta soltanto in relazione a un archetipo sacro, un po’ come avveniva ne I Malavoglia di Verga, dove Bastianazzo, per esempio, è grande e grosso quanto il San Cristoforo della città; o come avveniva nel film di Bunuel Los Olvidados, dove il bambino morto viene portato a una discarica su un asino da un uomo e una donna che ricordano Giuseppe e Maria di Nazareth. Così Orélie Antoine entra anche lui trionfante a cavallo di un asino, perché – come scrive Magris – voleva entrare come Gesù a Gerusalemme.
In un’intervista, Magris ha detto: “Nel libro, appunto, non affronto temi, ma delle vicende”. Vicende e documenti d’archivio. E qui avrei potuto e voluto annoiarvi, elencando le tante fonti archivistiche, letterarie, bibliografiche, esibite all’interno dei singoli resoconti biografici. Ma non lo faccio. Sono tantissime. Sono lo scheletro documentario che mette la sordina alla fiction. Il libro dà l’impressione di essere un sistema patchwork, e potrebbe simulare – la butto lì – la struttura centrifuga e provvisoria del taccuino di un antropologo. Fra conquistadores, esploratori, scienziati, si delineano i destini di tre eccentrici avventurieri, mossi da ragioni e utopie molto diverse ma comunque generose, e insieme a loro si muovono in tempi anche lontani tante figure secondarie altrettanto interessanti. Sono storie dentro la storia, sono embrioni di altre possibili biografie. Struttura a patchwork, dunque, e fertili anacronismi, con momenti storici lontani affiancati, storie dentro altre storie, per mettere insieme una narrazione che si autonega e che, in quel suo autonegarsi, raggiunge vertici di poesia. Trovo, a questo proposito, una indicazione metaletteraria all’interno del testo, dove Magris parlando di Poe parla di sé:
«Pym muore – forse nella cateratta del Polo Sud – racconta dieci anni più tardi la sua morte e muore mentre la sta narrando. Il genio di Poe fa sentire come una verità epica la stessa negazione del racconto. Penelope narra, nella tela che lei stessa disfa, la storia del suo tessere e del suo disfare» (Croce del Sud: 112-113)
Ci voleva uno spazio come questo «laggiù assoluto» di Croce del Sud, perché Magris mescolasse tutte le sue scritture – narrativa, saggistica, teatrale – fondendole in un timbro quasi asettico, asciutto, da resoconto etnologico, cogliendo con un colpo d’occhio le mirabilia del mondo, restituendole in una catena di istantanee, che sembrano sposare il succo desolato eppur magnetico dei Tristi tropici di Lévi-Strauss: «la follia, l’inganno dei racconti di viaggio… danno l’illusione di cose che non esistono più e che dovrebbero esistere ancora per farci sfuggire alla desolante certezza che ventimila anni di storia sono andati perduti» [4].
Probabilmente ci sono tanti errori storici e antropologici in Croce del Sud, e in questo caso rivendico la libertà del linguaggio letterario. Sembra quasi che lo scrittore intenda così legittimare la sua scrittura nata al confine fra storia e letteratura, ricordando l’assunto dell’antropologo Rodolfo Casamiquela, arrivato ad Aluminé nel 1993, secondo il quale «solo un “letterato”, una “penna di qualità”, attenta più alla fantasia che alla scienza» avrebbe potuto raccontare la vita del gaucho sloveno (Croce del Sud: 27)
Il libro ha una struttura ascensionale. C’è la impresa pragmatica dell’ingegnere Benigar che studia la cultura degli Indios e scava canali; c’è la follia di Orélie Antoine che si proclama re di un regno che non c’è e scrive una Costituzione quasi dadaista; c’è Suor Angela Vallese che si prende cura degli indios, conservando fino all’ultimo “l’incanto dell’infanzia e lo stupore delle cose” (Croce del Sud: 120), una suora di strada che non è stata chiamata ad essere “Santa Teresa d’Avila o Simone Weil”, ma “non per questo è una loro sorella minore” (Croce del Sud: 121).
La terza pala del retablo è forse la più bella, perché è anche un dialogo a distanza con l’amico Daniele Del Giudice e interagisce col suo ultimo libro Orizzonte mobile, che è il taccuino struggente di un viaggio terminale all’Antartide, un viaggio fatto subito prima che l’Alzheimer lo inghiottisse per sempre nel suo vuoto. C’è come una dolente pietas che avvolge uomini, animali, piante. Come nell’episodio del pinguino che “aveva perso l’uovo che doveva covare, se ne vergognava e se ne era fatto uno finto, di ghiaccio” (Croce del Sud: 90). È nel capitolo finale che la corda paesaggistica – la Terra del Fuoco, l’Antartide – prende più campo, se pur rimanendo ai minimi termini
Credo che il libro di Daniele Del Giudice, più volte citato, sia la chiave per capire l’orizzonte – come chiamarlo? – iperuranico di questo paesaggio che allude a un viaggio fuori dal tempo – il tema del tempo è uno dei più forti del libro (come lo era in Tempo curvo a Krems del 2019): tempo umano, tempo ciclico e tempo cosmico, che è anche tempo geologico, tempo curvo e tempo congelato in quella terra dove tutti i meridiani si incontrano – un viaggio dentro e fuori del tempo che è anche un viaggio dentro un paesaggio ipnotico e indifferente all’uomo, un paesaggio di sublime bellezza. Davanti agli occhi, resta un orizzonte di ghiaccio e luce, non delimitabile, cedevole come un risucchio nel suo mistero. Come recita la notizia editoriale di Orizzonte mobile, nel catalogo Einaudi, “sono luoghi, storie, giorni, anni, ere geologiche che resistono alla prospettiva lineare del semplice raccontare. Una millenaria geometria naturale che ogni cosa stratifica, ogni memoria cristallizza”.
Allora, mi sembra di capire perché Magris abbia scelto per il suo libro la forma dell’auto.-da-fé letterario che è una sfida al mercato editoriale, una sfida al lettore, una sfida al suo stesso modo di narrare. Perché il succo, il nucleo primario e profondo del libro sta nell’implicito (“questo libro ha un’energia implicita, per arrivare non solo alla testa, ma al cuore e alla fantasia di chi legge” – ha detto Magris o Rollo al Festivaletteratura di Mantova – “questo è un piccolo teatro di figure che ci raccontano un altro modo di sentire la vita, la follia, il fare”).
Come è segnalato infine nel risvolto di copertina, Croce del Sud sembra confermare un vecchio giudizio di Daniele Del Giudice: «Le tue figure mitteleuropee diventano, quando le racconti, personaggi da romanzo sudamericano».
Note
[1] A. STARA, L’avventura del personaggio, Le Monnier, Firenze 2004.
[2] C. MAGRIS, Le Robinsonaden fra la narrativa barocca e il romanzo borghese, in Studi in onore di Leonello Vincenti. Arti e Storia, Giappichelli editori, Torino 1965: 235-284.
[3] Si fa solo un esempio: “Al canto dell’orrore, ermetico e monotonamente ripetuto, Angela sembra rispondere col Veni Creator Spiritus, il più universale dei canti, come mi ripeteva spesso, quando ero poco più di un ragazzo, Biagio Marin, che ricordandolo aveva le lacrime agli occhi” (Croce del Sud: 95).
[4] C. Lévi-Strauss, Tristi tropici, tr. it. di B. Garufi, il Saggiatore, Milano 2015: 36.
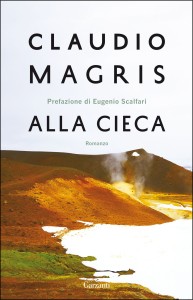 Spazi di luce rappresa: Croce del Sud di Claudio Magris
Spazi di luce rappresa: Croce del Sud di Claudio Magris
di Diego Salvadori
«Cielo e terra dicono qualcosa». Basterebbe l’attacco del pascoliano Imbrunire a rivelare l’essenza di Croce del sud, l’ultimo libro di Claudio Magris. Un libro agli estremi del mondo, nel Sud australe, sotto la volta di un firmamento che sin dal titolo è pronto a stagliarsi su uno spazio ultrafisico, inafferrabile, lacerante. Su un emisfero appiattito e del nulla in cui queste Tre vite vere e improbabili hanno ragione di esistere senza mai incontrarsi: vite ‘parallele’ – nel senso plutarchiano del termine – in un atlante che si rapprende e si disfa. Vite finali. Vite al confine, unite e separate al contempo, in una geografia ch’è limite estremo e purtuttavia refrattaria al concetto stesso di limite, che si risolve in topografia prosciugata e per certi aspetti compressa: il «macrocosmo argentino» e la Patagonia dell’etnologo Janez Benigar; lo spazio surreale dell’avvocato francese Orélie-Antoine de Tounens, che nel 1860 sbarca a Valparaíso e si proclama, il 17 novembre dello stesso anno, sovrano del Regno di Araucanía e di Patagonia; la Terra del Fuoco e la vicina Antartide in cui Angela Vallese, «la sartina di Lu Monferrato», avrà modo di dedicare la sua vita agli indigeni.
Innegabili i rimandi a geografie preesistenti, secondo una linea intratestuale che guarda alle pagine di Un altro mare, Alla cieca o Il grande Sud de L’infinito viaggiare, le cui battute finali pronosticavano il ritorno all’emisfero australe e parimenti il raggiungimento del vuoto antartico. Un viaggio, allora, alla fine del mondo, quasi un ‘finito’ viaggiare, in cui personaggi richiamano in tralice altri protagonisti delle opere magrisiane, a cominciare dall’Enrico Mreule di Un altro mare, che il 28 novembre 1909 lasciava Trieste per l’Argentina e, al pari di Benigar, attraversava la Patagonia e la Pampa. In Croce del sud, vuoi anche per la scrittura squisitamente citazionale, il luogo si fa palinsesto ed esibisce la sua densità narrativa attraverso quelle esistenze che, in un certo qual modo, vi si sono sedimentate al loro passaggio. Balugina, allora, il Campana dei Canti Orfici, giunto in Argentina un anno prima di Benigar (nel 1907) «per sfuggire al manicomio di Imola», al che la Pampa si fa «Canto orfico», spazio assente nella sua sconfinata presenza, «la cui piatta vastità in cui non ci si può orientare» – prosegue Magris – «è il vuoto della vita stessa»: quel vuoto cui sembra tendere lo stesso Croce del sud, nel suo strutturarsi a voragine, in un vortice immobile, verso l’immobile ghiaccio delle pagine terminali. Eppure Benigar – quasi ‘cerniera’ tra Campana e Mreule – resiste al «fascino neghittoso» delle steppose pianure sudamericane, alle solitudini «che hanno qualcosa d’indistinto, di sempre uguale»; per quanto tra l’etnologo sloveno e il protagonista di Un altro mare sussista tuttavia un’irriducibile osmosi, da Magris testificata a più riprese nel corso del libro. Quella di Benigar, insomma, è un’Argentina narrata e vissuta da altri. Un’esistenza, la sua, «fatta di rovesci», e che tuttavia finisce per fare del luogo, dell’Araucanía che lui studia da linguista, un suo autoritratto, uno «specchio del suo volto». C’è insomma un’ineludibile specularità tra i personaggi della scrittura magrisiana e lo spazio fisico agito da essi in quelle che sono le trame della scrittura, motivo per cui Croce del sud, proprio per il suo situarsi a valle del macrotesto, struttura tutta una serie di richiami con altri soggetti della produzione narrativa dell’autore. Se Janez Benigar e Enrico Mreule condividevano una topografia specifica (la Patagonia), l’avvocato Orélie-Antoine de Tounens non può non richiamarsi alle geografie plastiche, immaginarie e duttili dell’Ataman Peter Krasnov, protagonista a latere di Illazioni su una sciabola e ideatore di quella Carnia cosacca: entrambi hanno a che fare con uno spazio surreale e che non esiste, vertebrato sulla partitura del Nulla.
La narrazione, topograficamente parlando, tende a sprofondare, quasi attirata dalla forza magnetica ed abissale del Polo: già Magris, a proposito di Orélie, non ha mancato di ravvisare il suo essere «spinto sempre più verso il Sud, [in] una terra gelata di iceberg, popolata da famose leggende», giacché il libro si «protende sempre più verso il sud australe [...] di estreme solitudini, di colori che sono il risultato di cataclismi». Già Furio Colombo, in un’acuta lettura del libro, ha avuto modo di insistere su come la ‘terza’ di queste vite vere e improbabili sancisca l’apertura di «un grande scenario», a riprova di come la scrittura sia innegabilmente attratta verso l’abisso antartico, dove il tempo «si ferma come l’orologio» (non più curvo, dunque) e la conoscenza si fa inevitabile catabasi. È il luogo dell’epicedio e del non ritorno, tratteggiato sulla scorta di un’intertestualità narrativa che dal Gordon Pym di Edgar Allan Poe, passa a La sfinge dei ghiacci o Il viaggio al centro della Terra di Jules Verne; dalle Montagne della follia di H.P Lovecraft a Orizzonte mobile di Daniele Del Giudice. E, proprio da Del Giudice, Magris mutua quelle «pagine che dicono la bellezza diafana del paesaggio, i colori iridescenti provocati dal passaggio di raggi solari nel cielo intriso di minuscoli cristalli gelati, la luce scolorita dell’alba che sembra non generare il giorno, le vampate delle aurore boreali». Ma a voler nuovamente guardare al Magris narratore, è innegabile come le pagine di Alla cieca, e nella fattispecie la sua geografia liquida e prensile, costituiscano un antecedente ai racconti antartici di Croce del sud, non fosse altro la reductio ad unum della polarità deittica (lassù e quaggiù) che nel romanzo del 2005 guardava rispettivamente ai due emisferi, boreale e australe. Con le pagine dedicate a Suor Angela, viceversa, Magris spinge l’atlante al suo estremo, ne sfrutta la metadiscorsività e parimenti lo fa convergere verso un unico punto, in uno spazio di luce rappresa che a tratti sembra pietrificare, perché «il Sud è laggiù, anche in un senso più profondo e terribile di quello che ci dicono l’atlante e il mappamondo», motivo per cui i ghiacci antartici esasperano quel Nulla già ravvisato a più altezze del libro: «un estremo», si legge, «di gelo e di nulla».
Va da sé che in questa continua discesa l’abisso si faccia totale, deflagri: c’è come un appiattirsi dell’emisfero, una reductio australe, che vede l’atlante emanciparsi dal polo opposto e rapprendersi in una topografia asettica, fonte muta, il vuoto assoluto. Cielo e terra dicono qualcosa perché Croce del sud, sin dal titolo, sigla questo gioco di rispondenze tra spazi estremi e assoluti, talvolta forieri di suggestioni fantastiche o apocalittiche, talaltra percorsi con piglio scientifico, in una mappa della dilatazione che si risolve in descrizioni asettiche, prosciugate, sulla scorta di un «regno dell’iperbole, in cui il bianco diventa albedo, gli anni diventano migliaia e migliaia di secoli». E tornano, allora, la Storia come sedimento, la dialettica sommerso/emerso da cui l’elsa di Krasnov si faceva ipostasi indiscussa, purtuttavia bloccate in una sospensione perpetua, laddove il ghiaccio rapprende e ingabbia, fossilizzando l’atlante, financo a renderlo illeggibile (o quasi). Abbiamo parlato di ‘fonti mute’ perché la scrittura, prosegue Magris guardando al Gordon Pym di Poe, diviene ora «ghiaccio che blocca e dunque conserva ma anche uccide le storie che racconta, arabeschi disegnati dal gelo sul vetro, incancellabili perché trasformati in morte».
Ma alla geografia muta del libro, pronta a volgere, sulla scorta di Melville, nel «regno del bianco, colore della morte e dell’inquietudine», potremmo affiancare quelli che sono gli spazi mitopoietici di Croce del sud, pronti a scandire ciascuna di queste tre vite vere e improbabili. Una geografia altra e parallela, quasi sovrapposta agli spazi reali agiti dai protagonisti di questo libro, che da Atlantide su Antichthon, ovverosia l’Antiterra: il corpo celeste che per il pitagorico Filolao orbitava intorno ad hestia, e poi celebrato da Vladimir Nabokov nel suo Ada o Ardore. Non un’isola, quindi, né tantomeno un continente, quanto piuttosto immagine estrema della distesa antartica che nel suo situarsi al di fuori del mondo si stacca da terra e sembra prendere posto nella costellazione che dà il titolo a questo libro, come se il vuoto cosmico di quei ghiacci rendesse possibile un ribaltamento di prospettive. D’altronde, lo abbiamo detto all’inizio: in Croce del sud, «Cielo e terra dicono qualcosa».
Dialoghi Mediterranei, n. 51, settembre 2021
______________________________________________________________
Pietro Clemente, già professore ordinario di discipline demoetnoantropologiche in pensione. Ha insegnato Antropologia Culturale presso l’Università di Firenze e in quella di Roma, e prima ancora Storia delle tradizioni popolari a Siena. È presidente onorario della Società Italiana per la Museografia e i Beni DemoEtnoAntropologici (SIMBDEA); membro della redazione di LARES, e della redazione di Antropologia Museale.
Federico Fastelli insegna Letterature Comparate all’Università di Firenze. Tra le sue pubblicazioni, Dall’eresia all’avanguardia. L’opera poetica di Elio Pagliarani (2011), Il nuovo romanzo. La narrativa d’avanguardia nella prima fase della postmodernità (2013), Epica dell’ottobre (2018), Intervista letteraria (2019).
Zelda Alice Franceschi, è professore associato all’Università degli Studi di Bologna dove insegna (Storia dell’Antropologia, Antropologia delle Americhe & Antropologia Culturale, Tecniche della ricerca di campo) e dove vive. Dal 2004 lavora nel Chaco argentino con comunità indigene wichís. Qui svolge ricerca di campo ogni anno. Studia le autobiografie native, l’antropologia della nutrizione, la cultura materiale, il rapporto tra scritture native e oralità, il rapporto tra indigeni-missioni e meccanizzazione.
Luciano Giannelli, ha tenuto corsi di discipline linguistiche (inclusa Storia della Lingua Italiana) in varie Università italiane e dal 1987 al 2010 in quella di Siena (come professore ordinario L/LIN01 dal 2000). Ricercatore di campo, ha lavorato sui due settori italianistico e di linguistica e sociolinguistica di pertinenza amerindiana, con ricerche condotte in Paraguay, Argentina, Cile, Panama, Stati Uniti d’America.
Uršula Lipovec Čebron docente presso l’Università di Lubiana (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska Fakulteta), ha trascorso tra il 2003 e il 2005 alcuni mesi nella città di Neuquén, dove ha ricercato il patrimonio intellettuale di Benigar e ha rivisto la sua collezione dei testi inediti. Nello stesso periodo ha fatto ricerche di antropologia medica in Aluminé e Ruca Choroi, dove ha potuto intervistare alcuni membri della famiglia di Benigar e visitare il luogo dove questi ha vissuto fino alla sua morte. Ha pubblicato su questo tema, Uršula “Lipovec Čebron, Juan Ivan (Janko Benigar, Janez Benigar)”, in Barbara Šterbenc Svetina (a c. di), Novi Slovenski biografski leksikon, Lubiana, Založba ZRC, 2017, pp. 273-276.
Ernestina Pellegrini insegna Letterature Comparate all’Università di Firenze. All’opra di Claudio Magris ha dedicato la monografia, Epica sull’acqua. L’opera di Claudio Magris (1997,2003), oltre ad avere curato i due volumi delle Opere nei “Meridiani” (2012 e 2021).
Diego Salvadori è Dottore di Ricerca in Letterature Comparate. Assegnista, dal 2017 al 2019, presso il Dipartimento FORLILPSI dell’Università di Firenze, è attualmente borsista presso il medesimo Dipartimento con un progetto di ricerca dedicato alle carte del Fondo Claudio Magris. Si occupa di ecocritica, studi di genere, scritture autobiografiche e critica della ricezione. Ha realizzato e gestisce la banca dati “Dove/nondove. Il parco virtuale”, volto a repertoriare le narrazioni sui luoghi presenti nella letteratura al femminile. Tra le sue ultime pubblicazioni, si segnalano Camille Mallarmé. La scrittura senza volto (Florence Art Edizioni 2019) e L’atlante di Claudio Magris (Pàtron 2020).
______________________________________________________________









