dialoghi intorno al virus
di Dario Inglese
5 aprile
Immaginiamo. L’ultimo paziente ha appena lasciato la terapia intensiva. Dopo mesi di paura e angoscia la diffusione del virus è finalmente sotto controllo mentre all’orizzonte si stagliano il vaccino e la cura, qualora dovesse ripresentarsi. Una grandiosa e rigenerante orgia festiva saluta la fine della crisi. La gente torna per le strade: si stappano bottiglie, s’improvvisano trenini, ci si abbraccia, si fanno garrire le bandiere al vento.
Immaginiamo. Che cosa resterà dell’emergenza Covid-19 al termine di questa brutta storia? Che cosa ci porteremo dietro? Dimenticheremo e andremo avanti, come in fondo facciamo sempre? Tornerà tutto come prima? Ed esattamente che cos’è mai questo prima?
Veniamo all’oggi. Abbiamo più domande che risposte. E poche sono le certezze in questi giorni inquieti. Ciò che stiamo attraversando scuote dalle fondamenta la nostra idea di comunità. Ci sbatte in faccia, con una violenza disarmante, quanto le nostre vite siano legate a quelle dei nostri simili e, con forza ancora maggiore, quanto stretto sia il nostro rapporto con l’ambiente. Son cose che si tende a sottovalutare; elementi acquisiti che escono dal raggio d’azione della nostra coscienza per ritornarci prepotentemente quando sono negati, o comunque messi in discussione. Difficilmente si potrà far finta di niente.
Non ho mai creduto fino in fondo al vecchio adagio secondo il quale le crisi fanno brillare il potenziale creativo insito nell’uomo, ma le risposte che saremo in grado di fornire oggi, durante questa fase liminale, credo possano guidare ciò che faremo domani fronteggiando altre catastrofi. Covid-19, infatti, avrà un impatto marginale sui nostri comportamenti pro-sociali momentaneamente frustrati: uscire, socializzare, abbracciare, baciare – quelle abitudini che ci mancano così tanto in queste interminabili ore passate tra le mura domestiche [1]. Sfiderà, piuttosto, il modo in cui organizziamo il rapporto natura-cultura nelle nostre società; il nostro ruolo nel mondo; la nostra relazione con gli altri esseri umani, gli altri esseri viventi, l’ambiente; il modo in cui abitiamo mondo. Quando le certezze cadono a una a una è proprio il senso di casa a pagarne il prezzo e ad aver bisogno di essere ristabilito. Dovremo farci trovare pronti.
Tutte le culture, com’è noto, organizzano il rapporto tra uomo e natura cercando di sottrarlo simbolicamente, ognuna a suo modo, al divenire storico. Esse cercano di produrre stabilità laddove c’è mutamento, si sforzano di stabilire uniformità laddove c’è fermento: un’illusione (un “trucco” secondo Francesco Remotti; un “inganno” secondo James Clifford) che si riverbera nei concetti d’identità e tradizione – come fossero blocchi immobili nel tempo – e che trasmette l’idea di permanenza nonostante il cambiamento. Le culture si situano così a metà tra una natura indistinta da cui partono (fingendo accuratamente di non farlo, come spiegava Claude Lévi-Strauss) e una natura indistinta cui possono sempre ripiombare, tra l’ordine e la possibilità del disordine, tra la stabilità e l’eventualità del collasso. Ogni cultura, cioè, si staglia sullo sfondo dell’apocalisse: un orizzonte (esorcizzato da riti ad hoc) in grado di dar senso al mondo e far sì che ciò che è non possa essere altrimenti. O almeno che, attraverso il richiamo a valori esemplari in momenti critici, possa essere avvertito come tale.
Ernesto De Martino ha molto riflettuto su questi temi e le sue pagine rendono particolarmente bene il timore di non sentirci a casa (neppure al chiuso delle nostre abitazioni) che ci ha afflitto in questi strani giorni. Secondo lo studioso napoletano, la cultura assolve una decisiva funzione di “appaesamento”: serve, cioè, alla domesticazione del mondo e alla creazione di uno spazio di operabilità, sicuro e familiare, per l’essere umano. Questo processo, da lui definito «ethos del trascendimento», permette all’uomo di andare oltre l’insensata stereotipia dei cicli naturali e di darle un senso reintegrando il ripetitivo e assurdo movimento naturale in un orizzonte dato e condiviso. Tale processo, spiega De Martino, funziona tanto meglio quanto più resta dissimulato.
Perché la vita comunitaria proceda senza intoppi l’uomo ha bisogno di vivere in un grandioso come se: deve «stare nella storia come se non ci stesse» immettendo la propria azione (materiale e simbolica) in una cornice di senso più ampia di cui non ha immediata contezza. Per millenni questa cornice di senso è stata sorretta, complice una visione ciclica e non lineare del tempo, da una mirabile alleanza tra il simbolismo magico-religioso e il potere del rito. Quest’unione ha garantito, in modi diversi secondo le diverse culture, che l’ethos del trascendimento sopravvivesse alle spinte centrifughe cui è costituzionalmente sottoposto: la necessità, dal punto di vista delle società, che il mondo (leggi: la cultura) vada avanti e, di contro, la possibilità che il mondo (rileggi: la cultura) possa cessar d’essere. Cultura e società, secondo De Martino, alimenterebbero allora la riproduzione dell’universo simbolico-materiale grazie (anche) alla paura che esso possa finire, garantendo così la presenza umana dal rischio, sempre in agguato (scorrere del tempo, malattie, morte, etc.), della crisi. A tal fine si servono di procedimenti atti a bilanciare questa delicata tensione dialettica.
Ma che cosa fare, si chiede a un certo punto della sua ricerca l’etnologo, quando una società arriva al punto di poter distruggere definitivamente tutto? Che tipo di valori si possono mettere in campo quando lo stesso principio della reintegrazione del disordine nell’ordine è in pericolo? La tarda produzione scientifica di De Martino ruota tutta intorno a questo problema e si colloca in un periodo storico figlio degli orrori della guerra e testimone di cambiamenti epocali. L’Europa era uscita da due conflitti sanguinosi perdendo di fatto il proprio ruolo egemonico sullo scacchiere mondiale; la scoperta dei campi di sterminio nazisti aveva portato alla luce lo scandalo (tanto intollerabile quanto chirurgico e razionale nei suoi metodi) dell’eliminazione di categorie umane non gradite; il pericolo del cataclisma nucleare si era palesato, in tutta la sua furia, con gli ordigni sganciati a Hiroshima e Nagasaki. Non solo. La civiltà occidentale aveva saturato ogni angolo del pianeta; i sistemi magico-simbolici contadini, costantemente erosi dall’avanzare della cultura di massa, non si dimostravano più in grado di dar significato alla vita comunitaria; il nativo puro e incontaminato della tradizione etnografica si diluiva in processi d’ibridazione culturale la cui scoperta cominciava timidamente a incrinare i paradigmi antropologici consolidati. È in questo contesto che il tema dell’apocalisse, sempre presente in nuce nella sua opera, diventa centrale per l’antropologo. Lasciamo parlare direttamente De Martino:
«Per un verso il mondo, cioè la società degli uomini attraversata da valori umani e operabile secondo questi valori, non deve finire, anche se – ed anzi proprio perché – i singoli individui fruiscono di una esistenza finita; per un altro verso il mondo può finire, e non tanto nel senso naturalistico di una catastrofe cosmica che può distruggere o rendere inabitabile il pianeta terra, ma proprio nel senso che l’umana civiltà può autoannientarsi, perdere il senso dei valori intersoggettivi della vita umana, e impiegare le stesse potenze del dominio tecnico della natura secondo una modalità che è priva di senso per eccellenza, cioè per annientare la stessa possibilità della cultura» (De Martino 2019: 70).
Attraverso le sue inchieste empiriche e le sue elaborazioni teoriche, egli si poneva il problema di capire, in un sistema-mondo sempre più interconnesso e prossimo alla possibilità dell’auto-distruzione, quale fosse il quid in grado di legittimare l’esserci dell’uomo. Registrava la crisi degli universi mitico-rituali e la loro presa sulla realtà, ma in ogni caso non ne sentiva la mancanza. Avvertiva, piuttosto, come il problema dell’apocalisse avesse subìto un mutamento di scala (dal locale al globale con effetto su tutti i locali) in grado di eliminare ogni possibilità di reintegrazione escatologica e di annientare la stessa possibilità della cultura. Non è un caso, allora, che dopo la decennale indagine etnografica sull’universo folklorico in Italia meridionale De Martino, attirando critiche e generando malintesi, avesse puntato la sua attenzione sulla società borghese tout-court spostando lo sguardo dall’analisi della presenza alla concreta possibilità dell’assenza. In un imponente affresco rimasto purtroppo incompiuto (La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali) [2], dopo aver aggredito la questione dal punto di vista antropologico, storico, filosofico, psicologico, letterario-artistico, egli abbozzava i tratti di una nuova etica laica (“umanesimo antropologico” la definiva) che, basandosi su una forma di “etnocentrismo critico”, riconoscesse la natura intersoggettiva del nostro essere al mondo e valorizzasse l’enorme responsabilità creatrice che da ciò deriva:
«Se dovessi individuare la nostra epoca nel suo carattere fondamentale, direi che essa vive come forse non mai è accaduto nella storia nella drammatica consapevolezza di questo deve e di questo può: nell’alternativa che il mondo deve continuare ma che può finire, che la vita deve avere un senso ma che può anche perderlo per tutti e per sempre, e che l’uomo, solo l’uomo, porta intera la responsabilità di questo deve e di questo può, non essendo garantito da nessun piano della storia universale operante indipendentemente dalle decisioni reali dell’uomo in società» (De Martino 2019: 70).
L’attenzione per le crisi psicopatologiche (individuali e senza possibilità di reintegrazione in un orizzonte di senso collettivo); l’analisi delle crisi culturali del mondo contadino, della società borghese o della religione marxista; e infine l’osservazione del progressivo crollo degli universi simbolici dei cosiddetti “popoli di interesse etnologico” servivano allora a De Martino per indagare le diverse risposte date al problema del senso e per proporre una soluzione adatta alla situazione politica del suo tempo. Non potendo più attingere a esemplari valori locali dettati, una volta per tutte, da una forza trascendente (religiosa o laica che fosse), il consesso umano non aveva che da lavorare per rendere il mondo, qui e ora, un posto migliore per tutti. Per trasformarlo, cioè, in una casa – un’enorme patria culturale globale – che per continuare a esistere doveva passare attraverso la consapevolezza della sua intrinseca fragilità. Un progetto grandioso (e carico di decisivi problemi interpretativi) che De Martino non era riuscito, ahinoi, a portare a termine ma che ci ha comunque lasciato preziosi interrogativi e vie di ricerca possibili.
Sono passati più di quarant’anni da quando La fine del mondo è stato pubblicato la prima volta (1977); ben più di cinquanta da quando De Martino ha cominciato a lavorare sul materiale preparatorio. Le pagine dello studioso risuonano oggi in una fase storica in cui il problema del collasso ambientale e dell’insostenibilità di una socio-politica antropocentrica si rivela ogni giorno più evidente. Echeggiano in un periodo in cui, indipendentemente dalle dispute su chi o cosa porti la croce della responsabilità, le conseguenze dei comportamenti umani sono sempre più visibili. Oggi, contrariamente al periodo post-bellico in cui scriveva De Martino, la paura non ha a che fare con la possibilità che qualcuno (consapevolmente o no) prema un bottone nucleare. Non solo. Oggi l’iper-oggetto [3] “apocalisse” è polverizzato in migliaia di piccole catastrofi ecologiche che mettono radicalmente in crisi il sistema uomo-ambiente. A restare costante, però, è il rischio radicale cui questo tipo di apocalisse ci espone: l’assenza di reintegrazione escatologica. O, magra consolazione, l’offerta di alternative poco allettanti: il mondo senza di noi o noi senza il mondo (Danowski, Viveiros de Castro 2017).
 Le pagine di De Martino potrebbero allora aiutarci a leggere la situazione attuale e il nostro posizionamento; e, perché no, potrebbero aiutarci a rispondere agli interrogativi da cui eravamo partiti in questo scritto. Il mondo, quell’inestricabile matassa di natura e cultura, di noi + ambiente, in cui viviamo, amiamo, odiamo, scriviamo, lavoriamo, truffiamo, moriamo è entrato brutalmente in scena. Non possiamo più far finta di considerarlo un terreno neutro per le nostre azioni, bensì un prodotto, continuamente generantesi, d’ininterrotte relazioni. Relazioni fattibili diversamente. La fredda cronaca di questi tempi ci dice che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dopo la prudenza iniziale, ha elevato Covid-19 a pandemia. Le misure prese dal governo italiano (seguito, con un certo ritardo, da molte amministrazioni europee e dagli Stati Uniti) e i comportamenti che buona parte del tessuto sociale nazionale, dopo aver sottovalutato la diffusione del virus, si è auto-imposto (in primis la limitazione degli spostamenti per limitare la curva dei contagi), ci mettono davanti al peso della nostra responsabilità. Ci fanno capire, ora che ne stiamo saggiando il limite, quanto sia importante la sfera intersoggettiva del nostro esserci. Quanto sia fondamentale, per la nostra presenza, che un mondo di significati condivisi ci sia anche domani. E c’è di più (e di peggio).
Le pagine di De Martino potrebbero allora aiutarci a leggere la situazione attuale e il nostro posizionamento; e, perché no, potrebbero aiutarci a rispondere agli interrogativi da cui eravamo partiti in questo scritto. Il mondo, quell’inestricabile matassa di natura e cultura, di noi + ambiente, in cui viviamo, amiamo, odiamo, scriviamo, lavoriamo, truffiamo, moriamo è entrato brutalmente in scena. Non possiamo più far finta di considerarlo un terreno neutro per le nostre azioni, bensì un prodotto, continuamente generantesi, d’ininterrotte relazioni. Relazioni fattibili diversamente. La fredda cronaca di questi tempi ci dice che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dopo la prudenza iniziale, ha elevato Covid-19 a pandemia. Le misure prese dal governo italiano (seguito, con un certo ritardo, da molte amministrazioni europee e dagli Stati Uniti) e i comportamenti che buona parte del tessuto sociale nazionale, dopo aver sottovalutato la diffusione del virus, si è auto-imposto (in primis la limitazione degli spostamenti per limitare la curva dei contagi), ci mettono davanti al peso della nostra responsabilità. Ci fanno capire, ora che ne stiamo saggiando il limite, quanto sia importante la sfera intersoggettiva del nostro esserci. Quanto sia fondamentale, per la nostra presenza, che un mondo di significati condivisi ci sia anche domani. E c’è di più (e di peggio).
Gli scienziati sono sempre più concordi nell’evidenziare come la diffusione del Coronavirus sia l’esito delle spregiudicate politiche ambientali degli ultimi decenni e di una pressione antropocentrica ormai difficilmente sostenibile. Collegando la diffusione dei virus all’inquinamento – come causa scatenante (a monte) e come veicolo facilitatore per la loro diffusione (a valle) – i ricercatori ci lanciano un messaggio dirompente che non possiamo permetterci di ignorare: il problema va molto più in là della fine di questa pandemia. Ecco perché oggi Covid-19 è una piccola apocalisse. Perché, comunque vada, genererà un cambiamento in noi e nel nostro mondo: il mondo delle relazioni sociali; il mondo dei rapporti economici ed ecologici. E, sulle orme di De Martino, starà a noi decidere come affrontare questa apocalisse. Darle un senso. Reintegrarla senza negarla. Provarci almeno.
Oppure potremmo lasciarci trascinare dagli eventi vagheggiando la fine dell’emergenza (come fosse una mera parentesi) e il ritorno alla vita di prima. Ma siamo sicuri sia davvero possibile? Covid-19 ha fatto entrare in scena il mondo, in tutta la sua materialità e il suo intreccio di relazioni, e con questo mondo dovremmo pur farci i conti. Non è ingenuo realismo riconoscerne la durezza (in tutti i sensi) e gli effetti che produce sulle nostre vite. Giorgio Agamben, ad esempio, è stato travolto da un torrente di critiche dopo aver utilizzato il Coronavirus per ribadire la sua filosofia della storia e scorgere nell’azione profilattica del Governo italiano un secondo (e più vero) fine bio-politico (Agamben 2020a; 2020b). Quel che il filosofo romano non ha considerato, applicando meccanicamente la teoria dello stato di eccezione anche a questa situazione, è che ciò che sta accadendo (contagi, ricoveri, decessi, strascichi socio-economici) è reale e come tale va trattato. Sporcandosi le mani oggi, anche a costo di sospendere momentaneamente qualche libertà, per evitare che il contagio si diffonda domani e, soprattutto, pensando in prospettiva.
In un breve ma incisivo intervento sul blog La giusta distanza – Piccolo osservatorio etnografico sull’isolamento [4], Roberta Raffaetà dell’Università di Bolzano ha affermato che se il nesso tra epidemie e inquinamento dovesse essere confermato dai futuri studi scientifici, si potrebbe addirittura arrivare a sostenere che «la sospensione temporanea della normalità all’interno di una cornice democratica – ovvero sospensione “della normalità, non del diritto o dei diritti” – è una buona notizia. È una buona notizia perché ci permette di sfruttare le potenzialità di trasformazione offerte da questa fase di liminalità».
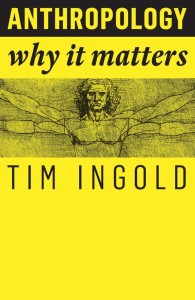 Che fare allora? I cambiamenti non si sono mai prodotti dal divano di casa, è vero. Ma lavorare sull’immaginario è ciò che adesso ci viene richiesto: trovare un modo per integrare demartinianamente questa apocalisse in un orizzonte di senso condiviso e autenticamente responsabile. Pensare quindi a soluzioni alternative per la gestione delle risorse. Considerare, visto che non v’è nulla di ineluttabile nelle nostre azioni e che il mondo lo generiamo ogni giorno, nuovi modi di esserci. Prendere gli altri sul serio. Prendere l’ambiente sul serio. Prendere tutti gli esseri viventi sul serio. Fare palestra cognitiva in questi giorni di stop forzato. E leggere. E studiare. E immaginare. E, perché no, fare antropologia: «it is not for anthropology to hold a mirror to the world. It is rather to enter the relations and processes that give rise to worldly things so as to bring them into the field of our awareness» (Ingold 2018: 129).
Che fare allora? I cambiamenti non si sono mai prodotti dal divano di casa, è vero. Ma lavorare sull’immaginario è ciò che adesso ci viene richiesto: trovare un modo per integrare demartinianamente questa apocalisse in un orizzonte di senso condiviso e autenticamente responsabile. Pensare quindi a soluzioni alternative per la gestione delle risorse. Considerare, visto che non v’è nulla di ineluttabile nelle nostre azioni e che il mondo lo generiamo ogni giorno, nuovi modi di esserci. Prendere gli altri sul serio. Prendere l’ambiente sul serio. Prendere tutti gli esseri viventi sul serio. Fare palestra cognitiva in questi giorni di stop forzato. E leggere. E studiare. E immaginare. E, perché no, fare antropologia: «it is not for anthropology to hold a mirror to the world. It is rather to enter the relations and processes that give rise to worldly things so as to bring them into the field of our awareness» (Ingold 2018: 129).
Al termine di uno dei capitoli de La fine del mondo (L’apocalisse dell’Occidente) Ernesto De Martino proponeva un antidoto contro il tragico showdown nucleare:
«Quando la tentazione vi prende di premere quel bottone – e si cade nella tentazione anche ammettendo che qualche altro un giorno dovrà premerlo “se necessario” –, quando siete vittima di questa tentazione ricordate non i duecentomila di Hiroshima o i sei milioni di ebrei, ma un solo volto umano in dolore, qualche volto concreto di persona che avete amato e avete visto soffrire, qualche bambina lacera e piangente che avete incontrato per via, una volta, il tal mese, il tal giorno della vostra vita: ricordate – non “immaginate” – questo episodio minuto, irrilevante […]; e se non vedete in quel volto tutti i volti, e il vostro stesso, o se avete bisogno ancora di Cristo per questo ricordo, o se addirittura non ricorderete nulla, o se direte che è segno di virilità non ricordare in questo momento, allora qualcuno oggi o domani, forse voi stessi, premerà il bottone» (De Martino 2019: 361).
Qui, per concludere, vorrei aggiungere solo un piccolo tassello per integrare, non contraddire, quanto sostenuto dal maestro napoletano. Esperienza e immaginazione non sono movimenti contrastanti; entrambe, infatti, concorrono a dar senso al mondo, a farci entrare in risonanza con esso e i suoi abitanti (tutti, anche quelli più distanti – nello spazio, nel tempo, nella specie) e a guidare le nostre azioni. Come scrive Tim Ingold (2020: 225-226), immaginare è un atto pratico: «un movimento di apertura, non di preclusione, […] l’impulso generativo di una vita che viene continuamente trascinata dalla speranza, dalla promessa e dall’aspettativa della sua continuazione». Come sostengono Matteo Meschiari e il collettivo di scrittori TINA impegnati da mesi nella creazione di un romanzo (antropologico, storico, filosofico) dell’Antropocene: «fiction is action». Ricordiamo, allora, il dolore di quella bambina. Allo stesso tempo, però, alleniamoci ad immaginarlo. E immaginiamo il modo in cui tante culture del passato (e del presente) hanno affrontato (e affrontano) le loro catastrofi. Prepariamoci, ora che la normalità è sospesa, a trovare vie alternative di (co)abitare il pianeta. In questo modo, forse, le apocalissi venture non significheranno la fine del mondo bensì la fine di un certo mondo.
Dialoghi Mediterranei, n. 43, maggio 2020
Note
[1] La semplice osservazione dei comportamenti di questi giorni non fa che confermare la celebre osservazione di Marx nei Gundrisse: «Nel senso più letterale, l’uomo è uno zoon politikòn (ζῷον πολιτικόν), non solo un animale sociale, ma anche un animale che solo in società può isolarsi». La spiccata propensione sociale dell’essere umano, infatti, sta trovando soluzioni creative per uscire comunque allo scoperto in tempi di isolamento e spostamenti ridotti all’osso (ed è forse l’ostacolo principale al rispetto dei ripetuti inviti a “stare in casa” per arginare il contagio). In questi giorni di quarantena sto conducendo una piccola osservazione partecipante sulla quotidianità nel mio quartiere (periferia ovest di Milano) e scorgo un modo nuovo – o forse vecchio? – di vivere la vita nei condomini. Gli abitanti del mio stabile, ad esempio, hanno letteralmente ripreso possesso dei balconi e vi passano tantissimo tempo. In queste soglie tra il privato e il pubblico, tra il dentro e il fuori, mangiano, fumano, giocano, litigano, si scambiano informazioni, fanno due chiacchiere con la gente che porta a spasso il cane o che torna dal supermercato, suonano, cantano, ballano, riproducono ritualità favorite dalle tecnologie digitali. Vivono questi spazi di confine, cioè, con un’intensità impensabile, addirittura inopportuna e molesta, solo un paio di mesi fa.
[2] Il volume ha avuto una gestazione piuttosto complessa, la sua prima apparizione risale al 1977 per i tipi di Einaudi (seconda edizione nel 2002), grazie alla supervisione di Clara Gallini. Nel 2016 Giordana Charuty, Daniel Fabre e Marcello Massenzio, sulla scia della progressiva riscoperta europea dell’eredità intellettuale di De Martino, hanno curato la traduzione francese dell’opera. Il testo, più snello e meno frammentario rispetto al ponderoso tomo delle precedenti edizioni, è stato presentato al lettore italiano, sempre da Einaudi, nel 2019.
[3] Il termine “iperoggetto” è stato introdotto nel 2010 dal filosofo inglese Timothy Morton, esponente della object-oriented ontology: approccio filosofico che intende superare il decostruttivismo postmodernista per prendere di mira gli oggetti un attimo prima che l’uomo, attraverso il linguaggio, ne alteri l’oggettività. Al di là della discussione sulla validità di questa proposta epistemologica, il concetto di “iperoggetto”, a mio avviso, ha una sua utilità euristica ed è riassumibile come segue: un’idea o un fenomeno (concreto o astratto) che riguarda da vicino tutti gli esseri umani ma che è percepito come lontanissimo e dunque difficilmente pensabile. Scrive Morton (2018): «l’iperoggetto per eccellenza è proprio il riscaldamento globale, la cui caratteristica principale è quella di esistere su dimensioni spazio-temporali troppo grandi perché possa essere visto o percepito in maniera diretta».
[4] Il blog è gestito dal gruppo di lavoro del World Anthropology Day, facente capo al Dottorato in Antropologia Culturale e Sociale dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. La pagina è stato creata per offrire un punto di vista antropologico sull’emergenza sanitaria in corso.
Riferimenti bibliografici
Agamben G. 2020a, L’invenzione di un’epidemia, in Quodlibet (26/02/2020).
Agamben G. 2020b, Contagio, in Quodlibet (11/03/2020).
Clifford J. 1993, I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel secolo xx, Bollati Boringhieri, Torino (ed. or. 1988, The Predicament of Culture. Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art).
Danowski D., Viveiros de Castro E. 2017, Esiste un mondo a venire? Saggio sulle paure della fine, Nottetempo, Milano (ed. or. 2014, Ha mundo por vir? Ensaio sobre os medos e os fins).
De Martino E. 2019, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino.
Ingold T., 2018, Anthropology. Why it Matters, Polity Press, Cambridge.
Ingold T. 2020, Siamo linee. Per un’ecologia delle relazioni sociali, Treccani, Roma (ed. or. 2015, The life of Lines).
Morton T. 2018, Iperoggetti, Nero Editions, Roma (ed. or. 2013, Hyperobjects. Philosophy and Ecology after the End of the World).
Lévi-Strauss C. 2003, Le strutture elementari della parentela, Feltrinelli, Milano (ed. or. 1947, Les structures élémentaires de la parenté).
Remotti F. 2014, Cultura. Dalla complessità all’impoverimento, Editori Laterza, Roma-Bari.
______________________________________________________________
Dario Inglese, ha conseguito la laurea triennale in Beni Demo-etnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo e la laurea magistrale in Scienze Antropologiche ed Etnologiche presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. Si è occupato di folklore siciliano, cultura materiale e cicli festivi. A Milano si è interessato di antropologia delle migrazioni e ha discusso una tesi sull’esperimento di etnografia bellica Human Terrain System.
_______________________________________________________________










