Follow the money, segui il denaro e scopri il boss e il complice in doppiopetto, il borghese mafioso. Giovanni Falcone, che inventò quel metodo investigativo, raccontò nel libro Cose di Cosa nostra che la morte di Boris Giuliano – l’incorruttibile capo della squadra mobile, freddato da Leoluca Bagarella con sette colpi di pistola alle spalle – conduceva al versamento di 300 mila dollari in contanti, sulla qual cosa il funzionario indagava, a nome di un certo signor Giglio. Nome fittizio, si scoprì. Era stato il direttore della banca, parente del boss Stefano Bontade, a sistemare le cose. E proprio uno degli uomini più fidati di Falcone – ed erano pochissimi – il colonnello dei carabinieri Angiolo Pellegrini, oggi sobrio e riservato generale ottantenne, stimò allora il tesoro di Cosa nostra in 20 mila miliardi di lire, quanto il bilancio di uno Stato, un patrimonio gigantesco in gran parte frutto del traffico d’eroina ereditato dai marsigliesi, oggi forse raddoppiato, triplicato (chissà) e in gran parte immerso nei circuiti misteriosi della finanza internazionale.
All’indomani della cattura di Matteo Messina Denaro, l’ultimo capo della stagione stragista, nessuno osa dire che la mafia con capitale Palermo sia finita, perché la questione, semmai, è dove sia finita e con quali giacche e cravatte si veste, come si è riorganizzata, soprattutto dopo Messina Denaro. Il tema è complesso, va diviso in due e con l’ausilio di acuti osservatori.
Il primo interrogativo è: quanto resta e quanto controlla nei territori la mafia tradizionale? Il secondo: come individuare la versione moderna, i manager del denaro tossico e insanguinato e fin dove si è espansa la linea della palma di sciasciana memoria? E in mezzo un punto focale collegato ai precedenti: come e perché Matteo Messina Denaro è finito in carcere, fatti salvi i meriti d’indagine di procura e carabinieri?
Prendiamo Palermo a modello della consorteria segreta che tutt’ora domina incontrastata nelle borgate del centro storico e della periferia. Qui il controllo della piccola economia circolare e nell’arbitraggio delle controversie non è mai venuto meno. Il “don” del rione è ancora riverito e si muove alla luce del sole, dispensando favori, benedizioni, posti di lavoro e castighi, il “don” vecchio stile dalla faccia bonaria o feroce all’occorrenza.
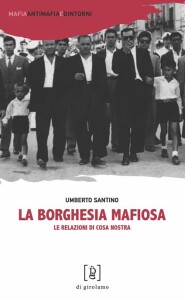 «Cosa nostra non è più quella delle stragi ma è presente e continua a condizionare l’economia della città», aveva detto al suo insediamento il procuratore Maurizio De Lucia, il quale solo tre mesi dopo si era ritrovato a gestire l’arresto in clinica del superlatitante tra gli applausi dei palermitani. E in quell’occasione aveva rilanciato un vecchio concetto sempre contrastato da una parte consistente del ceto dominante politico ed economico, siciliano e non: «Una fetta di borghesia mafiosa, noi ne abbiamo contezza in termini certi, ha aiutato la latitanza di Matteo Messina Denaro». Un’espressione risalente addirittura all’Ottocento e ripresa nel titolo di un famoso libro edito trent’anni fa da Umberto Santino, studioso della mafia e fondatore del Centro di documentazione Peppino Impastato, volume rivisto e da pochi mesi ristampato dall’editore trapanese Di Girolamo, La borghesia mafiosa, appunto.
«Cosa nostra non è più quella delle stragi ma è presente e continua a condizionare l’economia della città», aveva detto al suo insediamento il procuratore Maurizio De Lucia, il quale solo tre mesi dopo si era ritrovato a gestire l’arresto in clinica del superlatitante tra gli applausi dei palermitani. E in quell’occasione aveva rilanciato un vecchio concetto sempre contrastato da una parte consistente del ceto dominante politico ed economico, siciliano e non: «Una fetta di borghesia mafiosa, noi ne abbiamo contezza in termini certi, ha aiutato la latitanza di Matteo Messina Denaro». Un’espressione risalente addirittura all’Ottocento e ripresa nel titolo di un famoso libro edito trent’anni fa da Umberto Santino, studioso della mafia e fondatore del Centro di documentazione Peppino Impastato, volume rivisto e da pochi mesi ristampato dall’editore trapanese Di Girolamo, La borghesia mafiosa, appunto.
«Il fenomeno mafioso non è solo Cosa nostra e dintorni – scrive Santino nella nuova introduzione –è pure un sistema di rapporti, senza di cui molte attività, dagli appalti al riciclaggio del denaro sporco, sarebbero impossibili. E questo sistema relazionale … va dagli strati più bassi della popolazione a quelli più alti. In questo quadro operano professionisti, imprenditori, pubblici amministratori, politici, rappresentanti delle istituzioni, classificabili come “borghesia mafiosa”. Sono gli eredi dei “facinorosi della classe media” di cui parlava Franchetti nel 1876, che per arricchirsi e comandare praticavano “l’industria della violenza” e godevano di buoni rapporti con le istituzioni. Sono gli esemplari della “borghesia capitalistico-mafiosa”, di cui scriveva all’inizio degli anni ’70 Mario Mineo, leader dei gruppi nati a sinistra del Partito comunista».
E a proposito della cattura di MMD, una marea di incredulità si è sollevata nell’opinione pubblica: è possibile fare per trent’anni il latitante, e di questo spessore, e a casa propria, a Campobello di Mazara? La cattura nasce da una trattativa?
Se trattativa c’è stata, non con lo Stato ma dentro Cosa nostra – spiega Attilio Bolzoni, giornalista e autore, uno dei più acuti interpreti del fenomeno.
«In altri casi la trattativa c’è, adesso non credo, è stata una cattura soft, nessuna tensione nel momento dell’arresto e vorrei richiamare un momento de Il cane di terracotta di Camilleri. Quando il commissario Montalbano incontra un latitante lo invita al commissariato. La risposta del criminale spiega tutto: “No, lei sa leggere e sa scrivere, io mi posso solo fare arrestare”. Si diceva che la mafia è un cancro, ora la mafia ha il cancro, qui la malattia estrema s’incrocia con la latitanza, lui era diventato inservibile e forse un peso per i sodali. La cattura rappresenta la fine di una mafia già morta da almeno 20 anni, lui che dirigeva la distribuzione alimentare e l’eolico nella sua zona no, non è da capo dei capi, un padrino vero che aveva il pallino del padrino finto, chissà quante volte ha visto e rivisto l’omonimo film».
Parlerà? Roberto Scarpinato, ex procuratore generale di Palermo e oggi senatore del M5S, aveva detto:
«Lui sa per quale motivo Riina revocò l’ordine di uccidere Falcone a Roma, perché personaggi importanti avevano chiesto che si facesse con modalità esplosiva a Capaci. Lui sa chi chiese a Riina di anticipare l’omicidio Borsellino, lui sa chi ha l’agenda rossa e chi era il soggetto esterno che, come ha dichiarato Spatuzza, assistette all’operazione di caricamento dell’esplosivo della Fiat 126. Lui sa chi erano le menti politiche della strategia stragista».
Parlerà? «Se parla – aggiunge Bolzoni – crolla lo Stato, ma non so se parlerà, ha troppi parenti, una figlia, che tremi un sacco di gente è poco ma sicuro, tanti hanno avuto a che fare con lui, grandi patrimoni sono in mano a società». Finita la vecchia Cupola, conclude Bolzoni, resta la borghesia mafiosa. Ed è essa che comanda in Sicilia.
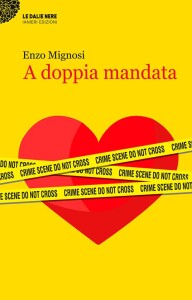 E a questa area grigia, ancora in gran parte sommersa, vanno aggiunti professionisti dell’informazione e testate giornalistiche, intellettuali e studiosi d’ateneo che scoprirono d’improvviso, a cominciare dalla “cantata” di Masino Buscetta e a seguire nei mesi caldi del maxiprocesso – i valori del garantismo (“peloso” fu allora definito), prima a protezione dei gran borghesi, imprenditori e uomini politici in particolare, coinvolti dalle confessioni del pentito storico di Cosa nostra, poi allargato ad ogni inquisito di mafia, con l’intento non tanto secondario di contrastare il lavoro investigativo di Falcone e del pool antimafia che aveva messo in crisi o arrestato per complicità un pezzo della classe dirigente siciliana. Il sospetto non è l’anticamera della verità era il motto capovolto rispetto a quello inventato non proprio felicemente da Leoluca Orlando che pure era impegnato ad agitare le acque paludose della città dove allignava una colonia di coccodrilli.
E a questa area grigia, ancora in gran parte sommersa, vanno aggiunti professionisti dell’informazione e testate giornalistiche, intellettuali e studiosi d’ateneo che scoprirono d’improvviso, a cominciare dalla “cantata” di Masino Buscetta e a seguire nei mesi caldi del maxiprocesso – i valori del garantismo (“peloso” fu allora definito), prima a protezione dei gran borghesi, imprenditori e uomini politici in particolare, coinvolti dalle confessioni del pentito storico di Cosa nostra, poi allargato ad ogni inquisito di mafia, con l’intento non tanto secondario di contrastare il lavoro investigativo di Falcone e del pool antimafia che aveva messo in crisi o arrestato per complicità un pezzo della classe dirigente siciliana. Il sospetto non è l’anticamera della verità era il motto capovolto rispetto a quello inventato non proprio felicemente da Leoluca Orlando che pure era impegnato ad agitare le acque paludose della città dove allignava una colonia di coccodrilli.
Proviamo ad inoltrarci ancora avanti nei meandri oscuri della finanza che gestisce il tesoro di Cosa nostra con la torcia di un altro esperto, il giornalista e autore palermitano Enzo Mignosi che dice:
«La mafia dei manager che gestisce pezzi del patrimonio infetto non opera in Sicilia, Cosa nostra si è riposizionata, ha cambiato pelle e non è più riconoscibile, è una mafia senza più mafiosi. Nei quartieri di Palermo e di Catania permangono i residuati di ciò che era, privi dello spessore e della pericolosità di un tempo, tra l’altro decimati da arresti e confische – nessun parente dei boss storici è stato individuato nei panni di finanziere – confinati in attività di basso conio come estorsioni e spaccio».
Mignosi, che ha esordito adesso come romanziere in A doppia mandata, storia ambientata durante la guerra di mafia negli anni Ottanta, considera un segno di decadenza l’alleanza nei vicoli palermitani con l’importata mafia nigeriana e prevede che il regime del 41 bis verrà abolito («a chi dovrebbero mandare i messaggi»), ma non subito perché sono ancora tanti i boss detenuti – Madonia, Lucchese, Spadaro, il figlio di Riina, i Graviano non sono ancora così anziani – insomma una strategia dell’estinzione.
Quanto al clan nigeriano a Palermo, la Black Axe, con roccaforte nella borgata di Ballarò, il filosofo e attivista sociale Nino Rocca, tra i fondatori del Centro sociale San Saverio, ha una visione precisa: la mafia nigeriana è all’angolo. E per tre motivi:
«Retate e processi, per cominciare. Il tentativo di creare una cosca è fallito, nonostante il sì da Verona dal Black Axe, sede centrale in Italia dell’associazione di stampo religioso-criminale. Inoltre, le ragazze nigeriane costrette a prostituirsi sono quasi scomparse dalle strade dopo l’intervento del re e massima autorità religiosa di Benin City, città da cui proviene la tratta, il quale radunò i sacerdoti comunicando di aver liberato le donne dal giuramento del vudù, divulgato tramite youtube in tutto il mondo, come una maledizione. Infine, è andato in crisi il mercato del crack portato dai nigeriani, la droga dei poveri con minime tracce di cocaina cucinata e confezionata in sede domestica dalle famiglie di Ballarò e in gran parte il traffico è passato ai palermitani. Il che ha generato un fenomeno di emigrazione nigeriana verso l’area napoletana».
Ma se la Piovra cambia pelle, anche il sistema dell’Antimafia, sia investigativo che della società civile che da sempre si oppone, sia della ricerca scientifica e didattica, dovrà mutare metodi di lavoro e di contrasto nonché di studio acquisiti negli anni?
Lo scrittore Marcello Benfante, che fu direttore della rivista “Kasba”, trasformata in chiave antimafia all’indomani delle stragi, offre uno sguardo originale:
«Volevo scrivere dell’inconveniente di essere siciliani, ci portiamo dentro questo senso di colpe che spesso hanno commesso altri, un’insolvenza dello Stato che si riversa su di noi, ma non voglio fare il sicilianista. Vittorio Feltri ha detto che se la mafia ha attecchito c’è stata una disponibilità del territorio, e in parte è vero. Ma noto che, nello stesso giorno della cattura di Messina Denaro, una marea di gente ha partecipato ai funerali di Biagio Conte, disposta a proseguire la sua missione, le due facce della Sicilia».
Il filosofo, autore e attivista Augusto Cavadi è certo che l’associazionismo abbia ancora molto da dire e da fare.
«Segnalo la vitalità scientifico-culturale sempre al passo dei tempi del Centro Impastato, Addiopizzo ha aggiornato l’analisi del fenomeno estorsioni a Palermo – va scomparendo la figura del commerciante che subisce, è lui che va a cercarli per capire come comportarsi – e noi come Scuola di formazione etico-politica Giovanni Falcone lavoriamo spezzettando in pillole la grande questione, facciamo da ponte tra ricerca scientifica e gente comune».
Secondo Adriana Laudani, già parlamentare comunista accanto a Pio La Torre, presidente di Memoria e Futuro ed esperta del fenomeno,
«con la cattura di Messina Denaro possiamo dichiarare chiusa la fase stragista apertasi negli anni ‘80 ad opera dei Corleonesi. La presa d’atto invita chi crede che la presenza delle mafie sia un vulnus insopportabile per le nostre democrazie e per la stessa civiltà, deve indurre ciascuno di noi che pratichiamo la cosiddetta antimafia a mettersi in discussione».
Cioè cambiare strategia, dirigere altrove lo sguardo?
«Dobbiamo prendere atto che da molti anni Cosa nostra ha abbandonato la vecchia strategia, recuperando il Dna di farsi parte della realtà finanziaria, quindi noi dovremo essere capaci di rinvenire e contrastare questo mimetizzarsi, questo mutamento, non possiamo più attardarci su versanti ideologici, dobbiamo provare noi a trasformarci».
 Anche le stanze del sapere hanno aggiornato le loro indagini scientifiche. In un seminario intitolato “Territorio, Ambiente e Mafie”, giunto alla decima edizione e in corso in queste settimane (ultimo appuntamento il prossimo 20 marzo), l’università di Catania, da un’idea dell’allora prorettore Antonio Pioletti, si cimenta da tempo sul tema nelle più diverse angolazioni. Una di queste è la povertà educativa, un buco nero scavato da una drammatica cifra sociale, il record nazionale siciliano dell’evasione scolastica. Che, tradotto, significa giovane manovalanza a disposizione delle cosche.
Anche le stanze del sapere hanno aggiornato le loro indagini scientifiche. In un seminario intitolato “Territorio, Ambiente e Mafie”, giunto alla decima edizione e in corso in queste settimane (ultimo appuntamento il prossimo 20 marzo), l’università di Catania, da un’idea dell’allora prorettore Antonio Pioletti, si cimenta da tempo sul tema nelle più diverse angolazioni. Una di queste è la povertà educativa, un buco nero scavato da una drammatica cifra sociale, il record nazionale siciliano dell’evasione scolastica. Che, tradotto, significa giovane manovalanza a disposizione delle cosche.
Dialoghi Mediterranei, n. 60, marzo 2023
_____________________________________________________________
Antonio Ortoleva, ex giornalista del Giornale di Sicilia, già direttore e co-fondatore del periodico antimafia “Il Quartiere nuovo” di Palermo e docente di giornalismo a contratto presso l’Università di Palermo. Autore di reportage di viaggi, del volume C’era una volta l’India e c’è ancora, Navarra Editore, e più recentemente dello stesso editore Non posso salvarmi da solo. Jacon, storia di un partigiano.
______________________________________________________________








