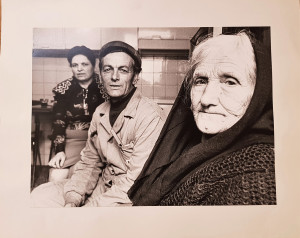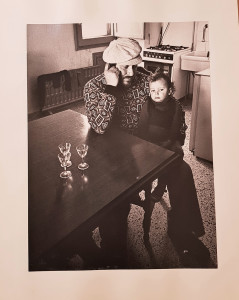di Aldo Aledda
Com’è noto l’Italia oggi attraversa una delle crisi più acute dell’ultimo Dopoguerra. Sprofonda nel baratro del debito pubblico incapace di risalire la china anche per effetto di una popolazione stanca e invecchiata che, fedele allo stereotipo dell’anziano facilmente esposto alle truffe, corre speranzosa dietro l’ultimo demagogo che promette la luna. Non fosse che per questo si pone con urgenza un’allarmante situazione anagrafica: invecchiamento della popolazione e preoccupante denatalità, aggravata dalla fuga dei giovani che non credono più nel nostro Paese.
Peraltro, se da un lato si può brindare per l’allungamento della vita, dall’altro ciò si traduce in scarsa apertura mentale, mancanza di attenzione al nuovo e assenza di energia necessaria per fronteggiare le difficoltà. Ciò si riflette anche sull’ambivalenza delle reazioni. Gli strati più avanzati in fatto di età nella società (e nelle posizioni sociali) avvertono la necessità del ringiovanimento e di nuove forme di imprenditoria, ma quando dall’analisi si scende alla proposta, ossia alla ricerca di soluzioni concrete, le difficoltà ad accettare il nuovo emergono tutte. Esemplificando, se da un lato si avverte appunto la necessità di avere giovani, quando si passa alla loro esatta individuazione vengono fuori tutte le riserve: così si scopre che questi non devono avere determinati colori della pelle e tratti fisiognomici diversi da quelli comunemente accettati nel Paese.
Altrettanto dicasi per le iniziative economiche: sì alle cosiddette start up, per esempio nel settore turistico, ma guai se toccano gli interessi delle organizzazioni alberghiere o dei ristoratori per quanto siano chiari i limiti del loro apporto all’economia reale, giacché se appartengono ai grandi gruppi internazionali trasferiscono i soldi nel Paese di appartenenza oppure se il padronato è locale vive di contributi pubblici complici spesso gli apparati di governo (come è capitato in Sardegna in cui le strutture alberghiere che ricevevano contributi regionali sono incappate nelle sanzioni europee per aiuti di Stato). Ma più in generale se potenziali gruppi di giovani intendono realizzare nuove iniziative, il più delle volte queste s’infrangono con certa mentalità pianificatrice e burocratica degli apparati.
Nella realtà di un Paese caratterizzata da endemiche e feroci resistenze al nuovo e dalla rassegnata attesa che i problemi si risolvano solo per decantazione, si colloca la proposta del Comitato 11 ottobre d’iniziativa degli Italiani nel mondo, di ricorrere agli stessi italiani che vivono all’estero per ripopolare e, soprattutto, di rivitalizzare l’economia e la società. In concreto il messaggio è rivolto fondamentalmente a due tipi di italiani: quelli che discendono dalle generazioni dei previ emigranti dell’Otto e Novecento e coloro che a cavallo del secolo scorso e gli inizi del 2000 hanno abbandonato il Paese. Non solo i “cervelli in fuga”, ma anche tutta quella serie di professionalità e competenze che sono andate fuori alla ricerca semplicemente di nuove opportunità. Ma l’interesse si manifesta anche nei confronti degli “italici”, ossia cittadini stranieri non di origine italiana ma che si riconoscono nei valori fondanti del nostro Paese. In fondo sono questi che, in alcune aree – pensiamo alla Sardegna in cui abbiamo tenuto l’ultimo workshop e in cui si acquistano abitazioni nei piccoli centri montani al prezzo figurativo di 1 Euro, ma anche alla Toscana tradizionale oggetto d’interesse di cittadini inglesi –, si danno da fare per rilanciare attività turistiche oltre che rivitalizzare il tessuto economico per il semplice fatto di risiedervi.
Da dove dovrebbero provenire questi nuovi apporti? Ci sono aree del mondo in cui i discendenti degli italiani vivono particolari difficoltà; pensiamo all’America Latina e caraibica, soprattutto all’Argentina e al Venezuela, ma anche a tutte le altre in cui, nonostante la crisi, l’Italia e in prospettiva l’Europa, rappresentano ancora una scelta interessante. Non a caso da queste arriva finora il maggiore apporto in termini di presenza nel nostro Paese tra quelli in cui si è rivolta a suo tempo la tradizionale emigrazione italiana. E, comunque, per quanto riguarda le ultime generazioni di emigranti, l’appello va esteso a tutto il mondo dove si ha notizia che diversi giovani siano tentati di cimentarsi nella patria dei propri antenati.
Perché questa massa dovrebbe venire in Italia? È questo solo un disegno dettato dalla disperazione o c’è dell’altro? Tutti i Paesi che possiedono e offrono standard di vita occidentali si sforzano di essere il più possibile attrattivi nei confronti di professioni e mestieri di altri. Paradossalmente in un mondo che mostra di chiudersi alle migrazioni dei popoli si va sempre più alla ricerca di quei flussi più utili allo sviluppo economico. In prima fila sono Paesi apparentemente refrattari come gli Stati Uniti, il Canada e l’Australia (totalmente aperti soprattutto per chi arriva con capitali da investire), ma anche altri che paiono più chiusi come la Germania o la Polonia – lo stesso Giappone sembra stia prendendo consapevolezza dell’essere il Paese più chiuso e più vecchio al mondo – sono oggi impegnati nella corsa al reclutamento non solo di professionisti ma anche di figure di lavoratori utili alla propria economia, segnatamente nel turismo e nei servizi. E ciò avviene non solo perché molti di questi Paesi presentano i medesimi problemi dell’Italia in termini di spopolamento, invecchiamento e denatalità, ma anche perché al ringiovanimento e al ricambio è legato il futuro di quella nazione.
In un quadro di competizione così estrema è chiaro che occorre giocare tutte le carte che si possiedono. L’Italia punta molto per la sua attrattività sull’ambiente e la qualità della vita, oltre che la cultura e l’arte di cui è satura. Ma è evidente che queste condizioni non bastano se si considera la scarsità dei servizi, dei trasporti e delle basse retribuzioni, oltre che la pesantezza dell’apparato amministrativo che, a differenza degli altri concorrenti, incide soprattutto sull’economia. Qui sembra che vi sia un gusto particolare nel gravare su un’economia che già di per sé ristagna, non crea opportunità e non offre posti di lavoro rivelandosi scarsamente attrattiva anche per chi proviene da parti del mondo che vivono condizioni di disagio estremo, come gli immigrati africani. Tant’è che quando sbarcano nelle nostre coste hanno come obiettivo solo il raggiungimento dei Paesi dell’Europa centrale e settentrionale e non di restare in Italia. Paradossalmente di questo passo avremo il problema di rendere più attrattivo il nostro Paese e non di cacciarli.
Quali ordini di problemi pongono in concreto questi possibili rientri? Su questi stiamo appunto cercando di attrarre l’attenzione e di sollecitare un dibattito. Il primo problema si pone per le generazioni più recenti di expat. Non solo i protagonisti della cosiddetta “fuga dei cervelli”, ma anche tutti coloro che hanno inseguito all’estero semplici opportunità, vanno sottratti dalla retorica del rientro a tutti i costi, magari accompagnato da sgravi fiscali, come accaduto in quest’ultimo decennio. È bene precisare che a proposito di apparati che remano contro la volontà delle istituzioni e dell’economia nazionale, ha cercato di mettere i bastoni tra le ruote proprio l’Agenzia delle Entrate che si è inventata il requisito dell’iscrizione all’Aire come precondizione per ottenere i benefici fiscali per chi ne aveva diritto in base a una normativa del 2010, una norma che il recente decreto “crescita” ha provveduto opportunamente a cancellare.
L’esodo dei giovani all’estero non va scoraggiato, al contrario va aiutato perché è fatto naturale e positivo e, infine, costituisce l’ossatura della stessa Unione Europea, come dimostra la feconda esperienza dell’Erasmus. Troppe volte, infatti, si assiste a un atteggiamento ambivalente delle istituzioni italiane che, da un lato, deprecano codesta “fuga” che impoverirebbe il Paese e comporterebbe la perdita delle risorse impiegate per la loro istruzione mentre, dall’altro, magari si varano progetti e si stabiliscono borse di studio perché i giovani possano studiare e lavorare all’estero.
A prescindere dall’obiezione che viene fatta alla supposta perdita di risorse per l’istruzione, che, secondo i calcoli dell’OCSE, riguarderebbero oltre l’un per cento del Pil nazionale, e che sarebbe comunque sprecata giacché la gran parte dei giovani proprio in Italia rimane non utilizzata o sottoutilizzata, non si deve escludere la possibilità di rientrare in quelle spese con un’oculata opera di recupero delle risorse umane. Infatti, esiste storicamente un ciclo nel percorso migratorio per il quale da un terzo alla metà dei previ migranti mostra la propensione, dopo un certo numero di anni, a tornare nel Paese di origine, anche prima del pensionamento. Orbene, piuttosto che forzare i rientri o cercare di ostacolarli con promesse vane è più opportuno intercettare chi rientra quando la curva della sua permanenza all’estero entra nella fase discendente grazie alla quale si avrà verosimilmente un migrante più motivato a inserirsi nel Paese di origine, e pronto a mettere a disposizione una maggiore conoscenza e professionalità.
Tuttavia il nodo più difficile da sciogliere per le più recenti generazioni di migranti sarà costituito proprio dalle ragioni che sono state all’origine della loro decisione: quella fuga dal sistema Italia che, dagli studi e le ricerche fatte nel nostro Paese, non induce al ripensamento più del 20 per cento di chi è espatriato. Anche a questo proposito occorre fare un discorso chiaro. Vecchie convinzioni culturali e teorie prevalenti hanno attribuito al fenomeno migratorio un esclusivo carattere economico, che in ultima analisi additava nella mancanza di lavoro la responsabilità della decisione di recarsi all’estero. Tutto ciò che possedeva un carattere diasporico rimaneva fuori dal discorso. Per fortuna gli altri fattori che stavano alla base della decisione di emigrare sono venuti gradualmente a galla negli ultimi decenni quando si è rifiutata l’idea che il migrante fosse un homo oeconomicus capace di assumere le proprie decisioni con insospettata razionalità. Infatti si è visto che tra le motivazioni di natura politica (per esempio, presenti nell’emigrazione italiana meridionale come conseguenza di un’unificazione non del tutto accettata) e le condizioni sociali (rifiuto della cultura opprimente del villaggio, della subordinazione alle gerarchie sociali e alle logiche familistiche, ecc.) quella economica agiva solo come concausa o, tutt’al più, come causa scatenante (non trovo nemmeno un lavoro, che cosa ci sto a fare?). D’altro canto che il più delle volte a uscire fossero le risorse migliori, giovani più coraggiosi e motivati, depone a favore del fatto che se questi, avessero avuto la costanza, avrebbero trovato una collocazione nella società non inferiore a quelli rimasti, smentendo in qualche modo la fatalità economica.
L’aspetto sociale, politico e culturale è importante non solo per capire più a fondo il fenomeno, ma anche per individuare le soluzioni. L’insofferenza nei confronti del professore universitario-barone ancora oggi è senz’altro all’origine della scelta del giovane ricercatore di trovare una collocazione altrove, così pure il dover dipendere per il posto di lavoro dal favore del politico più in vista in cambio del voto ha spinto chi non voleva adeguarsi a questo sistema a cercare lidi migliori. Discorso analogo va fatto rispetto alle visioni ristrette degli ambiti familiari e parentali che vedono il lavoro solo un’occupazione del posto e non un momento centrale nella realizzazione dell’individuo nella società come un soggetto produttivo. In buona sostanza tutti quei giovani che non hanno trovato nella società di origine il prevalere degli aspetti di meritocrazia ma solo l’affermarsi di obiettivi di mera sopravvivenza o adeguamento passivo al tessuto sociale hanno preso la decisione di andar via.
È chiaro che le soluzioni da offrire stanno tutte nel cercare di cambiare il sistema piuttosto che nella pratica dei piccoli incentivi per lo più rivolti a confermare quei tratti di società che non si accetta, come avvantaggiarsi di qualche anno di contratto in più o una retribuzione di poco superiore a quella media del residente per avvicinarsi un po’ di più a quella internazionale, aspetto quest’ultimo che per inciso innesca un’antipatica competizione locale.
È bene a questo punto tenere distinte tutte le situazioni. Star dietro le grandi professioni a livello internazionale non ha molto senso. È risaputo che nel mondo globale i grandi scienziati, i grandi manager e gli alti professionisti si muovono in base alla convenienza economica e professionale. Sperare di attrarli con espedienti di natura fiscale o, peggio, con argomentazioni sentimentali o facendo leva sulla presunta attrattività ambientale è altamente riduttivo. E non è neanche vero che da questo punto di vista in Italia non esista nulla. A meno che non si voglia ridurre tutto il discorso dei “cervelli” al comparto scientifico, la penisola presenta già eccellenze mondiali nell’ambito dell’arte (restauro e mosaici), della musica (segnatamente operistica), della gastronomia e dello sport. Direttori di musei, sovrintendenti dei teatri, responsabili di centri di ricerca gastronomica, grandi manager dello sport, sia italiani sia stranieri, vanno e vengono tuttora nel nostro Paese sulla base di una logica globale e meritocratica. Si tratta di un campo in cui prevalgono certamente logiche di selezione e di attrazione internazionale, che riguardano grandi organismi privati o a gestione privatistica che sono per fortuna sganciati dalle logiche dell’intervento pubblico. Questo, viceversa, possiede ancora ampi margini nel rendere più competitivo e meritocratico il sistema universitario, da cui si registra la maggiore fuga, oppure per sfrondare gli orpelli burocratici che impediscono a chi vuole mettere su impresa di farlo celermente e senza intoppi.
Diciamo che questi sono i grandi temi che stanno al centro dell’attenzione politica e dei media, ma ve ne sono degli altri che ne afferiscono inconsapevolmente anche se su di questi non vi è altrettanta visibilità. Parliamo del rientro delle generazioni di emigranti uscite a suo tempo e che oggi manifestano l’intenzione di rientrare. Il problema non è tanto semplice. In genere quasi tutti i discendenti degli italiani hanno perso la lingua della madre patria dei loro genitori. A parte che questa era poco parlata tra gli stessi emigranti che preferivano i rispettivi dialetti, nella nuova terra la lingua di Dante non serviva, talvolta anzi insospettiva come oggi da noi gli idiomi mediorientali. Quindi oggi va ripreso in qualche modo questo discorso attraverso un insegnamento della lingua italiana mirato e non diffuso a una generalità indistinta che non saprà che uso farne, se non strettamente culturale. In caso contrario avremo il fenomeno dei discendenti italiani dell’America latina che si fermano in Spagna invece che continuare per l’Italia.
Una volta che si possiede la lingua e la volontà di entrare nel nostro Paese il problema consiste nel superamento delle barriere burocratiche o, meglio, degli istituti che rendono possibile l’ingresso. Lasciando per ora da parte il problema della cittadinanza su cui si stenta a trovare un accordo politico a chi concederla, rimane quello dei visti e dei permessi che sono più utili alla causa giacché chi li ottiene è costretto a fermarsi nella penisola al contrario della prima cittadinanza che non solo può essere spesa in Europa, ma anche negli Stati Uniti (che oggi peraltro protestano per questo aggiramento delle loro norme). Dunque, il primo limite che risente la concessione di questo istituto amministrativo è l’assoggettamento alle norme che regolano tutti i migranti. È ovvio che se si vuole impostare una politica specifica, occorre semplificarne la concessione e creare per legge un qualche automatismo, una sorta di corsia privilegiata. Una volta in Italia il problema diviene prevalentemente delle Regioni e degli enti locali. In questo senso il convegno fatto a Cagliari il 28 settembre è servito a far chiarezza sui diversi aspetti. In primo luogo, l’aspetto dell’accoglienza. Se è vero che sugli “italiani” che rientrano non vi è l’ostilità che circonda gli immigrati che provengono dal continente africano, ve ne è comunque un’altra alimentata dal risentimento nei confronti di chi a suo tempo abbandonò la propria terra rinunciando a combattere e lasciando soli coloro che invece ritenevano di doverlo fare.
Il tema del risentimento nei confronti del migrante italiano da parte della società di origine non è mai stato studiato a fondo, ma è trapelato qua e là negli scritti di chi ha studiato il problema. La ragione è quella che abbiamo accennato prima. La rigida militanza in scuole di pensiero che vedevano nella causa economica l’unica degna di essere presa in considerazione ha impedito chi indagava di spingersi oltre qualche semplice constatazione. Le impostazioni degli studi internazionali più recenti hanno consentito di configurare il migrante come un soggetto sulle cui scelte influiscono più fattori. Perciò il cosiddetto richiedente asilo non può essere facilmente distinto dal migrante economico, come pretendono oggi le burocrazie dei Paesi di accoglienza, in quanto nello stesso tempo è l’uno e l’altro nella misura in cui fuggendo da una situazione politica o di guerra, in cui ha perso tutto, ha la necessità ricrearsi anche una posizione economica e non solo di mettere al sicuro la pelle.
Nel caso della tradizionale emigrazione italiana la decisione di abbandonare il Paese è stata spesso il frutto di una critica nei confronti della società in cui si viveva e di cui non si sopportavano più tradizioni familiari, pratiche sociali e religiose e l’ambiente politico-sociale, come si è detto. Perciò già l’uscirne era ed è spesso considerato come un gesto di contestazione della società in cui si vive. Questa condizione, per giunta, nella vecchia emigrazione si proiettava nel tempo e in qualche modo riemergeva negli occasionali rientri in patria. Infatti il migrante, come tutte le persone che vivono a cavallo di due culture, tende a mostrare un’ambivalenza che lo rende non troppo accetto alle società in cui vive quando tende a esaltare le forme dell’organizzazione sociale e politica del nuovo Paese in contrapposizione con quelle considerate superate di quello di origine e, dall’altro, quando si trova nel primo, tende a sottolineare le differenze e i valori del secondo – la cucina, il senso dell’amicizia, la solidarietà, ecc. – col risultato che non si rende accetto né dall’una né dall’altra parte.
La percezione di codesta diffidenza si proietta anche nelle istituzioni – costantemente messe a confronto dal migrante con quelle del Paese in cui ora vive – col risultato che queste tendono a chiudersi e a divenire ostili nei suoi confronti. Da qui i drammi che si affrontano quando si ha a che fare non solo col sistema sanitario o dell’istruzione italiani (notoriamente fanalini di coda soprattutto nelle regioni del Sud Italia), ma anche più banalmente con le istituzioni preposte a concedere visti e permessi. Testimonianze raccolte in questo campo hanno consentito di confermare come chi si occupi di visti o di cittadinanza abbia la tendenza a opporre resistenze culturali dell’ordine indicato, auspicando esplicitamente in cuor suo che l’utente non proceda ulteriormente a infastidire l’ufficio e torni quanto prima da dove proviene. Certamente influisce su questo atteggiamento anche la situazione poco felice che vive l’Italia che induce molti a ritenere che l’italiano che si è sistemato all’estero in qualche modo abbia risolto i propri problemi e stia solo infastidendo chi è dovuto restare nel Paese a fronteggiarne di maggiori.
Per queste ragioni l’insediamento o il reinsediamento nelle zone da cui un tempo erano partiti i propri antenati è destinata a creare problemi in ordine all’accettazione di questi soggetti da parte della stessa popolazione residente. Per prima cosa chi indossa la veste di funzionari pubblici rallenta o nega concessioni e permessi, mentre come utente in senso più generale tende a boicottare le iniziative. Un caso di scuola è stato registrato di recente proprio in Sardegna. Giovani emigrati fondano una start up per l’agroalimentare in una certa zona, immediatamente un residente affianca una porcilaia costringendo i primi a sloggiare. In questi casi non c’è niente da fare. Il diritto non va contro chi boicotta l’iniziativa. Per questo motivo sosteniamo che spesso il cambiamento, il ripopolamento sono visti solo teoricamente di buon occhio, a condizione cioè che nulla cambi o, come si suol dire con un’espressione più elegante alla moda, che non si alteri l’identità del territorio. Un ragionamento che è una gigantesca contraddizione in termini, perché qualsiasi nuovo insediamento – si tratti di africani o mediorientali oppure di giovani europei – è destinato comunque a modificare alla lunga tratti dell’identità culturale. Non voler pagare neanche questo sia pur minimo prezzo da parte di chi auspica di rivitalizzare un territorio è evidente che non porta da nessuna parte
Tutto ciò avviene nonostante il ripopolamento di un’area sia presentato come l’ipotesi più rispettosa di una cultura e di un’identità giacché, a differenza di altri insediamenti, chi “rientra” presenta la medesima matrice culturale e gli stessi caratteri fisici non si discostano troppo da quelli dei residenti. La verità è che forse la distanza culturale maturata in altri contesti è più grande di quanto non sembri.
In conclusione, posto che non si potrà evitare l’uscita di scena dell’attuale generazione, qualunque decisione si prenda in merito alla sua sostituzione non sarà priva di conseguenze rispetto ai presunti tratti originari del Paese e sarà comunque destinata a produrre conflitti e adattamenti forzati.
Dialoghi Mediterranei, n. 39, settembre 2019
______________________________________________________________
Aldo Aledda, saggista e ricercatore, esperto di pubblica amministrazione, coordinatore del “Comitato 11 ottobre d’iniziativa per gli italiani nel mondo”, è presidente del centro studi CEDISE e autore del libro Gli italiani nel mondo e le istituzioni pubbliche (Franco Angeli 2016).
_______________________________________________________________