di Laura Sugamele
Stupro etnico e reificazione sociale
Nel nazionalismo balcanico, l’intreccio tra genere, etnia e procreazione femminile ha condotto ad una sovrapposizione della sfera biologica con quella sociale, declinando le conseguenze di tale allineamento sul corpo femminile, corpo che nella guerra serbo-bosniaca (1992-1995) divenne uno “strumento” delle azioni belliche (Richter 2018: 100). Tale delineazione sociale va individuata già nella fase pre-bellica: la dissoluzione del territorio jugoslavo vede infatti, prima la caduta del muro di Berlino il 9 novembre 1989 e poi la fine del periodo titino, segnato dalla disgregazione geopolitica, disgregazione nella quale, conflittualità tra gruppi e categorizzazione delle identità su specifiche visioni culturali e sessuali, diventano funzionali per la formazione di nuove configurazioni collettive-nazionali tese a favorire l’uniformità di elementi sociali, gerarchici, di genere ed espressamente fondati su base etnica. Difatti, nella Jugoslavia titina gli odi e i conflitti etnici, deflagrati durante la seconda guerra mondiale, rimasero latenti grazie ad una politica della fratellanza e dell’unità, per poi riemergere alla morte di Tito, il “padre della patria” (Patuelli 2004: 46).
In questa ottica, il nazionalismo serbo ha affermato le proprie istanze gerarchiche e di contrapposizione etnica, attraverso la cristallizzazione di categorie patriarcali e di genere, a loro volta, convergenti su una configurazione del ruolo femminile come “riproduttore” della nazione. Perciò, l’inscrizione dell’elemento sessista nello statuto ideologico della nazione, sostanzialmente, vede il sistema dicotomico-patriarcale porsi come principio cardine di una omologazione nazionale sostenuta da una sorta di “fraterna” collaborazione maschile e da una identificazione delle donne con la stessa appartenenza collettiva, nella quale la rappresentazione “corporea” e “procreativa” femminile è considerata quindi, quale traslazione sessuale della patria. Di conseguenza, nell’ottica di una idea patriarcale che vede nella donna il simbolo della purezza nazionale, lo stupro etnico risulta essere determinante di una umiliazione pubblica, causata contro la parte maschile della comunità etnica ritenuta avversa, come emerge nella testimonianza di una donna anziana sopravvissuta alla guerra dei Balcani:
«Sono di Prijedor, e quando questa guerra ha condotto le bande dei cetnici nel nostro paese, hanno incendiato tutto, hanno portato via e ammazzato il bestiame, e saccheggiato tutto quello che durante la vita eravamo riusciti a ricostruirci. […] Mentre ci buttavano fuori di casa, nel cortile accanto, li ho visti trascinare fuori per i capelli la nostra vicina Armina, dopo di che l’hanno travolta i corpi di tre uomini. L’hanno stuprata davanti ai familiari, davanti agli occhi del padre e del fratello più piccolo. La madre è svenuta, il padre e il fratello piangevano fiumi di lacrime. Non ho mai visto un uomo piangere tanto amaramente. Hanno violentato la povera ragazza, poi hanno preso anche le sue due sorelle. Ho visto torturare e violentare anche loro. Le hanno sbattute a terra e hanno deriso le sventurate ragazzine» (Pašić 1993: 55-56).
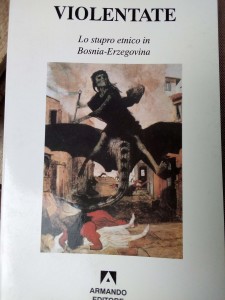 Secondo una visione che vede lo stupro delle donne come un “possesso” sulla nazione del nemico, le violenze sono adoperate in modo tale da creare terrore sulla popolazione, costringendola ad abbandonare la propria terra e la casa, laddove l’attuazione degli stupri caratterizzati dall’ostentazione pubblica degli atti esibiti davanti ai padri, fratelli, figli e mariti, aveva peraltro l’obiettivo di ledere la virilità del nemico.
Secondo una visione che vede lo stupro delle donne come un “possesso” sulla nazione del nemico, le violenze sono adoperate in modo tale da creare terrore sulla popolazione, costringendola ad abbandonare la propria terra e la casa, laddove l’attuazione degli stupri caratterizzati dall’ostentazione pubblica degli atti esibiti davanti ai padri, fratelli, figli e mariti, aveva peraltro l’obiettivo di ledere la virilità del nemico.
In tal senso, c’è da sottolineare che le violenze sessuali in realtà erano esplicitamente dirette agli uomini, così da decostruire una definizione della continuità maschile, cristallizzata all’interno di una immagine della proprietà e del disonore nazionale che ha il suo apice nella rappresentazione sessuale e materna del corpo femminile. Nel contempo, il “destino biologico” della donna si sedimenta su una ideologia strutturalmente fondata nella superiorità etnica, ideologia che identifica il suo corpo quale principio cardine della procreazione nazionale, individuato come il “nemico” principale da distruggere. In tali termini, la legittimazione del potere maschile di un gruppo su un altro tende ad esplicarsi nel modo più brutale, ossia mediante lo stupro delle donne e le gravidanze forzate, il cui risultato è quello di produrre una totale disumanità.
Da questo punto di vista, un certo particolarismo di idee patriarcali e culturali, dunque, conduce ad una progressiva esaltazione di aspetti collettivi-comunitari su cui viene a strutturarsi la nuova idea di nazione, innestata sull’elemento dell’omogeneità sessuale, la cui azione è disgregante per le altre identità, in particolare per la soggettività femminile, così ridotta a mero ruolo procreativo-nazionale.
Nel conflitto serbo-bosniaco – come del resto, in altri conflitti che hanno caratterizzato la storia contemporanea [1] – la contrapposizione etnica si innesta sul principio della rivendicazione nazionale, principio a sua volta connesso ad un altro principio, quello che identifica la guerra come una prerogativa fondata sul genere, in quanto è sul genere femminile che la guerra tende a concentrare le sue finalità aggressive, umiliando il nemico, intaccando – come si è detto – la sua virilità attraverso lo stupro delle sue donne, il cui valore – in una linea antropologica-patriarcale – è riconducibile ad una rilevanza che il corpo femminile acquisisce in senso procreativo e riproduttivo.
In tale orizzonte di senso, per il violentatore il fine principale è la personale “soddisfazione” di aver prodotto sul nemico, tramite le donne, una devastante degradazione, in primo luogo sessuale, destinata a traslarsi sul piano etnico-nazionale. Così, la sopraffazione ha il proprio fondamento su una profonda lacerazione, determinata da una metaforica e materiale invasione attuata sul corpo femminile allorché, la “distruzione” intima e sessuale produce una frammentazione delle relazioni umane precedenti, dilatandosi su quelle future.
Durante il conflitto della Bosnia-Erzegovina, gli stupri perpetrati in prevalenza su donne bosniache di religione musulmana, si sono delineati quindi, similmente ad una sofferenza inflitta all’integrità identitaria del gruppo di cui esse erano parte, in quanto fulcro della continuità etnico-riproduttiva della comunità bosniaca. Ševko Omerbašić, che all’epoca del conflitto era presidente della comunità islamica della Croazia-Slovenia, sottolinea che lo stupro rappresenta un disonore pubblico per una donna, data la sua immagine eminentemente simbolica della purezza collettiva. Tale aspetto, impone di focalizzare l’attenzione sulla centralità del ruolo femminile – storicamente declinato all’interno di un meccanismo di alleanze matrimoniali e scambi sessuali-procreativi – come “elemento” di notificazione e perpetuazione dell’identità bosniaca nonché della riproduzione culturale musulmana.
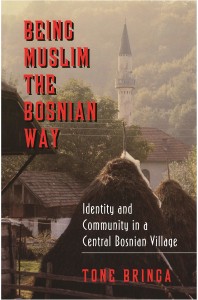 Come osserva l’antropologa Tone Bringa (Bringa 1995), la rappresentazione sociale del ruolo femminile corrispondeva alla kuća, cioè la casa; per cui, l’identità musulmana, fondata sia sull’appartenenza etnica, sia su un sistema sociale dicotomico, era sedimentata su una costruzione gerarchica della società che vedeva da una parte gli uomini titolari e proprietari della kuća, dall’altra le donne come sue sostenitrici (Bringa 1995: 86). In tal modo, nella strategia nazionalista serba volta, attraverso lo stupro delle donne bosniache, all’impregnazione forzata, il fine era la creazione di una “nuova” Nazione, purificata ed omogenea sul piano etnico, cosicché la violenza sulle donne era determinante di una lacerazione della kuća patriarcale, impattando sull’etnia ritenuta avversa.
Come osserva l’antropologa Tone Bringa (Bringa 1995), la rappresentazione sociale del ruolo femminile corrispondeva alla kuća, cioè la casa; per cui, l’identità musulmana, fondata sia sull’appartenenza etnica, sia su un sistema sociale dicotomico, era sedimentata su una costruzione gerarchica della società che vedeva da una parte gli uomini titolari e proprietari della kuća, dall’altra le donne come sue sostenitrici (Bringa 1995: 86). In tal modo, nella strategia nazionalista serba volta, attraverso lo stupro delle donne bosniache, all’impregnazione forzata, il fine era la creazione di una “nuova” Nazione, purificata ed omogenea sul piano etnico, cosicché la violenza sulle donne era determinante di una lacerazione della kuća patriarcale, impattando sull’etnia ritenuta avversa.
«Muslim women had been deliberately impregnated and kept so long in confinement that they would be forced to bear “Serb” children» (Mojzes 2011: 186). La donna soggetta allo stupro, dunque incarna la conquista del “territorio”, ragion per cui, l’aggressore per affermare il suo dominio distrugge il “bene sessuale” del nemico, con la conseguenza che le donne stuprate diventano uno “strumento” essenziale nei genocidi (Cacik-Kumpes 1995: 14).
Femminismo e attivismo: la forza della rivendicazione e il Tribunale delle donne
Dall’accordo di Dayton del 14 dicembre 1995, la situazione post-bellica in Bosnia è caratterizzata dalla regressione economica, dalla frammentazione sociale e dalla presenza di danni psicologici sulla popolazione, soprattutto su quella femminile. La fase post-bellica è inoltre segnata dalla divisione territoriale tra repubblica di Srpska e città di Srebrenica (in prevalenza abitate da serbo-bosniaci), federazione di Bosnia-Erzegovina (formata da bosgnacchi e croati) e distretto di Brčko, autonomo dal 1999. Ulteriormente, la fase post-bellica si è caratterizzata per un sostanziale irrigidimento delle relazioni etniche, sociali e familiari, relazioni connotate da una forte polarizzazione culturale tra uomini e donne (Tompuri 2010: 64).
È appena il caso di sottolineare la condizione femminile nel periodo post-bellico, contrassegnata – come informano le associazioni di assistenza alle donne vittime di violenza – da ristrettezza economica giacché, solo poche donne, immediatamente dopo la fine della guerra, sono riuscite a ricevere un sussidio mensile. Per quanto concerne, invece, la frammentazione dei rapporti sociali e familiari, è rilevante evidenziare che la situazione di allontanamento dal territorio di circa 2 milioni di persone è stata determinante di una reificazione e di uno smembramento sul piano socio-relazionale [2], la cui conseguenza sulle persone è stata la perdita dell’individualità e dell’identità come appartenenza sociale.
Dai dati emersi dall’indagine della Women’s Commission for Refugee Women and Children, con la fine della guerra, anche gli uomini – e non solo le donne – hanno avuto problemi di reinserimento sociale e stress psicologico, fattore a cui, secondo l’organizzazione sembra essere anche collegato l’aumento delle violenze e degli abusi in famiglia [3]. In tal modo, il contributo del femminismo è stato rilevante non solo per il fatto di avere messo in evidenza le problematiche connesse agli eventi bellici e alla grave condizione socio-economica di donne e uomini, ma soprattutto per aver attuato una critica nei confronti di una ideologia nazionalista – quella serba – fortemente distruttiva e concentrata su una specifica rivendicazione nazionale, consustanziale ad una concettualizzazione del corpo femminile, in cui le donne del “nemico” sono diventate “spazio” politico sia del primato nazionale, sia della contrapposizione etnica.
L’associazione pacifista e antimilitarista Women in Black (Žene u crnom), letteralmente “Donne in nero”, fondata a Belgrado nel 1991, all’epoca del conflitto serbo-bosniaco decise di assumere parte attiva e prendere posizione, criticando pubblicamente le azioni militari dei nazionalisti serbi e la loro devastante componente ideologica, e questo obiettivo divenne centrale per il Tribunale delle Donne di Sarajevo, aperto il 7 maggio 2015, la cui iniziativa di discussione, critica a ricordo delle violenze, venne attuata da molte donne tra cui attiviste, avvocatesse, giornaliste e filosofe, intellettuali grazie alle quali si diede avvio ad attività volte alla promozione della giustizia in ambito internazionale e penale.
Difatti, quando le femministe della Women in Black organizzarono la prima protesta che avvenne nel 1991 a Belgrado, lo fecero con il fine di opporsi a qualsiasi logica maschilista, dicotomica, nazionalista e politico-discriminatoria, che avevano in Slobodan Milošević il fulcro di tali ideologie. A quel punto, la partecipazione delle donne ad incontri collettivi ebbe il fine di creare un “ponte” inter-jugoslavo, che la guerra e il nazionalismo tentavano di ostacolare, a causa delle barriere etniche costituite; donne che decisero con grande determinazione di affermare le proprie convinzioni ispirate alla solidarietà, al sostegno reciproco e alla sorellanza (Camillotti 2011: 263).
Contemporaneamente al movimento sorto nell’ex-Jugoslavia, altri movimenti con analoghi obiettivi si svilupparono in Spagna e in Italia, Paesi nei quali la corrente femminista ha trovato forza nei dibattiti antimilitaristi così che, in questa crescente rete di donne, il movimento è diventato internazionale, grazie all’elevato livello di comunicazione e di unione dell’attivismo femminile (Cockburn 2015: 112).
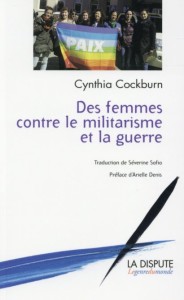 Ne è un esempio il gruppo delle “Donne in Nero” di Barcellona, che nel 1993, nella città di Zagabria, istituì il Centro per le donne vittime di guerra, per offrire un sostegno e uno spazio di confronto e di incontro. In tal senso, come sostiene Staša Zajović, attivista per la pace e co-fondatrice del movimento Women in Black, gli eventi in Bosnia non vanno dimenticati, ma mantenuti saldi nella memoria, perché costituiscono un incentivo per il consolidamento di nuovi modelli di giustizia in linea femminista e la elaborazione del trauma delle violenze subite, insieme all’affermazione del principio di autodeterminazione ha, dunque, consentito di contrapporsi alla dinamica patriarcale della guerra, favorendo nelle donne la possibilità di recuperare la propria esistenza interiore e quotidianità frantumata.
Ne è un esempio il gruppo delle “Donne in Nero” di Barcellona, che nel 1993, nella città di Zagabria, istituì il Centro per le donne vittime di guerra, per offrire un sostegno e uno spazio di confronto e di incontro. In tal senso, come sostiene Staša Zajović, attivista per la pace e co-fondatrice del movimento Women in Black, gli eventi in Bosnia non vanno dimenticati, ma mantenuti saldi nella memoria, perché costituiscono un incentivo per il consolidamento di nuovi modelli di giustizia in linea femminista e la elaborazione del trauma delle violenze subite, insieme all’affermazione del principio di autodeterminazione ha, dunque, consentito di contrapporsi alla dinamica patriarcale della guerra, favorendo nelle donne la possibilità di recuperare la propria esistenza interiore e quotidianità frantumata.
Grazie al Tribunale delle donne, la verità sulle azioni brutali e di violenza commesse in guerra e testimoniate dalle vittime, ha condotto alla necessità di dare voce alle donne, scelta estesa a tutti i movimenti pacifisti e femministi dell’intera area della ex-Jugoslavia; concretamente, le attiviste sono riuscite a dare alle donne vittime di stupro un riconoscimento giuridico strutturato. Infatti, a differenza della quarta Convenzione di Ginevra (1949), che all’articolo 27 definiva lo stupro e altri atti lesivi gravi come la prostituzione forzata, alla pari di condotte tese più che altro a colpire l’onore delle donne: «women shall be especially protected against any attack on their honour, in particular against rape, enforced prostitution, or any form of indecent assault», la guerra dei Balcani coincise invece con una nuova impostazione del discorso sui diritti delle donne, nel senso che l’individuazione del carattere strumentale dello stupro ha avuto notevoli riscontri sul piano del diritto penale internazionale, determinando un cambiamento radicale sulla comprensione universale che stupri e torture costituiscono una grave lesione dei diritti umani.
 L’interesse e il sostegno delle organizzazioni femministe in tema di violenza di genere, gradualmente, hanno prodotto una estensione del campo d’azione dell’attivismo stesso, tale da prevedere l’inclusione politica delle donne nei processi di pace. Così, nella linea di una giustizia transizionale, quando nel 2015 si svolse il Tribunale delle donne a Sarajevo, il Consiglio Giudiziario del Tribunale ebbe il merito di sancire, propriamente sul piano giuridico, la corresponsabilità di tutti gli Stati balcanici nella pianificazione delle violenze e delle epurazioni etniche laddove, sostenendo il principio di corresponsabilità, si affermò anche il riconoscimento militare e politico serbo di procurare un “danno” deliberato e intenzionale alle popolazioni non serbe.
L’interesse e il sostegno delle organizzazioni femministe in tema di violenza di genere, gradualmente, hanno prodotto una estensione del campo d’azione dell’attivismo stesso, tale da prevedere l’inclusione politica delle donne nei processi di pace. Così, nella linea di una giustizia transizionale, quando nel 2015 si svolse il Tribunale delle donne a Sarajevo, il Consiglio Giudiziario del Tribunale ebbe il merito di sancire, propriamente sul piano giuridico, la corresponsabilità di tutti gli Stati balcanici nella pianificazione delle violenze e delle epurazioni etniche laddove, sostenendo il principio di corresponsabilità, si affermò anche il riconoscimento militare e politico serbo di procurare un “danno” deliberato e intenzionale alle popolazioni non serbe.
Contemporaneamente, venne riconosciuta la responsabilità delle persone colpevoli di non aver offerto sostegno a donne, bambini e bambine, uomini e anziani perseguitati per la loro appartenenza etnica, come del resto la responsabilità di scrittori ed intellettuali serbi. Dallo scrittore Dobrica Ćosić, che sosteneva l’ideologia politica di Slobodan Milošević e di Radovam Karadžić, al sociologo Vojislav Šešelj, sino a Jovan Rašković, medico e psichiatra, i quali con le loro idee nazionaliste si resero colpevoli di aver spinto in modo decisivo alla contrapposizione etnica. Nel rapporto finale, a conclusione delle discussioni avvenute nel Tribunale, vennero dunque riportati i crimini compiuti sia durante il conflitto che nella fase post-bellica, tra i quali sono da annoverare l’allontanamento dal territorio, la separazione delle famiglie, lo stupro, abusi sessuali contro donne e ragazze, omicidio, sparizione di bambini, trattamenti degradanti commessi all’interno dei campi di detenzione serba, guerra etnica volta all’aggressione e utilizzo del corpo femminile come “strumento” di guerra (De Vido 2016: 56).
In particolare, nel rapporto si sottolineava l’utilizzo deliberato degli stupri all’interno delle azioni di guerra, la persecuzione sulla base dell’etnia, religione e genere, il rafforzamento degli stereotipi e delle categorie sociali inclusa la militarizzazione della vita quotidiana, il reclutamento forzato dei civili, la stigmatizzazione delle donne vittime di stupro e sopravvissute alla guerra (ivi: 57).
In questi termini, l’attivismo delle associazioni femministe, nella consapevolezza dell’importanza di assumere una prospettiva volta alla responsabilità individuale e alla corresponsabilità collettiva, ha orientato pertanto le sue battaglie sul riconoscimento politico della guerra e dello stupro come atti centrali nella pulizia etnica in Bosnia-Erzegovina, aspetto che ha condotto le attiviste ad insistere sulle proteste e nel dibattito pubblico cui parteciparono, durante l’organizzazione del Tribunale a Sarajevo, circa cinquemila donne, attiviste e sopravvissute di guerra, e queste ultime decisero di raccontare la propria esperienza uscendo dall’oblio, riappropriandosi così della propria “voce” e dignità. Certamente, nella riflessione femminista la critica al nazionalismo e al militarismo, si è rivelata essenziale ai fini della protesta, laddove la denuncia delle politiche nazionaliste aveva l’intento di mettere in luce la connessione tra nazionalismo e patriarcato, in convergenza ad una declinazione femminile del concetto di “patria” e “purezza” etnica, tema ben caro alla politica ideologica serba che identificava il corpo della donna come “riproduttore” dell’identità nazionale. A questo proposito, i lavori della storica Victoria De Grazia (De Grazia 2005), i cui studi sono incentrati sul nazionalismo fascista, mettono bene in evidenza proprio il “ruolo riproduttivo” delle donne per la Nazione, un ruolo cardine per le politiche nazionali sull’incremento demografico, il miglioramento della razza e le pratiche di eugenetica, tutti fattori collegabili ad un discorso sessista, misogino e militarista.
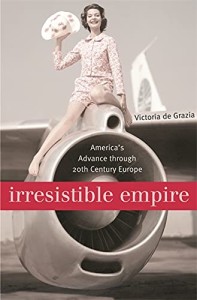 In questa prospettiva, le testimonianze fornite dalle donne sopravvissute agli stupri e alla guerra sono state concretamente utili, al fine di attivare forme di responsabilità collettiva a tutti i livelli, da quello sociale a quello politico e morale, oltre che sul piano della giustizia penale e internazionale. Il “racconto” pubblico delle esperienze personali aveva, dunque, l’obiettivo di rendere le donne non più vittime impotenti, quanto “soggetti” con una propria identità, allorché la possibilità di recuperare la “memoria collettiva” attraverso la testimonianza, ha consentito alle donne di riappropriarsi della propria autodeterminazione individuale. Come sottolinea Sara De Vido,
In questa prospettiva, le testimonianze fornite dalle donne sopravvissute agli stupri e alla guerra sono state concretamente utili, al fine di attivare forme di responsabilità collettiva a tutti i livelli, da quello sociale a quello politico e morale, oltre che sul piano della giustizia penale e internazionale. Il “racconto” pubblico delle esperienze personali aveva, dunque, l’obiettivo di rendere le donne non più vittime impotenti, quanto “soggetti” con una propria identità, allorché la possibilità di recuperare la “memoria collettiva” attraverso la testimonianza, ha consentito alle donne di riappropriarsi della propria autodeterminazione individuale. Come sottolinea Sara De Vido,
«È in questo ricordo dei reati compiuti che si innesta il nostro ragionamento sui tribunali dei popoli, e nello specifico delle donne. Là dove l’indifferenza dei governi ha impedito di ottenere giustizia e riparazione per le vittime, i tribunali dei popoli hanno contribuito a preservare e ‘mettere insieme’ la memoria collettiva. Nel caso dell’ex Jugoslavia, […] il Tribunale delle donne in Sarajevo è riuscito ad andare oltre la giustizia internazionale, dando voce alle donne vittime provenienti da ogni parte della regione, indagando non solo crimini che sono stati compiuti durante e dopo il conflitto a dimostrazione della difficoltà di ogni processo di transizione, ma anche crimini che difficilmente troverebbero collocazione in questa o quella fattispecie penale – basti pensare alla violenza economica» (De Vido 2016: 64).
È chiaro che il confronto sulle esperienze reciproche e vissute durante la guerra non aveva lo scopo di esprimere giudizi di valore sulle singole narrazioni. Nulla di questo. L’obiettivo era infatti quello di contestualizzare le “storie” personali, all’interno di un orizzonte di discussione collettiva scevro da gerarchie e dicotomie, così da contribuire alla creazione di un clima politico che ponesse in primo piano l’importanza di tutelare i diritti umani e di genere non meno della centralità del ruolo delle donne nella risoluzione dei conflitti. In tal modo, con l’adozione della risoluzione 1325 “Donne, pace e sicurezza” del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (31 ottobre del 2000), si mise in evidenza il ruolo femminile come presenza cardine nella prevenzione delle violenze e nel peace-building.
Questo cambiamento porterà nel 2004 alla formazione dell’Agency for Gender Equality, il cui scopo è quello di coordinare le attività di promozione dell’uguaglianza di genere e la non trascurabilità delle possibili violenze in tempo di guerra, come del resto, in fase di transizione e in tempo di pace, aspetto che ha spinto la comunità internazionale ad attivare concretamente la presenza delle donne nei processi di policy-making. A tale riguardo, la Commissione 780 istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite, il cui fine era di indagare sulle violazioni in campo umanitario commesse durante il conflitto della ex-Jugoslavia, ha sancito che gli stupri contro le donne in guerra, non sono un aspetto marginale, bensì una vera e propria strategia interna alle azioni militari.
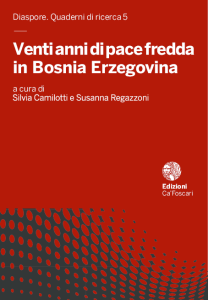 In quest’ottica, la rilevanza dell’associazionismo femminista – oltre che l’intervento delle organizzazioni non governative, sempre in linea femminista – si è resa evidente mediante il sostegno offerto alle donne che hanno subìto violenze sessuali e psicologiche, in particolare attraverso programmi di reintegrazione sociale e forme di sussistenza economica (Helms 2010: 18). Dagli aiuti per l’estensione del microcredito, ad azioni e progetti rivolti alla prevenzione della violenza di genere, nella Bosnia post-bellica, il ruolo dell’attivismo femminista in tema di sostegno e tutela dei diritti non è stato per nulla trascurabile, dato il persistente impegno per le donne nell’ambito dell’elaborazione dei traumi vissuti, elaborazione che, attraverso il racconto personale, può condurre a trasformare il dolore interiore in una “politica” dell’emancipazione (Simić 2012: 133).
In quest’ottica, la rilevanza dell’associazionismo femminista – oltre che l’intervento delle organizzazioni non governative, sempre in linea femminista – si è resa evidente mediante il sostegno offerto alle donne che hanno subìto violenze sessuali e psicologiche, in particolare attraverso programmi di reintegrazione sociale e forme di sussistenza economica (Helms 2010: 18). Dagli aiuti per l’estensione del microcredito, ad azioni e progetti rivolti alla prevenzione della violenza di genere, nella Bosnia post-bellica, il ruolo dell’attivismo femminista in tema di sostegno e tutela dei diritti non è stato per nulla trascurabile, dato il persistente impegno per le donne nell’ambito dell’elaborazione dei traumi vissuti, elaborazione che, attraverso il racconto personale, può condurre a trasformare il dolore interiore in una “politica” dell’emancipazione (Simić 2012: 133).
Sono, inoltre, rilevanti anche gli interventi volti alla ricostruzione del territorio e del processo di pace attuati dall’organizzazione non governativa Medica Zenica fondata nel 1993 in Bosnia-Erzegovina, la quale ha sostenuto le donne sopravvissute agli stupri e alla detenzione nei campi di concentramento (Spahic Šiljak 2013: 179). Pertanto, per le associazioni femministe l’impegno per la riconciliazione sociale è volto a rendere effettiva la rielaborazione interiore per le donne che hanno subìto stupro, anche in merito ad una loro reintegrazione nel tessuto sociale di appartenenza, per esempio aiutando le famiglie a capire che lo stupro non è una colpa di cui la donna è portatrice o in qualche modo istigatrice.
In conclusione, soprattutto, in ambito internazionale e umanitario, l’attivismo femminista ha avuto quindi il merito di sensibilizzare sulle conseguenze dello stupro nelle vittime e sul suo utilizzo deliberato in guerra, grazie anche alle Rules of procedure and evidence adottate dal Tribunale dell’Aja nel 1994. In particolare nella rule 96, si adopera il termine sexual assault (aggressione sessuale), che in senso lato include ogni modalità adoperata per umiliare e denigrare la vittima, affermando la non necessaria evidenza fornita dalla testimonianza della vittima di violenza; in pratica non vi è la necessità di sostenere prove ulteriori sul consenso o meno della vittima o prove di possibili forme di detenzione forzata, costrizione fisica o psicologica a cui la vittima è stata sottoposta contro la sua volontà. In tal senso, le questioni relative alla violenza di genere, lasciate dalla guerra dei Balcani hanno, chiaramente, condotto all’esigenza di un confronto sulle responsabilità collettive nei conflitti e sulla ricerca di modelli di giustizia alternativi.
Dialoghi Mediterranei, n. 53, gennaio 2022
Note
[1] Ad esempio, la guerra civile del Rwanda (1990-1994) tra Hutu e Tutsi.
[2] Tema trattato dalla scrittrice croata Slavenka Drakulić in Balkan Express (Drakulić 1993).
[3] È di rilievo il report Refugee women and domestic violence. Country studies Bosnia and Herzegovina, disponibile all’indirizzo https://www.refworld.org/pdfid/478e3c9ad.pdf
Riferimenti bibliografici
Bringa Tone, Being Muslim the Bosnian Way: Ideology and Community in Central Bosnian Village, Princeton University Village, Princeton, 1995.
Cacik-Kumpes Jadranka, War, Ethnicity, and Violence Against Women, in «Refuge. Revue canadienne sur les réfugiés», 14 (8), 1995: 12-15, https://doi.org/10.25071/1920-7336.21848
Camillotti Silvia, Le donne in nero si raccontano. Scritti di Marianita De Ambrogio, Staša Zajović e Lepa Mladjenović, «DEP. Deportate, esuli, profughe. Rivista telematica di studi sulla memoria femminile», 15, 2011: 261-292.
Cockburn Cynthia, Des femmes contre le militarisme et la guerre, La Dispute, Paris, 2015.
De Grazia Victoria, Irresistible Empire: America’s Advance Through Twentieth Century Europe. Belknap press, Harvard, 2005.
De Vido Sara, Il Tribunale delle donne in Sarajevo, in «Diaspore Quaderni di ricerca», 10/2016, DOI 10.14277/6969-094-5/DSP-5-5
Drakulić Slavenka, Balkan Express, Fragments from the Other Side of the War, W.W. Norton, New York, 1993.
Helms Elissa, The gender of coffee: Women and reconciliation initiatives in post-war Bosnia and Herzegovina, in «Focaal-Journal of Global and Historical Anthropology», 57, 2010: 17–32, doi: 10.3167/fcl.2010.570102
Mojzes Paul, Balkan Genocides: Holocaust and Ethnic Cleansing in the Twentieth Century, Rowan & Littlefield Publishers, Plumouth, 2011.
Pašić Ehlimana, Violentate. Lo stupro etnico in Bosnia-Erzegovina, Armando, Roma, 1993.
Patuelli Maria Chiara, Profughe in Serbia. Migrazioni forzate, identità etno-nazionale e relazioni di genere, in «Genesis. Rivista della Società Italiana delle Storiche», III/2, 2004, http://dx.medra.org/10.1400/78301
Richter Melita, Il superamento dell’eredità della guerra e la sfida all’ingiustizia strutturale: il Tribunale delle Donne e l’approccio femminista alla giustizia, in «Qualestoria. Rivista di storia contemporanea», anno XLVI, 2, 2018: 96-109.
Simić Olivera, Challenging Bosnian Women’s Identity as Rape Victims, as Unending Victims: The ‘Other’ Sex in Times of War, in «Journal of International Women’s Studies», 13 (4), 2012: 129-142.
Spahic Šiljak Zilka, Do It and Name It: Feminist Theology and Peace-Building in Bosnia and Herzegovina, in «Journal of Feminist Studies in Religion», 29 (2), 2013: 176-184, https://doi.org/10.2979/jfemistudreli.29.2.176
Tompuri Elina, Rape Warfare in the Bosnian War. The Bosnian Women during Serbian Occupation: a case study of gendered violence during wartime, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2010.
______________________________________________________________
Laura Sugamele, dottoressa di ricerca in Studi Politici (Università “La Sapienza”), i suoi interessi di ricerca si rivolgono agli studi di genere, filosofia politica, storia del pensiero femminista con un focus sullo studio del femminismo postcoloniale. È autrice di Bioetica e femminismo. Rivisitazione dell’etica dei principi e sviluppo della competenza dell’autonomia (Stamen 2016) e Percorsi e teorie del femminismo tra storia, sviluppi e traiettorie concettuali (Aracne 2019).
______________________________________________________________










