di Dario Inglese
Nelle settimane che hanno preceduto l’approvazione del DDL Cirinnà, gli oppositori della legge che regola le Unioni Civili hanno parlato spesso della famiglia nucleare – formata da uomo, donna e figlio/i – come di un dato antropologico originario. Utilizzando, di volta in volta, riferimenti diretti alla Natura (“Famiglia Naturale”) o alla Cultura (“Famiglia Tradizionale”), la famiglia nucleare eterosessuale, riconosciuta dal vincolo del matrimonio, è stata difesa perché valore assoluto: espressione di ciò che ci rende pienamente umani. Peccato, però, che in quest’uso disinvolto dell’aggettivo “antropologico” i sostenitori del Family Day abbiano ignorato proprio la letteratura antropologica e si siano accontentati di un’antropologia spontanea utile a fare della famiglia – della loro concezione di famiglia – un fatto universale, eterno e immutabile anziché un terreno di scelte e decisioni mutevoli. Un vero peccato si diceva. Proprio sul tema, infatti, l’antropologia culturale ha prodotto un discorso scientifico utile a smontare lo stereotipo etnocentrico che pretende l’estensione di un fenomeno locale a norma generale; un discorso che, prendendo le mosse dalla pratica etnografica, ha sfidato le convinzioni radicate nel senso comune ben riassunte dall’incisiva formula di Françoise Heritier: «tutti sanno – o credono di sapere – cos’è la famiglia. È iscritta in modo talmente forte nella nostra pratica quotidiana da apparire a ciascuno di noi come un fatto naturale e, per estensione, universale» (Heritier 1979: 3).
La famiglia, in effetti, è stata uno dei principali oggetti di studio dell’antropologia fin dalle sue origini. Quando l’espansione occidentale raggiunse ogni angolo del globo e amministratori, soldati, missionari o esploratori entrarono in contatto con i costumi delle popolazioni indigene, i sistemi di parentela suscitarono immediatamente grande attenzione e fornirono parecchio materiale ai primi antropologi. Man mano che le esigenze governative d’oltremare imponevano una conoscenza crescente degli usi nativi – esigenze che richiedevano una comprensione più puntuale di quella fornita dall’approccio esotista di viaggiatori o semplici curiosi – i protagonisti della nascente sociologia comparata si ritrovarono, in molti casi, a riflettere su dati che mettevano a dura prova le loro categorie interpretative. A colpire fu, soprattutto, la terminologia usata da certi gruppi indigeni: come spiegare, ad esempio, che presso alcuni popoli lo zio materno era indicato con lo stesso nome del padre? O che fosse per l’appunto lo zio a occuparsi dell’educazione del nipote al posto del padre? Proprio partendo da simili stranezze, Lewis Henry Morgan, studiando gli indiani Irochesi, dava inizio all’antropologia della parentela: ci sono società, diceva, che dividono nettamente i parenti lineari (padre, madre, figli) da quelli collaterali (zii, cugini) e altre, invece, che usano gli stessi termini per indicare consanguinei diversi. Morgan paragonava il sistema irochese a quello occidentale: mentre il secondo (il suo, il nostro) era fedele alle prescrizioni biologiche, il primo era lontano dai dettami naturali, espressione di uno stadio d’incivilimento più arretrato (cfr. Remotti 2008: 65-66). I primi antropologi, dunque, s’interessarono molto alle terminologie selvagge: essi si muovevano all’interno della cornice teorica dell’evoluzionismo sociale e consideravano gli usi nativi segno di ritardo culturale e ignoranza rispetto ai meccanismi della procreazione. Tuttavia, interessandosi alle curiosità dei popoli lontani, iniziavano inconsciamente a riflettere sul proprio modello di famiglia, il quale, pur essendo considerato acquisizione di una civiltà al culmine dell’evoluzione (quella dell’Inghilterra vittoriana di fine ‘800), iniziò timidamente a uscire «da una condizione di neutralità epistemologica per divenire un oggetto d’interesse scientifico» (Remotti 2008: 86).
Quando, nel tempo, l’antropologia culturale elaborò una metodologia di ricerca basata sulla cosiddetta “osservazione partecipante”, cioè sulla necessità di studiare le società sul campo e per un tempo prolungato, le credenze sull’ignoranza delle popolazioni indigene vacillarono fino a cadere. Gli studiosi abbandonarono la pretesa di legittimare scientificamente la gerarchia tra le culture e, in particolare, le ricerche dimostrarono che le stranezze familiari non erano sopravvivenze di stadi evolutivi arcaici né capricci di popoli primitivi lontani dal progresso. Erano piuttosto sistemi complessi alla cui realizzazione concorrevano fattori culturali, storici, economici, politici, ecologici, biologici. L’acquisizione di un’abbondante messe di dati, soprattutto, aggiunse ai due sistemi parentali indicati da Morgan una molteplicità di casi che scalfirono l’illusione della naturalità e universalità del modello occidentale [1].
Nei loro viaggi intorno al mondo, di forme di famiglia gli antropologi ne hanno scovate tante e una veloce carrellata [2] può servire a relativizzare la nostra prospettiva e a mostrarci che forse le nostre sicurezze dovrebbero essere quantomeno ripensate. Si può così partire dalla poligamia, uno degli spauracchi della morale occidentale (forse per via della prossimità geografica di alcune società che la adottano?), e osservare famiglie poli- giniche in cui un uomo ha più mogli e, meno diffuse ma etnograficamente attestate (ad esempio tra i Nyimba del Nepal), famiglie poliandriche in cui è la donna, invece, ad avere più mariti. Ci sono poi i co-matrimoni: casi in cui l’alleanza tra famiglie nucleari in territori ostili (come quello polare degli Inuit) è sancita dallo scambio dei partner e dai titoli ufficiali di co-moglie e co-marito. E ancora: unioni omosessuali praticate (prima di essere ferocemente sradicate dai conquistatori europei) da molte tribù native americane in cui, sancita l’esistenza di un terzo genere, uomini e donne (chiamati sovente “due spiriti” ad indicare la coesistenza in uno stesso corpo del maschile e del femminile) sposavano individui dello stesso sesso senza alcuna riprovazione pubblica. Si può continuare con le famiglie consanguinee dei ‘Na di Cina e dei Nayar dell’India: gruppi domestici di fratelli e sorelle che vivono insieme pur avendo rapporti sessuali e procreando con estranei (l’incesto, ovviamente, è proibito). Sono famiglie che non prevedono matrimonio e che si basano sulla regola della cosiddetta residenza natolocale: gli individui continuano ad abitare nella casa in cui sono nati e cresciuti. Sono, secondo l’efficace espressione dell’antropologo Cai Hua, famiglie “senza padre né marito” giacché i figli delle donne sono cresciuti in collaborazione con i fratelli. La stessa regola natolocale è altresì applicata in contesti che prevedono vincoli coniugali: prendiamo, ad esempio, la figura del Visiting Husband diffusa in molte società matri-centriche dell’Africa. Presso i Senufo della Costa d’Avorio un marito con più mogli continua a vivere presso la casa del suo gruppo d’origine e, ogni notte, fa visita a una delle mogli che risiedono altrove. In questo caso il matrimonio non si traduce in convivenza e la famiglia, composta di fratelli e sorelle, è sempre consanguinea.
E che dire poi di alcuni esperimenti che sfidano apertamente ogni nostra categorizzazione? Tra i Nuer, popolazione a discendenza patrilineare del Sudan, Edward Evans-Pritchard ha documentato casi in cui le donne sterili sono trattate come se fossero uomini: assumono, cioè, gli stessi diritti e doveri dei fratelli maschi. Non potendo andare in spose a un uomo di un altro lignaggio, anziché rischiare di essere un peso per i parenti ed essere emarginate, esse possono sposare un’altra donna. In questo caso, non si ha a che fare con un’unione omosessuale in senso stretto ma con una finzione giuridica. Proprio come farebbe un marito, queste donne si prendono cura delle loro mogli e, in più, trovano loro un uomo con cui procreare: i figli nati da questo legame apparterranno alla donna-marito e al suo lignaggio ed entrambi non subiranno i contraccolpi sociali, economici e psicologici della sterilità. Oppure, consideriamo l’istituto del Ghost Marriage attivo, sempre in società patrilineari, quando un uomo muore prima di aver avuto figli. Per evitare che con la scomparsa di un individuo maschio il suo lignaggio cessi, i Nuer, sempre loro, hanno sviluppato un’altra scappatoia giuridica: un parente del morto, utilizzando il bestiame a lui appartenuto, sposa una donna la quale è, in tutto e per tutto, moglie del fantasma. Analogamente, i figli frutto di quest’unione apparterranno al defunto e ne porteranno avanti il nome e la stirpe.
E se alla fine di questo breve giro intorno al mondo qualcuno, infastidito, obiettasse che in tutte queste strambe forme di famiglia – checché ne dicano indigeni e antropologi troppo fedeli al precetto malinowskiano: “vedere le cose dal punto di vista del nativo” – i figli hanno comunque, sempre, un solo padre e una sola madre? Beh, si potrebbe rispondere che molte culture hanno pensato (e attuato) forme di multigenitorialità nella consapevolezza che non basta generare per essere considerati veramente padre e madre, né per fare una famiglia. Una volta svezzati, i bambini Mossi del Burkina Faso, ad esempio, sono affidati a donne in menopausa che assumono, a tutti gli effetti, il ruolo di madre (e come tali sono chiamate e considerate dai figli). Ovviamente la genitrice che li ha partoriti non scompare e resta una figura di riferimento nella vita dei piccoli. Solo i Mossi ritengono che generazione e educazione della prole siano compiti da assegnare, per il bene dei bambini, a madri diverse ma ugualmente importanti.
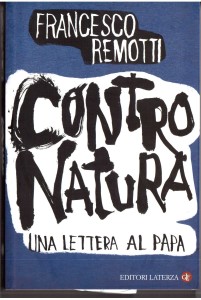 Come mi auguro di aver mostrato, nelle loro peregrinazioni gli antropologi si sono imbattuti in innumerevoli sistemi familiari mettendo insieme un serbatoio di dati che, anziché restare esclusivo patrimonio disciplinare per convegni e pubblicazioni specialistiche, potrebbe rivelarsi molto utile nel confronto con chi oggi in Italia difende a spada tratta la famiglia nucleare naturale. Posto così, il problema riguarda il come servirsi di questo sapere. Che cos’hanno cioè da mostrare i Nuer al lettore italiano oltre a suscitare, quando va bene, un’effimera curiosità esotista? E più in generale, cos’ha da dire l’antropologia? L’antropologo che relativizza e si produce in interminabili elenchi di strani casi etnografici sta dicendo qualcosa di sensato sulla famiglia o sta solo tergiversando perché, perso in questo mare di diversità, non è in grado di esprimere una posizione chiara?
Come mi auguro di aver mostrato, nelle loro peregrinazioni gli antropologi si sono imbattuti in innumerevoli sistemi familiari mettendo insieme un serbatoio di dati che, anziché restare esclusivo patrimonio disciplinare per convegni e pubblicazioni specialistiche, potrebbe rivelarsi molto utile nel confronto con chi oggi in Italia difende a spada tratta la famiglia nucleare naturale. Posto così, il problema riguarda il come servirsi di questo sapere. Che cos’hanno cioè da mostrare i Nuer al lettore italiano oltre a suscitare, quando va bene, un’effimera curiosità esotista? E più in generale, cos’ha da dire l’antropologia? L’antropologo che relativizza e si produce in interminabili elenchi di strani casi etnografici sta dicendo qualcosa di sensato sulla famiglia o sta solo tergiversando perché, perso in questo mare di diversità, non è in grado di esprimere una posizione chiara?
Francesco Remotti si è soffermato proprio sul rischio di approssimazione cui può incappare l’etnografo che intervenga su questi temi: «che cosa sono capaci di fare gli antropologi, a proposito della famiglia?» – si è chiesto. «Semplicemente di distruggere l’idea dell’universalità e della naturalità della famiglia nucleare?» (Remotti 2008: 101). Interrogativi, questi, che problematizzano il peso specifico dell’antropologia nella sfera pubblica: nel dibattito sulla famiglia, dunque, qual è il valore aggiunto della disciplina rispetto al senso comune (o alla morale religiosa) e ad altre scienze che studiano lo stesso oggetto? Posto davanti alle certezze di sociologi, storici, psicologi, giuristi economisti o demografi (i quali si concentrano su uno spazio e un tempo determinato), l’antropologo potrebbe sembrare a prima vista l’esperto meno preparato, intento a enumerare una lunga e inconcludente «accozzaglia di casi strani e senza senso» (ivi: 101-102). In realtà, il sapere di cui è depositario, forte della sua dimensione comparativa, gli fornisce alla lunga un grande vantaggio: partire dai casi concreti e abbandonare ogni assolutismo per analizzare il sistema di relazioni e connessioni che orienta la definizione di ogni concetto.
Remotti si rifà al lavoro del Wittgenstein delle Ricerche Filosofiche: l’invito è a osservare i fenomeni attraverso griglie concettuali abbastanza flessibili da lasciarsi costantemente modificare dall’esperienza. L’antropologo si riferisce, in particolare, a quelle che il filosofo chiama “somiglianze di famiglia”: caratteristiche che, pur non essendo presenti simultaneamente, accomunano fenomeni/oggetti appartenenti a una stessa classe. Si tratta di una nozione che Ludwig Wittgenstein ricava dall’osservazione di ciò che rende simili i membri di una famiglia: corporatura, tratti del volto, colore degli occhi, si sovrappongono distribuendosi diversamente tra i vari individui col risultato, pur nella differenza, di accomunarli. Nel caso specifico, il concetto antropologico di famiglia – analogamente a quelli di gioco o numero analizzati dal pensatore austriaco – emerge come l’esito dell’intreccio di casi diversi eppur somiglianti in qualcosa: la dimensione comunitaria del noi, la riproduzione biologica e culturale del gruppo, l’intimità, la cura reciproca e i comuni interessi (affettivi, sociali, economici, financo politici), la convivenza. Intreccio, beninteso, mai dato una volta e per tutte, bensì passibile di essere corretto, rafforzato, ripensato e ricostruito dall’apporto di nuovi dati. Intreccio, infine, diversamente intrecciabile cambiando prospettiva e punto di vista (ivi: 103-104).
Ovviamente, decretare che i confini di un concetto non siano fissi o esistenti là fuori indipendentemente dall’occhio che osserva, non vuol dire che essi non esistano, non siano importanti o robusti (o comunque percepiti come tali da chi ci sta dentro – o fuori); significa, al contrario, porre l’accento sui parametri usati per tracciarli. In ballo, infatti, non c’è solo una questione di definizione (cos’è la famiglia?), bensì un problema di scelte e decisioni (cos’è la famiglia per chi?). Un problema che implica una decisiva assunzione di responsabilità che sarebbe pericoloso scaricare su principi extra-umani e trascendenti come la Natura o la Rivelazione Divina. Quanto sarà capiente, si chiede allora Remotti, il concetto di famiglia utilizzato tanto dagli antropologi che propongono generalizzazioni quanto dai soggetti che vivono la pervasività di tale istituto culturale? Sarà considerato, allargandone o restringendone le maglie, un concetto aperto cui poter aggiungere sempre nuovi esempi (o dal quale, legittimamente, escluderne altri senza però negar loro il diritto d’esistenza [3]) oppure un concetto chiuso in cui tutto ciò che resta fuori è soltanto una pericolosa aberrazione da combattere? (ivi: 105-106). Non si tratta d’interrogativi oziosi ma di domande le cui risposte influenzano, in ogni società, concrete pratiche e politiche d’inclusione o esclusione dell’alterità.
La specificità del lavoro antropologico sulla famiglia sta, dunque, in questo: oltre a chiedersi cosa siano le famiglie, l’antropologo s’interroga sulle strategie usate dalle culture per decidere cosa esse siano (ivi: 108). Non solo documenta la diversità ma indaga le scelte degli uomini e i modi in cui esse sono sovente naturalizzate, ovvero celate: da chi, per quali motivi e con quali risultati. Il ricorso alla Natura cui fanno riferimento alcuni segmenti della società italiana, da questo punto di vista, è sempre strumentale: utile a stabilizzare i propri costumi e a respingere, allontanandoli nella perniciosa categoria del contro natura, quelli estranei.
La nostra famiglia basata sulla relazione tra un solo uomo e una sola donna che, dopo aver contratto matrimonio, convivono mettendo al mondo uno o più figli non può definirsi universale né tantomeno naturale. Essa non è data una volta e per tutte, diretta espressione di una natura umana immutabile, bensì è l’esito di lunghi, articolati e revocabili processi storico-culturali che s’innestano, interagendo dialetticamente, alle disposizioni naturali di cui ogni essere umano è dotato. D’altra parte, l’antropologia culturale non sostiene affatto che la natura non esiste. Piuttosto, in accordo con altre discipline, afferma che il modo in cui gli uomini guardano alla natura è sempre culturalmente orientato. Persino la fisica – la scienza per antonomasia – è conscia dell’impossibilità di una conoscenza non mediata: come sosteneva Werner Karl Heisenberg, essa non studia la natura bensì la natura esposta al suo modo (quello di un sapere prodotto in uno spazio e in un tempo particolare) di fare domande.
Più di cento anni di ricerche etnografiche hanno dunque contribuito a far perdere alla famiglia nucleare il suo privilegio e a mostrarla per ciò che è: costruzione storico-culturale fra le tante possibili. Ciò non significa che essa possa essere liquidata senza batter ciglio né legittima un rozzo e ambiguo relativismo secondo il quale una cosa vale l’altra – né mi risulta che i movimenti per l’estensione dei diritti chiedano nulla del genere. Vuol dire, piuttosto, che non può essere imposta a tutti indiscriminatamente trincerandosi dietro la Natura, la Tradizione o la Religione. Il contributo che l’antropologia può dare a un dibattito sereno e non isterico sulla famiglia, parafrasando Clifford Geertz, è così quello di mostrare “altre pecore in altre vallate”: presentare le risposte date da altri a domande che ci siamo posti anche noi e, nel far ciò, rivelare la culturalità nascosta delle nostre scelte (persino quelle che ci illudiamo ci siano state dettate pedissequamente dalla natura) per smascherare l’insensata pretesa che esse siano le uniche valide. Emerge, dunque, il ruolo forte che la scienza antropologica, grazie al suo «immenso archivio di esperienze umane», può avere in questo processo; ammesso che, stando ovviamente attenta a non legittimare spericolate (e pericolose) generalizzazioni, essa, come scrive David Graeber, cessi di essere «spaventata dal proprio potenziale […] di disciplina che prende in considerazione l’intera umanità e che ha familiarità con i casi anomali» (Graeber 2006: 94-95).
La famiglia è un fatto umano e come tale fattibile diversamente. Partendo da condizioni naturali di ordine biologico ed ecologico, nei loro tentativi di costruire i loro noi, gli uomini producono senza sosta molteplici forme di famiglia. Su ognuna di esse cultura, storia, ambiente e necessità materiali fanno sentire la loro decisiva influenza.
Dialoghi Mediterranei, n.19, maggio 2016
Note
1 Ovviamente le cose sono molto più complesse di quanto queste considerazioni, inevitabilmente parziali, lascino intendere. Nonostante il superamento dell’evoluzionismo, infatti, molti nomi illustri hanno continuato a sostenere, da tutt’altra prospettiva, se non la naturalità almeno l’universalità della famiglia nucleare. Per antropologi come George Peter Murdock, Robert Lowie e Jack Goody, infatti, la relazione basica uomo-donna-figlio/i costituisce il nucleo di ogni istituto familiare, anche quando (è il caso delle famiglie poligamiche o estese) esso non è immediatamente visibile. Come sostenuto da Francesco Remotti, per questi autori la famiglia nucleare resta «la base imprescindibile di qualsivoglia società» (Remotti 2008: 94) e il loro edificio teorico, paradossalmente, si dimostra più angusto di quello degli evoluzionisti. Mentre, infatti, questi ultimi non ignoravano la storia e in linea teorica ammettevano che l’evoluzione delle forme familiari potesse anche non arrestarsi alla famiglia vittoriana, l’approccio strutturalista alla Murdock è atemporale perché convinto di essere giunto al nocciolo irrinunciabile della famiglia (ivi: 96).
2 L’elenco di casi etnografici che seguiranno è tratto dal saggio Contro Natura. Una lettera al Papa (2008) di Francesco Remotti (Parte seconda: 71-161) cui rinvio per l’approfondimento degli esempi scelti e per i riferimenti bibliografici dei ricercatori che li hanno documentati. Il testo è concepito come una lunga lettera indirizzata all’allora Papa Benedetto XVI, il quale dedicò buona parte del suo Pontificato alla difesa della “famiglia naturale” dagli attacchi laicisti e relativisti. Si ricorderà, d’altra parte, che proprio in quegli anni il Governo guidato da Romano Prodi iniziava timidamente a discutere la possibilità di legiferare sulle Unioni Civili provocando la veemente reazione delle gerarchie cattoliche e dei partiti conservatori.
3 In questi casi Remotti propone il ricorso al concetto di “gruppo domestico”. Se, dice l’autore, la nostra categoria di famiglia è troppo culturalmente carica per accogliere, oltre ad alcuni esperimenti sopra menzionati, anche usi come quelli dei Wahehe della Tanzania, i quali, similmente a Mossi, prevedono la convivenza di nonna e nipoti dopo lo svezzamento, forse un concetto più neutro potrebbe avere il pregio di escludere senza tuttavia rifiutare e condannare. “Gruppo domestico”, da questo punto di vista, non si sostituirebbe alla categoria “famiglia” ma aiuterebbe una volta di più a far risaltare antropologicamente i condizionamenti storico-culturali che quest’ultima si porta dietro (Remotti, 2008: 155-161).
Riferimenti bibliografici
Graeber D. 2006, Frammenti di antropologia anarchica, Eleuthera, Milano; (ed. or. 2004).
Héritier F. 1979, «Famiglia», in Enciclopedia, Einaudi, Torino, vol. VI: 3-16.
Remotti F. 2008, Contro natura. Una lettera al Papa, Laterza, Bari.
________________________________________________________________
Dario Inglese, ha conseguito la laurea triennale in Beni Demo-etnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo e la laurea magistrale in Scienze Antropologiche ed Etnologiche presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. Si è occupato di folklore siciliano, cultura materiale e cicli festivi. A Milano si è interessato di antropologia delle migrazioni e ha discusso una tesi sull’esperimento di etnografia bellica Human Terrain System.










