Distopia del presente
L’11 settembre del 2001 si è inaugurata un’epoca della storia umana. Il futuro ha fatto irruzione nel presente e ne ha ipotecato la storia. Si è imposta come realtà all’opinione pubblica globale la descrizione di una società immaginaria e di una comunità molto indesiderabile. L’attacco alle Torri Gemelle, infatti, ha destabilizzato il sentire comune degli abitanti degli Stati Uniti d’America e del mondo intero: qualcosa d’inaudito è avvenuto – l’attacco sul proprio territorio all’unica superpotenza rimasta in campo dopo la Caduta del Muro di Berlino – ed è avvenuto sotto gli occhi di tutti. Il mondo intero, o una sua gran parte, ha assistito in diretta al più traumatico degli eventi mediatici: due grattacieli che precipitano al suolo, abbattuti da due aeroplani scagliati come proiettili.
La reazione all’evento da parte dei leader mondiali, degli opinionisti dei mass media e della stessa opinione pubblica è stata scomposta e inadeguata. Si è diffuso un senso di instabilità e di insicurezza nel sentire comune che è stato alimentato dai media e dalle retoriche messe in campo dalle élite politiche alla scala planetaria. Si è imposta così un’immagine catastrofista della società del presente, dominata da parole chiave come “L’Occidente colpito al cuore!” o come “Guerra al terrorismo”, impugnati e propugnati dalla leadership americana per mobilitare e chiamare attorno a sé in un’avventura militare i partner europei e i residui alleati del Mondo Arabo.
Gli effetti sull’immaginario collettivo sono stati e sono devastanti: da allora, la narrazione dominante ci mostra un mondo in cui il terrorismo si aggira come uno spettro, pronto a colpire, come e quando vuole, comunità inermi e impreparate ad affrontare un nemico invisibile che si anniderebbe nei gangli stessi della vita quotidiana delle città globali. Siamo proprio sicuri che il terrorismo sia così come ci appare? E, inoltre, è ragionevole pensare che la guerra sia la strategia più adatta per affrontarlo? Penso piuttosto che, per effetto dell’attentato, ma soprattutto delle reazioni globali che esso ha suscitato, vacillino i modelli interpretativi del mondo contemporaneo e dei suoi principali nodi geopolitici.
Dalle Torri Gemelle in poi, infatti, proviamo una sgradevole sensazione e un disagio profondo che deriva, fra l’altro, dal non potersi del tutto riconoscere nelle narrative dominanti. Ecco perché parlo di “distopia del presente” e la intendo proprio nel suo senso letterale come «descrizione di una società immaginaria e di una comunità altamente indesiderabile imposta come realtà all’opinione pubblica globale». Ritengo che compito primario e urgente, per la comunità scientifica internazionale, sia quello di decostruire l’immagine dominante e provare a costruire nel sentire comune un immaginario più coerente e più corrispondente a quanto ci accade intorno.
Prima questione: affermare che l’Occidente sia stato colpito al cuore dall’attacco terroristico non fa altro che alimentare, pur ribaltandola, l’immagine dualistica del mondo che sta alla base dei deliranti proclami dei leader terroristici. Come se veramente il mondo fosse diviso in due – e non profondamente integrato e interdipendente – tra un Occidente evoluto e moderno e il resto del mondo (il complesso degli Stati arabi, in particolare, inteso come matrice degli attacchi terroristici) arretrato sia sotto il profilo economico che culturale. Le cose non stanno, ovviamente, così e ribadire meccanicamente i termini di tale contrapposizione non fa che confondere le acque.
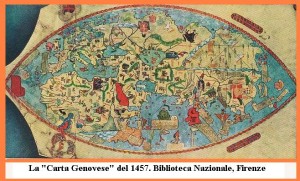 La seconda questione è più rilevante e niente affatto intuitiva. Il terrorismo non è così come ci viene raccontato e non può essere affrontato, così come ci viene proposto, in un’ottica militarista. Ci soccorre in proposito il pensiero del filosofo tedesco, Peter Sloterdijk, quando ci ricorda che il terrorismo è una tattica bellica messa in opera da grandi potenze a tecnologia avanzata (pensiamo ad esempio all’impiego della bomba atomica, ieri, o ai droni, oggi) al fine di fiaccare la resistenza di avversari militarmente più deboli, ma soprattutto al fine di mettere a dura prova la resistenza delle popolazioni civili. Ecco perché il terrorismo non può essere sconfitto dalla guerra. Esso non è altro che la guerra condotta nelle sue forme estreme. E come la guerra semina odio e desiderio di vendetta, così fa il terrorismo in forme parossistiche.
La seconda questione è più rilevante e niente affatto intuitiva. Il terrorismo non è così come ci viene raccontato e non può essere affrontato, così come ci viene proposto, in un’ottica militarista. Ci soccorre in proposito il pensiero del filosofo tedesco, Peter Sloterdijk, quando ci ricorda che il terrorismo è una tattica bellica messa in opera da grandi potenze a tecnologia avanzata (pensiamo ad esempio all’impiego della bomba atomica, ieri, o ai droni, oggi) al fine di fiaccare la resistenza di avversari militarmente più deboli, ma soprattutto al fine di mettere a dura prova la resistenza delle popolazioni civili. Ecco perché il terrorismo non può essere sconfitto dalla guerra. Esso non è altro che la guerra condotta nelle sue forme estreme. E come la guerra semina odio e desiderio di vendetta, così fa il terrorismo in forme parossistiche.
Per avere riscontri attendibili di questa visione, basta riguardare le immagini di Dresda distrutta dai bombardamenti nella Seconda Guerra Mondiale, o lo scenario postnucleare di Hiroshima e Nagasaki, o, ancora, le fotografie di Sebastiao Salgado [1] del Kuwait “liberato” e dei suoi pozzi in fiamme, o, infine, le immagini che scorrono sui nostri schermi televisivi, delle città di Aleppo, Mosul o Raqqa “liberate” dall’occupazione dell’Is (Stato Islamico).
Il XX secolo ha apportato alla storia dell’umanità una novità devastante che consiste nell’attaccare l’avversario corrompendo, talvolta irreversibilmente, l’ambiente di vita dell’avversario stesso. La prima occorrenza di un ricorso al terrorismo risale, infatti, all’uso di una nube tossica da parte dell’esercito tedesco nel corso della Prima Guerra Mondiale (a Ypres il 24 aprile 1915). Il terrorismo non può essere sconfitto dalla guerra perché non è un nemico, ma un metodo di combattimento e la guerra è il suo principale terreno di coltura (Sloterdijk, 2015: 82-3).
D’altronde, come osserva Peter Sloterdijk, «ogni attacco terroristico si comprende come un contrattacco entro una serie che, ogni volta, viene descritta come avviata dall’avversario» (2015: 98) La successione degli eventi appare, dunque, significativa: 1990-91 prima Guerra del Golfo; 7 ottobre 2001: inizio della guerra in Afghanistan all’insegna dell’operazione Enduring Freedom promossa dal governo statunitense come risposta all’attacco terroristico alle Torri Gemelle e al Pentagono; nel quadro della War on Terrorism, si avrà poi nel 2003 la seconda Guerra del Golfo.
Non è comunque da sottovalutare, all’interno del ragionamento che andiamo qui dispiegando, che l’impegno militare statunitense ha effetti non soltanto sotto il profilo geopolitico e militare, ma anche su quello strettamente economico. Come ha evidenziato l’economista Innocenzo Cipolletta:
«il mondo ha sperimentato due crisi globali, separate da un breve intervallo di tempo – la crisi del petrolio del 1973 e la crisi finanziaria globale del 2008 –, che hanno innescato due pesanti periodi di recessione globale. In entrambi i casi, gli Usa erano o erano stati impegnati sul piano militare con forti contingenti – nella Guerra del Vietnam prima, nella Guerra al terrorismo internazionale poi, e due fronti attivi in Afghanistan e Iraq…» (2010: XII-XIV).
I meccanismi, per cui l’esposizione finanziaria americana, determinata dalle spese militari, si è proiettata sulla scena mondiale, sono ben noti e consistono essenzialmente in un consistente incremento della liquidità disponibile sui mercati finanziari internazionali grazie all’immissione di ingenti quantità di dollari (Cipolletta, 2010: 9).
Come racconta Scott Anderson nel reportage “Terre spezzate: viaggio nel caos del mondo arabo”, pubblicato sul New York Times Magazine il 14 agosto 2016, il processo di destabilizzazione dei Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, che fu salutato in Occidente come “Primavera Araba”, degenerò presto in una crisi politica diffusa prima, e poi, in rapida successione, in una serie di tragiche e distruttive guerre regionali, con un coinvolgimento diretto o indiretto, dichiarato o implicito, di tanti protagonisti della geopolitica globale:
«Il modello che emerge è impressionante. La maggioranza dei ventidue Pesi che compongono il mondo arabo sono stati coinvolti in una certa misura nella Primavera Araba, ma quelli che ne sono stati più profondamente interessati – Egitto, Iraq, Libia, Siria, Tunisia e Yemen – sono tutti repubbliche, non monarchie. E di questi sei, i tre che si sono disintegrati tanto completamente da far dubitare che possano ancora esistere come Sati funzionanti – Iraq, Siria e Libia – sono tutti membri di quella breve lista di Pesi arabi creati dalle potenze imperiali dell’Occidente agli inizi del Ventesimo secolo» (Anderson, 2016: 5).
Lo scenario distopico, che fa da contesto al nostro itinerario di ricerca degli ultimi anni, deriva dal complesso intreccio tra globalizzazione, crisi finanziarie e politiche neoliberistiche; crisi degli Sati nazionali e delegittimazione delle autorità sovranazionali (vedi ad es. l’Unione Europea); processi di liberazione dalle dittature, destabilizzazione economica e politica e emergenza di nuovi protagonismi e egemonie in un’ampia regione largamente coincidente con il complesso degli Stati Arabi; incremento parossistico delle diaspore e delle migrazioni internazionali con forte incidenza di rifugiati politici, richiedenti asilo e profughi ambientali provenienti dall’Africa e dall’Asia e diretti, per vie regolari o, prevalentemente irregolari, verso l’Europa.
Sguardo cosmopolita e geografie dell’ascolto
Il vertiginoso accavallarsi di processi di crisi e mutazione degli equilibri economici, degli assetti politici e delle dinamiche culturali in atto ha costretto un gruppo di ricerca – formatosi in un contesto regionale, come la Sicilia, fortemente esposto alle prorompenti e spesso tragiche vicende che anche da orizzonti lontani si sono scaricate sul mondo mediterraneo – a interrogarsi sul proprio posizionamento etico e scientifico rispetto ai fenomeni da analizzare e alle strategie di azione da adottare. Sotto i nostri occhi si snodava un film molto più impressionante delle Torri Gemelle: una strage di migranti nei continui naufragi avvenuti nelle acque del Mediterraneo [2]. È avvenuto così che un gruppo di studiose e studiosi che si era raccolto attorno a un programma di ricerca nazionale dedicato alla “Città cosmopolita” ha dovuto a più riprese ridefinire sia il metodo che gli obiettivi della ricerca fino a comprendere che la diaspora mediterranea in corso (de Spuches, 2011: 102-19) costituisse una vera e propria sfida epistemologica.
Mostrare una mutazione in atto, a livello globale, degli assetti urbani e territoriali era l’intento iniziale di un gruppo di studiose e studiosi. Si trattava di un gruppo ampio e articolato. Un’équipe transnazionale di ricerca coordinata da Ola Söderström aveva, infatti, scelto Palermo per indagare sull’intreccio tra la dimensione culturale e quella urbana dei processi di globalizzazione. Urban Cosmographies. Indagine sul cambiamento urbano a Palermo (2009) ha mostrato con evidenza come nel capoluogo siciliano fosse in atto un processo che esponeva la città a flussi globali di persone, idee e capitali e inscriveva entro gli spazi della sua vita quotidiana nuovi paesaggi e regimi urbani cosmopoliti. Le azioni di governance urbana messe in atto da due amministrazioni della città di segno opposto vennero così valutate alla luce del complesso dei flussi di mobilità di persone, conoscenze e capitali che tali politiche erano state in grado di intercettare. Leggendo questo lavoro e le immagini che lo corredano, ciascuno potrà formarsi un proprio giudizio sull’efficacia di tali politiche, ma non potrà comunque negare che dall’uno e dalle altre scaturisce un’immagine inedita della città. Gli artefatti urbani attivano luoghi di contrasto e nuovi posizionamenti identitari ma, se reinscritti nelle catene d’azione che li generano, essi svelano le retoriche cui si ispirano le diverse pratiche di governance urbana e i regimi urbani cosmopoliti a esse correlati. Il caso di Palermo è stato poi rivalutato dallo stesso Söderström in un quadro comparativo a scala globale con altre dinamiche urbane in contesti asiatici e africani [3].
In parallelo si è sviluppata un’altra esperienza di ricerca che ha promosso un quadro di comparazioni a scala, questa volta, nazionale [4]. La composizione del gruppo di ricerca ha consentito di mettere a fuoco dinamiche in atto in città di diverse dimensioni, dalle grandi alle medie, e dislocate sia al Nord (Venezia e Trieste) che al Centro (Bologna e Pisa) che al Sud d’Italia (Palermo e Bari). Si è potuto così constatare quanto diffusa e capillare fosse la mutazione in atto nel nostro Paese. Una metodologia innovativa basata sui sopralluoghi e sulle pratiche dell’ascolto attivo ha consentito di esplorare, inoltre, i diversi contesti urbani nelle pieghe più intime della vita quotidiana e di valutare quanto fosse profondo il grado di coinvolgimento delle popolazioni e dei luoghi indagati in un processo di transizione che coinvolgeva il locale e il globale proprio al confine tra lo spazio pubblico e lo spazio privato. Aprendosi ad altre esperienze disciplinari, il gruppo di Palermo giungeva alla comprensione di quanto traumatica e spaesante fosse la transizione in atto e di quanto ineludibile la necessità di adottare una strategia di ricerca innovativa. La diaspora mediterranea s’impose, così, come asse portante dell’esperienza di ricerca e dei suoi prodotti a stampa [5] e come fuochi tematici di due eventi cui si decise, come vedremo, di dare vita all’insegna de La città cosmopolita [6].
La compressione spazio-temporale (Harvey,1993) aveva prodotto contesti urbani e territoriali il cui profilo non poteva essere descritto senza adottare uno “sguardo cosmopolita” (Beck, 2004). Senza mettere, cioè, in discussione quel “nazionalismo metodologico” che è, per così dire, congenito alle scienze sociali e territoriali e che consiste nel considerare ogni evento di natura socio-spaziale entro l’orizzonte costituito dai singoli Stati nazionali e dalle loro frontiere. Nel corso della ricerca il gruppo locale di Palermo è pervenuto alla convinzione che, piuttosto che esporre i paesaggi urbani a uno sguardo cosmopolita, una strategia più appropriata s’imponesse e che si dovessero sondare le opportunità metodologiche offerte dalle «geografie dell’ascolto» (Guarrasi, 2011: 46-59). Procedere dunque per sopralluoghi, esplorare quelle che Clifford chiama «zone di contatto» (1997) e provare a costruire «luoghi dell’ascolto», situazioni e contesti, cioè, in cui la narrazione autobiografica fosse resa possibile dall’interazione tra intervistatore e intervistato [7]. Il mondo vissuto dei migranti incontrati nel corso dell’inchiesta si dimostrava così intenso, sofferto e partecipato da sconsigliare ogni forma di generalizzazione o di astrazione. Il valore di ogni singola esistenza umana, che emergeva dalle interviste, era tale da imporsi come qualcosa di singolare e non sovrapponibile alle altre esperienze. La stessa diaspora mediterranea, da esodo di massa, si diversificava e frastagliava così in una varietà e molteplicità di esperienze soggettive.
Praticare le geografie dell’ascolto acquisiva il senso di misurarsi non con fenomeni collettivi quanto piuttosto con orizzonti di eventi specifici e singolari (Guarrasi, 2014). Tutto questo induceva anche noi stessi ad assumere, rispetto al campo delle ricerca e alla drammaticità delle esperienze di cui siamo diventati testimoni, un atteggiamento che non poteva che ispirarsi all’icastica frase di Michel Foucault: «La sofferenza degli esseri umani non deve mai essere un residuo muto della politica» (2009) e a fare nostro il programma d’azione enunciato dal pensatore francese: «non siamo altro che singoli individui che parlano, e lo fanno insieme, unicamente a titolo di una certa comune difficoltà a sopportare quanto accade» (2009: 235).
Si impose così una nuova strategia di confronto con i governi e le istituzioni basata su tre semplici principi d’azione:
« – Esiste una cittadinanza internazionale che ha i suoi diritti, i suoi doveri e che obbliga a insorgere contro ogni abuso di potere, chiunque ne sia l’autore e quali che ne siano le vittime.
- È dovere di questa cittadinanza internazionale rivendicare sempre agli occhi e agli orecchi dei governi le sofferenze degli esseri umani, poiché è falso che non ne siano responsabili. La sofferenza degli esseri umani non deve mai essere un residuo muto della politica. È il fondamento di un diritto assoluto a rivoltarsi contro chi detiene il potere.
- Bisogna rifiutare la spartizione dei compiti che spesso ci viene proposta: agli individui, di indignarsi e di parlare; ai governi di agire. La volontà degli individui deve inscriversi in una realtà di cui i governi hanno voluto tenere il monopolio, un monopolio che bisogna sradicare a poco a poco, giorno dopo giorno» (Foucault, 2009: 236-7).
Il gruppo di ricerca andava assumendo sempre maggiore consapevolezza del fatto che senza uno scatto etico e un coerente posizionamento politico non fosse possibile opporre alcuna resistenza alle politiche messe in campo dall’Unione Europea e dai suoi singoli Stati e alle retoriche a esse connesse. Si faceva strada nella nostra mente anche la convinzione che in quest’opera di resistenza non eravamo soli, ma che attorno a noi agiva un consistente drappello di intellettuali critici, nettamente schierati a favore di migranti, richiedenti asilo e rifugiati politici. Il silenzio era stato rotto da Giovanni Maria Bellu, inviato de la Repubblica. Il suo libro, I fantasmi di Portopalo (2004), infatti ha gettato una luce complessiva su una vicenda su cui si sarebbe steso, con la complicità di tanti, un velo di silenzio. La tragedia era avvenuta nella notte di Natale del 1996, ma la sua eco mediatica si era risentita soltanto a partire dal 2004, grazie alla coraggiosa inchiesta del giornalista de La Repubblica, mostrando il pauroso intreccio tra una vicenda drammatica e la banalità delle esigenze della vita quotidiana, tra la dimensione collettiva dell’evento e la sconvolgente singolarità del ritrovamento della carta d’identità plastificata di Anpalagan Ganeshu.
La storia del naufragio al largo della Sicilia richiamò l’attenzione anche sul valore nella società del presente del giornalismo d’inchiesta. Sull’attività di ricerca e di scavo che sola può sottrarre al silenzio e all’oblio il rimosso di tante esistenze mutilate dall’esperienza dell’espatrio e dell’esilio. Per questo motivo, mi pare importante evidenziare che in questa Isola, lambita da una tragedia umana di tale portata, non si assiste a tutto ciò con sgomento e silente assuefazione, ma si attivano da tempo le migliori energie intellettuali per lo studio e la comprensione del fenomeno. Un gruppo di studiosi siciliani, infatti, ormai da anni si cimenta in un confronto interdisciplinare che ha come campo di studi e osservazioni per l’appunto l’attrito delle frontiere sul fenomeno migratorio, il difficile rapporto tra globalizzazione, diritti umani e politiche degli Stati [8]. Dell’ampia bibliografia prodotta voglio qui ricordare i lavori più innovativi: Approdi e scogli (2002) e Crocevia e trincea (2007) di Marco Antonio Pirrone; Segnali di confine di Paolo Cuttitta (2007) e Migrazioni, frontiere, diritti a cura di Paolo Cuttitta e Fulvio Vassallo Paleologo (2006); La diaspora interculturale di Giuseppe Burgio (2007); Campi di forza di Alessandra Sciurba (2009) e Esilio/asilo a cura di Clelia Bartoli (2010).
 Orizzonte di eventi: naufragi mediterranei e moltiplicazione delle frontiere
Orizzonte di eventi: naufragi mediterranei e moltiplicazione delle frontiere
Le politiche europee nei confronti di migranti, rifugiati politici e richiedenti asilo disegna attorno a noi un tragico orizzonti di eventi. Ciascuno di essi, nello stillicidio della successione, merita di essere affrontato per il valore che ha in sé, ma la serie assume una rilevanza tale da indurre ad adottare la più pregnante parola “strage” e tende ad assumere i connotati di un vero e proprio crimine contro l’umanità.
Di fronte a una strage di tale portata [9], arduo è il compito di pensare l’evento. Come suggerisce Alain Badiou, infatti, pensare un evento implica tre opzioni: occuparsi della scelta, della distanza e dell’eccezione. Vuol dire cioè fare chiarezza sulle scelte principali del pensiero, sulla distanza tra il pensiero e il potere, sul valore dell’evento:
«Io sostengo che un concetto filosofico, nel senso inteso da Deleuze, quindi come creazione, è sempre qualcosa che lega insieme un problema di scelta (decisione), un problema di distanza (divario) e un problema di eccezione (evento). I più profondi concetti filosofici ci dicono: se desiderate che la vostra vita abbia un senso, allora dovete accogliere l’evento, mantenere le distanze dal potere, essere irremovibili nelle vostre decisioni» (Badiou, 2012: 11).
Pensare in questo modo l’evento – e il luogo – rappresenta una sfida sia per il pensiero filosofico sia per la ricerca geografica in quanto comporta la necessità di operare uno sfondamento nel regime di pensiero consolidato e confrontarsi con una situazione paradossale. L’elemento chiave, che mi preme sottolineare, è che il pensiero critico si attiva quando ci si trova in presenza di una relazione paradossale, cioè di una relazione che non è tale. Riuscire a pensare insieme il dramma del naufragio e la banalità della vita quotidiana non è così semplice, né naturale, perché c’è un mare che li separa. Un mare che oggi funziona come una frontiera.
Il gruppo di ricerca, però, si convinse ben presto che un obiettivo così ambizioso come pensare in forme inedite un evento, che si ripeteva con ossessiva cadenza sotto gli occhi di tutti (e nell’indifferenza di tanti) non potesse realizzarsi all’interno della ristretta arena della comunicazione scientifica. Per operare lo sfondamento, occorreva confrontarsi con una platea più vasta. Ecco perché il programma di ricerca aveva avuto inizio con due edizioni (2006 e 2007) di un evento denominato, come abbiamo visto, La città cosmopolita, in cui s’intrecciavano i momenti del dibattito scientifico, i sopralluoghi in “zone di contatto” e manifestazioni pubbliche comprendenti spettacoli, musica e performance artistiche.
And So Europe Deshumanized Itself: performance artistica e convegno internazionale
Nel 2014, ancora una volta, una performance artistica ha dato avvio a un nuovo stadio della ricerca. Questa volta l’iniziativa fu assunta da Giulia de Spuches che decise di organizzare un evento aperto a un pubblico di non addetti ai lavori. Mise in scena con attori, musicisti e una cantante un evento teatrale dal titolo “And So Europe Deshumanized Itself” [10]. L’efficacia dello spettacolo si fondava sul ricorso alla lettura di pagine altamente drammatiche di Beloved di Toni Morrison, creando una connessione emotiva e intellettuale tra il dramma della schiavitù e lo sconvolgente destino cui le politiche europee espongono i migranti. In entrambi i casi, l’esercizio del potere è così violento e prevaricante da compromettere l’umanità non soltanto di chi lo subisce, ma anche di chi lo pone in essere.
Il momento scientifico seguì nel novembre del 2015 e fu convocato attraverso una Call for Action, nella consapevolezza che le parole del discorso scientifico non fossero più sufficienti a opporre resistenza all’ondata di xenofobia e nazionalismo avanzante e che occorresse mettere in campo più decise azioni di contrasto. I convegnisti si sforzarono di elaborare un nuovo linguaggio e nuove pratiche, nella consapevolezza del fatto che l’impegno scientifico e politico messo in atto negli anni precedenti non facesse più presa sull’opinione pubblica, sopraffatto da parole d’ordine certo più rozze, ma di gran lunga più pervasive. Il gruppo dei geografi palermitani [11] che aveva promosso l’iniziativa, raccolse quanto emerso dalla discussione e gli fece prendere la forma del Manifesto (che qui si allega) e che è stato riproposto nel corso del XXXII Congresso geografico di Roma (7-10 giugno 2017) nella sessione “Il Mediterraneo: per una geografia critica della frontiera” coordinata da C. Brambilla, A. Casaglia, R. Coletti, P. Cuttitta, G. de Spuches e V. Guarrasi,
La “primavera araba” e le guerre regionali
Non è possibile, oggi, impostare un discorso critico in termini geografici sul Mediterraneo come frontiera, se non si tiene conto di quanto le dinamiche geopolitiche e umanitarie della regione siano divenute via via più complesse a partire dalla cosiddetta “Primavera araba”. Anche in questo caso mi pare opportuno iniziare da un evento. Come leggiamo in Preludio alla rivoluzione dove tutto è cominciato di Manuel Castells:
«È cominciato in un posto assolutamente improbabile: Sidi Bouzid, una cittadina di 40.000 abitanti di una impoverita regione centrale della Tunisia, a sud di Tunisi: Il nome di Mohamed Bouazizi, 26 anni, venditore ambulante, è ormai iscritto nella storia come colui che ha cambiato il destino del mondo arabo. L’autoimmolazione di Mohamed Bouazizi, che si è dato fuoco verso le undici e mezza del mattino del 17 dicembre 2010, di fronte alla sede di un ufficio governativo, è stata il suo ultimo grido di protesta contro l’umiliazione della ripetuta confisca della sua bancarella di frutta e verdura da parte della polizia locale dopo il suo rifiuto di pagare una tangente. L’ultima confisca aveva avuto luogo proprio quel giorno, un’ora prima. (…) Mohamed Bouazizi morirà il 3 gennaio 2011 nell’ospedale di Tunisi, dove il dittatore Ben Ali lo aveva fatto trasportare per placare la collera della folla» (2012: 2-3).
Di lì, nell’intreccio di storie individuali e drammi collettivi, divampò un fuoco che è ben lontano dall’estinguersi. Bisogna tenere insieme i due momenti: individuale e collettivo. Se li si separa, si perde tutto, sia la visione dell’insieme che il dettaglio decisivo. Sì, perché ogni destino umano nel suo svolgersi disegna un intero universo. Ne è ben consapevole Scott Anderson nel suo Terre spezzate: viaggio nel caos del mondo arabo, quando sceglie di raccontare uno scenario di guerre, esodi, violenze inaudite attraverso la storia di sei persone che di quanto iniziò a Sidi Bouzid sono state testimoni e protagonisti:
«I sei sono di regioni diverse, città diverse, tribù diverse, famiglie diverse, ma, assieme a milioni di altre persone del Medio Oriente, condividono un’esperienza di profondo disfacimento: le loro vite sono state cambiate per sempre dagli sconvolgimenti iniziati nel 2003 con l’invasione americana dell’Iraq, poi accelerati dalla serie di rivoluzioni e insurrezioni note in Occidente come la Primavera araba. Oggi continuano con le devastazioni dell’Is, con gli attacchi terroristici e con gli stati falliti» (2016: 3).
Dopo una serie di successi di una formazione militare e terroristica denominata Is (Stato islamico), di conquiste da parte sua di città e territori, dopo mesi di imposizione alle popolazioni locali di un potere dispotico e violento, nel momento in cui scrivo, si assiste alla sua debacle sui campi di combattimento. La vicenda geopolitica e militare, nonché economica e sociale, è tuttora in corso e non mi avventuro di certo a immaginarne gli esiti possibili né a ricostruirne i momenti fondamentali, perché la descrizione stessa di ogni evento della serie non può che essere parziale e soggettiva poiché troppe sono le parti in gioco e ciascuna portatrice di una prospettiva diversa e di una narrativa antagonista. Sotto il profilo geopolitico, è difficile distinguere gli eroi dagli antieroi, le vittime dai carnefici. Una cosa mi pare comunque evidente: non stiamo assistendo a nulla che assomigli a uno scontro di civiltà – Clash of Civilizations lo chiamava Samuel Huntington nel 1996 – e le vittime sono coloro che muoiono (a qualsiasi schieramento appartengano), coloro che fuggono dalle loro case e dalle loro città, coloro che si lasciano alle spalle comunità, territori e ambienti distrutti e vanno incontro a condizioni di rischio e di vulnerabilità estreme in terre e mari inospitali.
Gli accordi con la Turchia e con la Libia
I leader europei al fine di interrompere l’afflusso di migranti sulle coste greche stipulano nel marzo 2016 un accordo con il governo turco. L’accordo prevede tra l’altro il respingimento dei migranti irregolari; la creazione di canali umanitari per consentire il trasferimento dalla Turchia all’Unione Europea di siriani richiedenti asilo (con un rapporto di uno a uno: per ogni irregolare respinto si accoglie un solo esule dalla Siria); la liberalizzazione dei visti per i cittadini turchi oltre a aiuti economici alla Turchia (fino a un massimo di tre miliardi di euro entro la fine del 2018); l’apertura di nuovi capitoli per l’adesione della Turchia all’Unione Europea. Il paradosso è che una delle motivazioni addotte per stipulare l’accordo è l’intento di attuare «una misura temporanea e straordinaria necessaria per porre fine alle sofferenze umane (corsivo mio) e ripristinare l’ordine pubblico».
L’Italia e la Libia firmano nel febbraio del 2017 un accordo di cooperazione bilaterale al fine di chiudere la rotta del Mediterraneo centrale con il concorso della Libia. L’accordo è firmato a Roma, dopo una visita a Tripoli del Ministro dell’Interno italiano, Marco Minniti. Si rinnova il vecchio accordo di amicizia e di cooperazione firmato nel 2008 tra Silvio Berlusconi e Muhammad Gheddafi, che prevedeva tra l’altro, a chiusura definitiva del contenzioso coloniale, l’esborso da parte dell’Italia di un contributo di cinque miliardi di dollari. L’accordo parte dalla premessa che la lotta al traffico dei migranti si combatte con la stabilizzazione della Libia, con la cooperazione europea e bilaterale e con l’aumento delle capacità libiche di controllare autonomamente sia le frontiere terrestri nel Sud del Paese sia quelle marittime.
I governi europei riconoscono l’efficacia di tale accordo al fine di determinare un calo dei migranti in arrivo dal Mediterraneo centrale. Le autorità europee si manifestano del tutto indifferenti, invece, rispetto ai richiami delle Agenzie Onu che si occupano di migranti e le ripetute e drammatiche segnalazioni provenienti dalle Ong operanti sul territorio libico riguardo alle condizioni di vita dei migranti bloccati in territorio africano. Si fanno sempre più insistenti le voci di infiltrazioni di trafficanti di esseri umani in istituzioni libiche come la guardia costiera e i centri di detenzione.
Affermazione di forze nazionalistiche in Europa
L’unione Europea rischia di disgregarsi per l’insorgenza di sovranismi, nazionalismi e rifiuto di migranti, richiedenti asilo e rifugiati politici (e ambientali). La prima a vacillare è stata la libera circolazione dei cittadini sul territorio europeo prevista dalla Convenzione di Schengen. Il segnale più forte e inequivocabile è stato, però, la Brexit, cioè la maggioranza dei votanti del Regno Unito (51,89 %) che si è espressa a favore della scelta di lasciare l’Unione Europea il 23 giugno 2016. Non meno inquietante è l’affermazione elettorale di forze dell’estrema destra nazionalista e dichiaratamente xenofoba che vanno dal Front National in Francia a formazioni come i tre movimenti estremisti tedeschi (Republikaner, Npd e Dvu) o il Fpo di Haider in Austria o Per un’Olanda vivibile e il Partito del Popolo danese in Nord Europa, o nei Paesi dell’Europa dell’Est, dove si segnalano le posizioni i governi ad esempio in Polonia e in Ungheria. Non meno inquietante appare il virare su posizioni nazionaliste e xenofobe di formazioni di centro, com’è avvenuto nelle recenti elezioni austriache con l’affermazione dei popolari di Sebastian Kurz (Oevp).
Il mare Mediterraneo se guardato come uno specchio rimanda immagini di guerre e devastazioni dal suo fronte meridionale e orientale a cui sul fronte settentrionale – quello europeo – corrispondono frammentazione politica e dissonanze culturali del tutto impensabili e imprevedibili pochi anni fa. Governi nazionali e sovranazionali (l’Unione Europea) sono come ripiegati su se stessi e preoccupati solo del proprio sopravvivere. Tutto lascia pensare, piuttosto, che nessuna delle dinamiche distopiche in atto, potrà essere in alcun modo risolta senza intervenire in modo olistico sulla relazione malata tra questo mare e queste terre. La fluidità del mare mal si adatta a sostenere il ruolo di frontiera tra mondi la cui trama è fatta di contatti, scambi e cooperazione.
Nuove prospettive di ricerca: il cultural turn negli studi delle migrazioni mediterranee
In uno spazio in cui tende ad affermarsi una nuova configurazione del potere, e lo stato di eccezione (Agamben, 2013) produce vuoti giuridici, sospensioni del diritto paradossalmente legalizzati, e l’estrema precarietà dei corpi in movimento tra migrazioni, esili e diaspore, confini e frontiere sono i luoghi paradossali con cui la ricerca è chiamata a misurarsi. E la risposta non può non essere radicale: deve andare ai fondamenti del rapporto tra corpi, spazi e movimenti (Giubilaro, 2016). Se siamo chiamati ad agire per sovvertire questo stato di cose e sottrarci alla distopia del presente, non possiamo limitarci a constatare che il confine funziona come metodo, cioè produce e riproduce la moltiplicazione del lavoro nel mondo globale (Mezzadra, Neilson, 2014), occorre provare a costruire degli immaginari spaziali alternativi a quello dominante e ai dispositivi che lo generano e ribadiscono giorno dopo giorno. A tal fine il gruppo di geografe e geografi operanti a Palermo ha ritenuto di dover mobilitare le risorse più innovative di un discorso che si ispira alla geografia culturale e ai cultural studies, più in generale.
Per interrompere una spirale che espone i corpi in mobilità a condizioni di rischio e di vulnerabilità intollerabili, che produce instabilità politica, guerra e devastazione nel mondo arabo, che induce nazionalismi, disgregazione e divergenze in Europa, non è sufficiente mettere in atto politiche che si ispirano alla sicurezza o fare appelli all’accoglienza e alla convivenza civile. Bisogna andare alla radice della questione spaziale e domandarsi quali siano i termini del rapporto tra corpi, spazi e movimenti nella società del presente.
Partendo dalla nozione di “diaspora” (de Spuches, 2012) e di “singolarità nude” (Guarrasi, 2014), la ricerca teorica si è mossa in due direzioni suggerite dalle correnti più innovative dei cultural studies: interrogandosi sul potenziale espresso dal cosiddetto mobility turn e dai visual studies esplorati in modo sistematico all’interno del dottorato in Studi Culturali Europei dell’Università degli Studi di Palermo [12]. I rapporti tra estetica e politica sono stati così sondati su un ampio spettro di occorrenze, dalla fotografia (Giubilaro, 2016, 2018) alle teorie e alle pratiche cartografiche (Lo Presti, 2017). Mentre diasporic e border studies sono stati coniugati con le tematiche e le prospettive suggerite dai postcolonial studies (Proglio, 2016; Genduso, 2017).
Riflessioni conclusive
Il Mediterraneo pone oggi alle coscienze europee una questione epistemologica. Nella nostra esperienza di ricerca, essa si rivela tale perché va al cuore del nostro sentire e del nostro pensare. Quello europeo, intendo. Ma, non solo per questo. Essa risuona tale anche nei nostri corpi – e qui intendo proprio i nostri, quelli dello sparuto gruppo di ricerca che ha pensato di potere convivere con una questione così decisiva – perché ci ha posto di fronte a domande così radicali da corrodere alla radice la nostra possibilità di riconoscerci nelle tendenze culturali prevalenti e nelle forme di identità professate anche nei nostri ambienti di vita e di lavoro.
«Non si dà vera vita nella falsa» osservava Adorno in Minima Moralia. E Judith Butler, dopo aver constatato che tale frase risuona in modo diverso a seconda dei periodi storici in cui viene enunciata, così afferma:
«… fin dall’inizio ci troviamo di fronte a due problemi: il primo consiste nel chiedersi come si può vivere bene la propria vita, in modo da poter affermare di vivere una buona vita in un mondo in cui la vita buona è strutturalmente e sistematicamente inaccessibile a molte persone. Il secondo consiste nell’individuare quale forma oggi possa assumere la questione per noi; detto altrimenti, comprendere come il periodo storico in cui viviamo condizioni e pervada la forma stessa della questione» (Butler, 2013: 13-14).
Noi abbiamo provato a tradurre queste domande in altre modellate sul rapporto tra Europa e Mediterraneo. Ne sono derivati tre interrogativi, che considero ancora inesausti, e che sono i seguenti:
- Può il sapere geografico sottrarsi al cerchio della frontiera?
- Quale gerarchia dell’umano è sottesa alle politiche e alle retoriche delle migrazioni?
- Può il discorso sui migranti sottrarsi alla violenza della criminalizzazione quanto alla solidarietà dell’umanitarismo? [13].
Alla prima domanda, la risposta è no. Non in Europa. Per un motivo evidente: la risposta non richiede un atto intellettuale, anche ardito, quanto piuttosto un agire politico condiviso. E l’Europa, come abbiamo visto, sta andando in tutt’altra direzione. Alla seconda domanda, la risposta è nessuna, poiché essa è impensabile se non in chiave razzistica e/o nazionalistica. Ma anche in questo caso, constatiamo con sgomento che l’Europa sta andando in altra direzione. La terza domanda, infine, è la più insidiosa, perché si fonda su sistemi di pratiche, pur divergenti, ma che si fondano sui medesimi presupposti.
Eppure, non si trattava di domande retoriche. Per questo, le abbiamo riproposte nell’ambito della sessione 22 del XXXII Congresso Geografico Italiano dedicata al tema “Il Mediterraneo: per una geografia critica della frontiera”. Ci siamo confrontati con colleghi italiani e stranieri all’interno di un quadro teorico ampiamente condiviso e che ci induceva a guardare al Mediterraneo come borderscape e ad analizzare le tendenze alla delocalizzazione della frontiera e alle dinamiche di esternalizzazione e internalizzazione in atto nella gestione delle migrazioni mediterranee [14].
A che punto è oggi questa serie di questioni? Io temo che non ci siamo mossi dal punto di partenza, e non per insipienza o per mancanza di volontà. Quanto piuttosto perché la verità non può essere detta oggi in Europa – come dimostrano le tragiche esperienze di vita e di morte di Ilaria Alpi, Tullio Regeni o Daphne Caruana Galizia – troppi legami avviluppano il Mediterraneo in una rete di violenze, complicità e connivenze. Ciò non ci impedirà di continuare a esplorare anche gli intimi recessi di questo mondo e provare, comunque, a praticare il linguaggio della verità.
Dialoghi Mediterranei, n. 36, marzo 2019
Note
[1] Mi riferisco alla mostra di Sebastiao Salgado Kuwait. Un deserto in fiamme, esposta a Milano dal 20 ottobre 2017 al 28 gennaio 2018.
[2] Dal 1988 sono morte lungo le frontiere dell’Europa almeno 27.382 persone di cui 4.273 soltanto nel 2015 e 3.507 nel 2014. Il dato è aggiornato al 2 febbraio 2016 e si basa sulle notizie riportate sulla stampa internazionale. È possibile consultare la documentazione completa visitando il sito Fortress Europe di Gabriele Del Grande.
[3] Una recente mostra dal titolo Cosmopolis. Explorer la mondialisation des villes. Exploring globalising cities (16 giugno – 10 settembre 2011) organizzata dall’Università di Neuchatel è stata dedicata alla ricerca condotta tra il 2007 e il 2011 sulle trasformazioni in atto a Palermo, Hanoi e Ouagadougou.
[4] Si tratta del Programma nazionale di ricerca dal titolo “La città cosmopolita. Zone di contatto, flussi, geografie” cofinanziato dal MIUR nel 2007(coordinatore nazionale: Vincenzo Guarrasi).
[5] Si vedano ad esempio i saggi di Lorena Scarcella, Desiré Musumeci, Giulia Veca nel primo volume dal titolo La città cosmopolita. Geografie dell’ascolto (Guarrasi, 2011) e di Giulia de Spuches, Alessandra Di Maio, Manuela Lino e Angela Alaimo nel secondo volume dal titolo La città cosmopolita. Altre narrazioni (de Spuches, 2011)
[6] Le due edizioni dell’evento si tennero a Palermo nel settembre del 2006 e del 2007. La Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo organizzò, durante la mia presidenza, due edizioni di un evento dal titolo XXX. E mi piace sottolineare che la città di Palermo ha fatto tesoro di questa e altre esperienze, come risulta evidente dal successo dell’attuale Festival delle letterature migranti.
[7] L’esempio più efficace di tale scelta metodologica lo troviamo in Rapsodia in K di Desiré Musumeci (2011: 128-151) dove si racconta come una particolare empatia tra intervistatrice e intervistata abbia dato luogo a una struggente narrazione autobiografica.
[8] Nel 2013 si tenne ad Agrigento un convegno interdisciplinare i cui atti furono pubblicati a cura di Mario Grasso con il titolo: Razzismi, migrazioni, confinamenti (2014).
[9] Nel naufragio del 18 aprile 2015, il più grave, di cui si abbia notizia, dal dopoguerra nel Mediterraneo orientale perirono almeno 700 persone. 368 ne erano morte nel naufragio al largo di Lampedusa; altre 400 il 12 aprile 2015. Si calcola che dal 1 gennaio al 30 aprile del 2017 siano approdate sulle coste europee 29mila persone e che altre 663 siano morte durante il viaggio.
[10] La performance in forma di reading ebbe due repliche, entrambe a Palermo: la prima ai Cantieri Culturali alla Zisa, la seconda presso il locale Moltivolti. Accanto alla stessa de Spuches, che firmava i testi, comparivano in scena Irene Ientile, Filippo Luna e Lucina Marchese.
[11] Si tratta di Giulia de Spuches, Francesca Genduso, Chiara Giubilaro, Vincenzo Guarrasi, Laura Lo Presti e Marco Picone.
[12] Le tre più giovani tra gli estensori del Manifesto, Chiara Giubilaro, Francesca Governa e Laura Lo presti hanno conseguito il titolo Dottore di Ricerca presso tale dottorato. La prima nel XXVII ciclo, le altre due nel XXIX.
[13] Le domande sono contenute nella Call for Action del 2014.
[14] Le tematiche affrontate saranno in parte rese pubbliche negli Atti del Congresso in corso di stampa. Segnalo, in proposito, che una delle più suggestive letture del Mediterraneo è stata avanzata da Alessandra Bonazzi quando ha parlato del Mediterraneo come interferenza sul piano di immanenza del capitale. Interferenza tra dentro e fuori, tra libero scambio delle merci e forma degli Stati nazionali.
[15] A two days’ conference was held in Palermo on the 10th and 11th of November 2015, and its title was And So Europe Dehumanized Itself. Mediterranean Geographies in action. The title of the conference and of the manifesto are taken from Paul Gilroy’s interview to Toni Morrison (1993). See https://www.academia.edu/14524762/
And_So_Europe_Dehumanized_Itself._Mediterranean_Geographies_in_Action.
Riferimenti bibliografici
Bhabha, H. K. (a cura di), Nazione e narrazione, ed. it., Roma, Meltemi, 1997.
Badiou, A., “Pensare l’evento” in Badiou, A., Zizec, S., La filosofia al presente, ed. it., Genova, Il nuovo Melangolo, 2012: 5-30.
Bartoli, C. (a cura di), Esilio/asilo. Donne migranti e richiedenti asilo in Sicilia, Palermo, :duepunti edizioni, 2010.
Bartoli, C., Razzisti per legge. L’Italia che discrimina, Roma-Bari, Laterza, 2012.
Beck, U., Lo sguardo cosmopolita, ed. it., Roma, Carocci, 2005.
Butler, J., A chi spetta una buona vita?, ed. it., Roma, Nottetempo, 2013.
Castells, M., Reti di indignazione e speranza. Movimenti sociali nell’era di Internet, ed. it., Milano, Università Bocconi Editore, 2012.
Cresswell, T., On the Move. Mobility in the modern western world, New York, Routledge, 2006.
Cuttitta, P., Lo spettacolo del confine. Lampedusa tra produzione e messa in scena della frontiera, Milano, Mimesis, 2012.
Cuttitta, P., Vassallo Paleologo, F. (a cura di) Migrazioni, frontiere, diritti, Napoli-Roma, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006.
De Spuches, G., La città cosmopolita, vol. I, Palermo, Palumbo, 2011.
Foucault, M., La strategia dell’accerchiamento. Conversazioni e interventi 1975-1984, ed. it., :duepunti edizioni, Palermo, 2009.
Foucault, M., Il coraggio della verità. Il governo di sé e degli altri II. Corso al Collège de France (1984), ed. it., Milano, Feltrinelli, 2011.
Giubilaro, C., Spazi e narrazione: un’odissea in Guarrasi, V., La città cosmopolita, vol. I, Palermo, Palumbo, 2011: 64-85.
Giubilaro, C. ,Corpi, spazi, movimenti. Per una geografia critica della dislocazione, Milano, Unicopli, 2016a
Giubilaro,), On the Bride’s side ? Fra politica della dislocazione ed etica del posizionamento, Geotema, 2016b, 50: 57-63..
Giubilaro, C., Prekäre Räume. Körper, Verletzbarkeit, Widerstände, in V. Borsò, S. Borvitz, & L. Villacañas (A C. Di), Prekäres Leben: Empörung und (Un-)Verständnis in den Medien, Düsseldorf: Düsseldorf University Press, 2016c
Giubilaro, C., Shooting Borders: per una geografia visuale delle migrazioni, in La Rivista Geografica Italiana, 2017, 127: 315–336.
Giubilaro, C., (Un)framing Lampedusa Regimes of visibility and the politics of affect in Italian media representations, in L. Odasso & G. Proglio (A C. Di), Border Lampedusa. Subjectivity, Visibility and Memory in Stories of Sea and Land, London: Palgrave Macmillan, 2018a
Giubilaro, C., Lo spettacolo del naufragio Migrazioni, luoghi visuali e politica delle emozioni, in D. Salerno & V. Perilli (A C. Di), Padova University Press, 2018a.
Giudice C. & Giubilaro C, Re-imagining the border: Border art as a space of critical imagination and creative resistance, in Geopolitics, 2018b, 20(1): 79-94.
Guarrasi, V., Paradoxes of Modern and Postmodern Geography: Heterotopia of Landscape and Cartographic Logic in MINCA, C., (ed.), Postmodern Geography: Theory and Praxis, London, Blackwell, 2001: 226-238.
Guarrasi, V., La città cosmopolita, vol. I, Palermo, Palumbo, 2011.
Guarrasi V., Singolarità nude. Orizzonte di eventi mediterranei, in Grasso, M. (a cura di), Razzismi, migrazioni, confinamenti, 21-31, Roma, Ediesse, 2014: 21-21
Harari, Y. N., 21 lezioni per il XXI secolo, Milano, Bompiani, 2018.
Kanafani, G., Ritorno a Haifa, ed. it., Roma, Edizioni Lavoro, 2003.
Leghissa, G., Orientarsi nelle retoriche del multiculturalismo in aut aut, n. 312, 2002: 19-45.
Lindqvist, S., Sterminate quelle bestie, ed. it., Milano, TEA, 2003.
Mannoia, M., Il silenzio degli altri. Discriminati, illusi e invisibili, Roma, XL, 2011.
Mannoia, M., PIRRONE, M. A. (a cura di), Il razzismo in Italia. Società, istituzioni e media, Roma, Aracne, 2011.
Nancy, J.-L., All’ascolto, ed. it., Milano, Raffaello Cortina Editore, 2004.
Pirri, A. (a cura di), Libeccio d’Oltremare. Il vento delle rivoluzioni del Nord Africa si estende all’Occidente, XXX, Ediesse, Roma, 2011.
Pirrone, M. A. (a cura di), Approdi e scogli: Le migrazioni internazionali nel Mediterraneo, Milano, Mimesis, 2002.
Pirrone, M. A. (a cura di), Crocevia e trincea. La Sicilia come frontiera mediterranea, Roma, XL edizioni, 2007.
Proglio, G., Decolonising the Mediterranean. European Colonial Heritages in North Africa and the Middle East, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2016.
Rushdie, S., Patrie immaginarie, ed. it., Milano, Mondatori, 1991.
Said, E., Nel segno dell’esilio, ed. it., Milano, Feltrinelli, 2008.
Saletti, C. (a cura di), Fine Terra. Benjamin a Portbou, Verona, Ombre Corte, 2010.
Sciurba, A., Campi di forza. Percorsi confinati di migranti in Europa, Verona, Ombre Corte, 2009.
Spivak, G. C., La politica della traduzione, ed. it. in Devi, M., Invisibili, Napoli, Filema, 2007.
Traverso, E., Cosmopoli. Figure dell’esilio ebraico-tedesco, ed. it., Verona, Ombre Corte, 2004.
Vassallo Paleologo, F., Diritti sotto sequestro: Dall’emergenza umanitaria allo stato di eccezione, Roma, Aracne, 2012.
Appendice
Manifesto
And So Europe Dehumanized Itself
Introduction
How does one lead a good life in a bad life? (…) we have two problems: the first is how to live one’s own life well, such that we might say that we are living a good life within a world in which the good life is structurally or systematically foreclosed for so many. The second problem is, what form does this question take for us now?
Judith Butler’s incipit for the Adorno Prize Lecture poses the key question of the most recent history of the Mediterranean. Are we still able to consider it as a migratory phenomenon involving Europe? And can Europe honestly state it is no longer adopting emergency policies, after several decades?
Between the end of the 20th and the beginning of the 21st century, the Mediterranean has turned into both a transit zone and a border zone, where Schmitt’s ideas of a space of nomos, order and localisation seem to fall on hard times, and then finally into the space of a liquid-able humanity. Within this event horizon the dehumanization of Europe can be measured.
This manifesto finds its location in the Mediterranean and in the events impressed over several decades on its surfaces and bottoms. Here, the regimes of mobility control enacted by the so-called ‘Fortress Europe’ are challenged everyday by the bodies of those women and men who stubbornly try to resist them. Here, the border unveils the differential and violent nature of its very functioning, ceaselessly reproducing silent cuts between desired and undesired mobilities, economic migrants and political refugees, livable lives and ungrievable deaths.
Positionings
The call for actions of the Palermo conference15 aims at reflecting on the status quo of the Mediterranean issue and adopting a resistant positioning towards the rhetoric proposed by the Nation States and the EU.
Within the European policies on the migrants, within the continuous proliferation of highly nationalised discourses, within the ‘securing’ of the borders and the widespread feeling of extremely racist ideas lie the traces of a process of dehumanization which is far from reaching its conclusion, feeding on that same modernity which stems from colonialism and still persists in the colonialidad del poder (Quijano, 1991).
We should not forget that civilization and dehumanization can be considered the aspects of the process of conquest and cultural imposition committed by Europe and the Western episteme (Spivak, 1999) against the rest of the world. The creation of an imaginary in which the ‘we’ could act as a positive pole, as opposed to the ‘others’, has led to a new and ruthless hierarchisation of the humankind. Through this process of material, economic, and cultural subjugation, Europe has gradually dehumanized itself, losing sight of those human values in whose name it has always promoted and still promotes new war scenarios. Understanding how the relationship between ‘us’ and the ‘others’ is structured could serve as an epistemological tool to interpret the complexity of the present and to analyse current issues and ideological positions with a long-term perspective, aiming to grasp the continuities and discontinuities with the past. Therefore, the attempt to read our own times in the light of the colonial past can unveil the postcolonial condition of the Mediterranean space.
In the European policies, the construction of the Mediterranean as a border implies the sliding of the responsibilities of territorial control, because it mixes up the authority of the Nation states, the European directives and the financialisation of risk management. There are persons getting caught on these tangles of control, and it is these persons that must be listened to, it is these geographies that must be written.
The events happening in the Mediterranean today contain a decisive call to our responsibility, that is our capability to build up political and cultural responses aimed at radically questioning the unacceptable conditions the European governments have arranged at different scales – local, regional, national and transnational.
Moving from these events and their violent geometries of power, we intend to give rise to a collective discourse, which must be both anti-establishment and productive at the same time, and must keep critical force and creative impulse together.
Languages
In order to let emerge the complex architecture where migratory regimes take shape, it is necessary to make the different languages which give meaning to them resonate and collide, both in theory and in practice. A de-assembly and re-assembly of words, images, voices to transcode and to decipher, to diagnose and to reconfigure in the light of a twofold critical gesture: on the one hand, we feel compelled to provide a not-unitary and reifying approach to migration processes which effectively anesthetise and pathologise the polyphonic movement of bodies; on the other hand, we wish to activate, in the cracks and infiltrations of such regimes, alternative political spaces.
Our belief is that the Mediterranean represents the terrain of a fundamental battle on the modalities and forms which govern the representation of migrations in Europe today. This battle deals with different fields and scales, involving heterogeneous and irreducible subjects and languages. If the struggle over representation is so widespread and composite that it makes every intervention inside of it difficult and elusive, then we need to open our discourse to different languages, exceeding the verbal dimension and reclaiming other gazes and grasps on the world.
In front of the media weight exerted by the ‘migration crisis’ today – an excess which results in the proliferation of discourses, images, maps of migratory fluxes and routes, shipwrecks, fights, ‘invasions’, as well as in the obsession of statistics and the numerification of bodies – we might get stunned by a vertigo of saturation and a resulting sense of distance.
One question, then, becomes urgent and leads us to react: how can one capture that moment in which certain phenomena and stories demand to be looked at and listened to in a different way? That moment when a change of perspective – another way of seeing, feeling, and acting – is required?
To avoid falling into the trap of a unique discourse, we believe a polyphonic and polymorphic methodology must be implemented: audios, videos, images, maps and texts are the tools that have to rebound between each other, in order to reclaim the ethical and moral question that Judith Butler points out. Creating an archival network of the memories of these times is a responsibility that we feel we must not evade.
Laws, narratives and discourses
Writing has the power to create and shape common feelings and public discourses, to address political choices and totally rewrite the identities of the migrants, turning them into subaltern subjects. This ability can be brought back to an essential critical horizon through the textual production of a complex and varied archive, and reading this archive can unveil the discoursive background in which migration policies operate. This archive is composed of all those types of text – legal rulings, international agreements, political press or literary works, essays, narratives and public discourses – that depict the crucial rebound of these writings and words. That is the uniqueness of the voices, the acoustic of politics, and also the cold tone of power.
Visual and beyond
The visual field probably represents the most pervasive language usually employed to envision migrations on the public scene. Images of suspended boats on the sea surface and wreckages run ashore, crowds of bodies onto the docks and corpses lying on the beaches, attract media attention, mobilizing a soundless battle where our gaze becomes both a battlefield and the real issue at stake. The visual representation of migrations with its deeply racialized implications ceaselessly reproduces objects and subjects of vision, which, today more than ever, we need to critically interrogate. If the spectacle of suffering runs the risk of sliding into a mute and unproductive empathy, then only by questioning the viewers’ location and the geometries of power underlying it can the visual become a space for political responsibility and cultural critique.
Cartographies
Oscillating between Frontex’s operational cartographies and the contemporary map-activism, we suggest that the map, especially in its digital transposition, has become the historical recording machine of the contemporary geopolitical space. Thus, it configures, in all its evidence, the spatial arrangements in which the current necropolitical power (Mbembe, 2003) consumes and justifies itself. Therefore, it becomes essential to train and multiply the critical looks to deconstruct the complex system of representations and processes within which the migratory visualities take shape in the cartographic arrangement. Our gaze should be able to understand how these visualities compete with the Mediterranean necropolitical space. And since these cartographic visualizations constitute a peculiar type of iconography, we must not cease questioning how they can be redirected towards new horizons, how they can and should be reconsidered and reconceived in order to accommodate, rather than to expel, the human.
For a situated knowledge
Listening is a radical practice for us, at the root of other forms of thought so far discussed. If the meeting/clash with the other has proved to be the story of a silencing, a long process of foreclosure whose victims today are likely to be – or rather are – the migrants, activating a listening dimension might mean creating a resonance space where the voices complement each other and subjectivities result from an exchange and not from a despoliation.
These are the coordinates within which we move. Each of us is called to abide by them or to change them, to divert the path and to disorient them. None of us has to claim all these languages together. It is around these theoretical coordinates and in their insuppressibly political sense that we intend to give rise to a politics of coalition (Butler, 2015), within which the different positions can in turn be assembled into extroverted and dissonant forms.
In the dialogue between our alternative but shared positions it is mandatory to trace new figurations that are resistant to the stasis of representation, by welcoming ‘new’ subjects who cannot be tamed, measured and controlled. In short, we need to rethink the human where the European humanist promise has miserably failed.
References
Butler J. (2012), Can one lead a good life in a bad life? Adorno Prize Lecture, Radical Philosophy, 176: 9-18.
Butler J. (2015), Notes toward a Performative Politics of Assembly, Cambridge-London, HarvardUniversity Press.
Mbembe A. (2003), Necropolitics, Public Culture, 15 (1): 11-40.
Morrison T., in Gilroy P. (1993), Small Acts. Thoughts on the Politics of Black Cultures, London, Serpent’s Tail.
Quijano A. (1992), Colonialidad y Modernidad/Racionalidad, Perú Indígena, 13 (29): 11–20.
Spivak G.C. (1999), A Critique of Postcolonial Reason, Boston, HarvardUniversity.
___________________________________________________________________________
Vincenzo Guarrasi, è professore ordinario di Geografia presso il Dipartimento Culture e società dell’Università di Palermo. È stato Preside della Facoltà di Lettere e vicepresidente dell’Associazione dei Geografi Italiana. I suoi principali campi di ricerca sono stati: la condizione marginale; le migrazioni internazionali; le città cosmopolite. Ha pubblicato numerosi saggi e monografie su vari temi connessi alle dimensioni della geografia urbana e culturale.
___________________________________________________________________________















