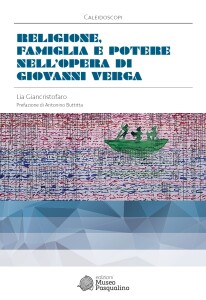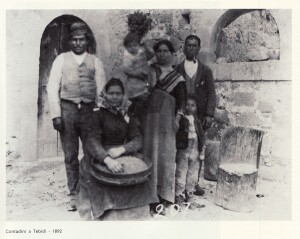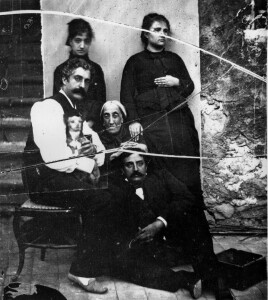Lia Giancristofaro, che insegna Antropologia culturale all’Università “G. D’Annunzio” di Chieti, ha letto le opere veriste di Giovanni Verga con l’intento lodevole di rintracciarvi e inventariare tutti gli aspetti etnografici, culturali e materiali, che caratterizzano la società arcaica rappresentata con tutte le sue vicende e tutta la sua umanità dallo scrittore siciliano. Ne è nato un volume, Religione, famiglia e potere nell’opera di Giovanni Verga (prefazione di A. Buttitta, Edizioni Museo Pasqualino, Palermo 2022), che riporta il ricco patrimonio etnografico utilizzato dal romanziere, cui si aggiungono, a riscontro di quanto rilevato, le testimonianze tratte dai lavori di Pitrè, Salomone Marino, Guastella ed altri studiosi minori, nonché le considerazioni svolte dalla stessa Giancristofaro che spiega le usanze e i costumi meno noti e guida il lettore alla loro comprensione. Se prima di questo lavoro potevamo solamente supporre che il Verga aveva costruito i suoi romanzi veristi e le sue novelle grazie alla sua esperienza personale acquisita durante gli anni di Tebidi e di Vizzini, a contatto con il mondo agro-pastorale di quelle zone, adesso sappiamo pure che si servì largamente delle opere etnografiche, che via via si pubblicavano a quel tempo, per dare i colori del vero alle sue trame narrative e ai suoi personaggi.
Grazie a questa rassegna così scrupolosa, Giancristofaro ricostruisce totalmente, pezzo per pezzo, le condizioni esistenziali e sociali e ambientali in cui si muovono i personaggi verghiani contenendole nei quaranta capitoli che costituiscono il libro, di cui i primi tre sono dedicati alla figura del Verga etnografo; di questi, però, vorrei discutere più in là. Nella catalogazione della Giancristofaro pertanto rientrano tutte le attività fondamentali di una comunità ma anche le più piccole: si va dal lavoro contadino, al commercio delle botteghe, a quello ambulante e a quello occasionale, dal lavoro artigianale a quello della miniera, al mestiere del pescatore (aspetto principale dei Malavoglia) e a quello del pastore; c’è poi la lunga serie del ciclo della vita, dalla nascita alla morte, con tutti i vari passaggi di stato e i relativi riti e credenze: battesimo, matrimonio, fujtina, lutto, vedovanza, ecc.. Lo sguardo della Giancristofaro si estende anche al paesaggio, all’ambiente campagnolo e a quello paesano, alle abitazioni dei contadini e a quelle dei borghesi e dei nobili decaduti; riguarda anche gli animali e i rapporti che si instaurano tra essi e gli uomini. Altre pagine sono dedicate alle colture più importanti: il frumento, l’oliveto e il vigneto, cioè quelle piante che garantiscono l’elementare alimentazione quotidiana, il pane, l’olio e il vino.
Ci sono, tuttavia, elementi della cultura popolare che nelle opere del Verga assumono un’importanza maggiore rispetto agli altri. Tra questi troviamo i proverbi che fanno quasi da struttura portante alle vicende narrate nei Malavoglia. Padron ‘Ntoni, il personaggio principale del romanzo, è interamente plasmato su materiale etnografico; egli, infatti, oltre ad affidarsi alle regole tradizionali della vita sociale, parla e ragiona mediante un uso ampio dei proverbi, tanto da aver attirato l’attenzione di molti folkloristi a caccia di detti popolari e dei critici letterari che hanno cercato di spiegarsi le origini dello stile dello scrittore. Con questo personaggio e con l’espediente dei proverbi Verga ci immette direttamente in un ambiente arcaico, lontano non solo da noi che viviamo nel XXI secolo, ma anche dai primi lettori del romanzo. I proverbi, come si sa, sono stati le guide per tutti i popoli senza scrittura, tramandati oralmente e basati sulle esperienze acquisite nella vita quotidiana. Essi sono stati definiti “sapienza dei popoli” ma la famiglia dei Malavoglia imparerà a sue spese quanto fallaci siano le conoscenze empiriche che si basano sulle apparenze della realtà. Lia Giancristofaro ha raccolto tutti questi motti, dei meno usuali ha spiegato il significato e poi ha fatto vedere come funzionano nel definire i personaggi e lo svolgersi delle vicende.
Il tema delle feste religiose, per la loro complessità, offre agli etnografi l’opportunità di studiare non solo gli aspetti tradizionali della ritualità ma anche altri tratti culturali delle società che le promuovono. Lo sapeva il Verga che spesso ambientava le sue storie durante questi riti religiosi e lo sa Giancristofaro che affronta questo tema raggruppando in apposito capitolo le notizie sulle costumanze e gli usi festivi riportati dal Verga. Ovviamente, oltre a quelle previste dalla liturgia cattolica, Natale e Pasqua soprattutto, sono le feste dedicate ai santi patroni delle varie località ad attirare l’attenzione del romanziere, in quanto durante il loro svolgimento è possibile cogliere i vari modi con cui si manifesta la religiosità popolare, nella quale convivono pratiche che spesso si allontanano dall’ortodossia della Chiesa e che riguardano non solo la professione di fede, talora fanatica, ma anche la superstizione, il fatalismo, la magia. Per sottolinearne l’efficacia narrativa e il realismo, le testimonianze letterarie del Verga sono confrontate dalla studiosa con brani ripresi da Salomone Marino, da Pitrè ed anche da Emilio Sereni.
Riferendosi sempre alle notizie comprese nell’opera verghiana, Giancristofaro ricorda che le feste patronali, tra l’altro, alla fine dell’Ottocento e ai primi del Novecento, erano anche le occasioni durante le quali si effettuavano gli scambi commerciali più importanti per le comunità contadine, perché, come sappiamo da quelle rare antiche tradizioni ancora oggi in vigore, era nei giorni della festa che si svolgevano fiere e mercati, le prime per la compravendita di animali da soma e da stalla, i secondi per l’acquisto di utensili necessari per la vita quotidiana (terraglie, posate, ecc.) e per rifornirsi degli attrezzi necessari per il lavoro dei campi.
Le feste erano, inoltre, importanti appuntamenti annuali durante i quali si poteva abbandonare la vita quotidiana per qualche giorno e dimenticarsi delle fatiche e degli stenti, per godere di momenti di riposo, di spensieratezza e di semplice divertimento: ed ecco la banda, le giostre ed i fuochi artificiali.
La visione verghiana dell’umanità è fortemente naturalistica: per lui gli uomini e gli animali condividono la stessa istintività. Per questo tra le due specie c’è la possibilità di una coabitazione e di una convivenza che in una società contadina arcaica è molto stretta. Il rapporto più diretto tuttavia è quello tra uomini e animali da soma, i quali costituiscono un indispensabile aiuto nei lavori dei campi e nel trasporto di persone e cose. Tra questi il mulo è l’animale preferito dai carrettieri, mentre l’asino è il compagno e l’aiutante insostituibile per chi, possedendo del terreno da lavorare, farà tanti sacrifici per acquistarlo e per mantenerlo, senza per altro smettere di usarlo e maltrattarlo fino allo sfinimento. Nelle opere verghiane questi animali spesso diventano i protagonisti o i comprimari delle storie con una duplice rappresentazione: scrive Lia Giancristofaro che l’uomo sfrutta duramente la bestia e nel far ciò perde la sua umanità, mentre gli animali finiscono per assomigliare a quegli uomini su cui si accanisce la vita. La vicinanza tra uomo e animale si riduce fino all’identificazione dei due esseri nei casi in cui sono gli uomini ad essere sfruttati ferocemente, al pari di bestie da soma, come Rosso Malpelo, Ranocchio, Bastianazzo, Luca, padron ‘Ntoni ed altri, che solo nella morte trovano «l’unica liberazione dalla sofferenza».
Ci sono tuttavia altri animali, come i lupi, che dal Verga sono guardati come gli emblemi di una natura selvaggia, violenta, non domesticata e indomabile. Per meglio illustrare questo aspetto della natura ferina cui appartiene anche l’umanità, lo scrittore lo rappresenta in una figura di donna, la “lupa”, simbolo della natura famelicamente creatrice ma nello stesso tempo metafora della natura che tutto distrugge e tutto divora. La Lupa è un essere che attrae fatalmente e che contemporaneamente provoca paure misteriose, forse anche nello stesso scrittore che l’ha immaginata e descritta, se dobbiamo dare ascolto alle sensazioni che ci procurano le pagine in cui la tragica vicenda è narrata.
Giancristofaro affronta, poi, il tema della “roba” in un capitolo che, nella sua interpretazione moderna, intitola “ Il capitale”; nei testi verghiani, tuttavia, la roba ha poco a che fare con il capitale che conosciamo oggi, come giustamente fa osservare Asor Rosa, citato dalla stessa Giancristofaro: Verga «si ferma alla fase dell’accumulazione primitiva (…), in cui si fissa socialmente quella brama di miglioramento che (…) assume più il carattere di una difesa dalla miseria che non di un vero e proprio meccanismo economico». In sostanza l’accumulazione di beni materiali (terreni, soprattutto, e case) e non di capitali finanziari è un modo per uscire dalla miseria e innanzitutto per dimostrare di essere capace di acquistare importanza sociale: «chi ha è, chi non ha non è», recita un proverbio popolare calabrese raccolto e interpretato da Vincenzo Padula. Gli sforzi e i sacrifici di Mastro don Gesualdo per raggiungere la ricchezza hanno lo stesso scopo: dimostrare che si è diventati “qualcuno” perché si possiedono beni materiali. I quali, tuttavia, non hanno una durata infinita, perché possono essere in breve tempo dilapidati da chi, come la figlia e il genero di don Gesualdo, non ha conosciuto la miseria, o che non hanno più necessità di esistere quando muore chi li ha per lunghi anni accumulati: è il caso di Mazzarò che, rimasto solo e presagendo la sua fine imminente, con un bastone cerca di ammazzare gli animali presenti nell’aia, gridando: «Roba mia, vientene con me».
In una società che non riconosce istituzioni fondate allo scopo di regolare la convivenza sociale, l’amministrazione della giustizia diventa un fatto personale, basandosi sulle capacità del singolo di sapersi difendere, magari ricorrendo alla violenza, come Jeli il pastore, o al duello rusticano come Alfio e Turiddu. Lo Stato nelle opere del Verga è assente e, se c’è, è visto come nemico dei poveri, su cui è solito infierire per mezzo dei suoi funzionari e soprattutto degli “sbirri”; anche i personaggi istituzionali della società, come medici, farmacisti, avvocati, sono considerati alla stregua di prepotenti dediti a rendere la vita difficile ai poveri. Per non parlare delle tasse, viste semplicemente come un furto legalizzato. Nelle opere verghiane, dunque, l’immagine dello Stato è quella di un intruso che si intromette negli affari del singolo. Ed è un’immagine inquietante perché ci rimanda ad una concezione dello Stato molto simile a quella su cui si basa la mentalità mafiosa.
C’è un altro aspetto dell’ideologia verghiana che Giancristofaro ha affrontato anche solo parzialmente e in occasione di vicende sfortunate dei personaggi presenti nella narrativa dello scrittore, ed è il pessimismo che percorre tutte le sue pagine. Rifacendoci alla letteratura italiana, per restare nel campo del Verga, rimane facilmente comprensibile il pessimismo del cattolico Manzoni derivante dalla consapevolezza della fragilità dell’uomo che inclina verso il peccato; esso, però, ha un contrappeso nella Provvidenza e nella misericordia divina; nel Verga, alquanto agnostico se dobbiamo così interpretare nella sua opera l’assenza di qualsiasi accenno di fede religiosa, la Provvidenza è il nome della barca dei Malavoglia il cui naufragio dà inizio alla decadenza della famiglia e alle drammatiche vicissitudini dei suoi membri. Compare sempre in tutte le vicende narrate dal Verga una forza misteriosa e maligna, una fatalità che manda in rovina i progetti di tutti i personaggi. L’unico rimedio sembra essere l’invocazione alla Madonna e ai santi, ma chi vi si rivolge molto difficilmente trova udienza e i suoi affari e la sua salute vanno conseguentemente in rovina.
Lo stesso pessimismo invade il campo della storia e della biologia, perché l’evoluzione, vista dal positivismo del tardo Ottocento come tendenza che si muove verso il miglioramento delle condizioni di vita e come progresso per tutti gli aspetti dell’esistenza umana, secondo Verga non prospetta nessuna possibilità di allontanare fatiche, disgrazie, miseria e malattie dagli esseri umani. È questo un pessimismo che spesso cade in quel fatalismo che è quasi connaturato con la mentalità siciliana. Da qui discende la convinzione che tutto debba rimanere immobile e che di conseguenza non ci sia nessuna opportunità di un cambiamento dei rapporti sociali: ognuno resterà aggrappato allo scoglio dove la natura l’ha destinato e così sarà fino alla fine dei secoli.
Con questa visione del mondo e della vita Giovanni Verga ha affrontato lo studio dell’umanità di Vizzini trasformandola in simbolo universale della condizione umana; per far questo ha dovuto rivolgersi all’etnografia, cioè studiare, partendo dal territorio di Vizzini, i costumi, le usanze, i modi di vivere, le tecniche di lavoro, la produzione di beni, tutto quanto, infine, è necessario alla sopravvivenza di una società.
La rappresentazione del mondo degli “umili” nelle opere del Verga deve dunque molto all’etnografia e molto deve anche alle teorie del Naturalismo francese fattegli conoscere dall’amico Luigi Capuana; l’accoppiamento di questi due elementi ha dato un esito felicissimo e il Verga è stato acclamato come colui che, attraverso l’arte, ha richiamato l’attenzione su una parte consistente della società italiana che viveva in condizioni di vita quasi primitive.
Il lavoro di accurata sintesi della Giancristofaro non si discosta da questo giudizio ma, a mio parere, può costituire un punto di partenza per ipotesi diverse da quelle comunemente accettate. Alla studiosa la scrittura del Verga appare più coinvolgente e più convincente di quella di Pitrè, di Salomone Marino e di tutti gli etnografi in genere; in questa affermazione sono implicite le riflessioni di J. Clifford, esposte nel libro I frutti puri impazziscono, secondo il quale etnologi ed etnografi nel raccontare gli esiti delle loro ricerche finiscono col fare letteratura. Sull’onda di queste considerazioni l’Autrice spiega perché il Verga scrittore è da ritenersi anche etnografo e antropologo, e talora superiore agli stessi etnografi perché riesce a far rivivere ciò che in questi era pura ed inerte documentazione.
C’è del vero in questa asserzione, tuttavia occorre fare qualche distinzione: l’antropologo non ha intenti letterari, vuole fare conoscere i tratti e i meccanismi culturali di una comunità, vuole informare gli altri di aver ritrovato di certe usanze e di certi comportamenti umani diventati tradizioni, spesso incomprensibili, l’originario significato. Il romanziere e il poeta, invece, non avendo interessi di tale natura, prendono da una cultura, quando la trovano interessante e adatta ai loro scopi letterari, gli spunti per creare i loro intrecci narrativi, i loro personaggi, le loro rappresentazioni poetiche, senza preventivamente analizzarne i meccanismi. Se poi, a lavoro finito, l’opera dello scrittore o del poeta suscita in noi godimenti estetici e sentimenti di solidarietà nei confronti dei personaggi, ciò è dovuto al fatto che, mentre l’antropologia usa metodi di ricerca e linguaggi scientifici e in genere comunica i risultati delle sue ricerche con una esposizione di tipo denotativo (che, però, non essendo necessariamente asettica e neutrale, può avere uno stile letterario), la letteratura, con il suo linguaggio basato principalmente sulla connotazione, provoca reazioni emotive diverse in ogni singolo fruitore.
Giancristofaro, difatti, afferma che l’etnografia (inconsapevole) di Verga esprime qualcosa in più rispetto a quella del Pitrè, ma è normale che l’arte, avendo strumenti adatti ad attribuire aspetti psicologici particolari ad ogni personaggio, sia capace di promuovere emozioni che l’etnografia e l’antropologia non hanno: lo scrittore rappresenta i personaggi da lui ideati come esseri viventi e per questo ce li fa amare, l’etnografo ce li mostra come oggetti di studio, solo per farceli conoscere. Nella scrittura di un narratore c’è, per così dire, un incantesimo, prodotto dall’arte, che le facoltà critiche ed interpretative possono rompere per farci vedere che dietro la sublimazione artistica c’è la realtà, come nel caso della narrativa verghiana, di una insopportabile condizione esistenziale.
Nello stesso periodo in cui Verga veniva pubblicando le sue opere di carattere verista, il poeta Giovanni Pascoli guardava al mondo rurale con un’empatia tale da fargli desiderare di essere lui stesso un contadino. Era il momento drammatico del passaggio da un mondo arcaico e rurale ad un mondo urbano che si sorreggeva su pilastri economici industriali e finanziari, e che il Verga, osservandolo con sguardo ostile, definiva appunto «società delle Imprese industriali e delle Banche», in cui i grandi valori di una volta, etici ed estetici, erano stati sostituiti dalla ricerca del piacere e della ricchezza, e si considerava arte la riproduzione grafica sulle scatole dei fiammiferi delle ballerine del can-can [1]. Era il tramonto di un mondo in cui si era vissuti senza problemi filosofici ed esistenziali, era il momento in cui si assisteva alla nascita di un altro mondo, che minacciava di travolgere ed annullare quanto gli uomini erano riusciti a costruire nel corso di molti secoli.
Davanti a questo imminente sfacelo, il proprietario terriero Verga si aggrappava alle immagini delle sue campagne dove braccianti e pastori con molto coraggio affrontavano l’esistenza quotidiana fatta di stenti e di sentimenti istintivi e, talora, selvaggiamente dettati da una natura ferina. Davanti allo stesso sfacelo Pascoli si rifugiava nel suo piccolo campetto difeso dalla siepe, dal cane fedele e dalla nebbia. Ciò che accomuna i due letterati è l’empatia che hanno nei confronti di un mondo diverso dal loro, ciò che li distingue è l’ottica con cui lo guardano: Verga vuole attenersi ad una riproduzione “vera” della realtà (come aveva suggerito E. Zola e come cercava di ottenere anche per mezzo delle fotografie scattate in quel di Vizzini); Pascoli usa un linguaggio fortemente metaforico con cui trasforma i vari aspetti della “realtà” in simboli. Il risultato per ambedue è paradossale, perché riescono a capovolgere la realtà: non è più la società arcaica, patriarcale e rurale a costituire l’alterità, ma è invece la società moderna, borghese e capitalistica, a manifestarsi come una diversità nemica dell’uomo [2]. Se le cose stanno così, possiamo dire che entrambi i letterati si identificano con i loro personaggi e, almeno sentimentalmente, vorrebbero essere “contadini”, cioè appartenenti a quella società cantata da loro e in procinto di scomparire dalla scena della storia. Nei loro racconti e nei loro versi mi sembra che più che la denuncia ci sia il compiacimento nei confronti dei loro personaggi, se non addirittura una volontà di “transfert”.
Ai suoi tempi Verga ebbe successo solo con i romanzi tardoromantici, quelli veristici non piacquero. Durante il fascismo le sue opere furono ricoperte da una pesante coltre di silenzio perché non si poteva parlare di plebi miserabili in un Paese che si voleva discendesse dagli antichi e nobili Romani; nel secondo dopoguerra, invece, Verga fu riletto come precursore e capostipite del realismo e del neorealismo, in antitesi al silenzio fascista, alla letteratura rondista, ai telefoni bianchi del cinema, in solidarietà con la nuova società che si andava delineando dopo la comparsa, sulla scena politico-sociale, del mondo contadino ed operaio diventato protagonista della Resistenza e fautore di una società democratica, libera ed egualitaria. Questa rilettura in chiave neorealistica e democratica non ha indagato sul retroterra filosofico e psicologico del Verga, limitandosi a coglierne solo l’aspetto più evidente, quello più confacente all’ideologia dei movimenti progressisti del tempo.
Con la sua meritoria e attenta lettura antropologica Lia Giancristofaro non fa che rinsaldare il giudizio che su Verga è stato formulato dalla critica letteraria nel corso degli ultimi ottanta anni: egli resta lo scrittore che più di tutti, tra quelli che hanno trattato gli stessi temi, ha saputo ritrarre condizioni di vita che altri non vedevano o sottovalutavano o addirittura disprezzavano; tuttavia lo stesso lavoro della Giancristofaro, a distanza di un secolo da quando Luigi Russo contestava il giudizio di Croce, parlando della «insurrezione lirica degli umili», e dopo più di mezzo secolo trascorso dagli studi di Baldi, di Asor Rosa, Luporini e di altri illustri storici della letteratura, ci consente oggi di poter congetturare altre ipotesi di valutazione, non tanto sul valore dello scrittore che resta indiscutibile, quanto invece sulla sua visione del mondo e dell’esistenza umana.
Il Verga, con l’uso amplissimo che fa della cultura e del mondo dei braccianti, dei contadini, della piccola e media borghesia rurale, non si comportava come un osservatore partecipante, piuttosto a quella vita partecipava idealmente, dato che, fortunatamente, non era la sua, osservandola, direttamente con i suoi occhi e indirettamente con gli occhi degli etnografi, come una forma eroica dell’esistenza umana: nonostante tutte le traversie, le disgrazie, le ingiustizie, la miseria e le malattie, i vinti rimanevano attaccati alla vita come l’ostrica allo scoglio. Il suo pessimismo, confortato da un modo tutto suo di interpretare le teorie darwiniane, gli faceva vedere quelle difficili condizioni di vita come le uniche destinate all’umanità, in contrasto con le opinioni comuni di quel tempo, secondo le quali l’evoluzione significava un continuo progresso tendente al meglio; per il Verga non c’era redenzione né possibilità di riscatto. Questo pessimismo totale e tetro aveva conseguentemente una ricaduta a livello filosofico e politico-sociale: per lui tutte le contemporanee ideologie progressiste e socialiste erano solo fantasie che, se messe in pratica, avrebbero potuto causare pericolosi sconvolgimenti sociali.
Dialoghi Mediterranei, n. 61, maggio 2023
Note
[1] Con questi argomenti il Verga si rivolgeva ai suoi lettori nella prefazione del romanzo Eva.
[2] Sull’atteggiamento che il Pascoli assunse di fronte al mondo contadino e alla nuova società che si profilava, si veda Fresta M., Stellato fisso, domattina piove. Folklore, antropologia e la poesia del Pascoli, in «Rivista Pascoliana» n. 22, Patron, Bologna 2010: 113-149.
_____________________________________________________________
Mariano Fresta, già docente di Italiano e Latino presso i Licei, ha collaborato con Pietro Clemente, presso la Cattedra di Tradizioni popolari a Siena. Si è occupato di teatro popolare tradizionale in Toscana, di espressività popolare, di alimentazione, di allestimenti museali, di feste religiose, di storia degli studi folklorici, nonché di letteratura italiana (I Detti piacevoli del Poliziano, Giovanni Pascoli e il mondo contadino, Lo stile narrativo nel Pinocchio del Collodi). Ha pubblicato sulle riviste Lares, La Ricerca Folklorica, Antropologia Museale, Archivio di Etnografia, Archivio Antropologico Mediterraneo. Ultimamente si è occupato di identità culturale, della tutela e la salvaguardia dei paesaggi (L’invenzione di un paesaggio tipico toscano, in Lares) e dei beni immateriali. Fa parte della redazione di Lares. Ha curato diversi volumi partecipandovi anche come autore: Vecchie segate ed alberi di maggio, 1983; Il “cantar maggio” delle contrade di Siena, 2000; La Val d’Orcia di Iris, 2003. Ha scritto anche sui paesi abbandonati e su altri temi antropologici. E’ stato appena edito dal Museo Pasqualino il volume, Incursioni antropologiche. Paesi, teatro popolare, beni culturali, modernità.
______________________________________________________________