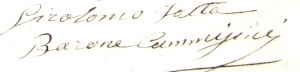di Giovanni Fatta
Tra i Fatta assai miti, talvolta anche piuttosto pavidi e timorati di Dio, uno è “fuori razza”, temerario, iracondo, prepotente, ma anche cordiale, estroverso, allegro, di compagnia.
Nella placida Polizzi, non ancora ufficialmente “Generosa”, nei primi anni dell’Ottocento abitava la nobile e stimata famiglia Fatta: da Orazio Calcedonio Fatta Torre, figlio del barone Girolamo Fatta Bonomo e di Teresa della Torre, sposato con Caterina Barile (o anche Barrile) dei baroni di Turolifi, erano nati Girolamo (1797), Giovanni (1798) [il nonno di mio nonno], Maria Stella (1802), Francesco (1804) e Maria Teresa (1814).
Orazio gestiva un discreto patrimonio essenzialmente composto da fondi agricoli e attività zootecniche, a differenza del fratello minore Francesco Paolo Fatta Torre (1770-1844) che aveva intrapreso una carriera che lo portò alla prestigiosa carica di Intendente di Ponti e Strade per la Sicilia e componente del Consiglio Civico della città di Palermo. Curiosamente, Francesco Paolo già a 25 anni aveva presentato una ampia documentazione per acquisire il titolo di barone della Fratta, per regola spettante al fratello maggiore, titolo che ottenne rapidamente e di questo poté fregiarsi per tutta la vita, anche nei tanti documenti ufficiali che lo riguardavano. Non mise su famiglia e non ebbe figli, lasciando, alla sua morte, eredità e titolo ai figli del fratello maggiore Orazio Calcedonio.
Il giovane Girolamo Fatta Barile a 24 anni, forse anche per la mancanza di una guida paterna (il padre Orazio era morto quando aveva soltanto sedici anni) che lo indirizzasse evitando eccessi e atteggiamenti scorretti, aveva sedotto (termine utilizzato anche negli atti giudiziari) la bella Angela Leto non ancora quindicenne, e i due si erano sposati in maniera frettolosa nel giugno del 1819 in quanto Angela era in gravidanza avanzata, con grande scandalo per la gente di Polizzi, ma soprattutto gravissima offesa per i genitori e i parenti stretti della ragazza. Nel mese di settembre nacque il figlio Orazio Fatta Leto, ma questo lieto evento non riuscì per nulla a quietare gli animi.
Girolamo aveva maturato un vero e proprio odio nei confronti del suocero Andrea Leto, che aveva più volte manifestato pubblicamente la propria vergogna per questo fatto che ne infangava la reputazione, ma soprattutto era montata nel genero una rabbia incontrollabile perché il suocero aveva rifiutato di corrispondere la ricca dote che di norma toccava alla figlia.
La famiglia Leto, baroni di Cammisini, era considerata molto ricca, sia per il consistente patrimonio che amministrava, sia in quanto «arricchita per alcune vantaggiose circostanze»: Andrea Leto era il “cassiere comunale” della città di Polizzi, il fratello Michele aveva assunto la carica di “prosegreto”, incaricato cioè della riscossione dei dazi del macino e della fondiaria. Il loro padre Gandolfo era da tempo l’esattore delle tasse comunali e titolare dell’arrendamento del patrimonio civico, cioè prendeva in affitto i beni comunali per poi subaffittarli a prezzo libero. Inoltre sia Andrea che la sorella Pasquala Leto avevano contratto “buoni” matrimoni con alcuni dei Gagliardo, la famiglia più in vista della cittadina.
Si può facilmente supporre che la potenza e l’ostentata opulenza dei Leto avessero suscitato risentimenti, invidie e gelosie, sia nel popolo minuto assillato da problemi economici quotidiani, sia presso le classi più elevate, anche per il loro recentissimo arrivo al titolo nobiliare rispetto ad altre famiglie di nome assai più antico. I Gagliardo di Carpinello inoltre avevano da tempo questioni legali con i Leto per la rivendica del feudo stesso di Cammisini, presso Collesano, di cui la famiglia Leto si fregiava.
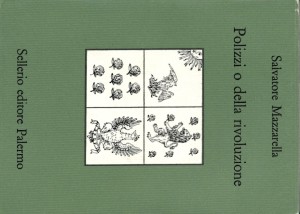 Nel luglio 1820 erano dilagati a Palermo i moti che scuotevano buona parte dell’Europa e, nei disordini che coinvolgevano la politica della Sicilia nei confronti del governo di Napoli, si insinuarono questioni locali fomentate da faccende generali e private. La tranquillità di Polizzi venne in quei giorni turbata da alcuni “villani” che cercarono di distruggere e bruciare i registri delle odiate tasse: secondo l’atto di accusa, Girolamo Fatta Barile approfittò di questa occasione per compiere le sue vendette, insieme ad altri che nutrivano gli stessi interessi, tra cui l’amico Giorlando Gagliardo di Carpinello, chiamato comunemente “baronello Cottonaro”.
Nel luglio 1820 erano dilagati a Palermo i moti che scuotevano buona parte dell’Europa e, nei disordini che coinvolgevano la politica della Sicilia nei confronti del governo di Napoli, si insinuarono questioni locali fomentate da faccende generali e private. La tranquillità di Polizzi venne in quei giorni turbata da alcuni “villani” che cercarono di distruggere e bruciare i registri delle odiate tasse: secondo l’atto di accusa, Girolamo Fatta Barile approfittò di questa occasione per compiere le sue vendette, insieme ad altri che nutrivano gli stessi interessi, tra cui l’amico Giorlando Gagliardo di Carpinello, chiamato comunemente “baronello Cottonaro”.
Le sue malevole intenzioni erano già note da giorni, quando al cugino Salvatore Fatta Salonia aveva confidato di voler finalmente fare i conti con quelli (i Leto) che avevano “devorato” un intero comune e che lu primu che avi a dari li cunti avi ad esseri me’ soggiru. La notizia correva veloce per il paese, e non ebbero successo né i tentativi di dissuaderlo del fratello Giovanni, più giovane ma anche assai più saggio, né i rimproveri dello zio Francesco Paolo Fatta Torre che, come sopra accennato, rivestiva un’importante carica pubblica.
Insieme a Giorlando Gagliardo e una moltitudine di polizzani sobillati nei confronti dei Leto e dei loro amici, Girolamo riorganizzò i ruoli comunali: azzerate le cariche di tutti i Leto, il baronello Cottonaro divenne capo provvisorio di pubblica sicurezza, Giovanni Fatta Barile sostituì Andrea Leto come cassiere comunale e lo stesso Girolamo Fatta Barile aggiunse alla precedente carica di decurione quella di componente della nuova giunta municipale, presieduta questa dal barone Gagliardo di Carpinello, padre del baronello Cottonaro.
La piazza era ormai incontrollabile nella sua rabbia contro la famiglia Leto, certamente per motivi più profondi e non solo perché sobillata da Girolamo Fatta e i suoi amici. Guidati da un gruppetto ristretto di persone più violente delle altre, più di duecento uomini di ogni ceto sociale avevano deciso di farsi immediatamente giustizia da sé. Gli scempi si consumarono in poche ore tra il 27 ed il 28 agosto 1820. Il lungo e circostanziato atto d’accusa, le cronache coeve di Giuseppe Errante e Domenico Scinà, i tanti saggi commentati, e in particolare quelli di Gaetano Falzone e Salvatore Mazzarella, raccontano i fatti accaduti e particolari raccapriccianti delle barbare uccisioni di Gandolfo Leto barone di Cammisini, dei suoi tre figli: il “baronello” Andrea, Michele e Giuseppe, ed infine del notaio Gandolfo Dominici. Si era fatto credere alla popolazione che i rivoluzionari di Palermo avessero espressamente richiesto “cinque teste” per ottenere un ricco compenso, e queste vennero atrocemente staccate dai corpi dei cinque assassinati ed esposte sanguinanti per le strade della cittadina, col proposito di spedirle a Palermo.
La responsabilità diretta di Girolamo Fatta Barile, del Cottonaro e di pochi altri maggiorenti nelle azioni crudeli e violente contro i Leto, invocata nell’atto di accusa, ai più recenti commentatori appare, al contrario, come «una assurda pretesa che tutto sia da spiegare con rancori personali malignamente usati per manovrare il popolo». Ciò, in quanto era noto il fierissimo odio che il popolo tutto nutriva nei confronti degli esattori, pur non potendo negarsi a Fatta e Gagliardo l’evidente ruolo di sobillatori, travolti poi anch’essi dall’evoluzione tragica degli eventi.
Passata la tempesta, si quietarono rapidamente gli animi, anche per l’intervento risolutore del conte Antonino Rampolla, futuro suocero di Giovanni Fatta Barile che ne sposerà la figlia Andreana (chiamata talvolta più comunemente Adriana), che dapprima riuscì a porre sotto la propria tutela i parenti residui dei Leto, e quindi fu inviato in delegazione a Palermo dove dal principe di Villafranca, capo del governo rivoluzionario, ottenne la chiusura di ogni ulteriore conflitto e delle violenze nel paese di Polizzi.
Malgrado le evidenti responsabilità per le uccisioni dei parenti della moglie, non abbiamo notizie di particolari dissidi o di incrinature nel rapporto tra Girolamo e la giovanissima Angela. Questa era in avanzata gravidanza durante i fatti di sangue, e il 18 novembre successivo nacque il secondogenito che (stranamente) decisero di chiamare Andrea, il nome del nonno odiato da Girolamo, che per di più aveva avuto un ruolo di protagonista nella sua fine. Questo nome era del tutto estraneo dalla tradizione della famiglia Fatta, ma spettava per regola al secondogenito secondo un’idea di normalizzazione dei rapporti sociali, dopo un breve momento in cui la follia aveva avuto il sopravvento. Il piccolo, destinato forse alla continuità del titolo, non avrebbe avuto fortuna, e cessò la sua breve vita dopo neppure quattro anni. I buoni rapporti matrimoniali tra i coniugi Fatta Barile proseguirono intatti, e il 1° gennaio 1822 si fece nuovamente festa per la nascita di Caterina Fatta Leto.
La restaurazione borbonica giunse rapidissima anche a Polizzi, già alla metà del mese di settembre 1820, mentre a Palermo il generale Florestano Pepe massacrava oltre 5000 rivoltosi. I superstiti Leto ottennero l’incarceramento di alcune decine di soggetti direttamente implicati in atti di violenza, ma non riuscirono a far arrestare immediatamente Girolamo Fatta Barile, malgrado avessero cercato importanti appoggi.
L’amnistia generale declamata a gran voce non salvò alcuni dei più crudeli autori materiali degli eccidi: il processo penale portò nel 1823 alla condanna dei soli esecutori, con cinque pene di morte, eseguite nella piazza di Polizzi il 22 ottobre dello stesso anno, oltre ad alcuni ergastoli ed altre lunghe pene detentive. Un dispaccio di polizia comunicava l’avvenuta esecuzione «nel massimo buon ordine al Piano degli zingari fuori abitato, vestiti di giallo e piedi nudi con cartello in petto a lettere cubitali con scritto: Per aver portato la Stragge contro una Classe di Persone va’ alla morte». Si era adoperata la Guillottina ed esposta alla vista del pubblico ogni testa recisa.
Il grosso dei facinorosi non venne condannato, ma non si può non notare come Girolamo Fatta e il baronello Carpinello di Cottonaro siano riusciti ad evitare l’immediata condanna, malgrado il durissimo contenuto dell’atto di accusa e le testimonianze nel dibattimento. Uno di questi testimoni lamentava che «la prepotenza degli stessi però è tanto intricante che nella istituzione di questo processo ne ha cercato soffocare le prove, e quelle che a stento si han potuto raccogliere, piene di timore e prevenzione, sono state il risultato delle pratiche adoperate dal delegato giudice barone Martinez». A proposito dell’impunità delle famiglie maggiorenti, commentatori postumi richiamavano «l’inevitabile riannodarsi delle antiche e profonde solidarietà, solo momentaneamente interrotte dalla rivoluzione autonomista».
Fu comunque spiccato un successivo mandato di cattura nell’agosto 1822 a carico di Girolamo Fatta Barile, del “baronello” Cottonaro, del “contino” Gaetano Rampolla e di altri che erano fortemente sospettati di avere avuto un ruolo negli eccidi, tra cui Salvatore Fatta Salonia, cugino di Girolamo. La notizia era già conosciuta da più giorni, ed ognuno di questi in fretta e in modo autonomo fuggì da Polizzi per evitare l’arresto.
Ai primi di novembre dello stesso 1822 l’occhiuta polizia borbonica, da sempre ben inserita nei meandri malavitosi dell’isola di Malta che solo da pochi anni era a pieno titolo nell’orbita dell’impero britannico, segnalava il fermo alla Valletta di un sedicente commerciante di Positano di nome Asmondo Romanoco, proveniente con una “speronara” maltese da Calabernardo nei pressi di Noto, il cui passaporto era evidentemente contraffatto. Indagini successive chiarirono che il nome era stato alterato più volte, e in realtà si trattava di “Girolamo Fatta figlio del Barone Fatta di Polizzi”. La ricostruzione del rocambolesco arrivo a Malta fa luce sui vani tentativi di fare perdere le tracce nei vari spostamenti. Girolamo, col nuovo nome di Salvatore Bonomo da Polizzi, dopo brevi tappe a Palermo e Napoli, era giunto fino a Livorno, e da lì su un brigantino svedese era tornato a Trapani. Sbrigate alcune faccende private, aveva poi proseguito la fuga precipitosa con soste e segnalazioni a Spaccaforno (Ispica), Noto e Siracusa, simulando commerci di carne e frumenti. Nella città aretusea, dopo aver comprato per ottanta onze il passaporto del Romanoco, aveva ricevuto “lettere commendatizie” e il denaro necessario per la latitanza, attraverso una cambiale che gli era stata pagata dal negoziante inglese Scott. Il governo luogotenenziale di Malta gli aveva notificato un decreto di espulsione con l’ordine di lasciare l’isola entro un mese.
A Malta negli stessi mesi si erano rifugiati anche gli amici Giorlando Gagliardo di Cottonaro e Gaetano Rampolla, ma sappiamo che tanti altri speravano di ottenere asilo nell’isola: un anno dopo a Malta venne arrestato un presunto marinaio spagnolo, che poi si rivelò essere il già citato Salvatore Fatta Salonia, proveniente da Gibilterra dopo lunghe peripezie, che viaggiava sotto il falso nome di Salvatore Rennis. Si rivelò inutile il suo tentativo di eludere il carcere cercando di imbarcarsi sulla nave Ulisse per raggiungere Zante: fu infine espulso verso il regno delle Due Sicilie nelle galere della nave inglese Principessa Elisabetta, accompagnato alla triste partenza dal cugino Girolamo e da altri fuoriusciti.
Dei tre compagni di sventura, Gaetano Rampolla era l’unico che effettivamente aveva poco o nulla da farsi perdonare, e comunque nessuna responsabilità negli eccidi. Alle ripetute richieste di autorizzazione al ritorno a casa, inoltrate dal padre Mariano Rampolla, nel giugno 1823 la stessa polizia riconosceva l’assenza di validi capi d’accusa nei suoi confronti, ma si ipotizzava l’appartenenza alla Carboneria dei tre giovani, e che Gaetano ne fosse addirittura uno dei capi locali. Lungaggini burocratiche rallentarono la decisione, e addirittura si resero necessari un’apposita delibera del Consiglio di Stato e un decreto del sovrano. Così soltanto nei primi mesi dell’anno successivo gli fu restituito il passaporto e Gaetano poté tornare nella sua Polizzi.
Al contrario, Girolamo Fatta e Giorlando Carpinello inviavano continue istanze per evitare l’estradizione in Sicilia, dove sarebbe stato alto il rischio di una dura detenzione, mentre a Malta erano liberi di agire come meglio credevano. Le indagini della polizia borbonica avevano verificato che Giorlando, malfermo in salute, attendeva a Malta l’esito del processo, pronto a far arrivare nell’isola la propria famiglia nel caso di esito sfavorevole della sentenza, e di lì rifarsi una vita in Francia. Lo stesso proposito aveva espresso Girolamo Fatta che, con l’aiuto impagabile del fratello Giovanni, chiedeva al Sovrano la grazia di potere restare a Malta nelle more del processo e che non fosse obbligato a lasciare l’isola, poiché non si era macchiato di un delitto politico. Pur di non tornare subito in Sicilia, era disposto a trasferirsi provvisoriamente in uno “Stato estero” qualora glielo si fosse richiesto. Gli abituali dispacci di polizia accettavano questa versione: Girolamo non si era macchiato personalmente di fatti di sangue e poteva ritenersi questo un reato di opinione, compatibile con la grazia richiesta.
Dopo altri quattro lunghi anni di lontananza, nel 1828 Girolamo chiedeva al sovrano di poter tornare in Sicilia, ma soltanto l’anno successivo l’amnistia generale del 1825 venne estesa anche a fatti delittuosi come quelli avvenuti a Polizzi nel 1820. Malgrado l’ordine di fare in fretta, il console di Malta non poté emettere il passaporto a Girolamo perché la sua condotta gli aveva causato ulteriori problemi: era nota «la sua vita la più licenziosa e dissoluta» che l’aveva condotto «nelle pubbliche prigioni» per essere accusato di avere capeggiato una vera e propria banda dedita alla fabbricazione e allo spaccio di moneta falsa. Addirittura, nell’aprile 1830 Girolamo era stato condannato dalla Suprema Corte Criminale di Malta alla «galera in vita con catena ai piedi e con dover servire alle opere pubbliche», sentenza che doveva essere messa in esecuzione nel mattino seguente. Le pressioni esercitate da amici dei familiari sul Luogotenente Generale di Malta, «profittando anche della prossima festività di San Giorgio», riuscirono però nell’effetto di far sospendere immediatamente la condanna, commutandola nell’allontanamento perpetuo dai cosiddetti “Domini Britannici”. Non si trattava della grazia, in quanto Girolamo avrebbe dovuto restare recluso in un carcere a Palermo in attesa della conclusione del processo a suo carico. Giunto in nave a Siracusa nel giugno 1830, grazie anche ai buoni uffici del fratello Giovanni, otteneva tuttavia il permesso di scontare la detenzione nel forte di Castellammare, assai più confortevole rispetto alla bolgia della Vicaria.
Ma non dovette subire neppure un giorno di carcere, perché il reato venne riconosciuto coperto dall’amnistia generale, a condizione che non si muovesse da Palermo e venisse controllato dalla polizia ogni 15 giorni. Gli stessi benefici di amnistia furono concessi in quei giorni anche al baronello Cottonaro e al cugino Salvatore Fatta Salonia, che così poterono fare ritorno in città.
Tornare in Sicilia significava per Girolamo anche cambiare del tutto i modi di vita, doversi adeguare a quelle convenzioni ineliminabili che nei i nove anni di esilio e di disordine morale e materiale aveva potuto eludere. Una lettera intercettata dalla polizia, fatta recapitare tramite un avvocato e l’anziana cameriera di Girolamo Elena Attard ad «una sua concubina in Malta nominata Angiola Cauchi di anni 21 nativa di colà battezzata in Burmola, figlia di Vincenzo Zammit, e di Maria Mastrojeni», ci racconta di una relazione affettiva che aveva costruito in quegli anni e della nascita del figlio Annibale a cui sarebbe stato legatissimo per il resto degli anni a venire.
Girolamo desiderava che Annibale arrivasse al più presto in Sicilia e chiedeva fiducia nella continuazione del loro rapporto affettivo, cercando di tranquillizzarla anche riguardo al suo futuro economico. «Per mezzo dell’avvocato Balzan e D. Elena [Attard] ti ho fatto sapere il mio felice arrivo in questa ed il desiderio che avrei di ricevere tue nuove. Voglio sperare che in breve sortirai e verrai in questa con il caro Annibale, io ho combinato con Carpinello di unirti con Maddalena e Maria, e venire se però ancora non hai ricevuto la grazia allora abbi un puoco di pazienza fintanto che io procurerò il mezzo di liberarti ed allora dipartirai o per Trapani o per Marsala per questo direttamente ch’è meglio, avvisami pari se il Sig. Gen…. ti passa i sei soldi al giorno, donami notizie di Pilé [suo compagno di avventure a Malta] s’è partito ti raccomando di restar saggia se vuoi la mia stima, e ti assicuro che non ti abbandonerò mai. Ti abbraccio col caro Annibale e credemi. Il tuo Girolamo Fatta».
Per Girolamo l’obiettivo primario era di tornare a Polizzi, presso i suoi congiunti e dove aveva «i suoi affari e rendite», ma soltanto nel 1831, insieme al baronello Cottonaro, poté fare ritorno “in patria”, dopo che la loro richiesta fu attentamente vagliata in relazione all’effetto, eventualmente provocatorio, che il rientro nel loro paese avrebbe potuto determinare. Certamente, durante il lungo periodo di lontananza dalla Sicilia, a Girolamo fu molto vicino il fratello minore Giovanni, nell’amministrazione dei beni privati e familiari, ma anche e soprattutto nella capacità di tessere rapporti con le autorità di Pubblica Sicurezza: in un dispaccio del duca di Lumia, Direttore Generale di Polizia, inviato per conoscenza anche a D. Giovanni Fatta Barile, si segnalava la buona condotta di Girolamo nel suo “soggiorno” a Malta e nei mesi di permanenza a Palermo, nella prospettiva di una prossima autorizzazione al ritorno nella sua cittadina.
Iniziò allora un nuovo corso della vita di Girolamo, scandito da lunghi viaggi di piacere e privo di legami stabili. Già nei primi mesi di permanenza a Polizzi si concesse una traversata navale per Napoli, dove poté incontrare dopo lungo tempo le sorelle Maria Stella e Maria Teresa. Appena tornato riebbe il passaporto per un lungo giro che lo avrebbe portato a Costantinopoli, attraverso Zante e Navarino in Peloponneso, dove la polizia ipotizzava che avrebbe dovuto incontrare un cugino “per lavoro”.
Girolamo fece ritorno a Polizzi in compagnia della maltese Elena Attard, che rimase nella condizione di sua “servitrice” fino al 1847, quando morì ottuagenaria con grande dolore di Girolamo, occupandosi anche del piccolo Annibale, visto che non ho trovato alcuna notizia riguardo alla presenza in Sicilia della giovane mamma Angiola Cauchi. Il figlio “spurio”, nato nel 1827, per buona parte della vita dovette sottostare alla difficile condizione di figlio illegittimo, non riconosciuto ufficialmente dal padre, malgrado questi lo facesse partecipare a tutte le attività familiari ed amicali. Della moglie Angela Leto non ho quasi più notizie, neppure nei diari o nella corrispondenza che ho potuto scorrere: dai registri anagrafici sembra che si fosse trasferita a Palermo, dove visse fino al suo decesso avvenuto nel 1864. Ritengo che il lungo esilio/latitanza e il figlioletto illegittimo siano stati causa di una separazione di fatto, di una interruzione totale di ogni rapporto, così che non si trova neppure una parola sulla moglie Angela Leto nel testamento del 1848. Soltanto in qualche passo della corrispondenza privata sembra che Girolamo avesse assunto degli obblighi dei confronti di questa, ma tendesse a non rispettarli tenendole nascoste alcune delle proprie attività e gli eventuali «complimenti ricevuti per tema di qualche firiticchio». D’altra parte, dal nipote Orazio Fatta Rampolla sappiamo della disordinata vita affettiva di Girolamo nel corso di oltre un decennio: il giovane timido e riservato notava, non senza un evidente imbarazzo, che lo zio in un’occasione «est trainé par une femme qui domine sa volonté», in altre era «invischiato in un laido amoraccio». Al contrario, rispetto alla cautela mostrata verso i Leto superstiti (la moglie Angela e lo zio prete), si mantennero abbastanza stretti i rapporti tra Girolamo e il primogenito Orazio, anche se alquanto sporadici per le lunghe permanenze di entrambi fuori dal regno di Napoli.
Ritengo che nei sei-sette anni successivi al ritorno a casa, Girolamo abbia viaggiato molto per l’intera Europa: solo così può spiegarsi la conoscenza approfondita di luoghi lontani che più volte dimostrerà. Dal diario inedito del nipote Orazio Fatta Rampolla (il nonno di mio padre omonimo) e da un interessante carteggio familiare si conoscono fatterelli e piccoli aneddoti, che diventano significativi per conoscere meglio Girolamo e la sua vera indole. Dal 1840-41 risiedeva stabilmente a Polizzi, con lunghe permanenze a Termini presso la casa del fratello Giovanni che da tempo vi si era trasferito, e a Palermo, specie nei periodi di festa. Fin da quegli anni a casa di Girolamo Fatta Barile si organizzavano allegre attività socializzanti che duravano diverse settimane, talvolta mesi con cadenza quotidiana.
Grazie alle proprie conoscenze artistiche, ma anche dei più rinomati locali pubblici, ristoranti, alberghi e delle migliori abitudini locali, nel 1842-44 si impegnava a costruire le tappe dei lunghi viaggi dei familiari in giro per l’Italia, da Napoli e le sue antichità, a Roma con i principali monumenti, a Firenze e Livorno. Appassionato di teatro, come tutti in famiglia, quando si recava a Termini, ma soprattutto a Palermo, non mancava alle serate nei teatri di ogni ordine e grado, dal Carolino, al San Ferdinando e al Santa Cecilia. Nelle lunghe settimane festive del Carnevale, Girolamo, più che cinquantenne, teneva testa a figli e nipoti con maschere e camuffamenti: «colorava colla calce la barba interamente cresciuta carbone, si travestiva da novizio Scolapio», con vestiti e parrucca femminili, o mascherato da bautta con mantello nero di velluto, un cappuccio aperto solo sul volto coperto da mascherina e cappello a tricorno. Il nipote ne ammirava «la forte costituzione fisica che a 48 anni agissait mieux qu’un giovane», sia nelle spedizioni di caccia nelle campagne di Sant’Onofrio che duravano alcuni giorni, sia nella pesca con le reti.
Ma ciò in cui Girolamo eccelleva era la capacità di animazione di gruppi di amici, anche con frequenti pesanti burle che non di rado rischiavano di degenerare. Dal diario del nipote: «egli muove e tiene animata la compagnia, quando parte se ne sente il vuoto». Mattina e sera si giocava a carte da lui, anche con poste molto elevate, ma sempre con buonumore e spensieratezza. Tornei di zecchinetta e bassetta costituivano il naturale epilogo anche di gite, escursioni e giornate di caccia, organizzate con attenzione per i dettagli anche durante la mobilitazione generale del 1848. Girolamo mostrava più volte soddisfazione per l’apprezzamento di cui godeva, soprattutto per l’allegria che riusciva a trasmettere: richiesto di intervenire e riorganizzare il gruppo a Termini, prometteva di tornare presto e di «riprendere gli incontri divertenti con Cassata, Riso, il Bianco e anche il Timbale»: non rinunciava alla passione per il buon cibo, talvolta da lui stesso preparato e cucinato, ma soprattutto per i dolci tipici delle Madonie.
Nel corso dei moti del ’48 seguiva con interesse le parate militari della Guardia Nazionale, vicino a soggetti influenti quali il barone Riso e il Presidente della Nazione Ruggero Settimo, pronto ad approfittare delle sue buone conoscenze nel Consiglio Civico e nel governo rivoluzionario per ottenere qualche lucrosa carica, come la Ricevitoria Distrettuale di Termini (che poi non ottenne).
Girolamo non smentì mai il proprio carattere molto energico: non esitava a rimproverare aspramente i figli anche per scelte molto personali, quali i fidanzamenti con donne a lui non gradite, o per comportamenti a suo avviso non corretti. Appare effettivamente paradossale che, malgrado il passato non certo cristallino e il presente ugualmente discutibile, se non riprovevole, il padre accusasse più volte lo schivo Annibale di «condurre una vita dissipata e non educata». Lo stesso nipote poco più che ventenne Orazio Fatta Rampolla, di cui aveva continuo bisogno e a cui ricorreva (più che il padre di questi, Giovanni) per sbrigare tanti affari e seccature, per amministrare le sue proprietà nei lunghi periodi di assenza, veniva rimproverato aspramente perché non sufficientemente sobrio nel vestire, come lo zio pretendeva. Le richieste del giovane Orazio di calze di alta qualità, di «tait ed equipaggio» dimostravano di non tenere conto delle sue esigui finanze, allargando la querelle all’altro nipote Corrado, assai più giovane e inesperto, e al proprio sfortunato matrimonio ormai da tempo finito: «… che diavolo sogni sarò quello che sono stato e con qualche deterioramento. Tu sarai la rovina del povero Corrado ma questi è abbastanza filosofo per non succhiare le tue massime di Coscia Tesa, e tanto mi ha promesso se la fortuna mi sarà favorevole forse mi farò un “scias” per … del felice e prospero matrimonio a cui il destino mi condannò per farmi esquilibrare ma pazienza».
Che l’indole di Girolamo avesse degli aspetti provocatori oltre il limite, è dimostrato dalla questione che creò e portò lungamente avanti riguardo alla successione araldica della famiglia della moglie. In mancanza di eredi maschi, vittime dell’eccidio del 1820 tranne il sacerdote Francesco che era stato risparmiato, il titolo di barone di Cammisini di cui si fregiavano i Leto doveva essere trasmesso maritali nomine in altra famiglia. Di questo credeva di potersi valere Girolamo, che appunto chiamò il secondo figlio col nome del nonno, sperando ed immaginando di potere così ereditarne il tiolo.
Sarebbe stato certamente paradossale se Girolamo Fatta Barile, pesantemente coinvolto nella responsabilità per la morte dei maschi di casa Leto, avesse assunto la baronia di Cammisini, che invece, a seguito di una lunga causa, andò attraverso la sorella Rosalia al marito di questa Giuseppe Porcari. L’indomabile Girolamo non si arrese, e più volte in documenti privati si firmò come barone di Cammisini, pur sapendo che si trattava di usurpazione di titolo. Che faccia tosta!
Girolamo Fatta Barile si firma provocatoriamente col titolo del suocero
Nel novembre 1854, senza che si fossero manifestati particolari disturbi, Girolamo fu improvvisamente preda di forti dolori addominali, con convulsioni che portarono ad una morte rapida a 57 anni, lasciando i familiari e i tanti amici attoniti ed inconsolabili. Nel testamento redatto sei anni prima, nominava erede universale il figlio Orazio. Un’attenzione particolare veniva osservata per Annibale, di cui il padre conosceva la fragilità e le difficoltà quotidiane, al quale si assegnava «un legato di denaro 50 onze annuali, il fondo Panitteri, il quarto a Polizzi, col mobilio completo, e anche quello proveniente dalla casa di Termini. Annibale, portato da Malta dalla mia serva Elena Attard, dovrà chiamarsi col mio nome Fatta». Il testamento rivelava inoltre che dalla defunta Elena Attard gli erano state consegnate in Prek (forse a Malta tanti anni prima dalla famiglia della madre naturale) 150 onze da dare ad una persona il cui nome fino allora era rimasto segreto, e che si svelò essere il figlio Annibale. In nessuna parte del testamento veniva citata la sfortunata moglie Angela Leto.
Dei tre figli superstiti di Girolamo, la minore Caterina visse la maggior parte della sua vita come moniale benedettina in un convento a Polizzi, dove morì nel 1871. Assai diversi tra loro i destini dei figli maschi. Di Orazio si notano fortissime affinità di carattere rispetto al padre: se a quest’ultimo era mancata la guida paterna, Orazio non lo conobbe neppure, se non verso i 12-13 anni, affidato alla sola madre giovanissima e inesperta, orfana e bisognosa di aiuto piuttosto che in grado di offrirne.
Le frequentazioni giovanili non sembra fossero sempre limpide e guidate da saggezza, conducendo il più giovane omonimo cugino nelle prime esperienze di vita. Dal diario inedito dell’anno 1842: Je fus mené ou mieux dire trascinato pour la première fois dans un B. par mon cousin Horace. Tra i due cugini trasparirà sempre evidente un rapporto molto stretto, sia per l’aiuto che lo zio Giovanni, fratello di Girolamo, aveva sempre dato alla cognata e ai suoi figli, sia per la vera e propria ammirazione che il timido Orazio Fatta Rampolla, il cui orizzonte era limitato a Polizzi, Termini e Palermo, nutriva nei confronti di Orazio Fatta Leto, più grande, esperto e conoscitore del mondo per i continui viaggi in varie parti dell’Europa: Genova, Firenze, Roma, Milano, Torino, ma anche Uri in Svizzera, Fiume in Croazia, Bucarest e Parigi. Beato lui! Combien je voudrais imitarlo! I beni e gli interessi economici di quest’ultimo erano totalmente affidati al cugino, che con pedante attenzione annotava tutto e ne riferiva di continuo.
Era chiamato familiarmente “Orazio maggiore” perché il più grande di età fra i tre cugini omonimi, o “Orazio il grosso” per la stazza, e alternava brevi periodi di soggiorno familiare a Polizzi e Palermo con lunghe permanenze all’estero, che si protraevano anche per più di un anno. Non ho chiarissimo di quali affari si occupasse, ma ritengo che Orazio fosse ben inserito nell’imprenditoria teatrale, ambito che mostrava di amare molto, visto che in ogni momento libero frequentava le opere liriche e ogni altra forma di rappresentazione nei teatri di Palermo e Termini.
A questo ambiente artistico Orazio dedicava anche i suoi interessi sentimentali: doveva godere di un certo fascino se riusciva in più occasioni a tessere relazioni più o meno lunghe e stabili con alcune delle cantanti d’opera più in vista dell’epoca. Si dichiarava “prossimo sposo” della genovese Luigia Abbadia, poi en amitié per più di un anno con la Marziali che andava seguendo in giro per l’Europa nelle sue applauditissime esibizioni, e ancora anni dopo il cugino lo indicava come ufficiale “amante di Marietta Anselmi”, notissima soprano e primadonna al Carolino.
Puntuali arrivavano i rimproveri del padre Girolamo, che pretendeva di mettere il naso nelle scelte sentimentali del figlio: con una lettera personale invitava la Abbadia a desistere da ogni velleità matrimoniale, e arrivò quasi a minacciare lo stesso Orazio (disquietavasi col figlio) che dichiarava di essere in procinto di sposarsi con Adele Binotti, figlia di un facoltoso commerciante fiorentino.
Morto il padre (1854) e più libero nelle proprie scelte, Orazio intensificò la frequentazione con la madre e lo zio Abate, imbarcandosi in rapporti di maggiore impegno. Nel 1858 presentò al cugino un figlioletto, probabile frutto di una delle relazioni sopra richiamate, ma di cui non sono in grado di fornire altre informazioni. Tre anni dopo (ottobre 1861) Orazio Fatta Leto si sposa a Palermo con Carolina Perez, anch’essa una cantante dilettante, malgrado l’affezionato cugino l’avesse vivamente sconsigliato («io gli ho detto vituperi! Egli se ne mostra mortificato»). Dal diario inedito viene fuori fin dall’inizio un rapporto matrimoniale non facile: grandi regali del marito, vita brillante e dispendiosa, viaggi per l’Italia. Il cugino commentava quanto fosse esigente la moglie e notava molti problemi: «pazzo in dispendi per abiti e galanterie, oggi più che un marito sembra un innamorato». Difatti il matrimonio, in crisi già dopo un anno circa, naufragò presto risvegliando in Orazio il desiderio di riprendere la vita erratica: «Orazio parla sempre della sua sventura pel matrimonio, agogna partire in Grecia in aprile 1864».
Si era rivelata disastrosa la gestione in società del teatro Bellini, e piuttosto che imbarcarsi in nuove imprese, Orazio organizzò per lungo tempo una vera e propria bisca a casa propria, dove si giocava con poste molto alte. Questa fase mette in luce la somiglianza del figlio al padre, per capacità aggregativa e naturale simpatia: organizzatore di gite e spedizioni di caccia, di allegri travestimenti e di scherzi anche piuttosto crudeli. Orazio maggiore porta sempre delle novità.
Con un atto notarile datato giugno 1869 Orazio Fatta Leto, abitante in via del Volturno a Palermo, cedeva al cugino Orazio Fatta Rampolla il titolo di barone della Fratta che gli competeva di diritto in quanto figlio ed erede del padre primogenito Girolamo, optando per quel titolo baronale proveniente dalla linea materna che, a suo dire, gli spettava. «… dapoiché il medesimo comparente [cioè lui stesso] possiede il titolo di Barone di Cammisini, pervenutogli per eredità materna, del quale titolo trovasi in atto investito». Continuava così l’atteggiamento provocatorio che il padre aveva condotto per tutta la vita nei confronti della famiglia Leto. Orazio Fatta Leto muore a Palermo nel 1874 a 55 anni.
Orazio Fatta Leto consapevolmente si firma col titolo usurpato.
Assai diverso dal padre e dal fratello maggiore era invece Annibale, chiamato talvolta Zammit forse per il cognome del nonno maltese. Dall’epoca dell’arrivo da Malta, rimase accanto al padre Girolamo che gli fece frequentare l’Educandato delle Scuole Pie a Palermo e lo conduceva con sé in ogni circostanza.
Per tutta l’età giovanile fu costretto a subire, lui timidissimo, la dirompente ed eccessiva personalità del padre, pronto a sindacare ogni sua scelta autonoma, a rimproverarlo per una vita, a suo dire, sconveniente. Partecipò con grande passione alla rivoluzione del 1848, pronto a prendere parte ad una spedizione per aiutare i “fratelli di Lombardia”, assai contento di non ricevere la solita “scomunica” dal padre per il suo ardore condensato nel motto o morire o rigenerare! richiamato in una lettera in cui si firmava “Il cittadino Annibale”, indirizzata al solito cugino Orazio che ne curava gli interessi e gli inviava a Palermo scarpe, vestiti, un fucile e tanto altro.
I rapporti difficili col padre si chiusero soltanto alla morte di questo, nel 1854, e nel dicembre dell’anno successivo Annibale convolò a nozze a Polizzi con la ventiquattrenne Teresa Trapani, figlia del “dottore in legge” Nicolò e di Angela Dominici, proveniente da una famiglia piuttosto in vista che aveva ed avrebbe dato alla cittadina alcuni sindaci.
Come per il padre ed il fratello, il matrimonio non fu certo felice, privo di figli e pieno di problemi caratteriali ed economici, e si concluse duramente pochi anni dopo. Si racconta che Annibale sia stato così costretto a restituire alla famiglia della moglie la dote di 3000 lire, con un grave appesantimento delle già esigue finanze. Tentò, sembra senza successo, anche di rintracciare la madre naturale maltese attraverso l’avvocato Di Marco, per ottenere “gli alimenti” che, a suo dire, gli sarebbero spettati.
Il carattere mite e le effettive condizioni di difficoltà gli facevano ottenere piccoli ma costanti aiuti da parte dei parenti: la zia Maria Stella, sorella di Girolamo e moglie benestante di Andrea Spinelli barone della Scala, nel testamento del 1877 gli assegnò il legato di lire 1275 annue, che contribuì un poco ad alleviare i problemi del nipote Annibale.
Visse tra Polizzi e la masseria di Torretonda e assunse qualche marginale ruolo di rappresentanza nel suo paese: sappiamo che nel 1881 la delegazione CAI per la visita sulle Madonie fu accolta da Annibale Fatta e dal sindaco cav. Antonio Trapani, forse parente della moglie.
La corrispondenza con i parenti più stretti degli ultimi anni conferma l’aggravarsi della depressione dovuta alla solitudine ed alle difficoltà economiche. Al cugino Corrado confidava da Torretonda: «la mia posizione finanziaria mi ha reso sfiduciato … perdo la fidata persona di servizio … malato e con una vita di intollerabile di prolungata agonia». Pochi mesi dopo, il 21 novembre 1889 a 62 anni Annibale, già vedovo, moriva a Polizzi in Chiasso Fatta.
Così, dopo molti lutti e qualche sorriso, si chiudeva anche la discendenza (conosciuta) di Girolamo Fatta Barile.
Dialoghi Mediterranei, n. 51, settembre 2021
Riferimenti bibliografici
Archivio di Stato di Palermo. Fondo Ministero Real Segreteria di Stato presso il Luogotenente Generale di Polizia. Sezione degli Affari di Sicilia.
Gran Corte Criminale della Valle di Palermo, Atto d’accusa anno 1823. Copia manoscritta integrale conservata presso Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli, archivio Gaetano Falzone, in Palermo.
Archivio privato Giovanni Fatta.
Falzone G., Il tumulto di Polizzi Generosa del 1820, in “Comitato Provinciale di Trapani dell’Istituto per la storia del Risorgimento Italiano. Atti del 1959 a cura di Gianni di Stefano”, Giovanni Corrao Editore, Trapani 1960: 56-64.
Mazzarella S., Polizzi o della rivoluzione, Sellerio editore, Palermo 1988.
Sansone A., La rivoluzione del 1820 in Sicilia, Tipografia Fratelli Vena, Palermo 1888.
_____________________________________________________________
Giovanni Fatta, Professore ordinario di Architettura Tecnica in quiescenza presso l’Università di Palermo, componente di Comitati Scientifici ed Editoriali di riviste qualificate, ha orientato la propria ricerca sui temi attinenti la storia della costruzione, l’analisi delle tecniche dell’architettura storica, il recupero edilizio ed ambientale, la storia locale, con particolare attenzione al contesto siciliano. Tra i numerosi saggi ed articoli: Palermo nell’“età del ferro” (1983); Ponti tardo-medievali nel territorio siciliano (2009); Cuspidi e cupole in mattoni maiolicati nell’architettura religiosa dell’area siciliana (2010); Teatri storici in Sicilia (2014); Mercati coperti a Palermo (2013); Il ponte delle Teste sul fiume Oreto (2016); Il progetto e il cantiere del teatro Massimo (2018); Piazza Marina a Palermo. Memoria di cronache cittadine (2019); La costruzione del soffitto della Cappella Palatina (2020); Il palazzo Fatta: storia di pietre e di vita (2021).
______________________________________________________________