di Mariano Fresta
Introduzione
È meritevole il progetto dell’Istituto centrale per il Patrimonio Immateriale di pubblicare ogni sei mesi un Quaderno che riproduca la documentazione fotografica delle ricerche etnografiche e demoantropologiche effettuate in Italia negli anni passati e quelle che saranno svolte in futuro. Come si legge nella presentazione del primo Quaderno, stesa da Leandro Ventura, le foto saranno corredate da testi brevi esplicativi e da considerazioni affidate «ad esperti del settore dell’antropologia visiva, a fotografi e a esponenti delle comunità interessate dalle campagne di documentazione».
Il progetto si inserisce opportunamente nel dibattito internazionale degli ultimi trent’anni che si occupa del tema dei beni cosiddetti “immateriali” o “intangibili”, diventati oggetto di patrimonializzazione secondo i criteri stabiliti dalla Convenzione Unesco del 2003, che riguardano la loro tutela, la salvaguardia e la conservazione. Non è qui il caso di riportare tali questioni, basti ricordare che tutto quanto è stato raccolto, dalle forme dell’espressività agli oggetti e ai manufatti della cultura materiale, una volta fissato sulla carta (con scritti e con foto e con disegni) o catalogato ed esposto nei musei, perde la sua vitalità, diventa materiale inerte, buono solo per essere studiato e per essere osservato più o meno distrattamente, soprattutto se si tratta di documentazione iconografica, di registrazioni sonore e di raccolta di oggetti relativi ad una festa o allo svolgimento periodico di una cerimonia rituale.
Così, dopo decenni di raccolte, di classificazione e di musealizzazione, si è arrivati a due conclusioni: la prima è che, anche quando le modalità di esecuzione e gli oggetti usati in quelle circostanze sono molto diversi, feste e celebrazioni rituali appaiono uguali ovunque; la seconda è che questa somiglianza è dovuta a qualcosa che esse hanno in comune e che travalica sia la data dell’evento, sia il nome che ad esso si dà, sia soprattutto la sensazione che ogni comunità possiede della peculiarità della propria tradizione. Questo “qualcosa” è proprio il “bene immateriale”, che non si può concretizzare materialmente e che non può essere trasferito su nessun supporto, che non può essere trasformato in un oggetto da esporre nei musei. Questo “bene intangibile” può essere identificato con quell’atmosfera, quel clima particolare che si determina durante una festa e durante qualsiasi performance in cui ogni singolo partecipante, attivo o passivo, si sente solidale con gli altri, avverte di far parte di una comunità, la quale si riconosce proprio in quell’evento che la fa distinguere dalle altre.
Questo “bene intangibile e immateriale” è anche “volatile”, “effimero”, perché la sua esistenza è delimitata dall’inizio e dalla fine dell’evento celebrato. Questa sua volatilità e questa immaterialità fanno sì che di esso non si possa avere nessun tipo di documentazione, perché dell’evento possiamo registrare magnetofonicamente voci suoni e rumori, possiamo videoregistrare e fotografare l’insieme e i dettagli, ma non possiamo documentare l’atmosfera che attorno ad esso si crea e che rende culturalmente significativi anche gli aspetti minimi dei riti che ogni piccola comunità celebra periodicamente.
Il che non significa che bisogna rinunciare alla memorizzazione dei fenomeni con l’aiuto di tutte le tecniche e di tutti gli strumenti in nostro possesso, perché la loro documentazione è necessaria se vogliamo tracciare la storia dei processi culturali di ogni comunità e se vogliamo trasmettere alle generazioni future qualche immagine di quello che è successo nel passato.
Non ci si può, tuttavia, fermare solo ai fenomeni culturali tradizionali, perché esistono altri beni che sono altrettanto immateriali, volatili e instabili, come per esempio i paesaggi, soggetti a continue trasformazioni dovute sia a fattori naturali sia al lavoro umano; e ancora: il mutevole paesaggio sonoro della campagna, quello dei paesi di montagna e quello delle città piccole e grandi. Ci sono, infine, beni persi per sempre come quelli di paesi e città distrutti da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e frane. In questo caso non sono andati perduti soltanto case, edifici monumentali, opere d’arte, strade, attività economiche, perché con quello urbano è scomparso un altro tessuto, quello che teneva insieme le comunità degli abitanti, le loro relazioni parentali e sociali, le loro feste, la loro parlata, i loro saperi tecnici, tutto quello, cioè, che sta alla base del senso dell’appartenenza ad un luogo e che è l’essenza stessa di una comunità.
Di questi tipi di “beni immateriali” i due primi Quaderni dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, intitolati «Visioni d’Archivio» ci presentano due documentazioni, una recente relativa ad una festa patronale, e l’altra, invece, nel quarantesimo anniversario del tragico evento, è dedicata al terremoto dell’Irpinia del 1980. Bene inteso, le foto non sono gli eventi reali, immediatamente o successivamente fissati sulla carta, né da esse si può ricavare l’atmosfera vissuta dagli attori di una festa, né ci possono far rivivere i sentimenti di paura di chi si trova in mezzo ad un terribile terremoto; possono, però, provocare suggestioni.
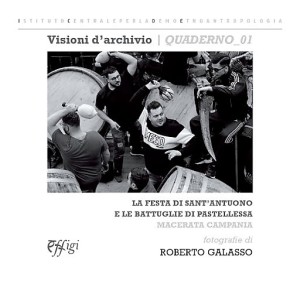 Quaderno 1 – La festa di san’Antuonu e le battuglie di pastellessa – Macerata Campania, Fotografie di Roberto Galasso, Effigi, Arcidosso (GR) 2019
Quaderno 1 – La festa di san’Antuonu e le battuglie di pastellessa – Macerata Campania, Fotografie di Roberto Galasso, Effigi, Arcidosso (GR) 2019
Sorprende positivamente il fatto che il primo quaderno di «Visioni d’archivio» sia dedicato alla documentazione di un evento studiato piuttosto recentemente invece che a qualche testimonianza raccolta in anni molto lontani da noi e rimasta per lungo tempo negli archivi dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale: il fatto ci fa sperare che ci sarà la stessa attenzione editoriale nei confronti di altri eventi demoantropologici contemporanei che non dovranno aspettare decenni prima che la loro documentazione possa essere diffusa presso un pubblico vasto.
Si tratta della festa di sant’Antonio Abate che si celebra ogni 17 gennaio a Macerata Campania, in provincia di Caserta e che solo da circa un ventennio ha acquisito una notevole rilevanza antropologica, perché sulla base di riti presenti nell’antica cultura contadina è stata innestata una performance spettacolare, che è quella di un corteo di carri, addobbati con figure di cartapesta, su cui stanno una cinquantina di persone, chiamate bottari, dirette da un capoparanza, impegnati a percuotere ritmicamente botti, tini e falci. In questa festa confluiscono, come hanno rilevato ricerche di qualche anno fa, elementi di cultura tradizionale, di cultura di massa, aspetti del carnevale urbano moderno e perfino, come fa osservare Francesco Faeta nel suo intervento, alcuni tratti delle culture giovanili postmoderne dark e punk.
Dopo una breve presentazione dovuta a Leandro Ventura, che si richiama ad alcune attività di ricerca ed editoriali di Annabella Rossi riguardanti la Campania di un cinquantennio fa, quasi a collegare le feste studiate dall’antropologa a quella di Macerata Campania che apre la collana, il Quaderno ospita un bell’intervento di Francesco Faeta. Il quale, basandosi sulla sola documentazione fotografica, intuisce ed individua le novità che sono state introdotte nella manifestazione:
«La festa, attorno al suo nucleo musicale eccessivo e trasgressivo … mette insieme, senza unirli, tratti diversi: l’albero della cuccagna e la processione; i fuochi di san’Antonio, quelli d’artificio e le consuetudini gastronomiche; i piumini posti sopra gli abiti rituali (qualcosa che avrebbe costituito sacrilegio soltanto dieci anni fa); … i confratelli che ostentano i loro modesti abiti rituali … la rozza smisuratezza artigianale delle mazze da percussione e il sostrato “neomelodico” dell’elaborazione punk … la banda di paese e la benedizione degli animali, tutti e soltanto cani da passeggio portati in braccio da bambini e anziani … ».
Per Faeta la festa appartiene al postmoderno, perché le tracce visibili del passato (il periodo della celebrazione, che è quello del solstizio invernale, i falò rituali, il rumore – ma ora organizzato musicalmente – la questua, ecc.) stanno solo alla base o sono il pretesto per mettere prepotentemente in evidenza i segni dell’oggi, quelli delle mode giovanili dei giubbini finti Monclair, dei capelli rasati e scolpiti, delle canzonette moderne eseguite da tastiere elettroniche sul ritmo primitivo battuto da bastoni su botti e falci, residui del mondo contadino che fu.
La festa è veramente un groviglio di elementi arcaici, tradizionali, moderni e postmoderni. Il tutto assemblato, comunque, con quell’antica mentalità delle classi subalterne che ha dato vita a tutti i prodotti della cultura folklorica, composti da elementi presi da sistemi culturali diversi per età ed eterogenei per origine, che Gramsci, giustamente ricordato da Faeta a conclusione del suo contributo, definì «coacervo indigesto».
Protagonisti, dunque, della festa e delle battuglie sono le generazioni giovanili (tutti maschi, con qualche eccezionale presenza femminile), mentre gli anziani guardano ed osservano senza magari rendersi conto di come un rito invernale, quasi clandestino, agito da qualche gruppetto di contadini, sia potuto diventare un evento spettacolare che richiama migliaia di spettatori. I giovani, da parte loro, vivono l’evento del tutto immemori del passato e, apparentemente, incuranti, come rileva Faeta, di un futuro che sembra piuttosto opaco e precario.
A dipanare un po’ il groviglio ci pensa Vincenzo Capuano, quasi deus ex machina della festa, che ne racconta le vicende attraverso ricerche storiche e d’archivio, con l’intento di dare così all’evento una qualche nobiltà di origine. Capuano descrive pure sinteticamente i momenti della festa rifacendosi agli studi che le sono state recentemente dedicate. Non sempre la sua visione da bottaro appassionato gli fa distinguere le interpretazioni scientifiche corrette da quelle orecchiate qua e là e proposte da folkloristi improvvisati.
Segue poi il contributo di Roberto Galasso, fotografo espressamente inviato a Macerata Campania nel 2019; la sua vasta documentazione fotografica riesce a darci un’immagine completa della festa; le foto sono suddivise in due sezioni ben delimitate: nella prima esse riprendono i dettagli, con in primo piano le grottesche figure in cartapesta, che rimandano ad esseri sotterranei e al carnevale; poi seguono i protagonisti, gli strumenti, il corteo dei carri, la processione religiosa, i falò, la questua, la riffa, l’albero della cuccagna, ecc… Nell’altra sezione, le foto sono ordinate secondo una classificazione che riguarda l’attesa, la preparazione e le prove della sfilata dei carri con le paranze dei bottari, che rappresentano il clou dell’evento rituale e festivo. Come dire, prima l’aspetto estetico, quello appariscente, e poi quello che a questo sta dietro: la progettazione, l’organizzazione, il lavoro.
Il Quaderno risulta essere molto bello nella parte della documentazione fotografica e assai interessante per il notevole contributo di Faeta; decoroso nei testi illustrativi, il volume, tuttavia, avrebbe avuto bisogno di un controllo competente da parte di un antropologo, onde evitare l’intervento piuttosto inopportuno di un giornalista (Luigi Ferraiuolo) che azzarda l’ipotesi, degna del Sant’Uffizio di una volta, che il suono delle botti serva a scacciare il diavolo; considerazione che, purtroppo, è stata incautamente ripresa da Ventura nella sua presentazione.
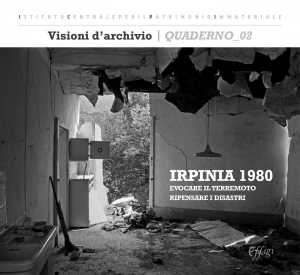 Quaderno 2 – IRPINIA 1980. Evocare il terremoto, ripensare i disastri, a cura di Irene Falconieri, Fabio Fichera, Simone Valitutto; foto di L. Basco, P. Ciambelli, P. Revelli Beaumont, Effigi, Arcidosso (GR) 2020
Quaderno 2 – IRPINIA 1980. Evocare il terremoto, ripensare i disastri, a cura di Irene Falconieri, Fabio Fichera, Simone Valitutto; foto di L. Basco, P. Ciambelli, P. Revelli Beaumont, Effigi, Arcidosso (GR) 2020
Questo libro, scrive Leandro Ventura presentando il Quaderno_2, «vuole suscitare il recupero della memoria della fase iniziale dello spaesamento, del cambiamento, attraverso immagini scattate in momenti di poco successivi alla scossa». Da parte sua, Simone Valitutto aggiunge: «Il fine ultimo di questo volume, restituendo alle comunità dei paesi del terremoto del 1980 un preziosissimo materiale fotografico inedito custodito per decenni in un archivio ministeriale, è sovvertire l’idea di uno Stato che non riesce a ricordare se non a modo suo».
Più sopra, ho tentato di dire che cos’è un “bene immateriale”. Guardando le foto della documentazione che riportano le immagini della tragedia di quaranta anni fa, mi viene difficile usare il termine “bene”, perché esso si può riferire solo a cose positive, per esempio alle foto che ricordano la storia di villaggi poveri ma lindi nella loro struttura urbanistica, con i loro abitanti operosi, con i loro momenti di gioia e di spensieratezza; ma stona nell’uso di quelle scene di morte e di distruzione. È anche difficile sforzarsi di vedere che dietro le macerie, le lapidi dei cimiteri, le donne vestite a lutto, lo smarrimento negli occhi dei bambini c’era stata, qualche giorno prima, qualche ora prima, una vita fatta di lavoro, di socialità, di speranze e progetti per il futuro. Ma se vogliamo evocare quei tragici momenti e avere qualche vaga idea di cosa c’era prima del sisma, non possiamo che guardare quelle foto che pure nella loro bellezza estetica, e forse proprio per questo, ci permettono di rivivere quei terribili e terrificanti novanta secondi, la durata della scossa.
Solo novanta secondi, un minuto e mezzo, non certo cronometrato da coloro che subivano il sisma, i quali l’avranno percepito come un’eternità. Novanta secondi, scanditi dagli orologi dei sismografi, dopo i quali niente più è come prima. Il terremoto, dicono gli antropologi dei disastri, è un fenomeno complesso che riguarda la paura e lo smarrimento delle vittime, la morte di centinaia o migliaia di persone, la distruzione di famiglie intere, delle case, degli edifici monumentali, lo sconvolgimento delle strade e delle vie di comunicazione; e poi i soccorsi, l’estrazione dei morti e degli ancora vivi dalle macerie, la mancanza di viveri e di medicinali; gli slanci della solidarietà dei volontari partiti anche da regioni lontane e, contemporaneamente, le repellenti azioni di sciacallaggio; e poi i primi sguardi rivolti al futuro ancora incerto e misterioso, la forte volontà di ricominciare, i primi progetti, le promesse degli uomini di governo e dei politici, le tendopoli, le roulotte e le casette prefabbricate; la ricostruzione, infine, che non è mai la restaurazione del “prima” e che spesso è causa di immense delusioni.
Per questa complessità non sarebbero bastate due o tre persone ad esaminare tutti gli aspetti del sisma del 1980 evocati dalla documentazione; ed ecco che a presentare le foto del volume e a commentarle sono stati chiamati antropologi, architetti, fotografi, testimoni vari che con interventi, talora brevi, hanno fatto luce sugli aspetti delle molte questioni aperte da un fatto così tragico.
Ad Anna Pasqua Recchia è toccato il compito di Narrare l’indicibile (è il titolo del suo contributo), di raccontare, cioè, cosa ha significato il terremoto nei paesi dell’Irpinia e in quelli confinanti della Basilicata. A quel tempo, fa osservare, non c’erano i mezzi di documentazione odierni (foto e videocamere digitali facilmente trasportabili in un taschino; telefoni cellulari), né allora a causa dello sbriciolamento dei paesi, delle strade, del blocco delle linee telefoniche e delle centrali elettriche (tutti problemi immediatamente irrisolvibili, anche per la mancanza di una Protezione Civile), fu possibile avere una documentazione immediata del tragico disastro; tutto o quasi tutto fu documentato, quando le condizioni lo permisero, dalla televisione di Stato e da fotografi professionisti. Tutto il materiale documentario fotografico è finito poi in letargo negli archivi, anche in quello dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, che, però, nel quarantesimo anniversario dell’evento lo pubblica mettendolo a disposizione di tutti.
L’area interessata fu immensa (qualcuno l’ha calcolata pari a quella dell’intero Belgio), comprendendo ben 687 comuni, con una distruzione del patrimonio edilizio che va dal 40 all’80%. Non tutto va ascritto al terremoto, perché molta responsabilità ricade sulla fragilità delle costruzioni, sul degrado pregresso, sull’assenza, in un territorio già povero per conto suo, di una governance efficiente: «Gli effetti devastanti del sisma furono dunque il risultato dell’incrocio tra la straordinaria pericolosità del fenomeno naturale e la peculiare vulnerabilità del patrimonio edilizio in generale e di quello monumentale in particolare».
Ben più grave fu il danno arrecato al patrimonio culturale su cui la Recchia si sofferma ampiamente: oltre ai monumenti che indicano le tappe della lunga storia di quelle regioni, furono sepolti anche luoghi di culto e gli oggetti artistici e devozionali in essi contenuti che erano considerati «potenti simboli identitari».
Come è accaduto in occasioni similari, il terremoto ha, in maniera imprevista, riportato alla luce tanti segni della storia di quelle popolazioni che il tempo aveva sepolto e fatto dimenticare: oggi, le scoperte archeologiche del dopo sisma sono visibili presso il Parco Archeologico di Conza.
Quasi sempre, dopo un cataclisma, che si è abbattuto, azzerandone la vita, su regioni distanti da noi, ci si chiede: chi erano costoro? come vivevano? come parlavano? Sono interrogativi che Francesco Faeta, nel suo contributo denso di notizie e di riflessioni, sintetizza nel titolo Il giorno prima. Ovviamente nessuno può sapere cosa avevano fatto i terremotati il giorno prima, è solo possibile ricordare ciò che avevamo fatto noi, ben lontani dai luoghi del disastro. Ed è quello che fa l’antropologo-fotografo Faeta: racconta la cronaca della sua giornata fino alle 19.34 del 23 novembre 1980 – l’ora della scossa.
Partendo dalla sua personale memoria, l’antropologo ricorda la sua visita ai paesi della Valle del Belice due anni dopo il sisma (1968). Confrontando la situazione di allora con quella dell’Irpinia di dodici anni dopo, nota che molti aspetti hanno accomunato i due territori terremotati: essi appartengono a due zone storicamente emarginate e marginali, in cui il sisma ha colpito più violentemente per la loro estrema fragilità. Anche i soccorsi sono arrivati con molto ritardo in ambedue le aree: «Ne ha ucciso più l’omissione dei soccorsi che il terremoto», scriveva Rossana Rossanda su “Il Manifesto” del 27 novembre 1980; cosa che provocò l’intervento, forse opportuno ma certo costituzionalmente non inappropriato, dell’allora Presidente della Repubblica Pertini, e soprattutto inascoltato da chi aveva funzioni e responsabilità politiche ed amministrative. Inoltre, ricorda ancora Faeta, la ricostruzione dei paesi ha avuto nelle due zone le stesse caratteristiche autoritarie, senza che i diretti interessati potessero esprimere le loro opinioni, tanto che molti preferirono affrontare l’emigrazione piuttosto che restare in un paese che non sentivano come proprio.
La documentazione fotografica non riporta in vita ciò che è stato distrutto, ma ci dice tante cose. Faeta discute il problema di cosa possono restituire le foto, alla fine non può che arrivare ad un’amara conclusione: oltre a raccontarci i disastri provocati dalla calamità, le foto dicono che una minaccia più grande incombeva su quelle popolazioni, quella della «solitudine, il silenzio, la perdita definitiva della località; quella stessa che era venuta materialmente meno nei giorni e nelle notti del sisma e che veniva invece, con cinismo, costantemente e falsamente promessa». Questa considerazione dà a Faeta la possibilità di raccontare come si mosse allora la “macchina della disinformazione”: troppe magagne il sisma aveva svelato e chi ne era responsabile fece di tutto per seppellirle insieme alle macerie.
Avviandosi alla conclusione, Faeta prende ad esaminare l’opera fotografica dell’americano Frank Cancian che, nel 1957, era andato a Lacedonia, sempre nell’Irpinia, a svolgere un’inchiesta di comunità, come facevano in quegli anni tanti altri studiosi americani, il cui esponente più importante e più discusso è stato E. Banfield. A Lacedonia, come nei paesi confinanti Bisaccia ed Aquilonia, nel 1930 c’era stato un terremoto disastroso; ma nessuno, alla fine degli anni ‘50, ne parlava più. Eppure la situazione che Cancian descrive nei suoi taccuini e nelle sue foto era molto simile a quella che si sarebbe riscontrata nel Belice del 1968 e nell’Irpinia del 1980; ma qualcosa aveva operato per la rimozione collettiva dell’accaduto e del ricordo. Analizzando il lavoro dell’americano, Faeta suggerisce che su questi disastri lo sguardo e la mente degli antropologi odierni abbiano come guida la ricerca proprio di Cancian.
Nella sezione del volume intitolata Dall’Archivio alla comunità, troviamo tre brevi interventi che presentano lo scopo della pubblicazione: la restituzione fotografica dell’evento e delle memorie che esse possono evocare nelle comunità vittime del sisma. L’antropologa Irene Falconieri spiega perché i terremoti sono eventi dinamici e complessi e che, oltre tutto, hanno la caratteristica di svelare le manchevolezze politiche nella gestione dei territori amministrati, giungendo alle stesse conclusioni di Faeta: il disastro «si ri-configura come “prodotto sedimentato dell’ingiustizia sociale” e “diventa specchio della condizione di marginalità del Mezzogiorno”». Aggiunge alle sue considerazioni sugli effetti del sisma anche quelle riguardanti il ricercatore: «Frequentemente i contesti di ricerca dell’antropologo sono caratterizzati da sofferenza fisica e sociale … delle persone incontrate sul campo»; il che suscita nello studioso emozioni che possono modificare il suo sguardo indagatore. L’influenza, tuttavia, che le emozioni possono avere su di lui deve essere ancora studiata bene.
Per Simone Valitutto le foto costituiscono una testimonianza dei fatti, nel senso che ne evocano la memoria. Sottolinea che esse sono state scattate dopo il sisma, nel momento in cui le popolazioni stanno prendendo chiara coscienza dell’avvenuto e sentono la necessità di pensare al futuro, di progettarlo. Per descrivere qual è il sentimento delle popolazioni in quel momento, Valitutto riporta due versi di Vinicio Capossela:
Così com’ero restar non posso,
quello che sono mi porto addosso.
Il poeta immagina che sia il borgo messo a nuovo dalla ricostruzione a parlare: non può più essere quello di prima, ma non può dimenticare ciò che prima era: quella memoria se la porta addosso. Il discorso vale anche per noi che guardiamo le foto contenute nel volume: sono immagini di macerie, di edifici pericolanti, di mozziconi di villaggi che hanno la funzione, come scrive Fabio Fichera, di restituirci la memoria dell’accaduto, rendendocene in qualche modo partecipi.
Chiude il volume il contributo di Mara Benadusi (L’Italia il giorno dopo; siamo tutti terremotati) che si sofferma principalmente su alcuni importanti punti. Innanzitutto lo spaesamento spazio-temporale dei sopravvissuti, specialmente giovani, quelli della “generazione scossa”: chi ha vissuto quei momenti e quelli immediatamente successivi al sisma porterà con sé una ferita che non guarirà mai. C’è poi l’aspetto della solidarietà che scatta spontaneamente, quando succedono eventi calamitosi. In Irpinia giunsero volontari da tutta l’Italia, tra cui una parte di rilievo ebbero quelli che avevano esperienze sindacali, che nel caos dello smarrimento e della impreparazione riuscirono a coordinare attività di sussistenza oltre ad indicare le soluzioni per gestire, in momenti così difficili, i bisogni delle popolazioni. L’antropologa fa notare, poi, che spesso in queste situazioni di estrema emergenza nascono attività di mutuo soccorso e si evidenziano capacità di iniziative a prima vista un po’ strane, ma che alla lunga dimostrano la loro importanza, come quella di approntare un posto di ristoro dove offrire una tazza di caffè ai soccorritori. E poi sono proprio queste calamità, che sembrano il simbolo della fine del mondo, che diventano «terreno propizio per l’emergenza di immagini utopiche di una società migliore». Ed infine, una considerazione piuttosto triste, comune a tutte le comunità che hanno vissuto tragedie simili: dopo il terremoto, il disastro. Purtroppo ci siamo abituati: le calamità in Italia, dai terremoti alle alluvioni, sono piuttosto frequenti ed ogni volta c’è chi approfitta di queste sventure per speculare sulle roulotte e le casette prefabbricate, sulla ricostruzione dei paesi, sugli investimenti di nuove attività produttive; e soprattutto c’è una cinica speculazione politica, fatta di promesse che non saranno mai mantenute.
Ogni qualvolta succede un terremoto nasce la sterile polemica se era possibile prevederlo. Il problema, però, non è poter conoscere anzitempo il momento del sisma, perché in caso di una previsione, indovinata o ragionata che sia, si potranno salvare delle vite umane ma non si può impedire alla natura di sconvolgere tutto ciò che esiste in quel momento. Ormai è noto che ai disastri che possono essere attribuiti al sisma si devono aggiungere quelli causati dalle manchevolezze decennali degli amministratori e dei politici, incuranti delle condizioni materiali di vita delle popolazioni, irresponsabilmente disinteressati alla manutenzione dei territori. Dal 1861 in poi, per parlare solo di responsabilità più vicine a noi, tutto il Mezzogiorno è stato abbandonato a se stesso; ad eccezione di alcune zone più fortunate, il Belice, la Calabria, l’Irpinia non hanno mai attirato l’attenzione dei governanti e sono stati negletti perché territori marginali, buoni solo a fornire mano d’opera migrante. Ovviamente, parlando di fenomeni geologici, c’è da dire che anche le montagne e le colline del Centro e del Nord Italia non hanno mai avuto la cura necessaria a ridimensionare gli effetti delle eventuali calamità.
Scrive Faeta che «I giorni dopo del Belice sono i giorni prima dell’Irpinia»; purtroppo dal 1980 al 2020 si sono susseguiti altri “giorni prima” di altri terremoti e di altri disastri che hanno colpito la Penisola italiana. A quanto pare, tuttavia, i “giorni prima” non hanno insegnato nulla se l’Abruzzo, l’Umbria, le Marche, il Lazio hanno profonde ferite non ancora rimarginate e se su di loro grava un silenzio più pesante del lenzuolo di cemento di Burri che copre il “cretto” dell’antica Gibellina.
Dialoghi Mediterranei, n. 47, gennaio 2021
______________________________________________________________
Mariano Fresta, già docente di Italiano e Latino presso i Licei, ha collaborato con Pietro Clemente, presso la Cattedra di Tradizioni popolari a Siena. Si è occupato di teatro popolare tradizionale in Toscana, di espressività popolare, di alimentazione, di allestimenti museali, di feste religiose, di storia degli studi folklorici, nonché di letteratura italiana (I Detti piacevoli del Poliziano, Giovanni Pascoli e il mondo contadino, Lo stile narrativo nel Pinocchio del Collodi). Ha pubblicato sulle riviste Lares, La Ricerca Folklorica, Antropologia Museale, Archivio di Etnografia, Archivio Antropologico Mediterraneo. Ultimamente si è occupato di identità culturale, della tutela e la salvaguardia dei paesaggi (L’invenzione di un paesaggio tipico toscano, in Lares) e dei beni immateriali. Fa parte della redazione di Lares. Ha curato diversi volumi partecipandovi anche come autore: Vecchie segate ed alberi di maggio, 1983; Il “cantar maggio” delle contrade di Siena, 2000; La Val d’Orcia di Iris, 2003. Ha scritto anche sui paesi abbandonati e su altri temi antropologici.
______________________________________________________________
































