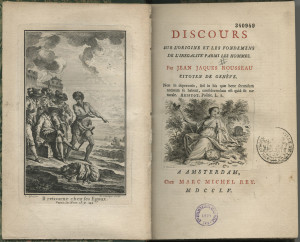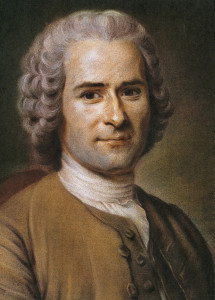Il Discours sur l’origine de l’inegalité parmi les hommes (1755) è stato scritto da Rousseau per criticare le forme e le modalità politiche non solo della società feudale, ma anche di quella borghese nascente, basata sulla proprietà privata, la divisione del lavoro e lo sfruttamento delle classi egemoniche a danno di quelle subalterne. La società moderna in cui sono presenti l’ingiustizia e la diseguaglianza, si contrappone allo stato di natura che per Rousseau è un’ipotesi, un principio ideale, «uno stato che non esiste più, che forse non è affatto esistito e probabilmente non esisterà mai, e sul quale tuttavia è necessario avere delle idee giuste per giudicare bene intorno al nostro stato presente» (Rousseau 1755: 29).
Per avere un’idea attendibile dello stato di natura Rousseau pensava che fosse necessario, attraverso il procedimento del deshabbillage de l’esprit (Formigari 1981: 68), separare ciò che è originario da ciò che è artificiale nella natura dell’uomo civilizzato, togliere tutto quanto è acquisito e inessenziale nell’intento di raggiungere la nuda coscienza umana, il vero carattere originario dell’uomo da cui poi è possibile seguire i mutamenti che hanno determinato la condizione attuale dell’umanità.
Rousseau intendeva distinguersi da tutti quei filosofi che si sono interrogati sull’origine della società perché sentivano la necessità di risalire allo stato di natura, senza tuttavia riuscire nel proprio intento perché essi hanno sempre applicato allo stato di natura criteri e metodi che fanno parte dell’attuale condizione umana, parlavano dell’uomo selvaggio e invece dipingevano l’uomo civile.
Al fine di capire veramente la mentalità dell’uomo di natura, Rousseau riteneva che si dovesse abbandonare il nostro modo abituale di pensare per superare l’abisso che separa il passato dal presente: occorre dunque risalire all’origine del tempo e della vita umana per capire l’uomo prima dell’avvento della civilizzazione umana e delle istituzioni che tanto hanno determinato la sua condotta (Einaudi 1979: 109). Tutte le teorie che i filosofi hanno elaborato per descrivere lo stato di natura sono, agli occhi del filosofo francese, inattendibili: in particolare è inaccettabile la visione hobbesiana dell’uomo naturale basata sulla predominanza dell’istinto aggressivo, dell’orgoglio, della vanità e della disposizione innata al combattimento e alla prevaricazione; per altri versi invece Rousseau apprezzava l’analisi impietosa di Hobbes del mondo competitivo in cui vive l’uomo moderno.
I caratteri dell’uomo naturale sono invece l’amore di sé, che va nettamente distinto dalla vanità, e la pietà, ossia quella innata ripugnanza a vedere soffrire gli altri esseri sensibili, «un sentimento naturale che temperando in ogni individuo l’attività dell’egoismo concorre alla mutua conservazione della specie» (Rousseau 1755: 63). Ai suoi occhi il potere, la sopraffazione, l’egoismo, la guerra appartengono al mondo civilizzato e sono sconosciuti all’uomo di natura, al quale risulta estraneo anche il desiderio della proprietà e la dipendenza dagli altri:
«le catene della servitù si sono formate soltanto per opera della mutua dipendenza degli uomini e dei bisogni reciproci che li uniscono, è impossibile asservire un uomo senza prima averlo messo nella condizione di non poter far a meno dell’altro; e siccome questa condizione non esiste nello stato di natura, vi lascia ognuno libero dal giogo e rende vana la legge del più forte» (ivi: 70).
Tra i confini che delimitano lo stato di natura Rousseau inseriva anche la proprietà privata della quale dava un giudizio fortemente negativo (ivi: 72). Se per Locke la proprietà privata è un diritto naturale antecedente alla società civile, la quale attraverso le leggi ha il compito di regolare questo diritto, per Rousseau invece è un abuso, un’usurpazione, è la negazione della libertà. È dal riconoscimento della proprietà che deriva la diseguaglianza tra gli uomini, la loro divisione in sfruttati e sfruttatori. In questo modo Rousseau, sottolineando l’origine particolaristica e di classe sia del governo che dello Stato, ha dimostrato quanto sia illusoria la sua presunta universalità, dietro la quale restano intatte le diseguaglianze sostanziali.
Il mito del buon selvaggio corrisponde anche a un modello letterario, ad una figura popolare della letteratura il cui esempio forse più emblematico è il personaggio di Venerdì di Robinson Crusoe (1719), il ragazzo selvaggio salvato da Robinson mentre stava per essere sacrificato in un rituale di cannibalismo. Nelle intenzioni di Defoe il personaggio di Venerdì appare in una luce molto positiva che risalta soprattutto quando è messo a confronto con Robinson il quale esalta il lettore per le sue avventure, ma non ha la spontaneità e la capacità emotiva del ragazzo; probabilmente Rousseau lo utilizzò come modello per le teorie pedagogiche discusse nell’Emile ou De l’éducation (1762).
Al buon selvaggio Rousseau riconosceva tutte quelle qualità, sia di carattere fisico che morale, ormai perdute per l’uomo civilizzato, come la capacità di vivere in armonia con la natura, la generosità, l’altruismo e l’innocenza, l’incapacità di mentire, il coraggio fisico, la forza del corpo, la fedeltà e il disdegno della lussuria:
«errabondo nelle foreste, senza industria, senza favella, senza domicilio, senza guerra e senza amicizie, senza avere alcun bisogno dei propri simili e senza avere alcun desiderio di nuocere loro (…) non aveva che i sentimenti e i lumi propri a questo stato, non sentiva che i suoi veri bisogni» (Rousseau 1755: 67-68).
Questa immagine mitica del selvaggio è costruita in continuità con il pensiero di Pascal per criticare la società del suo tempo; il suo significato per essere inteso nel senso pieno del termine deve essere inquadrato all’interno di quella corrente del pensiero illuministico che non era poi tanto interessata alle reali condizioni di vita dei popoli che prendeva ad esempio, quanto alle condizioni della società denunciate in nome appunto della prospettiva utopica dello stato felice di natura. Ciò che risalta, insomma, in questo contesto è un’istanza politica, più che un interesse etnologico (Tullio-Altan 1979: 32). Non è un caso infatti che questa prospettiva mitica resisterà alle confutazioni che verranno dall’antropologia e da tutte le osservazioni dirette che smentiranno la maggiore bontà dei cosiddetti selvaggi.
L’idea del buon selvaggio ha svolto una duplice funzione: in primo luogo ha rappresentato un tentativo di ristabilire il valore degli stili di vita indigeni, delegittimando la presunzione dell’eurocentrismo e denunciando gli eccessi dell’imperialismo sostenuto dalle potenze occidentali. In secondo luogo ha costituito l’occasione per mettere in dubbio la concezione trionfalistica del progresso e l’idea che il rischiaramento delle menti sia sempre un elemento infallibile di emancipazione umana.
Una delle tesi espressa nel Discours sur le sciences et les artes (1750) è infatti proprio quella che intravvede tra il progresso materiale e quello morale un rapporto inverso rispetto a quello immaginato dagli altri philosophes (Rousseau 1750: 6). Qui si misura il rapporto difficile e contradditorio tra Rousseau e gli altri grandi protagonisti della cultura illuminista come Voltaire, Diderot, D’Alembert, Holbach, con i quali del resto frequenti sono state le incomprensioni, i malintesi e le vere e proprie rotture, anche sul piano personale. Ad esempio, sul piano giuridico-politico le diversità di pensiero non potevano essere più rilevanti: se per la maggior parte dei philosophes l’alternativa all’antico regime era una forma di dispotismo illuminato, un rinnovamento guidato dall’alto e imposto da un’élite, per Rousseau invece il rinnovamento poteva aver luogo solo in seguito all’istituzione di un reale governo democratico perché basato sul consenso popolare.
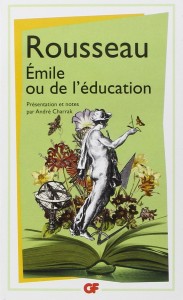 Anche per quanto riguarda la concezione della religione e della morale le posizioni sono molto diverse: nei philosophes frequenti sono i motivi anticlericali e antireligiosi, in Rousseau invece permane una concezione della vita e dell’uomo segnata dalla religione. Quando Voltaire pubblicò nel 1756 il Poéme sur le désastre de Lisbonne, in cui polemizzando con Leibniz, sottolineava quanto il mondo fosse affidato al caso e al male di cui il terremoto è appunto un simbolo, Rousseau replicò a Voltaire con una lettera molto critica dichiarando con fermezza e anche con una certa dose di fanatismo la sua fede nella religione e nella provvidenza divina. Successivamente anche nel Contrat social (1762) Rousseau considerava addirittura obbligatori i dogmi relativi all’esistenza di Dio e all’immortalità dell’anima. Sulla scorta di questi e altri possibili esempi Casini (1980: 445-46) ha scritto che il centro comune verso il quale i singoli aspetti dell’opera di Rousseau convergono è proprio l’ambito etico e religioso.
Anche per quanto riguarda la concezione della religione e della morale le posizioni sono molto diverse: nei philosophes frequenti sono i motivi anticlericali e antireligiosi, in Rousseau invece permane una concezione della vita e dell’uomo segnata dalla religione. Quando Voltaire pubblicò nel 1756 il Poéme sur le désastre de Lisbonne, in cui polemizzando con Leibniz, sottolineava quanto il mondo fosse affidato al caso e al male di cui il terremoto è appunto un simbolo, Rousseau replicò a Voltaire con una lettera molto critica dichiarando con fermezza e anche con una certa dose di fanatismo la sua fede nella religione e nella provvidenza divina. Successivamente anche nel Contrat social (1762) Rousseau considerava addirittura obbligatori i dogmi relativi all’esistenza di Dio e all’immortalità dell’anima. Sulla scorta di questi e altri possibili esempi Casini (1980: 445-46) ha scritto che il centro comune verso il quale i singoli aspetti dell’opera di Rousseau convergono è proprio l’ambito etico e religioso.
Associando l’immagine del progresso con quella dell’alterazione sociale, il filosofo francese voleva sottolineare che la condizione dell’uomo sociale è segnata dall’infelicità anche nel periodo in cui lo sviluppo della tecnica e l’affinamento delle arti stanno raggiungendo un livello considerevole. La divisione del lavoro, la moltiplicazione delle ricchezze, lo sviluppo produttivo, la competizione hanno anche dei notevoli costi sociali e umani come l’alienazione, l’isolamento, l’incapacità di distinguere tra avere ed essere, l’avidità. La sua posizione corrisponde a quella di chi esprime una condanna del mondo in cui vive e un sogno di rifondazione di quel mondo. Se pertanto vogliamo trovare un’esemplificazione dello stato di natura di derivazione hobbesiana non dobbiamo far altro che guardarci intorno per scoprire che la società civile in cui pensiamo di vivere ha delle sorprendenti somiglianze con la giungla descritta da Hobbes.
I desideri dell’uomo naturale sono limitati e non forgiati dall’immaginazione, le sue conoscenze risultano molto circoscritte, la sua condizione di vita primitiva e innocente non conosce il pensiero e il linguaggio (Droixhe 1988). L’uomo naturale dunque non vive l’insoddisfazione e la frustrazione, la fuga nell’immaginario gli è sconosciuta perché «l’immaginazione appartiene a quelle forme stupende e funeste che fomentano l’insoddisfazione, costringono la mente a vedere lontano da sé e le fanno abbandonare il suolo natio della vita immediata» (Starobinski 1994: 132). In quest’ottica la riflessione è considerata dannosa perché allontana dalla vita istintiva e dalla spontaneità dei primi tempi, per questo viene associata al dolore ed è ritenuta responsabile dell’isolamento e dell’egoismo dell’uomo civilizzato.
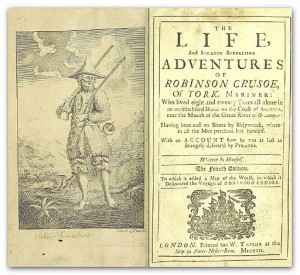 L’origine del male non risiede né in Dio né nella natura – che, anzi, ci ha destinato a essere felici – ma proprio nella società che trasforma gli uomini in nemici della natura e di se stessi, che genera bisogni e passioni sconosciuti all’uomo di natura e che mette a disposizione i mezzi per soddisfarli senza riguardo e senza limiti. Per questa ragione Rousseau, pur essendo profondamente religioso, è per certi aspetti lontano dalle forme tradizionali della fede tradizionale visto che rifiutava in parte i dogmi della Chiesa, primo fra tutti quello del peccato originario.
L’origine del male non risiede né in Dio né nella natura – che, anzi, ci ha destinato a essere felici – ma proprio nella società che trasforma gli uomini in nemici della natura e di se stessi, che genera bisogni e passioni sconosciuti all’uomo di natura e che mette a disposizione i mezzi per soddisfarli senza riguardo e senza limiti. Per questa ragione Rousseau, pur essendo profondamente religioso, è per certi aspetti lontano dalle forme tradizionali della fede tradizionale visto che rifiutava in parte i dogmi della Chiesa, primo fra tutti quello del peccato originario.
L’antropologia del primitivo elaborata da Rousseau si basa pertanto su una concezione dialettica che vede da un lato, nel sistema valoriale positivo, le caratteristiche dell’uomo naturale e dall’altro, nel sistema negativo, i tratti della società civilizzata come il linguaggio, la riflessione, la politica e la filosofia. Questa concezione dualistica da una parte ci fornisce gli strumenti per mettere in luce le storture e le ingiustizie che caratterizzano il sistema sociale in cui gli uomini vivono, e anche per mettere in discussione la concezione molto diffusa della rivoluzione industriale come fonte di benessere e prosperità; dall’altra, però, ci presenta una concezione idealizzata della natura e dell’uomo primitivo in cui si dà per scontato, con una sorta di petizione di principio, che questi rappresentino una mitica età dell’oro, un primordiale paradiso di libertà e innocenza ormai irraggiungibile.
Il sistema filosofico di Rousseau è segnato da interessanti contraddizioni come ad esempio quella che riguarda la non coincidenza tra le posizioni avanzate in senso politico sociale e quelle sostenute nel senso dell’emancipazione dai dogmi della religione (Timpanaro 1985: LVIII-LIX): rispetto alle idee politiche di Voltaire o Holbach senz’altro la posizione di Rousseau (o anche di Robespierre) è più avanzata e più vicina all’ideale democratico, tuttavia il mancato laicismo rappresenta comunque un limite di cui non possiamo non tenere conto per una piena comprensione del suo pensiero filosofico e antropologico.
Dialoghi Mediterranei, n.32, luglio 2018
Riferimenti bibliografici
Cassirer E. – Danton R. – Starobinski J. (1994), Tre letture di Rousseau, Roma-Bari, Laterza.
Einaudi M. (1979), Il primo Rousseau, Torino, Einaudi.
Casini P. (1980), Introduzione all’illuminismo. Da Newton a Rousseau, Roma-Bari, Laterza.
Droixhe D. (1988), “Rousseau e l’infanzia del linguaggio”, in Formigari e Lo Piparo (1988): 225-40.
Formigari L. (1981), La scimmia e le stelle, Roma, Editori Riuniti.
Formigari L. e Lo Piparo F. (1988), a cura di, Prospettive di storia della linguistica. Lingua, linguaggio, comunicazione sociale, Roma, Editori Riuniti.
Rousseau J. J. (1750), Discours sur les sciences et les arts, tr. it. In Rousseau 1972: 3-17.
Id. (1755), Discours sur l’inegalité parmi les hommes, tr. it. Di G. Preti, Origine della disuguaglianza, Milano, Feltrinelli, 1996.
Id. (1756), “Lettera di J.J. Rousseau a Voltaire”, in Rousseau (1972: 125-35).
Id. (1972), Opere, a cura di P. Rossi, Firenze, Sansoni.
Starobinski J. (1994), “Rousseau e il pericolo della riflessione”, in Cassirer-Danton-Starobinski 1994: 93-190.
Timpanaro S. (1985), “Introduzione” in Holbach P.T., Il buon senso, Milano, Garzanti: VII-LXXXI.
Tullio-Altan C. (1979), Manuale di antropologia culturale, Milano, Bompiani.
___________________________________________________________________________
Alessandro Prato, docente di Retorica e linguaggi persuasivi all’Università di Siena, è redattore della rivista Blityri. Studi di storia delle idee sui segni e sulle lingue. Tra le sue pubblicazioni si segnalano: Comunicazione e potere. Le strategie retoriche e mediatiche per il controllo del consenso, Roma, Aracne, 2018; La retorica. Forme e finalità del discorso persuasivo, Pisa, Edizioni ETS, 2012; Linguaggio e filosofia nell’età dei lumi. Da Locke agli idéologues, Bologna, I libri di Emil, 2012.
___________________________________________________________________________