di Bernardo Puleio
Questo scritto trae origine da un intervento tenuto il 2 dicembre 2022 presso il Teatro delle Arti, nella succursale del liceo Umberto I di Palermo, in occasione della giornata di studio intitolata Le eresie degli intellettuali del Novecento come eredità dissipate: Gramsci, Sciascia, Pasolini, Camilleri. La giornata di studio muoveva i suoi passi dalla pubblicazione dell’ottimo libro di Francesco Virga, Eredità dissipate (Diogene Multimedia, Bologna 2022), di cui una mia recensione è stata pubblicata sul numero 57 di Dialoghi Mediterranei (1settembre 2022) col titolo di Nani sulle spalle dei maestri.
In questo mio piccolo intervento, in maniera assolutamente cursoria, cercherò di designare alcune presenze di Gramsci in Sciascia e nel Camilleri autore di romanzi storici, con particolare riguardo allo snodo fondamentale del 1860. In realtà, preliminarmente, bisognerebbe chiedersi se abbia un senso, oggi, parlare di Maestri, occorrerebbe cercare di stabilire che cosa significhi essere Maestri, cioè discutere sulla vecchissima ma quanto mai attuale questione del canone. Ha ancora un senso nella società liquida, contraddistinta dal politicamente corretto che rivoluziona continuamente ogni idea sui valori del passato, parlare di un canone e parlare di Maestri? E che cosa significa o significherebbe una concezione della letteratura in una società senza Maestri e senza canone? Interrogativi che qui ovviamente non possono essere affrontati ma che in qualche misura intersecano le eredità dissipate e i difficili conti con i Maestri del Novecento.
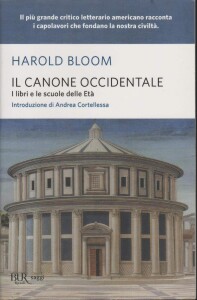 In un testo canonico sulla questione del canone, pubblicato quasi trent’anni fa, Il canone occidentale, Herald Bloom , ben prima del politicamente corretto, segnalava una condizione di sofferenza in cui si sarebbe trovata la letteratura assediata dalla tecnologia. E se la prendeva contro i maestri del Risentimento, contro quelli che negano l’idea del canone. Secondo Bloom, il canone è elemento indispensabile della concezione estetica che è il principio fondamentale della letteratura. Chi ama leggere non può fare a meno di stilare giudizi e graduatorie: d’altronde (alla maniera di Nietzsche) la vita, come la letteratura e l’atto compositivo, è una lotta, un continuo aggiornamento di modelli e canoni. Nel saggio, Un’elegia per il canone [2], viene sostenuta l’autonomia della poesia come essenza dell’opera letteraria. L’opera è un fatto di piacere, non si può prescindere dal piacere estetico: sarebbe una fuga, una rimozione di una delle principali funzioni dell’opera letteraria.
In un testo canonico sulla questione del canone, pubblicato quasi trent’anni fa, Il canone occidentale, Herald Bloom , ben prima del politicamente corretto, segnalava una condizione di sofferenza in cui si sarebbe trovata la letteratura assediata dalla tecnologia. E se la prendeva contro i maestri del Risentimento, contro quelli che negano l’idea del canone. Secondo Bloom, il canone è elemento indispensabile della concezione estetica che è il principio fondamentale della letteratura. Chi ama leggere non può fare a meno di stilare giudizi e graduatorie: d’altronde (alla maniera di Nietzsche) la vita, come la letteratura e l’atto compositivo, è una lotta, un continuo aggiornamento di modelli e canoni. Nel saggio, Un’elegia per il canone [2], viene sostenuta l’autonomia della poesia come essenza dell’opera letteraria. L’opera è un fatto di piacere, non si può prescindere dal piacere estetico: sarebbe una fuga, una rimozione di una delle principali funzioni dell’opera letteraria.
Gramsci viene definito da Bloom il protagonista degli anticanonizzatori [3], perché nega la possibilità che gli intellettuali si affranchino dai gruppi a cui fanno riferimento. Qui non è il caso di andare a impelagarsi in una lunga discussione sulla funzione e le caratteristiche dell’intellettuale organico che infiniti lutti addusse alla sinistra italiana e allo scontro tra partito comunista e intellettuali laici. Va osservato però un piccolo particolare che sfugge all’analisi di Bloom: Gramsci è un maestro del Novecento, un autore canonico che, negli anni ‘90, all’epoca cioè della pubblicazione de Il canone occidentale, era diventato, anche e soprattutto nel mondo anglosassone, un punto di riferimento. Sarà un frutto della eterogenesi dei fini della storia, sarà il gusto del paradosso delle vicende che intersecano i piani della realtà e della letteratura, ma fatto sta che Gramsci, nel Novecento, è un Maestro. Dal grande sardo trae origine gran parte della discussione nel secondo dopoguerra della cultura italiana. Il peso, il lascito, l’eredità di Gramsci, per fortuna questa non dissipata, non è in Italia, ma fuori dall’Italia.
 Aspetto questo che, a mio avviso, costituisce una macchia della nostra nazione, che, d’altronde, è quasi sempre stata caratterizzata, come forma mentis dominante, dalla presenza di forze occultamente o palesemente reazionarie quando non apertamente antidemocratiche e incostituzionali. L’Italia ha inventato il fascismo, ha dato origine, in epoca recentissima, a movimenti e partiti post fascisti che si rifacevano apertamente all’ideologia fascista ben lontani dalla concezione di una destra liberale europea: quindi, a prescindere poi dalle indubbie colpe di quella che impropriamente si fa chiamare sinistra, l’abito mentale di questa nazione, che non gode di grande prestigio a livello internazionale sul piano della coscienza etica, di coscienza dello Stato [4], è l’abito di una nazione di destra, di una destra, per di più, tranne rari casi, sostanzialmente storicamente ideologicamente, illiberale. Con questo stato di cose noi e Gramsci, l’eredità di Gramsci, dobbiamo fare i conti.
Aspetto questo che, a mio avviso, costituisce una macchia della nostra nazione, che, d’altronde, è quasi sempre stata caratterizzata, come forma mentis dominante, dalla presenza di forze occultamente o palesemente reazionarie quando non apertamente antidemocratiche e incostituzionali. L’Italia ha inventato il fascismo, ha dato origine, in epoca recentissima, a movimenti e partiti post fascisti che si rifacevano apertamente all’ideologia fascista ben lontani dalla concezione di una destra liberale europea: quindi, a prescindere poi dalle indubbie colpe di quella che impropriamente si fa chiamare sinistra, l’abito mentale di questa nazione, che non gode di grande prestigio a livello internazionale sul piano della coscienza etica, di coscienza dello Stato [4], è l’abito di una nazione di destra, di una destra, per di più, tranne rari casi, sostanzialmente storicamente ideologicamente, illiberale. Con questo stato di cose noi e Gramsci, l’eredità di Gramsci, dobbiamo fare i conti.
Ma, a proposito di conti con i maestri del Novecento, soprattutto relativamente a Gramsci, occorre, in maniera lucida e oggettiva, fare i conti con la sinistra che si è impadronita del pensiero di Gramsci e che ne ha tradito alcuni aspetti. Gramsci è stato utilizzato dal partito comunista e dagli intellettuali ad esso organici, come una bandiera irrinunciabile ma spesso e volentieri su alcuni aspetti problematici del suo pensiero è calato il silenzio quando non apertamente il travisamento. In particolare, è assolutamente traditrice, fuorviante e mistificatrice, rispetto al pensiero gramsciano, l’idea che la sinistra, gli intellettuali di formazione comunista, hanno fornito di Garibaldi, rappresentato sostanzialmente mitologicamente come un eroe onesto dalla parte del popolo, sopraffatto poi dagli interessi di Cavour e del Piemonte. L’immagine che Gramsci fornisce di Garibaldi è assolutamente impietosa. Eppure la sinistra non si è mai voluta occupare del lascito gramsciano sull’eroe dei due mondi.
 In un passo del quindicesimo Quaderno, scritto nel 1933, mentre era tenuto in carcere dal tiranno fascista del quale, il presidente del Senato, la seconda carica della Repubblica, pubblicamente si è vantato di tenere una collezione di busti in casa, Gramsci, riadattando il concetto di rivoluzione passiva [5], osserva, analizzando la spedizione dei Mille, il carattere demagogico dei capi popolo che, come Garibaldi, ottennero successo quando furono asserviti alle forze di potere tradizionali, come i piemontesi, con buona pace di ogni istanza di progresso e di modernità. Senza l’intervento decisivo delle forze tradizionali reazionarie come quelle torinesi e, senza la protezione della flotta britannica, la spedizione dei Mille, tanto osannata a sinistra come esempio di istanza democratica e popolare, non avrebbe mai avuto successo: per di più Garibaldi viene descritto come un esempio di capo demagogo. Se ne potrebbe dedurre che, da sapiente capo popolo a servizio degli interessi delle classi dirigenti e reazionarie, Garibaldi si serviva del suo fascino per ingannare le masse illudendole in una rivoluzione che non aveva nessuna intenzione di fare dal momento che aveva stretto accordi precisi con Cavour e Vittorio Emanuele. E quando i contadini sobillati e illusi dalla presenza di Garibaldi e dalle promesse della spartizione di terre demaniali, la rivoluzione tentarono di farla per davvero, Garibaldi non solo reagì violentemente ma istituì la guardia nazionale infiltrata di forze mafiose che avrebbero poi pesantemente e costantemente impedito ogni azione di rivendicazione dei contadini. Garibaldi nell’isola si comportò come un perfetto doppiogiochista, un politicante scaltro e navigato, un demagogo pronto a ingannare quella parte che aveva infiammato e illuso.
In un passo del quindicesimo Quaderno, scritto nel 1933, mentre era tenuto in carcere dal tiranno fascista del quale, il presidente del Senato, la seconda carica della Repubblica, pubblicamente si è vantato di tenere una collezione di busti in casa, Gramsci, riadattando il concetto di rivoluzione passiva [5], osserva, analizzando la spedizione dei Mille, il carattere demagogico dei capi popolo che, come Garibaldi, ottennero successo quando furono asserviti alle forze di potere tradizionali, come i piemontesi, con buona pace di ogni istanza di progresso e di modernità. Senza l’intervento decisivo delle forze tradizionali reazionarie come quelle torinesi e, senza la protezione della flotta britannica, la spedizione dei Mille, tanto osannata a sinistra come esempio di istanza democratica e popolare, non avrebbe mai avuto successo: per di più Garibaldi viene descritto come un esempio di capo demagogo. Se ne potrebbe dedurre che, da sapiente capo popolo a servizio degli interessi delle classi dirigenti e reazionarie, Garibaldi si serviva del suo fascino per ingannare le masse illudendole in una rivoluzione che non aveva nessuna intenzione di fare dal momento che aveva stretto accordi precisi con Cavour e Vittorio Emanuele. E quando i contadini sobillati e illusi dalla presenza di Garibaldi e dalle promesse della spartizione di terre demaniali, la rivoluzione tentarono di farla per davvero, Garibaldi non solo reagì violentemente ma istituì la guardia nazionale infiltrata di forze mafiose che avrebbero poi pesantemente e costantemente impedito ogni azione di rivendicazione dei contadini. Garibaldi nell’isola si comportò come un perfetto doppiogiochista, un politicante scaltro e navigato, un demagogo pronto a ingannare quella parte che aveva infiammato e illuso.
Ora, sicuramente sarà una mancanza mia, ma non mi pare che nella storiografia italiana comunista che tanto ha preso a modello le istanze di Gramsci, i conti con Garibaldi siano stati regolati in maniera critica: la prima a dissipare l’eredità di Gramsci e a falsificarne il bilancio, a non farne correttamente i conti è stata la sinistra, la vecchia sinistra socialcomunista dei bei tempi antichi, duri e puri, che prese a modello nel 1948, pur dopo la pubblicazione della prima edizione dei Quaderni, la icona di Garibaldi nella campagna elettorale del 18 Aprile. E nonostante successivi e più accurati studi, anche filologici, su Gramsci, Garibaldi è rimasto una icona della sinistra
Un patrimonio mondiale della letteratura e della cultura è costituito dalla celebre leggenda del grande inquisitore inserita da Dostoevskij all’interno de I fratelli Karamazov. Com’è notorio Cristo si presenta di fronte al grande inquisitore della Chiesa cattolica romana che, con cinismo, pena la sopravvivenza della Chiesa stessa, lo condanna a morte. Analogamente si può forse asserire che, se Gramsci scrivesse oggi alcune delle cose che ha scritto circa un secolo fa o anche di meno, dopo la congiura del silenzio perpetrata a sinistra nel secondo dopoguerra su alcuni passaggi scomodi, si abbatterebbe su di lui la mannaia inquisitoria del politicamente corretto progressista: oggi, Gramsci passerebbe per neo-borbonico. Questo è il livello attuale della discussione nel nostro Paese: appena muovi una critica al processo di formazione del governo unitario, post unitario, quello che io definisco il governo nazisabaudo, ti appioppano l’etichetta di neo-borbonico, anche quando sei anni luce lontano, come nel caso di Gramsci, da questo tipo di impostazione.
Una rappresentazione critica invece del fenomeno unitario del nostro Risorgimento che, in qualche modo può essere riconducibile anche ad una lettura gramsciana, si può riscontrare in Camilleri ma anche in parte in Sciascia. Nel diciannovesimo Quaderno, Gramsci affronta la questione del Risorgimento. L’affronta, vedendo l’evoluzione, che a suo avviso è un’involuzione, del quadro politico in Italia. Dalla rivoluzione mancata e fallita nel ‘48 in poi, è il partito d’azione che riuscirà a realizzare un processo unitario. Gramsci ammette che indubbiamente il partito d’azione ha qualità di classe dirigente ma osserva che il quadro politico subisce una trasformazione in senso negativo soprattutto per le classi che approssimativamente potremmo definire proletarie e per il Sud. Gramsci si sofferma anche sul 1860 in Sicilia, sull’operato di Garibaldi e dei garibaldini e non si limita a criticare la feroce repressione di Bronte, sulla quale peraltro Sciascia [6], prendendo le mosse da Gramsci, nel 1960, in occasione del centenario, scriverà una serie di saggi molto critici verso il processo unitario e parlerà della lotta di questa Italia, quella vincitrice, contro l’altra Italia, cioè quella meridionale, ma parla anche di altre cose come per esempio dell’istituzione della cosiddetta guardia nazionale, che era lo strumento di controllo adoperato dai garibaldini. Scrive Gramsci [7]:
«È da studiare la condotta politica dei garibaldini in Sicilia nel 1860, condotta politica che era dettata da Crispi: i movimenti di insurrezione dei contadini contro i baroni furono spietatamente schiacciati e fu creata la Guardia nazionale anticontadina»
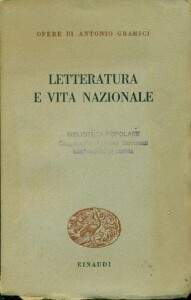 Già questa è una prima definizione: la guardia nazionale, fondata da Garibaldi, agì contro i contadini. Qua non si tratta delle tante discusse infiltrazioni dei picciotti mafiosi a partire da Calatafimi accanto alle forze garibaldine. Qui arriviamo al paradosso, un fatto gravissimo che Garibaldi costituisce una struttura logistico militare, la guardia nazionale per mantenere l’ordine pubblico e la affida direttamente ai mafiosi. L’ordine pubblico mantenuto dai mafiosi è il marchio di infamia del nascente Stato unitario che diede un vantaggio poi non facilmente colmabile alla criminalità mafiosa collusa con la nuova identità del nuovo Stato! A sovrintendere la guardia nazionale Garibaldi mise il tanto discusso barone Turrisi Colonna che affidò l’incarico militare al ragazzo di borgata fino allora poverissimo, diventato in breve tempo feroce astro nascente della mafia palermitana, Antonino Giammona che, naturalmente, segno evidente della collusione anche dei governi successivi, rimase intoccato e intoccabile per oltre trent’anni finché rimase in vita il barone Turrisi Colonna, pur essendo depositata contro di lui una lunga serie di denunce e di dossier [8].
Già questa è una prima definizione: la guardia nazionale, fondata da Garibaldi, agì contro i contadini. Qua non si tratta delle tante discusse infiltrazioni dei picciotti mafiosi a partire da Calatafimi accanto alle forze garibaldine. Qui arriviamo al paradosso, un fatto gravissimo che Garibaldi costituisce una struttura logistico militare, la guardia nazionale per mantenere l’ordine pubblico e la affida direttamente ai mafiosi. L’ordine pubblico mantenuto dai mafiosi è il marchio di infamia del nascente Stato unitario che diede un vantaggio poi non facilmente colmabile alla criminalità mafiosa collusa con la nuova identità del nuovo Stato! A sovrintendere la guardia nazionale Garibaldi mise il tanto discusso barone Turrisi Colonna che affidò l’incarico militare al ragazzo di borgata fino allora poverissimo, diventato in breve tempo feroce astro nascente della mafia palermitana, Antonino Giammona che, naturalmente, segno evidente della collusione anche dei governi successivi, rimase intoccato e intoccabile per oltre trent’anni finché rimase in vita il barone Turrisi Colonna, pur essendo depositata contro di lui una lunga serie di denunce e di dossier [8].
Sempre nello stesso passo dello stesso Quaderno, Gramsci [9] lo dice chiaramente, citando anche fra Pantaleo: la questione che smuoveva le masse a sud e in Sicilia, era la questione agraria ma la guardia nazionale, istituita dall’eroe Garibaldi, ebbe il compito di soffocare ogni istanza contadina.
«È tipica la spedizione repressiva di Nino Bixio nella regione catanese, dove le insurrezioni furono più violente. Eppure [anche] nelle Noterelle di G.C. Abba ci sono elementi per dimostrare che la quistione agraria era la molla per far entrare in moto le grandi masse: basta ricordare i discorsi dell’Abba col frate che va incontro ai garibaldini subito dopo lo sbarco di Marsala. In alcune novelle di G. Verga ci sono elementi pittoreschi di queste sommosse contadine che la guardia nazionale soffocò col terrore e con la fucilazione in massa (Questo aspetto della spedizione dei Mille non è mai stato studiato e analizzato)».
«Questo aspetto della spedizione dei Mille non è mai stato studiato e analizzato» scrive Gramsci: occorreranno anni prima che alcuni aspetti, e non tutta la faccenda nella sua interezza siano analizzati da autori progressisti che peraltro in alcuni casi, come per esempio Sciascia, finiranno anche con il rompere col partito comunista. Il problema è che quando Gramsci viene pubblicato, nel 1947, Garibaldi era considerato l’eroe della sinistra: gruppi di formazioni partigiane si chiamavano brigate Garibaldi. Naturalmente, per il partito comunista di Togliatti, piuttosto che fare un serio processo di revisione che avrebbe messo in dubbio e in crisi l’identità del partito che non sbagliava e non falliva mai nell’indicare i suoi santi numi ed eroici protettori alla stessa stregua di una religione assolutista e fanatica, fu più facile silenziare Gramsci anziché criticare l’eroe di Caprera.
 E, d’altronde lo stesso atteggiamento di mancata revisione storica, fu tenuto da Togliatti che era stato spettatore, quando non in qualche caso complice dei misfatti di Stalin, su Stalin. Il Migliore com’era fanaticamente a priori definito Togliatti, su Stalin tenne sempre una posizione di elogio, come testimonia il suo famoso discorso in Parlamento dopo la morte del dittatore sovietico. E addirittura, quando durante il ventesimo Congresso del partito comunista sovietico furono denunciati alcuni dei crimini di Stalin, l’Unità non ne diede conto, perché sarebbe stato imbarazzante parlare di un padre della libertà come di un feroce dittatore. Salvo poi essere messi in ridicolo da tutta la stampa internazionale che naturalmente a quelle notizie dava ampio risalto. Ma questo era il partito comunista italiano che i conti con Gramsci li ha fatti a senso unico, unilateralmente, cinicamente a volte, strumentalmente, prendendo, sfruttando quello che appariva più conveniente e tacendo su quello che avrebbe potuto creare un elemento di destabilizzazione. Questo atteggiamento costituisce il primo grave esempio di tradimento del pensiero di Gramsci, il primo esempio di eredità dissipata.
E, d’altronde lo stesso atteggiamento di mancata revisione storica, fu tenuto da Togliatti che era stato spettatore, quando non in qualche caso complice dei misfatti di Stalin, su Stalin. Il Migliore com’era fanaticamente a priori definito Togliatti, su Stalin tenne sempre una posizione di elogio, come testimonia il suo famoso discorso in Parlamento dopo la morte del dittatore sovietico. E addirittura, quando durante il ventesimo Congresso del partito comunista sovietico furono denunciati alcuni dei crimini di Stalin, l’Unità non ne diede conto, perché sarebbe stato imbarazzante parlare di un padre della libertà come di un feroce dittatore. Salvo poi essere messi in ridicolo da tutta la stampa internazionale che naturalmente a quelle notizie dava ampio risalto. Ma questo era il partito comunista italiano che i conti con Gramsci li ha fatti a senso unico, unilateralmente, cinicamente a volte, strumentalmente, prendendo, sfruttando quello che appariva più conveniente e tacendo su quello che avrebbe potuto creare un elemento di destabilizzazione. Questo atteggiamento costituisce il primo grave esempio di tradimento del pensiero di Gramsci, il primo esempio di eredità dissipata.
Camilleri su Garibaldi, interviene in uno dei suoi primi testi di un romanzo storico, pubblicato nel 1980, Un filo di fumo. In quel contesto Camilleri [10], che non ha mai disconosciuto la sua identità comunista, registra in un dialogo tra l’antiborbonico marchese Curtò e il borbonico padre Imbornone, le critiche al malgoverno piemontese in Sicilia, impartendo una lezione di storia all’ingegnere torinese Lemonnier
“Le faccio una domanda: quando Garibaldi sbarcò a Marsala”
“coi vapori di Rubattino” si immischiò padre Inbornone, e rise rotando a varie riprese il braccio destro in un gran gesto che voleva significare oscuri e indicibili sottintesi.
“… quando Garibaldi sbarcò a Marsala lo sa quanti telai avevamo in funzione qui in Sicilia?”
“no”.
“glielo dico io: circa tremila. E lo sa quanti ne restarono in funzione dopo l’Unità?”
“No”.
“Meno di duecento, egregio amico”.
“Rubattino, Rubattino” canticchiò padre Imbornone. “E la stoffa che ha incominciato ad arrivare da Biella l’abbiamo dovuta pagare a prezzo doppio. E la gente che si guadagnava il pane coi telai è andata, con rispetto parlando, a minarsela”.
“Dato che le stanno facendo la lezione di storia” intervenne padre Imbornone “la sa la faccenda del ‘patriota’ Rubattino, un nome che è tutto un programma?”
“Credo di non sapere più niente”.
“Rubattino aveva l’acqua al collo, stava fallendo e prese al volo l’occasione. Diede a Garibaldi due scassati vapori che lo sa solo Dio come facevano a mantenersi a galla – erano più pirtusi che vapuri – e il nostro generale, appena arrivato a Palermo, mise le mani, e magari i gomiti, nelle nostre casse e glieli pagò, in oro, tre volte tanto il loro giusto valore. E così i siciliani poterono subito capacitarsi di come sarebbero state amministrate le cose dello Stato”.
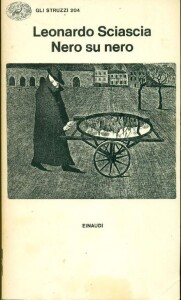 Questo non è l’unico passaggio in cui Camilleri se la prende con il governo piemontese; per esempio quando ricevette la laurea honoris causa a Cagliari tenne una lezione magistrale in cui effettua un’affermazione più volte ripresa [11]: ‘i piemontesi ‘nni livaru u piaciri do futtiri’, cioè di mettere al mondo figli, perché fu imposta la obbligatorietà di un duro e spietato servizio di leva che in Sicilia non era stata imposta durante il governo borbonico. Paradossalmente gli odiati napoletani avevano mostrato più attenzione per l’autonomia della Sicilia del nuovo ordine imposto dai fratelli calati dal nord.
Questo non è l’unico passaggio in cui Camilleri se la prende con il governo piemontese; per esempio quando ricevette la laurea honoris causa a Cagliari tenne una lezione magistrale in cui effettua un’affermazione più volte ripresa [11]: ‘i piemontesi ‘nni livaru u piaciri do futtiri’, cioè di mettere al mondo figli, perché fu imposta la obbligatorietà di un duro e spietato servizio di leva che in Sicilia non era stata imposta durante il governo borbonico. Paradossalmente gli odiati napoletani avevano mostrato più attenzione per l’autonomia della Sicilia del nuovo ordine imposto dai fratelli calati dal nord.
E d’altronde di un governo peggiore di quello borbonico insediatosi o forse sarebbe meglio dire insidiatosi in Sicilia dopo il 1860 c’è traccia in una famosa pagina di Nero su nero, redatta nel 1979. Scrive Leonardo Sciascia [12]:
«Nella bottega di un antiquario scopro un ritratto di Maria Sofia, ultima regina delle Due Sicilie. È un ritratto ufficiale, mandato da Napoli al Luogotenente, forse, o a qualche altro rappresentante, di grado elevato, del potere Reggio in Sicilia: e sarà stato involato da qualche fedele di grado umile, quando, all’entrata di Garibaldi a Palermo, quelli che stavano in alto abbandonavano uffici e residenze e si davano a cancellare ogni traccia della loro devozione alla dinastia borbonica, del loro zelo nel servirla (esattamente come, nel 1943, abbiamo visto fanatici gerarchie funzionali dei voti al regime distruggere divise, distintivi, diplomi di benemerenza, fotografie compromettenti e libri apologetici). [....] verso i Borboni di Napoli il mio sentimento è sempre rimasto quello che ne avevi alle scuole elementari: più o meno, cioè, come di fronte a quella “negazione di Dio” con cui Gladstone volle definire il loro regnare. E questo sentimento mi condiziona nel giudizio, anche se tante cose lette in questi ultimi anni avrebbero dovuto portarmi a rivederlo e a mutarlo, e comunque a riconoscere che non erano poi peggio dei Savoia, e anzi un po’ meglio. [....] Appeso nel mio studio (e servirà, se continui a scrivere libri “sbagliati”, a farmi passare per Borbonico addirittura), il ritratto della regina di Napoli suscita improvvisi rapimenti nella donna che ogni tanto viene ad aiutarci nelle faccende di casa».
Mi avvio alla conclusione ritornando al punto di partenza cioè al maestro Gramsci che, nel 1918, fa una recensione sull’Avanti in cui giudica L’aria del continente di Martoglio e Pirandello, un testo teatrale scritto in siciliano e rappresentato con successo in tutta Italia in dialetto siciliano. Oggi con queste affermazioni Gramsci [13] sarebbe additato come filo borbonico o, come un reazionario ancora più becero, un sicilianista che esalta l’idea di nazione della Sicilia:
«Cinquant’anni di vita unitaria sono stati in gran parte dedicati dai nostri uomini politici a creare l’apparenza di una uniformità italiana: le regioni avrebbero dovuto sparire nella nazione, i dialetti nella lingua letteraria. La Sicilia è la regione che ha più attivamente resistito a questa manomissione della storia e della libertà. La Sicilia ha dimostrato in numerose occasioni di vivere una vita a carattere nazionale proprio più che regionale…La verità è che la Sicilia conserva una sua indipendenza, e questa si rivela più spontanea e forte che mai nel teatro. Esso è diventato gran parte del teatro nazionale, ha conquistato una popolarità, nel settentrione come nel centro, che ne denotano la vitalità e l’aderenza a un costume diffuso e fortemente radicato».
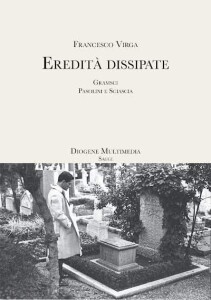 Concludo con una brevissima citazione tratta dalle Eredità dissipate di Francesco Virga [14]:
Concludo con una brevissima citazione tratta dalle Eredità dissipate di Francesco Virga [14]:
«Credo che abbia spiegato le ragioni che hanno spinto a considerare almeno in parte dissipata la grande verità culturale lasciata da Gramsci, Pasolini e Sciascia. I tre, malgrado il successo che hanno avuto in momenti della loro vita, sono stati in gran parte incompresi dai loro contemporanei. Antonio Gramsci si è sentito isolato e incompreso dai suoi stessi compagni di lotta […] la storia di Pasolini è stata una storia di incomprensioni, malgrado il successo di critica e pubblico che tutte le opere hanno registrato nel mondo intero […] in Italia Leonardo Sciascia ha sempre diviso l’opinione pubblica e la classe politica, insieme alle gerarchie ecclesiastiche hanno guardato sempre con sospetto al suo spirito eretico».
Dialoghi Mediterranei, n. 59, gennaio 2023
Note
[1] H. Bloom, The western canon. The books of the ages (1994), trad. it., Il canone occidentale. I libri e le Scuole delle età, IIIª ed., Rizzoli, Milano 2005.
[2] Ivi: 13-35
[3] Ivi: 19
[4] Giacomo Leopardi è autore di un testo considerato profetico, pubblicato solo nel 1906, ma scritto nel 1824: Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani. Prima ancora che esistesse lo Stato italiano, Leopardi osservava, come caratteristica preponderante dei cittadini della nazione non ancora Stato, il cinismo che ne caratterizza non tanto i costumi quanto la scostumatezza, la mancanza di rispetto per le regole comuni da cui deriva l’abito mentale all’intrallazzo, pena anche la perdita della stima e della onorabilità pubblica, non considerati in Italia, come invece in Francia o in altre nazioni, beni di fondamentale importanza. Lo sguardo lungo di Leopardi sembra aver colto l’Italia di sempre, se è vero che giuristi e antropologi si sono rifatti spesso a questo testo, cogliendone l’attualità ed evidenziando una serie di mali collettivi mai sanati neanche nei 150 anni di vita unitaria
[5] A. Gramsci, Quaderni dal carcere, a cura di V. Gerratana, vol. 3: 1772-3, Einaudi, Torino, 2001
Quaderno 15 (II) § (15) Machiavelli
«Il rapporto “rivoluzione passiva-guerra di posizione” nel Risorgimento italiano può essere studiato anche in altri aspetti. Importantissimo quello che si può chiamare del “personale” e l’altro della “radunata rivoluzionaria”. […] È da osservare che la difficoltà tecnica contro cui andarono sempre a spezzarsi le iniziative mazziniane fu quella appunto della “radunata rivoluzionaria”. Sarebbe interessante, da questo punto di vista, studiare il tentativo di invadere la Savoia col Ramorino, poi quello dei fratelli Bandiera, del Pisacane ecc., paragonato con la situazione che si offrì a Mazzini nel 48, a Milano e nel 49 a Roma e che egli non ebbe la capacità di organizzare. Questi tentativi di pochi non potevano non essere schiacciati in germe, perché sarebbe stato maraviglioso che le forze reazionarie, che erano concentrate e potevano operare liberamente (cioè non trovavano nessuna opposizione in larghi movimenti della popolazione) non schiacciassero le iniziative tipo Ramorino, Pisacane, Bandiera, anche se queste fossero state preparate meglio di quanto furono in realtà. Nel secondo periodo (1859-60) la radunata rivoluzionaria, come fu quella dei Mille di Garibaldi, fu resa possibile dal fatto che Garibaldi si innestava nelle forze statali piemontesi prima e poi che la flotta inglese protesse di fatto lo sbarco a Marsala, la presa di Palermo, e sterilizzò la flotta borbonica. A Milano dopo le cinque giornate, a Roma repubblicana, Mazzini avrebbe avuto la possibilità di costituire piazze d’armi per radunate organiche, ma non si propose di farlo, onde il suo conflitto con Garibaldi a Roma e la sua inutilizzazione a Milano di fronte a Cattaneo e al gruppo democratico milanese.
In ogni modo lo svolgersi del processo del Risorgimento, se pose in luce l’importanza enorme del movimento “demagogico” di massa, con capi di fortuna, improvvisati ecc., in realtà fu riassunto dalle forze tradizionali organiche, cioè dai partiti formati di lunga mano, con elaborazione razionale dei capi ecc. In tutti gli avvenimenti politici dello stesso tipo sempre si ebbe lo stesso risultato (così nel 1830, in Francia, la prevalenza degli orleanisti sulle forze popolari radicali democratiche, e così in fondo anche nella Rivoluzione Francese del 1789, in cui Napoleone, rappresenta, in ultima analisi, il trionfo delle forze borghesi organiche contro le forze piccolo-borghesi giacobine). Così nella guerra mondiale il sopravvento dei vecchi ufficiali di carriera su quelli di complemento ecc. (si questo argomento cfr note in altri quaderni). In ogni caso, l’assenza nelle forze radicali popolari di una consapevolezza del compito dell’altra parte impedì ad esse di avere piena consapevolezza del loro proprio compito e quindi di pesare nell’equilibrio finale delle forze, in rapporto al loro effettivo peso d’intervento, e quindi di determinare un risultato più avanzato, su una linea di maggiore progresso e modernità».
[6] A partire dal 1960 Sciascia scrive una serie di saggi che riguardano la spedizione garibaldina come I fatti di Bronte, Verga e il Risorgimento, Verga e la libertà. Su questo aspetto rimando al mio saggio Verga e Sciascia, tra storia e identità siciliana, pubblicato in Dialoghi mediterranei, n. 55, 1 maggio 2022
[7] Quaderni dal carcere, cit., XIX, 26, vol. 3: 2045
[8] Con decisione parlamentare del 3 luglio 1875 fu inviata in Sicilia la prima commissione d’inchiesta sulle condizioni dell’Isola. Cfr. L’inchiesta sulle condizioni sociali ed economiche della Sicilia (1875-6) a cura di S Carbone e R. Grispo, 2 voll., vol. I: 405, Archivio centrale dello Stato (Cappelli editore, Bologna 1969)
Il relatore era Romualdo Bonfadini che nell‘udienza dell’11 novembre 1875 interroga Bartolomeo Rastelli Questore di Palermo. Bonfadini: Lei ha parlato della maffia e dei gruppi di maffia. C’è mai avvenuto il sospetto che queste maffie nella provincia di Palermo siano entrate qualche volta nelle elezioni politiche? R. I capi specialmente esercitano una certa influenza, non sarà molto estesa, con tante chiesuole e maffiotte che hanno, però un 15, 20 o 30 voti possono averli: ci sono molti capi maffia che hanno potenza su degli elettori. Bonfadini: Non può citare qualche caso? R. Durante le elezioni io non ero qui, ma per esempio mi dicevano che c’era un certo Giammona giù nella piana di Palermo, e questo è un capo maffia bello e buono, tempo fa non aveva niente, adesso gli si conta un patrimonio di due o trecento mila lire, capisce, e questo ha una certa influenza in quelle date frazioni, e questo disporrà di 30 o 40 voti, non potrei dire preciso. So questo perché mi è venuto occasione di scrutarlo in un processo che si sta facendo che spero darà buoni risultati e che purgherà un poco quella parte di Palermo tanto interessante. Dovendo scrutare la vita immorale di questo uomo sono venute insieme molte cose, e tra le altre si sa che ha 40 o 50 voti nelle elezioni. Cusa: anche nelle elezioni amministrative? R. Se li ha nelle politiche, li ha anche nelle elezioni amministrative.
[9] Quaderni dal carcere, cit., XIX, 26, vol. 3: 2045-6
[10] A. Camilleri, Romanzi storici e civili, Mondadori, Milano, 2004: 28-9
[11] In rete è facile reperire la lectio magistralis tenuta da Camilleri il 10 maggio 2013 a Cagliari in occasione del conferimento della laurea honoris causa
[12] L. Sciascia, Nero su Nero, in Idem, Opere, vol. II, Bompiani, Milano, 1989: 676-9
[13] A. Gramsci, Letteratura e vita nazionale, Einaudi, Torino, 1972: 321-2
[14] F. Virga, Eredità dissipate, Multimedia Diogene, Bologna, 2022: 315-8.
__________________________________________________________________________________
Bernardo Puleio, insegna Lettere al Liceo Umberto di Palermo. Tra le sue pubblicazioni: I sentieri di Sciascia (Palermo, Kalos, 2003); Il paradigma impossibile: nuovi saggi su Leonardo Sciascia (Palermo, Nuova Ipsa, 2005); Il linguaggio dei corpi straziati. Potere e semantica del potere nell’Italia del XVI secolo (Firenze, Clinamen, 2007). È redattore dei Nuovi Annali del Liceo Umberto I di Palermo.
______________________________________________________________








