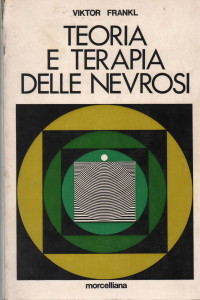di Augusto Cavadi
La sofferenza ha molti volti. Nella nostra percezione soggettiva, e più ancora nel nostro approccio terapeutico, è possibile distinguerli; ma a patto di non dimenticare che si tratta di sfaccettature dell’unico poliedro. Rami che si dipartono da un unico tronco e che, proprio in forza di questo ceppo comune, si influenzano reciprocamente.
Così distinguiamo il dolore fisico, il disagio psichico, la sofferenza esistenziale, ma consapevoli che queste dimensioni si innervano e si embricano e si intrecciano inestricabilmente. Là dove questa consapevolezza si obnubila, emerge la tracotante stupidità degli specialismi succubi della parola d’ordine: “Nient’altro che…”. Là dove, invece, permane, ogni professionista ricerca, con sincero desiderio di complementarietà, l’apporto dei colleghi impegnati in altre discipline.
In questa ottica complessiva – in questa sinottica – una qualche priorità logica (se non sempre cronologica) spetta all’approccio medico e farmacologico: nel soggetto concreto che ho davanti ci sono disfunzioni fisiologiche che gli provocano malessere? E, se sì, quali farmaci possono incidere sui processi bio-chimici per ridurre il dolore? Siamo in un ambito problematico dove ancora – in pieno XXI secolo – si registrano ritardi incredibili. Mi riferisco alle cure palliative che – a differenza di ciò che si suppone ordinariamente – non sono per nulla dei rimedi illusori, bensì delle vere e proprie terapie che azzerano, o per lo meno riducono drasticamente, il dolore fisico. Molti medici, per impreparazione o per resistenza culturale o per pigrizia (alcune sostanze possono essere prescritte solo mediante procedure particolari su ricettari specifici), si esonerano dal ricorso a tali cure: con conseguenze facilmente immaginabili per i pazienti, specie se in fase terminale.
È ovvio che i dolori fisici alterino lo stato d’animo del soggetto in sofferenza: e già questo rende ineludibile l’approccio psicoterapeutico. Approccio irrinunciabile ancor più nei casi in cui un malessere psichico non può considerarsi causato da patologie organiche (e, anzi, ne è esso stesso causa). Neppure in questo ambito mancano resistenze culturali dagli effetti pragmatici deleteri: medici, in particolare psichiatri, che si attestano sul fronte farmacologico irridendo ogni alternativa terapeutica basata sulla parola [1]; pazienti che, da parte loro, sono disposti a dichiararsi malati (sino a sconfinare nell’ipocondria) finché si tratta di disturbi organici, ma si rifiutano fermamente di esaminare anche solo l’ipotesi di aver bisogno di un aiuto dal punto di vista psicologico (“Non sono certo un pazzo…”).
Come spiegare questa diffidenza repulsiva? Qualche volta ci si può imbattere in uno psicoterapeuta che incarna la caricatura della sua professione: ma ciò avviene in ogni settore della vita sociale. Quando invece – come nella maggior parte dei casi – si tratta di un professionista serio, l’attenzione al paziente prevarrà nettamente sulla fedeltà bigotta a una determinata scuola di psicoterapia: infatti un intelligente eclettismo metodologico consente di utilizzare tecniche di matrice differente calibrate sul tipo di sofferenza psichica di ciascun paziente in ciascuna fase della sua vita [2].
La professionalità e l’onestà di uno psicoterapeuta possono indurlo a sospettare che alcune sofferenze psichiche non siano soltanto, o prevalentemente, “psicogene”. Tra i primi ad accorgersene è stato, durante l’internamento in quattro differenti lager nazisti, il giovane Victor Frankl (un viennese laureato in medicina e in filosofia, discepolo di Freud e di Adler). Egli ha notato, osservando se stesso e dialogando con i compagni di detenzione, che il culmine della sofferenza si raggiunge quando – al di là delle privazioni corporee e delle repressioni psichiche – viene mortificato un bisogno ancor più radicale e globale del soggetto umano: la “fame di significato”. Chi vive l’esperienza di una malattia dolorosa o di una prigionia umiliante può sopportare rinunce anche pesanti purché intraveda un barlume di “senso”. Per lui vale il detto di Nietzsche: «Datemi un perché (vivere) ed accetterò quasi ogni come (vivere)»[3]. Chi di noi ama, o ha mai amato, un animale con un suo musetto, un suo pelo, un suo nomignolo… avrà sperimentato l’amarezza di doverlo sottoporre a cure veterinarie dolorose: infatti, può prodigargli analgesici e carezze, ma non spiegargli le ragioni delle sofferenze che gli si infliggono per il suo bene.
A quale professione spetta il compito di affrontare le sofferenze “noogene”? La domanda non ammette risposte secche. In quest’area a elevato tasso di problematicità si possono tentare delle riflessioni molto orientative, da rifinire e approfondire.
Tradizionalmente ci si è rivolti ai ministri di culto: ai preti cattolici e ortodossi, ai pastori anglicani e protestanti. Le “narrazioni” teologiche, però, sono oggi in crisi in tutta la cristianità (metto fra parentesi, almeno in questa sede, le situazioni registrabili nell’ambito dell’ebraismo, dell’islamismo e delle altre grandi religioni dell’umanità): sono dunque sempre più rari i credenti in senso confessionale disposti a chiedere con fiducia a un ministro della propria chiesa delle indicazioni per interpretare il senso della propria sofferenza.
È proprio pensando ad atei, agnostici, ricercatori in cammino, come anche a credenti che – accanto, o dopo, una risposta teologica da accettare per fede – avvertono l’esigenza di un accompagnamento più ‘laico’ che si rivolga alla loro intelligenza ‘naturale’, che Victor Frankl ha elaborato la sua “logoterapia” e la sua “analisi esistenziale”: una psicoterapia consistente nel sollecitare il paziente verso un mondo di significati, di valori, di “logoi” che diano un senso, un orientamento, alla sua unica, irripetibile, “esistenza”. Siamo in uno scenario antropologico lontano dai riduzionismi biologici, sociologici e perfino psicologici [4]: si suppone che nell’uomo emerga una dimensione “spirituale” (anche se non necessariamente religiosa), dal momento che «la logoterapia assume lo spirituale come punto di partenza e l’analisi esistenziale come punto di arrivo» [5].
Chi lavora quotidianamente a contatto con degenti di lungo periodo, con invalidi gravi, con malati in fase terminale sa apprezzare per esperienza diretta il ruolo di quanti – come gli assistenti religiosi di varia confessione o gli psicoterapeuti più o meno vicini all’approccio della logoterapia frankliana – si affiancano all’opera dei medici e degli psicologi di altri orientamenti.
Sinora si è parlato di terapia, di cura, di assistenza: ci si è mossi all’interno di una logica asimmetrica in cui qualcuno (in una posizione in qualche misura up) cura, o almeno si prende cura di, qualche altro (in una posizione in qualche misura down). Questa attività di “aiuto” si può svolgere nella maniera più delicata, più rispettosa, più soft: ma si attua in una relazione che, per quanto rivestita di gentilezza e savoir faire, di per sé resta non-paritetica.
Può però accadere che un malato guardi negli occhi un medico o uno psicoterapeuta o un prete e – interpellandolo da uomo a uomo (intendo: in quanto uomo che interpella un altro uomo) – chieda: “Secondo te, perché?”. Può accadere che una madre in fase terminale, o un padre al capezzale di un bambino in agonia, chieda: “Secondo te, perché proprio a me?”. In questa ipotesi emerge una domanda di senso che è, tipicamente, filosofica.
A questo punto il logoterapeuta esistenziale di scuola frankliana sa che, in quanto psicoterapeuta, deve limitarsi a sollecitare il paziente a individuare una sua risposta, in base alla visione-del-mondo complessiva del paziente stesso: può invitarlo, anche mediante qualche suggerimento, a rintracciare quale significato possa nascondersi per lui stesso in una fase così tragica dell’esistenza.
Ma se la domanda è ancora più radicale (“Voglio confrontarmi dialetticamente con qualcuno per capire se c’è – e, se c’è, quale sia – un possibile senso dell’esistenza sofferente”), allora non è l’aiuto di un competente o la cura di un terapeuta che si sta cercando, bensì un’interlocuzione paritetica con chi per mestiere abita queste domande metafisiche. Con molta onestà il logoterapeuta riconosce che, su questo limite, la sua professione si arresta: egli sa di non avere né il compito né gli strumenti per discutere a trecentosessanta gradi la tematica ontologica e di dover dare per presupposte alcune verità (“il Tutto ha senso e, all’interno del Tutto, la vita dell’essere umano ha sempre senso”) che il filosofo non può concedersi di presupporre [6]. Qui si entra in un terreno dove i metodi, nel senso di tecniche operative, vengono meno [7]. Un discepolo di Frankl racconta di essersi pentito ogni volta che si è lasciato trascinare da un paziente in dibattiti filosofici o teologici su Dio, il male nell’universo, la sofferenza umana [8]: in quanto terapeuta la sua decisione è legittima e saggia, ma allora queste domande sono destinate a essere eluse, rimosse?
Esiste una figura professionale di filosofo disposto a “filosofare” autenticamente con un altro (presumibilmente non-filosofo di professione, ma animato di spirito filosofico), dunque disposto a dedicargli tempo e soprattutto a mettersi in gioco in prima persona? Da una quarantina di anni la risposta è affermativa: il consulente filosofico o (per evitare confusioni con il mare di counselor moltiplicatisi in questi decenni) il filosofo-consulente [9].
Ovviamente neppure il filosofo-consulente ha una risposta all’interrogativo sul male nell’universo e comunque, ammesso che l’avesse o supponesse di averla, sarebbe perfettamente inutile ammannirla come un cibo precotto. Se è davvero filosofo, accetta la sfida di pensare ogni volta come se fosse la prima volta – e dunque senza dare per scontata nessuna conclusione – la questione che gli viene posta: di pensarla e di pensarla insieme, di co-pensarla dialogicamente, con chi gliene faccia richiesta. Di co-pensarla senza rete di protezione: disposto, intendo, a pervenire, secondo l’andamento del confronto dialettico, a idee per lui stesso impreviste.
 Liberare il campo dalle pseudo-risposte
Liberare il campo dalle pseudo-risposte
Quando accenno a questa figura professionale – che in Italia abbiamo importato una ventina di anni fa grazie soprattutto al lavoro pionieristico di Neri Pollastri e che oggi è rappresentata in maniera più significativa dall’associazione nazionale “Phronesis” (www.phronesis-cf.com) – l’interrogativo che mi viene rivolto più di frequente suona su per giù così: “Ma, in concreto, cosa può significare?”. Per un verso la domanda è mal posta: come si fa a dire, in generale, come si svolge un colloquio in particolare? Se la consulenza filosofica è un dialogo, ogni volta unico, fra un filosofo-consulente, ogni volta unico, con un consultante (e per ciò stesso, in qualche misura, aspirante filosofo), ogni volta unico, come si può descrivere come si svolge, in astratto, una consulenza filosofica? Ma se, per un verso, la domanda è fuori posto, per altro verso esprime una curiosità legittima. Infatti, nell’immaginario collettivo, letteratura e cinema ci hanno fornito esempi di colloqui psicoterapeutici; qualche volta di colloqui teologico-religiosi; mai di colloqui meta-tecnici fra un consulente e un consultante.
Dirò, dunque, in breve qualcosa sul tema della sofferenza in base a ciò che ho potuto sperimentare e intuire sino a questo momento.
Se nella consulenza il filosofo non è un maestro né tanto meno un guru che fornisce risposte illuminanti a richiesta, come una sorta di juke-box metafisico, egli è interpellato (e, di norma, pagato) perché si suppone che possa mettere in comune sul piatto del con-filosofare una certa competenza e una certa attitudine al senso critico. Egli ha dunque il dovere, più ancora che il diritto, di formulare ipotesi di ricerca – nel caso che il consultante ne richieda – e di avanzare obiezioni a ipotesi di ricerca che il consultante esponga come proprie o come suggeritegli da qualche altra fonte.
In territori di tradizione cristiana, come l’Europa e in particolare l’Italia, non è difficile – ad esempio – che un malato si senta invitato (o inviti se stesso) ad accettare con pazienza la sua malattia, anche grave, in quanto “effetto della Volontà divina”. Se il filosofo-consulente non ha nessuna preparazione in campo teologico può anche dichiarare la propria incompetenza settoriale o, per lo meno, la propria indisponibilità ad entrare in tematiche che avverte come estranee. Se però non è del tutto asciutto in teologia, e può dunque frequentare certi terreni dove si muove l’interlocutore, può avanzare i suoi dubbi.  È vero che la tradizione cristiana è intrisa di “dolorismo”, di esaltazione della sofferenza come “prova” della propria fedeltà a Dio: da Gesù in poi, si ripete di generazione in generazione che, più Dio ci ama, più ci chiede di soffrire per purificare noi e, attraverso i nostri “meriti”, l’umanità. Ma da alcuni decenni questa interpretazione del dolore viene contestata come blasfema da sempre più numerosi teologi: e ciò a titolo non di rottura di una tradizione autentica, bensì di recupero di un messaggio originario. Infatti, sulla base di una rilettura esegetica del dato biblico scientificamente più attrezzata, si rivela infondata qualsiasi immagine di un Dio despota feroce disposto a perdonare il peccato dell’umanità solo a prezzo del “sangue” del Figlio e di quanti decidono di seguirne le orme sul calvario della storia. Dio, in quanto Fonte della vita, vuole che gli uomini «abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza» (Giov. 10,10): ogni esperienza di morte, di malattia, di sofferenza in questo mondo è uno scacco all’intenzione profonda del Creatore. Altro che “valle di lacrime” preparata da Dio per quanti vuole “mettere alla prova” e “premiare” nell’altro mondo! Gesù per primo, nel vangelo secondo Giovanni, ha cercato di contestare la teoria giuridicista della pena “riparatrice”. Quando gli presentano un cieco nato, gli chiedono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco?». La sua risposta è tranciante: «Né lui ha peccato né i suoi genitori» (Giov. 9, 2-3) Ma la teoria che vede nel peccato morale la radice di ogni sofferenza fisica, già respinta fieramente da Giobbe nel Primo Testamento, sopravvive anche al Secondo: una delle tante eresie cristiane talmente ataviche e ripetute anche da papi, vescovi e teologi da essere spacciate per ortodossia indiscutibile [10].
È vero che la tradizione cristiana è intrisa di “dolorismo”, di esaltazione della sofferenza come “prova” della propria fedeltà a Dio: da Gesù in poi, si ripete di generazione in generazione che, più Dio ci ama, più ci chiede di soffrire per purificare noi e, attraverso i nostri “meriti”, l’umanità. Ma da alcuni decenni questa interpretazione del dolore viene contestata come blasfema da sempre più numerosi teologi: e ciò a titolo non di rottura di una tradizione autentica, bensì di recupero di un messaggio originario. Infatti, sulla base di una rilettura esegetica del dato biblico scientificamente più attrezzata, si rivela infondata qualsiasi immagine di un Dio despota feroce disposto a perdonare il peccato dell’umanità solo a prezzo del “sangue” del Figlio e di quanti decidono di seguirne le orme sul calvario della storia. Dio, in quanto Fonte della vita, vuole che gli uomini «abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza» (Giov. 10,10): ogni esperienza di morte, di malattia, di sofferenza in questo mondo è uno scacco all’intenzione profonda del Creatore. Altro che “valle di lacrime” preparata da Dio per quanti vuole “mettere alla prova” e “premiare” nell’altro mondo! Gesù per primo, nel vangelo secondo Giovanni, ha cercato di contestare la teoria giuridicista della pena “riparatrice”. Quando gli presentano un cieco nato, gli chiedono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco?». La sua risposta è tranciante: «Né lui ha peccato né i suoi genitori» (Giov. 9, 2-3) Ma la teoria che vede nel peccato morale la radice di ogni sofferenza fisica, già respinta fieramente da Giobbe nel Primo Testamento, sopravvive anche al Secondo: una delle tante eresie cristiane talmente ataviche e ripetute anche da papi, vescovi e teologi da essere spacciate per ortodossia indiscutibile [10].
E allora, come dobbiamo pensare il mondo, l’uomo, il divino? Inutile cercare nel vangelo risposte ‘filosofiche’. Gesù non ha chiarito teoreticamente le cause del dolore: non era un filosofo. Ha mostrato, con le parole e più ancora con la testimonianza, che il dolore va contrastato con tutti i mezzi disponibili in ogni determinata fase della civiltà umana.
Spetta al filosofo-consulente cercare, insieme al suo consultante (specie se attanagliato dall’esperienza del dolore), di diradare – almeno parzialmente – alcune ombre dell’enigma. Liberare il campo dalle risposte false, certamente sbagliate, è solo un primo passo. Ma, anche se restasse l’unico progresso, sarebbe già prezioso. Eviteremmo di colpevolizzare un padre di famiglia, estenuato da un tumore inguaribile nel pieno della maturità, lasciandogli supporre che stia pagando un debito verso Dio stesso, contratto da lui o da qualche suo congiunto. Eviteremmo, insomma, di aggiungere sofferenza a sofferenza e apriremmo la via verso interpretazioni più ragionevoli, e forse per ciò stesso meno disperanti, dell’esperienza universale del dolore [11].
Dialoghi Mediterranei, n. 37, maggio 2019
Note
[1] «Tornano qui a proposito le parole di Paul Dubois: il medico può senza dubbio accontentarsi di esser soltanto medico, nello stretto senso della parola; ma in tal caso si renda conto che tra lui ed il veterinario c’è una sola differenza: il diverso genere di clientela» (V. Frankl, Teoria e terapia delle nevrosi, Morcelliana, Brescia 1978: 193).
[2] «La psicoterapia e non solo la logoterapia,fa assegnamento di continuo sulla prontezza dell’improvvisare. Là dove esiste la possibilità di svolgerla accuratamente in forma di dimostrazioni cliniche, quello che si deve insegnare, non da ultimo, è l’improvvisazione, con la conseguenza che la si può imparare» (ivi: 39).
[3] Cfr. V. Frankl, Uno psicologo nei lager, Ares, Milano 2012.
[4] «Frankl parla di homunculismo, nel senso cioè che si comprende, in modo travisato, come nient’altro che, così come viene affermato dal biologismo, dal sociologismo e dallo psicologismo. Inserito in una catena di produzione, non è altro che un ingranaggio facilmente sostituibile nel caso non funzioni a dovere» (E. Fizzotti, Logoterapia per tutti. Guida teorico-pratica per chi cerca il senso della vita, Rubbettino, Soveria Mannelli 2012: 129).
[5] V. Frankl, Homo patiens. Soffrire con dignità, Queriniana, Brescia 1998: 29.
[6] Frankl afferma, ad esempio, che «il senso dell’esistenza sia sempre e soltanto un senso concreto; esso si riferisce solo ad personam e ad situationem (appunto perché corrisponde non solo ad ogni singola persona, ma anche ad ogni situazione personale»; invece «interrogarsi sul senso del tutto è un non-senso» dal momento che «il senso assoluto è del tutto fuori dalle possibilità umane») (Ivi: 72-73).
[7] Sui punti di contatto e di differenza fra la logoterapia frankliana e la consulenza filosofica inspirata a Gerd Achenbach cfr. le pp. 110-115 di N. Pollastri, Il pensiero e la vita. Guida alla consulenza e alle pratiche filosofiche, Apogeo, Milano 2004 (dove, per uno strano lapsus calami, l’autore scrive Jung invece di Adler). Vi si nota come la scuola italiana aggiunga, alla lezione originaria di Frankl , «una componente metodologica» che appare «del tutto incompatibile con un lavoro di ricerca filosofica» (114). Infatti si prevedono delle «tecniche psicolinguistiche» che presuppongono, nel logoterapeuta, «un’esplicita direttività e l’assunzione di un modello di salute» (115): insomma una serie di elementi tipici di «un atteggiamento propriamente e pienamente terapeutico» ma estranei «alle specificità di un filosofo» (ivi).
[8] Mi riferisco al paragrafo Il logoterapeuta di fronte a problematiche metafisico-religiose, a firma di Tullio Bazzi, nel volume di E. Fizzotti, Logoterapia per tutti, cit.: 249 – 251.
[9] Cfr. A. Cavadi, Filosofia di strada. La filosofia-in-pratica e le sue pratiche, Di Girolamo Trapani 2010.
[10] E. Rindone, Nati per soffrire? Il male: una questione sempre attuale, www.ilmiolibro.it, Roma 2012.
[11] Non c’è dubbio che le nuove cosmologie e le varie teorie evoluzionistiche da Darwin in poi impongano una revisione ab imis della problematica del male “fisico” così come i campi di detenzione e di sterminio in Unione Sovietica (gulag) e in Germania (lager) ne hanno imposto un’altra a proposito del male “morale” causato da uomini ai danni di altri esseri umani. Delle piste interessanti sono state tracciate in V. Mancuso, Il principio passione, Garzanti, Milano 2013.
Augusto Cavadi, tra i pionieri della filosofia-in-pratica contemporanea, già docente presso il Liceo “G. Garibaldi” di Palermo, è fondatore della Scuola di formazione etico-politica “Giovanni Falcone”. Collabora stabilmente con La Repubblica-Palermo. I suoi scritti affrontano temi relativi alla filosofia, alla pedagogia, alla politica, con particolare attenzione al fenomeno mafioso, nonché alla religione, nei suoi diversi aspetti teologici e spirituali. Tra le ultime sue pubblicazioni si segnalano: Il Dio dei mafiosi (San Paolo, 2010); La bellezza della politica. Attraverso e oltre le ideologie del Novecento (Di Girolamo, 2011); Il Dio dei leghisti (San Paolo, 2012); Mosaici di saggezze – Filosofia come nuova antichissima spiritualità (Diogene Multimedia, 2015); Peppino Impastato martire civile. Contro la mafia e contro i mafiosi (Di Girolamo, 2018).
_______________________________________________________________