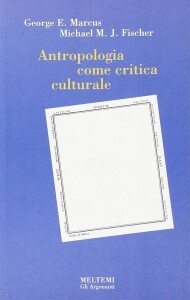di Giovanni Cordova
Questo breve articolo per Dialoghi Mediterranei origina dal crescente disagio che in quanto studioso sto percependo negli ultimi mesi in relazione al peggioramento politico e al deterioramento del quadro sociale di un contesto (la Tunisia) che in anni recenti ho diffusamente attraversato per motivi di ricerca. Non sarò un ingrato a essere così critico rispetto all’attuale situazione politica del Paese dopo esserne stato ospite e aver goduto di ampi margini di sicurezza e libertà di ricerca? Non sarà che con questa reiterata postura critica e polemica finirò con il produrre dei danni, pur nelle minute dimensioni della mia voce e del mio statuto scientifico, a un contesto che invece avrebbe bisogno di ben altre rappresentazioni per godere di maggior credito tra turisti, expat, investitori e chi più ne ha più ne metta? La domanda non è retorica ma matura da un recente confronto con alcuni operatori che erogano servizi turistici e assistenziali rivolti a cittadini e cittadine di provenienza europea in Tunisia.
Utilizzo il termine ‘disagio’, benché non sia sicuro che esso possa tradurre fedelmente delle sensazioni che sono progressivamente mutate in rabbia, impegno, tentativi velleitari di controinformazione e assunzione di limitate forme di advocacy. Eppure, gira e rigira, questa parola permane, impressa dalle mie dita mentre battono i tasti del computer. Certo, il ‘disagio’ è legato a un’esperienza di ricerca peculiare, l’etnografia, senza la quale esso nemmeno sarebbe sorto, convertendosi direttamente nelle fasi emozionali e nelle azioni che ho appena elencato.
Questo breve contributo non intende in alcun modo aspirare ai contenuti di un saggio sull’etnografia. Tuttavia, alcune considerazioni preliminari sono necessarie.
L’etnografia è il registro pratico, epistemologico e metodologico con cui studiose e studiosi accedono a un terreno di ricerca aprendosi all’imprevedibile, al caos, al disordine che appartengono al fluire umano. Lungi dal poter essere condensata in un casellario preordinato – o peggio, prescrittivo – di norme, prassi e regole da seguire per acquisire risultati scientifici rigorosi, solidi e coerenti (falsificabili e riproducibili, come nelle scienze ‘dure’), l’etnografia è la croce e la delizia di scienziati e scienziate sociali che la praticano. Condannata (o benedetta?) al «pessimismo dell’approssimazione ineluttabile» (Olivier de Sardan 2004), da una parte essa ha contribuito, associandosi al ‘metodo’ dell’osservazione partecipante, a fare la fortuna e il fascino fatale di un immaginario che solo recentemente (e faticosamente) l’antropologia è riuscita a scucirsi di dosso. D’altra parte, essa continua a rappresentare una sfida stimolante e angosciante per chiunque voglia cimentarsi nella co-produzione di una teoria sociale incorporata, situata, contestuale e “con i piedi per terra”, che affiori dalle pratiche e dalle produzioni culturali di chi ‘abita’ il terreno della ricerca e dall’interpretazione (autoriale) di un’esperienza che nella maggior parte dei casi l’etnografo/a vive e realizza in solitaria [1].
L’antropologia, in particolare, fonda un sapere corrosivo, tendente alla decostruzione e all’incrinatura di modelli etici, comportamentali, politici e sociali che i gruppi umani sogliono considerare naturali, ineccepibili, ancorati alla consuetudine o, meglio ancora, all’inscalfibile piano mitico delle verità divine e universali. L’antropologia, nel prendere atto, perlopiù rispettosamente, di questa saldatura, ne svela il carattere arbitrario e profondamente culturale. Questo disvelamento non va però inteso nei termini marxiani dell’estirpazione di una falsa coscienza ingannatrice e riproduttrice di dislivelli di classe. Esso rientra piuttosto nel consueto “giro lungo” che l’antropologia non ha cessato di realizzare dalla sua nascita (e, anzi, ben prima della sua fondazione scientifico-disciplinare), nell’ambito del quale essa individua le differenze per istituire somiglianze, solidarietà, connessioni, terreni di muta e reciproca comprensione. Come afferma Michael Jackson in un importante lavoro di teoria antropologica, tale opera non può compiersi senza l’impegno a
«esplorare empiricamente l’esperienza vissuta delle persone reali nelle situazioni quotidiane prima di avventurarsi in suggestioni inerenti a cosa gli esseri umani abbiano in comune, indipendentemente dalle circostanze personale, culturali o religiose. Come afferma Veena Das, il nostro obiettivo “non è una specie di ascesa nel trascendente ma una discesa nella vita quotidiana” […]» (2013: 9).
Oltre a suscitare valide e vivissime questioni di carattere ermeneutico e metodologico, l’etnografia come impresa idiosincratica dell’antropologo/a (da cui “l’essere stato là” di matrice geertziana) costituisce anche uno snodo esistenziale che chi ha condotto ricerca sul campo non può dimenticare o trascurare. Per questo motivo, non è raro che gli antropologi e le antropologhe sviluppino col passare del tempo delle riflessioni attinenti al rapporto tra se stessi/e e il proprio oggetto di studio. Questi approcci autobiografici aiutano a capire perché e come lo/a studioso/a si sia ritrovato a (pre)scegliere quell’oggetto di ricerca, a concentrarsi su una particolare sfumatura, su particolari categorie di attori sul campo e non su di altre.
L’etnografia e l’esperienza del ‘campo’ producono uno straniamento più o meno permanente nello/a studioso/a. Una dislocazione intellettuale, emotiva e perfino sensoriale; una destabilizzazione profonda che studiosi e studiose inevitabilmente provano nelle loro esperienze di ricerca. Se considerare la propria visione del mondo depositaria di una legittimità che affonda le radici nella natura, nel mito, nell’ordine ‘normale’ delle cose e nel ‘buon senso’ appare un orientamento più che diffuso a ogni latitudine, è vero al contrario che poco rappresentata è la tendenza opposta, ovvero lo sforzo di sottoporre a verifica i propri più intimi convincimenti obbligandosi a un allontanamento da sé che possa schiudere opportunità euristiche di comprensione dell’‘altro’.
Ora, indipendentemente dal successo o dall’insuccesso di questa operazione, l’etnografia è circondata da un alone di incertezza, pur nella straordinaria ricchezza epistemologica e nella fecondità delle opportunità politiche che pone (ad esempio, considerare ‘scienza’ un discorso che attinge alla parola o alle pratiche delle classi che storicamente dispongono di pochi mezzi per far levare la propria voce e renderla udibile).
Per questo motivo, è assolutamente comprensibile che fare etnografia porti l’etnografo/a a sviluppare non solo una forte intimità sociale ma anche sentimenti di profonda gratitudine nei confronti delle persone e dei contesti con cui entra in contatto e grazie ai quali produce il proprio sapere (oltre che maturare un certo avanzamento nella propria carriera accademica o professionale). Da ciò deriva l’impostazione tendenzialmente legittimista con cui antropologi e antropologhe finiscono con il promuovere forme di difesa, supporto e rappresentanza anche politico-istituzionale dei gruppi sociali con i quali hanno interagito nelle loro ricerche, specie quanto questi corrispondono a categorie subalterne, vulnerabili e marginali, in ogni parte del mondo. Senza ricordare l’ambiguo e complesso posizionamento dell’antropologia “classica” rispetto al suo oggetto di studio, è emblematico a tal proposito l’impegno degli antropologi e delle antropologhe nei confronti dei gruppi indigeni che, specie in America Latina ma non solo, fanno i conti con una violenza neo-colonialista e capitalista agita da più fronti. Lo stesso potrebbe dirsi per le ricerche-azione e l’attivismo di studiosi e studiose che negli ultimi anni hanno studiato i processi migratori dalla lente della violenza strutturale, delle necro-politiche, del potere della burocrazia e delle istituzioni di istituire e ratificare esclusione e marginalità sociali.
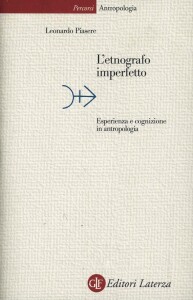 Anche quando non sfocia in un posizionamento militante, il conforto che ‘gli informatori’ (per ricorrere al linguaggio naïf dell’antropologia d’un tempo) forniscono alla ricerca e a chi la esegue, assurgendo a punti di riferimento imprescindibili sul terreno all’interno di una relazione complessa nella quale non è raro che si attivino processi di transfert e contro-transfert (Crapanzano 1980; Devereux 2012; Piasere 2002), può più semplicemente assumere i contorni di un’empatia in virtù della quale l’antropologo/a sovrappone la propria traiettoria biografico/esistenziale (oltre che professionale) a quella delle persone che ha incontrato sul campo. Non è raro che nell’etnografia si vengano a creare relazioni che potremmo definire di amicizia, benché convenire su quanto questo sentimento sia effettivamente reciprocato e disinteressato richiederebbe una dose di realismo che, traslato su un più serio terreno epistemologico, non può non evocare la “finzione di comunità” che l’antropologo/a sul terreno imbastisce con i suoi interlocutori.
Anche quando non sfocia in un posizionamento militante, il conforto che ‘gli informatori’ (per ricorrere al linguaggio naïf dell’antropologia d’un tempo) forniscono alla ricerca e a chi la esegue, assurgendo a punti di riferimento imprescindibili sul terreno all’interno di una relazione complessa nella quale non è raro che si attivino processi di transfert e contro-transfert (Crapanzano 1980; Devereux 2012; Piasere 2002), può più semplicemente assumere i contorni di un’empatia in virtù della quale l’antropologo/a sovrappone la propria traiettoria biografico/esistenziale (oltre che professionale) a quella delle persone che ha incontrato sul campo. Non è raro che nell’etnografia si vengano a creare relazioni che potremmo definire di amicizia, benché convenire su quanto questo sentimento sia effettivamente reciprocato e disinteressato richiederebbe una dose di realismo che, traslato su un più serio terreno epistemologico, non può non evocare la “finzione di comunità” che l’antropologo/a sul terreno imbastisce con i suoi interlocutori.
Tale orientamento empatico si sviluppa anche in relazione ai luoghi, ai contesti territoriali e geo-politici in cui si fa ricerca. Ciò è ancor più vero quando la ricerca etnografica si compie in quei siti che, nell’economia del sistema-mondo, possono essere definiti ‘periferici’ e che nella storia sono stati sussunti entro le maglie di colonialismo, sfruttamento predatorio di risorse (materie prime e manodopera), imperialismo, etero-direzione politico-economica affidata alle grandi organizzazioni internazionali (l’imposizione di piani di sviluppo, umanitarismo, controllo dei flussi migratori, ecc.). Ecco che, comprensibilmente, fare ricerca in tali contesti si traduce in una simpatia politicamente connotata.
Di ritorno dal ‘terreno’, l’antropologo/a compirà opere di sensibilizzazione prestando la sua voce in luogo di soggettività afone o, ancora meglio, aiuterà ad amplificare il punto di vista, le rivendicazioni, le richieste di aiuto, gli orientamenti polemici dei suoi interlocutori sul campo e della località/regione/Paese in cui ha condotto i suoi studi. È però possibile che questo rapporto venga se non incrinato quanto meno interrogato dalle possibili evoluzioni cui vanno incontro gli scenari politico-sociali dei contesti in cui l’antropologo/a ha operato. Colpi di stato, recrudescenze identitarie, ascesa al potere di fondamentalismi, curvatura autoritaria e xenofoba delle istituzioni, assunzione di posture politiche autoritarie. Si tratta di dinamiche che in ogni caso non andrebbero addebitate esclusivamente ai Paesi ‘ai margini’ in cui antropologi e antropologhe lavorano, dato che le relazioni di questi Stati con l’Occidente sono fitte e capaci di direzionarne gli orientamenti e le politiche. Cosa fa allora l’antropologo/a quando torna a casa e, dopo essere stato identificato – legittimamente o meno – come portavoce di una popolazione se non di un intero Paese, assiste a trasformazioni che interrogano modalità e termini di questa sovrapposizione?
 Dov’è finito il profumo dei gelsomini?
Dov’è finito il profumo dei gelsomini?
Ho iniziato a dedicarmi alla Tunisia nel 2014. Come nel migliore degli strabismi e degli sguardi incrociati che l’antropologia invita ad assumere e a rivolgere contemporaneamente a se stessi e agli altri, la prima volta mi focalizzai sulla mobilità attuata da alcune categorie socio-economiche dall’Italia alla Tunisia. Una mobilità “inversa” rispetto a quelle che immaginiamo essere le forme prevalenti e unidirezionali dei flussi intra-mediterranei. In questo caso, una mobilità nord-sud, agita da imprenditori e pensionati italiani.
Negli anni successivi avrei invece dedicato le mie energie a esplorare i mondi morali e culturali dei giovani tunisini delle classi medie in via di impoverimento nella fase post-rivoluzionaria (o post-Primavera Araba), al fine di comprenderne le inquietudini, i turbamenti, la convivenza di registri morali apparentemente contrastanti: desiderio di autonomia e affidamento a vincoli sociali e familiari; sogno di mobilità e solidità di riferimenti identitari territoriali; grammatiche del Sé improntate all’autorealizzazione e all’emancipazione personali e reviviscenze religiose influenzate da fondamentalismi contemporanei (Cordova 2022). Studiare la gioventù in una fase di transizione (come viene definita la ‘transizione democratica’ che dovrebbe – o avrebbe dovuto – accompagnare la Tunisia dalla Primavera araba al consolidamento di un quadro democratico saldo e pluralistico) invita a percepire questa confusa temporalità secondo la lente di una liminalità che vede coincidere da un lato le incertezze di una stagione politica, destinata a scivolare ogni giorno di più nei recessi di un autoritarismo ormai senza remore, e dall’altro, le vite in attesa di tanti giovani che, nonostante i percorsi di studio o di formazione, maturano progressivamente la consapevolezza che questa transizione politico-identitaria ed esistenziale sembra non risolversi secondo modalità consuete, attese e desiderate. In altri termini, il futuro sembra non essere più l’automatico canovaccio di una temporalità ordinata e prevedibile.
Il presente ci restituisce un’immagine ancora più tetra. Come le austere sembianze del presidente Kais Saïed, che nel giro di un paio di anni ha esautorato il parlamento, accentrato prerogative legislative ed esecutive, imposto una riforma costituzionale, messo fuori gioco i principali partiti e leader politici e rimesso il bavaglio a media e organizzazioni della società civile [2]. O come la tragica immobilità dei corpi di Dosso Fati e Marie, madre e figlia camerunensi, tragica trasfigurazione di Hagar e Ismaele nelle Sacre Scritture ma private di ogni benefica epifania divina, la cui immagine nel deserto tunisino ha denunciato con violenza il silenzio e l’ipocrisia che stanno accompagnando la gestione e le politiche internazionali del fenomeno migratorio.
I pogrom contro i ‘subsahariani’, categoria essenzialista e razzializzata che in nord Africa alimenta stereotipi e polarizzazioni identitarie mai sopite, hanno concentrato le attenzioni della cronaca di questa estate. Le tipizzazioni antropologiche che plasmano i profili di appartenenza ed estraneità nel Maghreb sono radicate in modelli culturali le cui genealogie dell’alterità rinviano alla storia e agli itinerari di popolazioni che hanno attraversato la vasta regione sahariana: commercio, confraternite religiose, schiavi – anche dopo la ratifica formale dell’abolizione della schiavitù. Non è un caso che la Libia sia tristemente diventata così centrale nella tratta degli esseri umani, così come Paesi del Sahel quale il Niger, ovviamente. Allo stesso modo non è casuale la centralità di Sfax, in Tunisia, nelle partenze cui assistiamo negli ultimi mesi, visto il suo ruolo storico di snodo carovaniero tra Sahara e Mediterraneo.
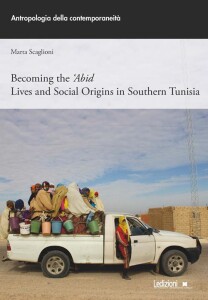 Pratiche e configurazioni politiche altre rispetto ai modelli della statualità occidentale precedono dinamiche geopolitiche quali la fine del regime del generale Gheddafi o l’instabilità della fascia saheliana. Essere “neri”, tratto fenotipico tutt’altro che inconsueto in un contesto storico di fluidità sociale e culturale, vede nel Maghreb l’assegnazione di uno statuto di persona differenziale, la cui inclusione nei modelli della ‘cittadinanza’ è ancora oggi un dato piuttosto provvisorio e non scontato, fortemente legato alla provenienza geografica, alla condizione sociale e professionale familiare, al prestigio assegnato all’ascendenza religiosa. La stratificazione culturale dei significati associati al ‘cittadino’ (baldî) e allo “straniero” (barrânî) è ampia e complessa. Rappresentazioni sociali e stigmatizzazioni e gerarchizzazioni politiche si sovrappongono fino a farsi indistinguibili. Nella storia moderna della Tunisia (dal XVII secolo) le memorie dell’origine (sociale, familiare, individuale) si legano a doppio filo a una gestione comunitaria e politica complessa e cangiante della valutazione accordata all’estraneità. Come ricorda Adbdelhamid Hénia (2015), subalternità, lignaggio e provenienza si fondono in una coalescenza semantica tale per cui, ad esempio, nella città di Sfax la parola gharîb, “straniero”, è impiegata anche per denominare e individuare le persone povere. È evidente, tra l’altro, che lo spettro semantico della “povertà” è qui molto più ampio della mera certificazione del patrimonio materiale, associandosi piuttosto a una più estesa declinazione di capitale sociale e simbolico.
Pratiche e configurazioni politiche altre rispetto ai modelli della statualità occidentale precedono dinamiche geopolitiche quali la fine del regime del generale Gheddafi o l’instabilità della fascia saheliana. Essere “neri”, tratto fenotipico tutt’altro che inconsueto in un contesto storico di fluidità sociale e culturale, vede nel Maghreb l’assegnazione di uno statuto di persona differenziale, la cui inclusione nei modelli della ‘cittadinanza’ è ancora oggi un dato piuttosto provvisorio e non scontato, fortemente legato alla provenienza geografica, alla condizione sociale e professionale familiare, al prestigio assegnato all’ascendenza religiosa. La stratificazione culturale dei significati associati al ‘cittadino’ (baldî) e allo “straniero” (barrânî) è ampia e complessa. Rappresentazioni sociali e stigmatizzazioni e gerarchizzazioni politiche si sovrappongono fino a farsi indistinguibili. Nella storia moderna della Tunisia (dal XVII secolo) le memorie dell’origine (sociale, familiare, individuale) si legano a doppio filo a una gestione comunitaria e politica complessa e cangiante della valutazione accordata all’estraneità. Come ricorda Adbdelhamid Hénia (2015), subalternità, lignaggio e provenienza si fondono in una coalescenza semantica tale per cui, ad esempio, nella città di Sfax la parola gharîb, “straniero”, è impiegata anche per denominare e individuare le persone povere. È evidente, tra l’altro, che lo spettro semantico della “povertà” è qui molto più ampio della mera certificazione del patrimonio materiale, associandosi piuttosto a una più estesa declinazione di capitale sociale e simbolico.
Bisognerebbe poi distinguere tra popolazioni originarie del Maghreb e della Tunisia stessa (i “neri” tunisini) e i migranti che dall’Africa Subsahariana si recano in Tunisia per varie ragioni: studio, lavoro e, solo marginalmente, maggiore prossimità all’Europa. La costruzione culturale del ‘diverso’ segue copioni diversi tra le due categorie, com’è facile immaginare. A un trattamento culturale ambivalente nel quale sono sussunti i ‘neri tunisini’ – specie nel sud del Paese (Scaglioni 2020) – corrisponde un’altra profilazione attivata, sia nel discorso popolare che tra le élites politiche – dei ‘nuovi’ neri.
In ogni caso, la profondità storico-antropologica delle categorizzazioni identitarie di inclusione ed esclusione non è sufficiente a spiegarci l’accelerazione e le modalità con cui la caccia ai migranti si è verificata in Tunisia nelle ultime settimane. Infatti, in continuità con una lunga tradizione di esternalizzazione delle frontiere e appalto delle politiche migratorie che vede l’Europa interagire senza scrupoli con Stati autoritari o che attuano azioni tutt’altro che rispettose dei diritti umani (basti pensare alla Libia), la caccia(ta) ha avuto avvio in Tunisia esattamente dopo la visita della premier Meloni nel Paese dei gelsomini. Non si tratta di una casualità. L’Europa chiede e promette; gli altri Paesi della sponda meridionale mediterranea devono eseguire, soprattutto se intendono avvalersi di linee di credito o di mediazioni privilegiate con istituti internazionali da cui dipende l’erogazione di finanziamenti (come il Fondo Monetario Internazionale).
Queste relazioni di dominio e subalternità incontrano solo parzialmente le resistenze di autocrati come il Presidente tunisino Saïed. I migranti subsahariani deportati in queste settimane nel deserto e che sono riusciti a sopravvivere sono stati presi in carico da organizzazioni umanitarie internazionali come l’OIM, le quali hanno potuto procedere con i processi di rimpatrio nei Paesi di provenienza. Del tutto comprensibile il desiderio di rimpatrio espresso da persone (donne e uomini con bambini al seguito) estromessi violentemente in pochi giorni da ogni configurazione possibile di domesticità, appaesamento, sicurezza. E, a proposito di sicurezza, missione compiuta per i governi mediterranei (delle sponde nord e sud) che senza alcuna remora hanno cacciato la polvere sotto il tappeto: i migranti sono tornati a casa loro, con il pretesto di disordini sociali e di minaccia alla sicurezza pubblica. Temi e registri discorsivi che riecheggiano con poche variazioni da una riva all’altra del nostro mare. Le parole di Meloni, Saïed e Minniti (l’ex ministro degli interni) si appigliano a repertori comuni: evocare il caos, costruire l’emergenza, seminare morte nel Mediterraneo.
Ritorno adesso, però, alla riflessione che voleva essere l’obiettivo di questo contributo e che invece è scivolata alle ultime righe. Se l’antropologo/a è un traduttore di culture, l’ermeneuta dei significati che gli esseri umani attribuiscono alle loro pratiche e alla loro vicenda storica, egli (o ella) può essere anche un traditore, esattamente come chi si cimenta nella mediazione linguistica. Questa constatazione non si limita alla possibile fallacia scientifica del lavoro antropologico: mal interpretare un proverbio; confondere un rapporto di parentela; equivocare sui nessi tra pratiche religiose; non cogliere la stratificazione storica di identità e rappresentazioni collettive; distorcere un vocabolo dall’ambigua referenza semantica. Il tradimento può essere morale e politico.
Parallelamente al mio lavoro sul campo, negli anni, ho incluso i temi confluiti nelle mie ricerche in un ambito di attivismo e di militanza. Le migrazioni; il controllo violento e scriteriato della mobilità; la categorizzazione selettiva che si abbatte sui maghrebini quando sbarcano sulle nostre coste, dal momento che quasi sempre si impedisce loro di presentare domanda di protezione internazionale; la superficialità delle letture politiche delle turbolenze verificatesi negli ultimi anni; l’insostenibilità di modelli turistici che non portano ricadute egualitarie ed estese alla popolazione; l’allarmismo con cui è stata legata la questione migratoria al fenomeno terroristico, soprattutto dopo il 2011; gli interessi economici e geopolitici che determinano le politiche mediterranee delle cancellerie europee, compresa quella italiana. Sono tanti gli spunti critici che sanciscono la presenza attiva dell’antropologo/a nella sfera pubblica. Spunti che poggiano, tuttavia, su sentimenti di gratitudine, di simpatia e di vicinanza – affetti declinati in senso politico – nei confronti della popolazione tunisina, a partire dagli interlocutori e dalle interlocutrici incontrati/e sul terreno.
Ecco, antropologi e antropologhe sanno benne che ricondurre i pochi ai molti non è che una delle trappole dell’essenzialismo. Eppure questo scivolamento metonimico avviene quasi sempre, anch’esso in quanto conseguenza delle proiezioni immaginarie e sentimentali che caratterizzano, al pari del metodo e del rigore scientifico, la ricerca sul campo. Dunque la gratitudine agli individui particolari che sono stati conosciuti durante la ricerca e il rapporto con i quali è tracimato in una relazione che potremmo definire di amicizia trascendono in una sovrapposizione complessiva e totale. Ci si sente quasi ‘familiari’ di persone aventi la nazionalità del Paese dal quale si è stati ospiti. Si sostiene la causa di un popolo, o perfino di una nazione o di uno Stato, benché gli orientamenti politici del ricercatore possano non essere tra i più allineati alla configurazione statuale e istituzionale della politica.
Nel caso specifico di chi scrive, ciò ha comportato sentirsi solidali, oltre che vicini, alle tante persone che solcano il mare per cercare un futuro diverso, alle persone (disoccupati/e, lavoratori e lavoratrici, giovani e adulti) che scontano infinite ristrettezze della vita materiale addebitabili alla miopia e all’avidità di politiche ciniche, così come alle realtà di lotta che negli anni non hanno mai smesso di impegnarsi, pagando un prezzo altissimo, per veder realizzate le istanze portate avanti nei processi confluiti nella Primavera araba. Ma questa corrispondenza (empatia o, termine che preferisco, solidarietà) non deve obbligatoriamente tramutarsi in un sostegno indiscriminato allo Stato e alle sue istituzioni, benché la confusione sia legittima e comprensibile allorquando si tratti di Stati posti “ai margini” degli scacchieri geopolitici internazionali.
Due episodi da richiamare per sommi capi. A un importante convegno di studiosi e studiose delle scienze sociali, alcuni anni fa, una mia collega che aveva compiuto ricerche in Marocco esibiva fieramente sulla sua camicia, all’altezza della clavicola, una spilla tonda su cui era disegnato il simbolo della bandiera marocchina. La Tunisia non aveva ancora imboccato quel percorso di parziale retromarcia che ha inaugurato un paio di anni fa e a quel Paese tutti persistevano a guardare con grande simpatia. Guardando quella spilla, mi chiedevo invece come fosse possibile indossarla se non applicando un’amnesia selettiva nei confronti di diversi misfatti perpetrati dalla monarchia marocchina: dalla censura interna alla repressione storicamente agita contro gli oppositori politici, passando per il controllo vetero-coloniale delle popolazioni abitanti i territori sahariani occidentali. Si può rivolgere la propria simpatia alle persone originarie del o residenti in Marocco senza automaticamente parteggiare per il regime monarchico che lo governa?
Secondo esempio, sulla Tunisia. Avere a cuore un territorio, un contesto che evoca suoni, profumi, storie e persone ai quali si è legati non può tradursi in un’indefinita e approssimativa operazione di promozione turistico/culturale. Confrontandomi con persone e agenzie che – più che legittimamente – promuovono la Tunisia, le sue località e il suo articolato patrimonio culturale in circuiti turistici o per l’erogazione di servizi rivolti a categorie che vi si stabiliscono per altre ragioni, ho capito che l’interesse della ricerca non coincide e non può che essere irrimediabilmente diverso da quelli di altri operatori e operatrici. A distinguerlo è quella vocazione critica che invece infastidisce questi ultimi, i quali possono ritenere che denunciare le criticità strutturali o transitorie di una fase politica possa essere inopportuno se tale postura critica rischia di esercitare un impatto negativo sui flussi turistici, sui viaggi, sulle percezioni che del Paese hanno potenziali e attuali utenti/clienti di servizi di varia natura. Insomma, «Da che parte stai?» potrebbe essere la domanda di avvertimento a quel ricercatore o quella ricercatrice che pone a se stesso/a e ad altre persone troppe perplessità, troppi problemi.
Ma la gratitudine non può divenire miopia, sebbene il rischio che ciò si verifichi è sempre alto quando si mobilitano sentimenti che alterano i contorni delle prospettive e delle visioni. Il disagio che l’etnografia procura si espande al seguito dell’esperienza di campo. Rientrato a casa, l’antropologo/a non solo riflette su ciò che ha visto, sentito, toccato, gustato, odorato e compiuto. Mette a distanza ciò che è stato per guardarlo da una nuova prospettiva, arricchita e arricchente. Oltre alla tensione critica con cui generalmente parteggia per chi/coloro con cui è stato in contatto, subentra anche il disagio. Cosa ho visto? Quali filtri hanno distorto la mia percezione? Sulla base di quale patto posso parlare in vece di altri? Ecco però che subentra il disagio di una seconda messa a distanza, anch’essa figlia – è bene ricordarlo – della medesima tensione critico-politica che anima ogni etnografia e ogni antropologia.
L’antropologo/a, si diceva, compie un “giro lungo” per tornare a se stesso e comprendere quel terreno comune di umanità che alimenta aspirazioni di eguaglianza pur nella diversità. Alcuni hanno utilizzato a tal proposito la formula della “critica culturale”, vero obiettivo dell’impresa etnografica (Marcus, Fisher 1998). Tornato a casa, l’irriducibilità si decompone, e nel gettare semi di reciprocità per la comprensione e l’azione reciproche, si capisce che gli attaccamenti che ci rendono esseri umani compartecipi del fluire storico non sono un ostacolo all’esercizio di quel lume della ragione critica senza il quale ogni opera intellettuale è destinata a restare flebile e incompiuta.
 E anzi, proprio in ragione di quelle sincere solidarietà sviluppate sul campo, il posizionamento non può e non deve ridursi alla semplice riproduzione di bandierine, confini, frontiere, fantasmi autoritari e narrazioni distopiche. “Essere stato là” significa partecipare di un progetto comune e condiviso che volge all’emancipazione delle persone. Anche quelle che vivono nei Paesi i cui abitanti sono stati così ospitali nei nostri confronti. Anzi, proprio per loro – dotati come siamo, noi, di maggiori libertà, mezzi e casse di risonanza – dobbiamo compiere quelle lotte che i nostri compagni e le nostre compagne di viaggio non possono condurre. Anche contro i loro (oltre che i nostri) Stati, dal momento che, recuperati allo sguardo un po’ naïf con cui guardiamo alle appartenenze e alle affiliazioni altrui, sappiamo che l’identificazione con lo Stato matura sempre in sentieri irti di cinismo, antipatia, diseguaglianze quando non di abusi di potere. In ogni parte del mondo. Cosa rappresenta per un tunisino o una tunisina uno Stato che nega possibilità di sviluppo? Che reprime, controlla, categorizza, sorveglia, disciplina – oltre che, certo, distillare dosi controllate di benevolenza paternalista? Basterebbe prestare più attenzione all’esperienza di vita dei soggetti che si incontrano sul terreno per coglierne una valutazione molto più disincantata del rapporto allo Stato e alle sue impalcature simboliche.
E anzi, proprio in ragione di quelle sincere solidarietà sviluppate sul campo, il posizionamento non può e non deve ridursi alla semplice riproduzione di bandierine, confini, frontiere, fantasmi autoritari e narrazioni distopiche. “Essere stato là” significa partecipare di un progetto comune e condiviso che volge all’emancipazione delle persone. Anche quelle che vivono nei Paesi i cui abitanti sono stati così ospitali nei nostri confronti. Anzi, proprio per loro – dotati come siamo, noi, di maggiori libertà, mezzi e casse di risonanza – dobbiamo compiere quelle lotte che i nostri compagni e le nostre compagne di viaggio non possono condurre. Anche contro i loro (oltre che i nostri) Stati, dal momento che, recuperati allo sguardo un po’ naïf con cui guardiamo alle appartenenze e alle affiliazioni altrui, sappiamo che l’identificazione con lo Stato matura sempre in sentieri irti di cinismo, antipatia, diseguaglianze quando non di abusi di potere. In ogni parte del mondo. Cosa rappresenta per un tunisino o una tunisina uno Stato che nega possibilità di sviluppo? Che reprime, controlla, categorizza, sorveglia, disciplina – oltre che, certo, distillare dosi controllate di benevolenza paternalista? Basterebbe prestare più attenzione all’esperienza di vita dei soggetti che si incontrano sul terreno per coglierne una valutazione molto più disincantata del rapporto allo Stato e alle sue impalcature simboliche.
La complessità politica e affettiva (oltre che epistemologica e metodologica) della ricerca sul campo determina proprio questa compresenza di motivi apparentemente inconciliabili. Percepirsi ‘dentro’ e ‘fuori’, locali e stranieri, perenni abitanti della soglia, mediatori tra mondi, solidali ma critici. Pronti a schierarsi anche quando questo comporta la possibilità di veder tramutato il proprio statuto in quello di ospiti ingrati. Fare etnografia non significa diventare promotori o promotrici di un prodotto o dell’idea-rappresentazione di una nazione, bensì dell’umanità che la abita e delle cause che vanno sostenute per realizzare forme progressive di giustizia ed eguaglianza.
Ne va della nostra coscienza ma soprattutto dell’ambiziosa possibilità di fondare una nuova solidarietà di rapporti umani sul nostro pianeta, come si augurava Ernesto de Martino (2002).
Dialoghi Mediterranei, n. 63, settembre 2023
Note
[1] In questo articolo provo per la prima volta ad applicare una modalità di scrittura che recepisca, senza imbarazzi per chi scrive, l’invito a una piena inclusività linguistica. Ho scelto di declinare i sostantivi e gli aggettivi per i quali avrei convenzionalmente dovuto utilizzare il ‘maschile universale’ flettendone le desinenze sia al maschile che al femminile. Mi rendo conto che questa opzione, già impiegata da diversi/e studiosi/e, possa appesantire e inficiare la scorrevolezza della lettura e chiedo pertanto a lettori e lettrici il beneficio di una benevola pazienza.
[2] Il tono inequivocabile con cui in questo contributo mi esprimo su Saïed non deve tuttavia far dimenticare quanto egli sia apprezzato da un’ampia porzione della popolazione tunisina. Né possono essere sottovalutate alcune letture, provenienti da osservatori e studiosi tunisini, nelle quali si afferma – e non senza ragione – che l’autoritarismo del presidente riconosce “dall’alto” e si nutre, in modo forse strumentale, anche di aspirazioni e registri che erano parte delle rivendicazioni espresse dal movimento rivoluzionario (cf. https://www.middleeasteye.net/fr/opinion-fr/tunisie-referendum-constitution-kais-saied-transition-democratie).
Riferimenti bibliografici
Cordova G., 2022, Karim e gli altri. La gioventù tunisina dopo la Primavera, Torino, Rosenberg & Sellier.
Crapanzano V., 2000, Tuhami. Ritratto di un uomo del Marocco, Sesto San Giovanni, Meltemi.
de Martino E., 2002 (1977), La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, Torino, Einaudi.
Devereux G., 2012 (1967), De l’angoisse à la méthode, Paris, Flammarion.
Hénia A., 2015, Mémoires d’origine et gestion communautaire de l’intégration en Tunisie (XVIIe-XIXe siècles), “EtnoAntropologia”, 3(1): 73–88. https://doi.org/10.1473/181
Jackson M., 2013, Life Worlds. Essays in Existential Anhtropology, Chicago, The University of Chicago Press.
Marcus G.E., Fisher M.J., 1998 (1986), Antropologia come critica culturale, Roma, Meltemi.
Oliver de Sardan J.-P., 2004, La riguer du qualitatif. L’anthropologie comme science empirique, “EspacesTemps”, 84-85-86: 38-50.
Piasere L., 2002, L’etnografo imperfetto, Roma-Bari, Laterza.
Scaglioni M., 2020, Becoming the ‘Abid. Lives and Social Origins in Southern Tunisia, Milano, Ledizioni.
_____________________________________________________________
Giovanni Cordova, ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia, Antropologia, Religioni (curriculum etno-antropologico) presso l’Università ‘Sapienza’ di Roma. Ha preso parte a progetti di ricerca inerenti al Nord Africa (Tunisia, Libia) e alle migrazioni internazionali. Attualmente è docente a contratto di antropologia culturale presso l’Università Federico II di Napoli e assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Catania, dove conduce uno studio sulla ritualità religiosa delle comunità di origine asiatica residenti in Sicilia. Ha recentemente pubblicato per le edizioni Rosenberg&Sellier il volume Karim e gli altri. La gioventù tunisina dopo la Primavera.
______________________________________________________________