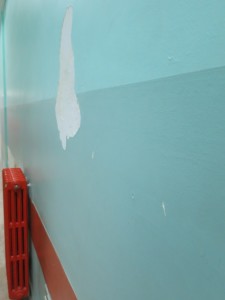Nemmeno il tempo di aprire la portiera – per aiutare mia madre a uscire dall’auto – che si presenta, proiettato dal vuoto, un signore in nero; lui si avvicina dal nulla (con il quale si confondeva, secondo la mia percezione annebbiata dal mio scatto verso l’auto) e mi dice che posso stare lì per non più di quindici minuti. Basteranno, ribadisco. Lui non mi ascolta nemmeno, continua a parlare con la voce e con il corpo; io annuisco, pensando ad altro, immaginando di essere spettatore di un film, in qualche modo già esperito. Lui parla e io fingo di ascoltare, mentre mi sovviene che, per arrivare a un Pronto Soccorso (intendo alla sala dove il medico si fa finalmente carico del paziente), si devono superare diverse frontiere – simboliche e materiali, più o meno visibili, più o meno ostentate, alcune autorizzate altre meno – che costituiscono dei veri e propri micro-rituali di passaggio ai quali rispondono, da parte dell’‘autorità’, simmetrici riti di istituzione e delega di potere al passaggio. Se riti di passaggio si confrontano con riti d’istituzione, chi avrà la meglio? Se devo ‘passare’, qualcuno dovrà pure ‘autorizzarmi’ a farlo, istituendo il da farsi, prima e durante il transito, regolando il flusso delle azioni da compiere, così come i programmi da realizzare.
Il punto è: prevale il passaggio del soggetto o l’istituzione che ne legittima l’azione rituale? Una cosa è certa. In un pronto soccorso, il flusso delle azioni è strettamente regolato, autorizzato. Anzi, di più, si potrebbe dire che l’idea stessa di flusso è inconcepibile in un pronto soccorso dove tutto deve essere regolato, visto per segmenti discretizzati, chiaramente comunicati. È soltanto un’ipotesi, per ora, che mi viene in mente mentre varco una soglia che mi (tras)porta in uno stato di marginalità simbolica: una proposta per conciliare le opposte prospettive di Van Gennep (Van Gennep 1981) e Bourdieu (Bourdieu 1982) e smussare nel frattempo la rigidità delle frontiere che mi accingo ad affrontare contestualmente, pensandole in situazione, dal vivo, con un’‘attitudine’ deleuziana. Pensandole, cioè, mentre ci sono, agisco e attendo nel divenire dell’azione. Questo è senz’altro un modo per prendere sul serio anche l’invito di Wittgenstein a non farsi prendere dall’astrazione del senso, proiettandosi nella situazione al fine di ricavarne rapporti significativi: «Un’attesa è adagiata in una situazione, dalla quale scaturisce» (Wittgenstein 1967: 201). E io mi ci adagio, nella situazione, per trarne tutte le conseguenze possibili, per valutarne gli aspetti metalinguistici, per rimestare le forme di enunciazione in uso (Montes 2005; Montes 2005-2006). Mi ci adagio anche per ricavarne un guadagno conoscitivo a partire dalla perdita certa di tempo consumato nell’attesa.
Il tempo si consuma, ma dove va? È una metafora, ovviamente, ma va presa nella giusta considerazione in quanto implicita categorizzazione dell’esistenza. Da antropologi, ci si può investire persino nel quotidiano – talvolta interrotto come adesso dall’irrompere dell’incidente – e trasformare lo scorrere del ‘tempo in perdita’ in forme di osservazione-partecipante (Montes 2009). E, visto che ci siamo, a proposito di frontiere e temporalità, l’uomo in nero dall’eloquio vivace nella mia immaginazione farebbe parte di questo insieme variegato che costituisce il sistema ‘pronto soccorso’: tutto vestito in nero, richiama in modo ineludibile su di sé l’attenzione – non soltanto quella mia – e può, per questo, essere considerato una sorta di soglia in carne e ossa con cui confrontarsi prima di passare alla ricezione del pronto soccorso dove i responsabili dovrebbero richiedere i dati dei pazienti e fare qualche domanda sul male che li affligge. Il tutto trascritto in un foglio – uno stampato riepilogativo, freddo resoconto dell’accaduto in termini di sintomi – che si darà al medico, dopo le varie transizioni, dopo le attese e le simmetriche aspettative deluse o colmate: per conservare traccia dell’accaduto, ma, anche, perché, qualsiasi esperienza – al fine di essere veicolata e comunicata – abbisogna di una codificazione e testualizzazione.
Esperienza e testo si accompagnano. Il ‘medico’ rappresenta naturalmente la fase finale, terminativa dei passaggi pianificati: ciò verso cui tutti i pazienti tendono (l’attesa è anche una tensione verso qualcosa e non pura inattività), così come la figura della soddisfazione (di esserci arrivati dopo tante attese accumulate e rimandate) e dell’ appagamento di ritorno (risultante dall’ essere diventati oggetti di cura, ricompensati delle attese protratte, differite). L’uomo in nero, da parte sua, fa il lavoro quotidiano per il quale è pagato: in attesa delle auto, comunica un interdetto agli autisti, smista il traffico davanti l’entrata principale del pronto soccorso, evita insomma ingorghi, mantiene l’accesso libero in modo da facilitare lo stazionamento e il transito di qualche paziente grave la cui priorità è innegabile. Io, invece, non penso altro che a quello: entrare dentro, parlare con il medico, capire cosa deve fare mia madre. L’ordine può cambiare ma la sostanza è quella: più che un valore sintagmatico, nella mia testa in fuga, queste azioni (entrare, parlare, capire) hanno valore paradigmatico potenzialmente realizzato in uno stesso atto sincronico. Come in una poesia, alla stessa stregua, direi, benché l’efficacia è d’un diverso livello: saltare a piè pari l’attesa e risolvere l’imprevisto accaduto a mia madre. Lui, l’uomo in nero, assolve all’obbligo della comunicazione orale (che in questo caso ha anche la forza illocutoria e l’efficacia dell’autorità); io mi adeguo come posso (capisco che il suo ‘dire’ sostituisce l’inefficienza di un segnale scritto che sarebbe, in questo contesto, altamente liminale, ignorato). Gli aspetti cognitivi, nella versione orale o scritta, non sono un contorno secondario del sistema ‘pronto soccorso’, ma fanno parte integrante del dispositivo di transito e del posizionamento delle diverse frontiere. Io, sul momento, do però per scontato, intuitivamente, il fatto che il passaggio debba rimanere libero per le altre vetture che arrivano. Passaggio? L’ipotesi iniziale, passaggio o transito che sia, incomincia sempre più a divenire un’idea precisa – precisata dal contesto, convalidata dall’esperienza in corso – che coinvolge anche la dimensione temporale del vissuto in forma di ossimoro. È retorica la questione? Vediamo un po’.
Per arrivare alla fase finale di un pronto soccorso si devono superare varie barriere quando invece la fretta di arrivare al punto e farsi medicare vorrebbe il contrario: il pronto soccorso, cioè, come luogo dove si arriva, si è subito ricevuti, presi in carico, curati con diligenza. Non se ne parla nemmeno! Si deve prima aspettare chi viene prima, ovviamente; si devono superare tutte le barriere previste, naturalmente; si deve assaporare il brivido contenuto della pazienza, certamente. Il fatto eccezionale è che il sentimento d’urgenza (di chi arriva con un problema da risolvere rapidamente) e il senso dell’attesa (di chi aspetta in sala annegato in tempi morti) si scontrano provocando una strana sensazione interiore, straniante: in sostanza, come dicevo poco prima, ossimorica e quindi retorica. (Com’è noto, le figure retoriche non fanno soltanto capolino nei testi letterari, ma, anche, nella vita, dandole un senso o un altro, richiamando i modi della cultura, il suo essere insieme di tratti discreti in fuga verso il ‘continuo’ da riarticolare).
Accompagno dunque mia madre verso la ricezione tenendo a mente che devo affrettarmi, uscire per andare a parcheggiare l’auto, in modo da non creare intralcio. All’entrata, proprio alla mia destra, c’è un lungo bancone bianco. Una persona, da dietro, mi fa cenno di passare: io, per primo, gli avevo lanciato uno sguardo interrogativo come fosse un grido di allerta, indicando al contempo le mani fasciate di mia madre; lui, a sua volta, mi aveva risposto con questo suo breve e fugace movimento laterale della testa che voleva essere un’indicazione di direzione, oltre che un’autorizzazione a passare. Indicazione di direzione e segno di assenso. Insieme in un solo gesto. Senza pensarci più. Nemmeno un istante. Un gesto automatico. Lo è eccome. Lui è abituato alla fretta degli altri. Sa bene che si deve adeguare alla comunicazione. Non si parla, infatti, qui si comunica a gesti: efficaci e rapidi, quelli di chi sa che non ci si può perdere in dettagli. Si mira al sodo, tanto ci saranno tante altre attese, altre verifiche, altre forme di comunicazione diretta e indiretta, prima di arrivare dal medico: alla verifica, al finale di partita, come direbbe Beckett.
Intanto, devo ammettere che i gesti sono anch’essi – in molti casi – componenti adeguate di un linguaggio vero e proprio, autonomo e codificato, comparabile a una lingua in sé quale l’italiano o altro. E non è poco. E non è tutto. E la domanda è: qual è il linguaggio del ‘sistema pronto soccorso’? In che modo la segmentazione delle frontiere spaziali e temporali contribuisce alla sua specificità? Per rispondere, rituffiamoci nel processo, lasciando parlare la consecuzione degli eventi in divenire ritagliati per ordini di frontiere e attese. Appena superato questo ulteriore sbarramento, nella prima sala mi si para innanzi un altro signore in nero, in uniforme mi sembra (non ho il tempo di guardarlo bene e penso che sia anche lui della ‘sicurezza’), mi indica la direzione da seguire. Devo andare alla mia sinistra. Gli chiedo se c’è modo di sapere quando entrare e mi risponde che devo aspettare. Per il turno, mi dice, è semplice: “voi venite dopo questo ragazzo”. Posso allora fare la fila ‘a occhio’: significa però che non posso distrarmi; significa pure che non posso mettermi a leggere il libro che, come sempre, mi ero portato dietro per ogni evenienza; significa inoltre che non ho modo di ingannare l’attesa. Significa, significa, significa! Come scrive Barthes, abbiamo tutti – persino nei momenti meno strani della vita – la passione «costante (e illusoria) di apporre su ogni fatto, anche il più minuto […] la domanda del senso, come se tutte le cose fremessero di senso: cosa vuol dire? Bisogna ad ogni costo trasformare il fatto in idea, in descrizione, in interpretazione» (Barthes 1980: 171). Voglio anch’io, al pronto soccorso, interpretare e tradurre in altri termini un concetto, rimandando ad altre accezioni, magari decontestualizzate? Non proprio. Chiedermi adesso il significato di situazioni – per me, individuo che accompagna d’urgenza una paziente da un medico, tra altri pazienti sofferenti e in cerca d’aiuto – rappresenta un modo per riportare il trambusto dell’esperienza vissuta a un ordine pratico dell’agire; significa sapere cosa fare in un certo ordine; significa porsi in relazione con gli altri individui che aspettano anche loro il turno già da molto e sembrano rassegnati all’andazzo, pronti tuttavia a ribellarsi di fronte alla furberia di qualcuno.
‘Chiedersi il perché’, in alcuni casi, più che rimandare all’intenzione di arrivare a un singolo significato fa parte degli ampi processi di socializzazione dell’esperienza vissuta di un soggetto tra altri soggetti, dei modi di aggiustamento del suo pensare e agire alle interazioni di altri individui. Se mi chiedo dunque il perché di qualcosa non è soltanto per interpretare, ma per stare in mezzo agli altri adeguatamente, da essere sociale. Cosa significa concretamente fare la coda in un pronto soccorso? A quali atti specifici corrisponde la richiesta di cura e presa in carico medica? È quello che mi chiedo, in questo istante, nell’atto di attendere. Me lo chiedo e lo vivo al contempo senza chiedere tempo al tempo, nella contingenza. Strategicamente: nel senso che questo modo di procedere può diventare una strategia di ricerca, un modo per interrogare la realtà, esplicitando i presupposti di implicita soggettività e partito preso prospettico di un individuo in azione. E così è: per approssimazioni di esplicitazioni.
Accanto a noi c’è un ragazzo che, lui, ha l’aria di attendere da tanto. Io sono appena arrivato e non so cosa fare. In un pronto soccorso si ha l’impressione che il tempo sia ridondante: se ne ha così tanto, di tempo, che ci si sente strani, fuori luogo, rispetto alla vita ordinaria in cui esso sembra venire meno. Lui, il ragazzo, passeggia nervosamente, non vede l’ora di entrare. Di fatto, non vede altro, non pensa ad altro. Non pensa al tempo e all’attesa, alle frontiere e ai riti di passaggio. È nell’atto. Assorto. Passeggia su e giù, si piazza poi davanti la porta. Fa sempre lo stesso movimento, lo stesso percorso, lo stesso ritmo. In modo monotono. Azzerando il novero delle possibilità, il ragazzo si “esaurisce esaurendo il possibile”, continuando a finire un atto che sembra, ai miei occhi, non finire mai (Deleuze 2015: 16): nella speranza che la porta si apra. Lui è nell’atto e io nell’attesa? Io, tra una riflessione e un sospiro di rassegnazione, ho il tempo di gettare un’occhiata al cartello sulla porta: c’è scritto “triage” (dal francese, ‘selezione’ o ‘smistamento’, e questa è probabilmente la ragione per cui avranno preferito il termine francese, meno comprensibile, meno sgradevole dell’equivalente in italiano). D’altronde, nessuno vorrebbe pensarsi come individuo-desoggettivato di una selezione, per il motivo stesso di essere in un pronto soccorso dove invece il vaglio della situazione si presuppone celere e indistinto, non valutativo, non sottoposto alle molteplici anticamere di altrettante frustranti attese. Meglio non tradurre allora, meglio rimanere nel vago, meglio lasciare intendere che chi aspetta ha ancora una parvenza di soggettività densa, non incrinata.
Subito dopo – non so perché – do un’occhiata ai posti a sedere che presumo liberi. Niente da fare, sono tutti occupati: nessuno vorrebbe, d’altronde, aspettare in piedi. Non si richiede nessuna azione specifica al pronto soccorso, tanto vale sedersi e rassegnarsi all’attesa. Io mi rassegno, non mi indispongo. Dico a mia madre di stare comunque accanto a me per tenerla d’occhio: mi sembra smarrita. Lo sono anch’io. Mentre cerco di capire un po’ meglio cosa fare e dare un ordine alle mie azioni, il mio sguardo si posa automaticamente sul cartello affisso alla porta: “porta chiusa, non bussare, non aprire”. A chiare lettere. Cubitali. La frontiera è giustificata, sembrerebbe. Anche questa è una sorta di prima frontiera, invalicabile ma ambigua, che si presta alla confusione, all’ansia di chi vuol ricevere subito informazioni: un avviso mette allora in guardia su cosa fare. La denotazione è che non si può superare la soglia senza autorizzazione, si deve essere pazienti (non per niente il malato viene etichettato come ‘paziente’, cioè come colui che sopporta di buon grado disagi e difficoltà). Non si possono chiedere informazioni, non si deve disturbare, punto. Basta. Non c’è niente da fare, si deve soltanto aspettare. Ma qual è la connotazione, oltre il senso denotato? La connotazione rimanda al fatto che ‘qualcuno ha l’autorità’ (di far attendere), la comunica ad altri che, con ciò, sono posti in situazione di controllo, di subordinazione ‘politica’ dell’altrui volere: insomma, ancora, si deve aspettare buoni buoni. La mia mente va automaticamente a Barthes. Benché faccia riferimento al discorso amoroso, l’osservazione di Barthes vale anche in altri campi: «Fare aspettare: prerogativa costante di qualsiasi potere, passatempo millenario dell’umanità». (Barthes 1979: 42). L’avviso affisso sulla porta potrebbe sembrare ridondante, ma è necessario che lo sia, in questa situazione, per essere chiari con il pubblico e scoraggiare chiunque volesse entrare comunque, magari facendo finta di non capire, per accelerare la procedura, distraendo lo svolgimento dei compiti all’interno della stanza. Vorrebbe dire: “qui si lavora, non ci si può perdere in chiacchiere”. Ma le traduzioni, anche quelle intralinguistiche, possono essere poco gradite, possono essere mal comprese. Meglio quindi adottare una formula che metta l’accento sull’efficacia del messaggio.
Nel sistema ‘pronto soccorso’, non è possibile privilegiare l’obliquità, il messaggio bello o poetico: tutto deve essere chiaro e il messaggio deve essere diretto, referenziale. Le informazioni, d’altronde, si possono chiedere agli altri pazienti e ai loro accompagnatori e servono pure a far passare il tempo: per farlo scorrere senza gravità. Non tutto il male vien per nuocere allora. Infatti, ciò provoca – senza intenzione da parte dell’amministrazione – una socializzazione in qualche modo ‘costretta’, benché positiva, tra coloro i quali si trovano in sala e si scambiano notizie, aneddoti, storie e resoconti di un passato vicino e lontano. Tutti si sentono chiamati in causa dalla discussione, tutti hanno la loro da dire, tutti hanno un dolore da condividere e smussare parlandone, rivendicandolo. Tra una frontiera e l’altra, si parla, si condividono malesseri, si mettono in relazione cause (“sono caduto accidentalmente”) ed effetti (“mi sono rotto il piede, spero non sia grave”): si socializza, per dirla in breve, si fa pure amicizia talora, si scambiano persino i numeri di cellulare talvolta. Se non si parla, si scambiano sguardi eloquenti: di rassegnazione, di fatalismo esasperato, di rabbia incontrollata. La comprensione solidale regna.
Tra riti di passaggio e riti d’istituzione se ne mettono dunque in opera altri che definirei così: riti di necessaria socializzazione. Tra Van Gennep (riti di passaggio) e Bourdieu (riti d’istituzione) c’è perciò altro: i riti di necessaria socializzazione. (E insisto sul ‘necessario’!) Si apre, in questo senso, sulla base della mia esperienza vissuta, una questione da esplorare nella sua ampiezza, nei diversi contesti della vita quotidiana: in che modo si mettono in ‘forza’ i riti di socializzazione nei diversi contesti d’uso e quali regimi di comunicazione si instaurano nei riti di passaggio e d’istituzione di cui sono un contrappunto necessario, immancabile? Io rifletto su tutto questo molto tranquillamente, come se fossi sul punto di scrivere un saggio, poco rispettoso delle convenzioni scientifiche, mentre il mio sguardo – sempre lui – è invece irrequieto, tanto irrequieto che «All’improvviso, senza avvertimento, il presente si presenta alla coscienza» (Poulet 1987: 61). Sono le parole che Poulet usava per la poesia e la concezione della vita di Char.
La poesia? Qui e adesso? In una sala d’attesa? Può stupire. Niente potrebbe essere più lontano dalla atmosfera di un pronto soccorso. Niente potrebbe essere ipoteticamente più alieno al risveglio della mia viva coscienza adesso. Eppure, al di là dei parallelismi fonetici, mi vengono in mente queste parole – il loro vivo senso e assenso – dal niente imbiancato di grigio: parole che cristallizzano questa strana sensazione di presenza che sento dentro e nell’aria spenta della sala d’attesa; parole che parlano al cuore e vanno dritto al significato dell’esserci. Poulet parlava di Char, del suo modo di essere poeta, del suo modo di vedere Van Gogh: le cose accadono e il soggetto le vede accadere nella loro precipitazione, da vicino, nell’imminenza, nello stesso darsi del pensiero nell’azione. È una difesa della prossimità, presumo. È un elogio dell’intreccio stretto del pensiero con l’azione, ritengo. Nella poesia di Char, secondo Poulet, il presente non si fa aspettare: si presenta nei paraggi dell’accadere. A partire da questi ricordi, incomincia nella mia mente un circolo di rimandi a Char che trova il suo climax in un suo verso: «L’imprecisione del tempo, anch’essa, ha bisogno di essere vissuta. Come il sedimentarsi della parola» (Char 1987: 13).
I tempi d’attesa sono inclini ai flussi di pensiero, al divagare della mente senza scopo. Divago. Rifletto: saranno nel mio caso sicuramente gli effetti della stanchezza che producono un allentamento del controllo di me stesso e una irruzione più fluida del tempo. Non svio. Rimugino: nell’attesa, il tempo diventa impreciso e io mi costringo – prendendo appunti – a viverlo da vicino, nell’immediatezza della prossimità. Il presente si presenta allora con tutte le sue stranezze nel vivo dell’esperienza, memore della poesia, dimentico di alcuni grigi elementi contestuali. E, mentre rifletto e rimugino, divago e mi trattengo, lo sguardo non si dà pace. Lo sguardo non si contiene. Va nuovamente alle due file di posti della saletta: sono tutti occupati. Una persona è addirittura distesa, dorme, e ne occupa almeno tre. Nessuno gli dice niente, nessuno solleva obiezioni alla sua presunta sregolatezza. D’altronde, non c’è nessun cartello che lo vieti esplicitamente. E suppongo che ciò avvenga comunemente in un pronto soccorso: qualcuno sta male e si allunga sui sedili, in mancanza d’altro. Le regole d’ordine sociale (“non si occupano tanti sedili arbitrariamente”) in uso in altri contesti di vita, qui si smussano alle prese con le regole d’ordine morale (“in compresenza, la sofferenza e il male destano l’indulgenza e la comprensione degli altri”). L’importante è non dare fastidio a chi lavora, oltre la porta chiusa, agli infermieri e ai medici: al di qua invece, in questo spazio di attesa imposta e necessaria, è pure possibile rompere le regole e qualcos’altro. Di posti, ce ne sono pochi, è vero. E non è comunque comodo – medito – allungarsi su tre sedili in plastica con curvature diverse che tentano di infilzarti da tutte le parti. Lui non è un fachiro. È un paziente come gli altri, ma forse soffre di più e non si ‘cura’ – in attesa che qualcuno si ‘prenda cura’ di lui – di ciò che sarebbe conveniente fare. La posizione assunta attrae sguardi e considerazioni: ha le braccia sul volto e i gomiti stranamente posti verso l’alto, forse nel tentativo di schermare la fastidiosa luce al neon che cerca, nonostante tutto, di colpirlo al viso. I muscoli in tensione delle braccia non infastidiscono il suo torpore? Perché mai tiene i gomiti così in alto? Potrebbe essere una forma di resistenza di cui il corpo stesso si fa carico in prima istanza. Lui è immobile, non fa una mossa, né una minima grinza: perché – si potrebbe affermare, così io sento – tutto il corpo è un’enorme grinza, la dimostrazione (per me, ovviamente, nello svolgersi del mio processo in corso, in lite con l’immagine statica del paziente) che l’‘essere’ non può che ‘esserci’ in una postura particolare che tende a trasgredire tutte le altre che l’hanno preceduta.
A guardarlo bene, sembra una statua. Una statua di sale, mi viene di pensare, fuori luogo e fuori tema certamente, andando con la mente al bel romanzo autobiografico di Memmi in cui l’autore racconta la sua giovinezza in Africa, la sua vita da adulto complicata dalle esclusioni coloniali, e la fuga verso l’America considerata il nuovo mondo e dove una nuova vita è probabilmente possibile. Che c’entrerebbe in questo momento, con me, in un sordido, freddo pronto soccorso? Che cosa ha a che vedere con il colonialismo francese? Più che l’idea di statua, si tratta qui d’altro, suppongo, andando indietro nel tempo, all’intrigo del romanzo. Il personaggio principale non è un ‘vero’ francese, ma nemmeno un ‘vero’ algerino: semmai sarebbe un ebreo con – per di più – una madre berbera. La sua collocazione identitaria è confusa, non riconosciuta dallo sguardo del suo prossimo e il suo senso di appartenenza è incerto. I francesi di Vichy inoltre lo consegnano – se ricordo bene – ai tedeschi proprio perché è ebreo mentre la Francia libera, nonostante lui si offra di combattere in sua difesa, non lo accetta per la sua origine. Paradossalmente, accettare d’essere ebreo (e avere così una identità non critica) non gli è nemmeno possibile poiché queste tradizioni sono a lui aliene e gli sembrano imposte.
Ecco, di ricordo in ricordo, mi è venuto in mente il perché di questo romanzo, il possibile collegamento tra me e Memmi: il personaggio principale si trova su più di una frontiera allo stesso tempo, tra due civiltà, due religioni, due lingue, due nazioni, due vite. In sé, sarebbe tutto molto positivo, se solo lui fosse accettato e riconosciuto dallo sguardo dell’altro che, invece, viene a mancare e sgretola il suo senso di identità. E io mi sento, anch’io, al pronto soccorso, nel mio piccolo, in attesa su una frontiera da superare: una frontiera da superare dopo l’altra. Io mi sento preso nel bel mezzo di due particelle discorsive qui molto significative: il ‘tra’ e il ‘dopo’. Mi dibatto ‘tra’ una frontiera e quella che viene subito ‘dopo’. Mi dibatto senza accettazione della situazione, in attesa che ci chiamino dalla ricezione. L’uomo-fachiro sdraiato – mi viene in mente adesso – è anch’egli su una frontiera, benché materiale. Anzi, occupando lo spazio di più sedie, trasgredisce pure la frontiera materiale assegnata a una sola sedia e la ricodifica semioticamente nel suo specifico modo indisciplinato di attendere: quella che gli detta il dolore e la stanchezza o la resistenza e la trasgressione alle regole imposte e non accettate. Se fosse in piedi, con le mani riverse all’indietro che toccano la fronte sarebbe un’inequivocabile posa di sofferenza, forse pure di disperazione. Da sdraiato, non so cosa pensare sinceramente! Vorrei che fosse l’ostentazione di un anarchismo trasgressivo che rifiuta la pochezza di un ordine dettato dalla ragione ristretta, dall’istituzione di una differenza «tra coloro i quali devono attenersi al rito e coloro i quali non devono farlo» perché sono i latori di un potere di istituzione del rito stesso (Bourdieu 1982: 58). Coloro i quali non devono farlo sono proprio i garanti delle regole (le persone della sicurezza, l’usciere, l’infermiera, il medico), ed è l’istituzione stessa che li legittima (il pronto soccorso è un dispositivo pensato per aiutare le persone nei casi di emergenza, ma, anche, l’istituzione di regole da far rispettare nell’ottica di chi le ha messe in forza).
Noi dobbiamo attenerci alle regole del rito: io e mia madre. La questione è però, in teoria, controversa. Nella prospettiva di Van Gennep, in cui si articolano tre momenti fondamentali (separazione, margine, aggregazione), saremmo nel bel mezzo del transito, del margine. Nella prospettiva di Bourdieu, invece, starem- mo ‘attraversando’ un momento di limen che è il risultato di una istituzione che lo legittima attraverso le sue regole, in definitiva, un lavoro di inculcazione sociale che pone il senso dei limiti, delle distanze da mantenere, di un potere che induce ad attenersi ad alcune regole e non altre. Noi stiamo in piedi, sull’uscio, tra la grande sala e la saletta d’attesa che conduce alla ricezione. A un certo punto, non so come, si libera un posto a sedere. Evviva! Ma lo dico nel mio animo, al mio interno, senza suono emettere, senza emozione mostrare. Non ci precipitiamo. Non ci vogliamo impegnare in una gara con qualche altro contendente che spera, anch’egli, di sedersi finalmente. Non è una sfida. Siamo tutti nella stessa barca e non vogliamo interrompere questo flusso di solidarietà che sento nell’aria e negli sguardi. Nell’imbarazzo, qualcuno ci dice a larghi gesti di andarci a sedere. (Anche noi, io e mia madre, siamo osservati instancabilmente, me ne rendo conto ora; io non sono il solo a vedere tutto come se fosse, nella mia prospettiva, uno strano spettacolo dell’inattività da osservare in attivo nelle minuzie – soltanto – in apparenza insignificanti.) E allora ci decidiamo.
Io metto inconsapevolmente in opera il solito rituale di rilassamento. Io prendo posto come se stessi per sedermi su una comoda poltrona di casa mia, soffice e arrendevole, che richiede vari sussulti e dondolii del corpo prima del dolce assestamento finale. Lo faccio per sentirmi altrove, in un luogo dell’intimità, della tranquillità, in uno spazio della topofilia come direbbe Bachelard (Bachelard 1975). L’essere ‘qui’ dell’uomo, nella sua dimensione sensoriale, è talvolta in attrito con l’essere ‘altrove’ dell’attività cognitiva ed emotiva: non sempre vanno d’accordo, non sempre procedono secondo una identica opzione (Montes 2014). L’immaginazione ha anche questa funzione: trasporta altrove e crea al contempo un effetto di ricezione su chi legge, proprio come nel famoso incipit di Malinowski: «Immaginatevi d’un tratto di essere sbarcato insieme a tutto il vostro equipaggiamento solo su una spiaggia tropicale […] Immaginate ancora di essere un principiante […] Immaginatevi quindi mentre fare il vostro primo ingresso nel villaggio» (Malinowski 2004: 13, mio corsivo). Beh, anch’io, nonostante ci sia stato tante volte al pronto soccorso, mi sento sempre un principiante che deve nuovamente essere iniziato all’agire, un agire adeguato a un luogo di sopportazione eroica. Il bello dell’iniziazione è proprio questo: deve essere reiterata nel tempo in funzione dei contesti che la regolano.
Indipendentemente dal fatto che io consideri questa mia permanenza al pronto soccorso una ricerca sul campo o meno, un ritaglio motivato di osservazione-partecipante o no, devo seguire alcune regole, nell’idea tuttavia di trasgredirne altre per arrivare al mio fine: vedere finalmente un medico. La ragione pratica si fa viva. Volente o nolente, sono al pronto soccorso: non potrei astrarmi totalmente dalla situazione. Sono nel flusso della vita inevitabilmente ritagliato in soglie e sequenze, continuità e discontinuità. Nel frattempo, d’elucubrazione in elucubrazione, vado lentamente giù, sul sedile, come fossi palla di neve bianca in un pendio scosceso. Chiedo, durante il lungo processo di assestamento sul sedile, a mia madre come sta, come va, che si dice, perché non parla. Glielo chiedo più volte, riformulando la questione, finché lei, con un filo di voce, ironica e falsamente rassegnata, risponde: “è tutto fuori posto”. Faccio un cenno con la testa, rimanendo in silenzio e pensando che non potrebbe avere più ragione di così: deve essere tutto ‘fuori posto’, visto che siamo – come ricorda Van Gennep – in una fase di margine, di sospensione, di disordine. Margine e disordine vanno strettamente associati. Quando il movimento di passaggio si risolverà tutto tornerà a posto: torneremo a casa, pronti a ‘riaggregarci’ alla socialità di sempre, seppure con qualche piccola conseguenza dovuta al compimento trasformativo del rito. E mentre farnetico, tra il passaggio e l’istituzione, tra Van Gennep e Bourdieu, sono ancora alla ricerca di una posizione del mio corpo che mi consenta di rilassarmi, senza per questo cedere al dovere dell’inattività del pronto soccorso: un minimo di tensione è necessaria al fine di tenere sveglio lo spirito e l’attenzione. In fondo, tra le altre cose, dobbiamo stare guardinghi, non farci sfuggire il turno.
Tra una divagazione dello sguardo e una congettura della mente in movimento, mi rendo conto che il ragazzo, che ci precede nel turno, è pronto per entrare. Si è piazzato davanti la porta della ricezione in attesa di entrare non appena il paziente che è dentro, prima di lui, lascerà la postazione libera. “Non appena” a quanto tempo corrisponde al pronto soccorso? Io mi alzo e mi metto dietro di lui, con le braccia conserte, scandendo bene i passi per non dare l’impressione di avere fretta, ma ne ho invece tanta, ma ne ho così tanta che non è nemmeno possibile immaginarla. E aspetto e aspetto. E non succede niente. E continuo ad aspettare. Così, mi metto a passeggiare anch’io, avanti e indietro per la saletta, per ottundere nervosismi potenziali, incipienti. Questo ‘principio di attesa’, molla invisibile dell’agire umano che collega spazi materiali e simbolici, vale per un pronto soccorso, vale pure per un luogo di vacanze in cui l’apparente assenza di attività ne connota invece tante altre, ugualmente portatrici di agentività, ritagliate da altrettante, varie frontiere (Montes 2015). Ciò non deve stupire.
Le frontiere sono costitutive non soltanto della componente simbolica delle comunità, ma, anche, della formazione del singolo individuo in sé, persino nei momenti più insignificanti dell’ordinario. Le frontiere hanno da sempre avuto un ruolo centrale nella formazione delle comunità e dei simboli ad esse associate dagli individui (Cohen 1989). Questo ruolo importante, centrale, irrinunciabile dell’essere umano non deve essere pensato come un irrigidimento che sfocia nella costruzione di veri e propri muri e palizzate, ma è – dovrebbe essere – invece funzionale alla permeabilità e all’incremento di quegli scambi che si creano – si arricchiscono per l’appunto – in ‘terre’ di confine, vere o immaginate. Valga per tutti l’esempio del bilinguismo polimorfico «che di regola trova espressione letterale nelle pratiche linguistiche degli abitanti le terre di confine tra due aree culturali» (Lotman 1990: 142). Le frontiere, più che a isolare come comunemente si crede, sono sovente elementi catalizzatori della comunità: la realizzazione di frontiere è di fatto equivalente alla fabbricazione e rinsaldamento del gruppo nel dibattito e confronto con altri gruppi (Barth 1969). E le frontiere, nel tempo, sono continuamente ridefinite e rinegoziate. In questa prospettiva, le frontiere non vanno prese alla lettera: in quanto baluardo insormontabile o posizionamento inderogabile. Le frontiere sono – dovrebbero essere – i luoghi materiali e simbolici dove si svolgono gli scambi più frenetici e dove la ritualizzazione del passaggio produce un ritorno sulla stessa eventuale rigidità della frontiera, smussandola e smorzandola. Un punto è da sottolineare: il collegamento tra frontiere e (im)mobilità. Infatti, nelle varie epoche e culture esistono accentuazioni di mobilità (con conseguenti tendenze allo smussamento delle frontiere) o di immobilità (con conseguenti tendenze all’incremento di frontiere) individuali e comunitarie.
Oggi, nel mondo odierno, si insiste sempre più sulla trasformazione delle nostre vite sottoposte a una maggiore mobilità, ai flussi che le definirebbero, diversamente da un passato non lontano in cui il senso di identità si fondava invece maggiormente sulle radici, sull’iscrizione simbolica dell’individuo in un luogo staticamente inteso. Le nostre stesse vite sono, sovente nella loro interezza, mobili (Elliott, Urry 2013). La vita, oggigiorno, nel bene e nel male, fa tutt’uno con la mobilità. Niente di più vero: si va verso una maggior grado di mobilità, si ha tendenza a sgretolare sempre più le frontiere che diventano liquide, benché le società tendano paradossalmente a individualizzarsi (Bauman 2002). La riflessione antropologica sul rapporto esistente tra mobili- tà/immobilità e sgretolamento di frontiere collettive e individuali è ancora in corso, non conclusa, data la vicinanza storica con gli eventi maggiormente produttori di globalizzazione nella modernità. C’è ancora tanto da capire. Un elemento è però certo, almeno nella mia prospettiva semiotica e antropologica. In questo meccanismo generale, è pure necessario riconoscere il ruolo centrale occupato dall’attesa – spesso poco visibile, ma onnipresente – che si produce nel passaggio da un luogo all’altro, sita tra un flusso e la sua sospensione, calata immancabilmente tra la ricerca di mobilità e il radicamento nell’immobilità (Montes 2007).
L’attesa, nelle sue più svariate forme, è un operatore di rallentamento della mobilità; essa è una controparte antagonista dei flussi odierni: se il flusso cede alle molteplici frontiere, esso cede altresì a quelle più impalpabile dell’attesa intesa essa stessa in quanto frontiera, benché in veste temporale, più sottile, meno apparente. Immerso in queste riflessioni, non mi rendo conto che il ragazzo che mi precede non solo è già entrato, ma sta pure per uscire. Mi sorride tutto contento, mentre mia madre mi strattona per svegliarmi dal torpore metafisico che mi ha preso e che mi blocca dal profondo del mio ‘essere in pausa’ rispetto alla pienezza del tempo esperito nella prossimità. Riesco a scuotermi. Entriamo. Un mulinello di memoria s’instaura vorticosamente, mentre noi passiamo, lentamente, in caduta libera e attesa prolungata, verso l’interno del pronto soccorso, verso la sua seriale incontrollata complessità: la sala d’attesa della ricezione (e la ricezione) cede allora il posto alla sala d’attesa dell’infermeria (e all’infermeria) che, a sua volta, cede il posto alla sala d’attesa del medico (e al medico), e così di seguito, per coppie minime di articolazioni reiterate dell’attesa. Così, compreso il meccanismo, risparmio i dettagli al lettore – importanti è vero, ma bisogna pur finire – e mi affretto ad abbozzare sintetiche conclusioni.
Ho ingannato l’attesa al pronto soccorso prendendo appunti, osservando e partecipando. Mi sono ‘divertito’ a mettere alla prova, in un contesto d’uso esperito in prima persona, la nozione di passaggio di Van Gennep e la nozione d’istituzione di Bourdieu. I riti possono leggersi in un modo o nell’altro: passaggio o istituzione. Io li ho letti coniugando le due prospettive, nonostante Bourdieu, il quale dice di Van Gennep: «ha descritto un fenomeno sociale di grande importanza; io non credo che abbia fatto molto più di questo» (Bourdieu 1982: 58). Nella mia prospettiva, coniugarli, significa inoltre aprire la strada alla riflessione su un elemento trascurato dai due autori – i riti di necessaria socializzazione – che io ho collegato strettamente ai riti di passaggio/d’istituzione. Sempre in quest’ottica, la conseguenza è che l’attesa non può più essere considerata un non-fare, un elemento di sospensione dell’azione, ma dovrebbe essere invece vista come intersezione di attività – cognitive ed emotive, performative e causative – in cui il ‘potere’ entra in gioco. Questa è pure la ragione per cui credo, ad ampio raggio, che si debba parlare di una politica e poetica dell’attesa. Un terzo punto credo sia importante per finire: l’impegno sociale, sovente, non è soltanto rappresentato da grida ostentate e rivolte giustificate, ma, anche, da esplorazioni semio-antropologiche di quelle sedimentazioni intersoggettive in atto che conducono alla rivelazione di dispositivi impliciti di inculcazione del potere. Che sia questa una possibile differenza tra l’antropologia (dell’introspezione) e la sociologia (dell’impegno)? Me lo chiedo.
Dialoghi Mediterranei, n.19, 2016
Riferimenti bibliografici
Bachelard G., La poetica dello spazio, Dedalo, Bari, 1975
Barth F., “Introduction”, in Barth F., a cura di, Ethnic Groups and Boundaries, Little, Brown and Company, Boston, 1969: 9-38
Barthes R., Frammenti di un discorso amoroso, Einaudi, Torino, 1979
Barthes R., Barthes di Roland Barthes, Einaudi, Torino, 1980
Bauman Z., La società individualizzata. Come cambia la nostra esperienza, Il Mulino, Bologna, 2002 (2001)
Bourdieu P., “Les rites comme actes d’institution”, in Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 43, giugno 1982: 58-63
Char R., Le vicinanze di Van Gogh, SE, Milano, 1987
Cohen A. P. The symbolic construction of community, Routledge, Londra, 1989
Deleuze G., L’esausto, Nottetempo, Roma, 2015
Elliott A., Urry J., Vite mobili, Il Mulino, Bologna, 2013
Lotman Y. M., “The notion of boundary”, in Universe of the mind, Tauris, Londra, 1990: 131-142
Malinowski B., Argonauti del Pacifico occidentale, vol. I, Bollati Boringhieri, Torino, 2004
Memmi A., La statua di sale, Costa & Nolan, Genova, 1991
Montes S., “Enoncer soi-même, énoncer le terrain. La deixis des anthropologues et le métalangage des linguistes”, a cura di D. Monticelli, R. Pajusalu e A. Treikelder, Studia Romanica Tartuensia, vol. IV, Tartu Ülikooli, Tartu, 2005: 141-169
Montes S., “L’ethno-anthropologie comme genre : construction de la subjectivité et effets d’énonciation”, Recherches Sémiotiques/Semiotic Inquiries, vol. 25 (3), vol. 26 (1), a cura di C. W. Francis, Montréal, 2005-2006: 27-45
Montes S., “La narrativité de l’aspect dans L’attente de Borges. Une étude sémio-anthropologique de la phénoménologie du « moment présent »”, Studia Romanica Tartuensia, VI, a cura di D. Monticelli e A. Treikelder, Tartu Ülikooli, Tartu, 2007: 159-189
Montes S., “Tradurre il quotidiano in concreto? Con una cornice surrealista del gioco, ovviamente”, Analele Universtăţii Spiru Haret, Seria Filologie, Limbi şi literaturi străine, An XII, 12, vol. 1, 2009: 249-276
Montes S., “In divenire. Istantanee, passeggiate e flussi di coscienza”, Dialoghi Mediterranei, 7, maggio 2014
Montes S., “Tempo d’estate, tempo di mare, tempo al tempo. Sull’agentività in vacanza”, Dialoghi Mediterranei, 15, settembre 2015
Poulet G., “Char”, in Char R., Le vicinanze di Van Gogh, SE, Milano, 1987
Van Gennep A., I riti di passaggio, Bollati Boringhieri, Torino, 1981
Wittgenstein L., Ricerche filosofiche, a cura di M. Trinchero, Einaudi, Torino, 1967
_______________________________________________________________
Stefano Montes, ha insegnato Letteratura francese, Antropologia Culturale e Semiotica nelle Università di Parigi, Catania, Tartu, Tallinn, Palermo e Agrigento. Al di là delle etichette disciplinari, s’interessa ai modi molteplici secondo cui dinamiche culturali organizzano forme testuali (letterarie ed etnografiche). Nelle sue ricerche, ha privilegiato le analisi delle narrazioni di vita, lo studio delle modalità di produzione della cultura in alcuni testi esemplari, l’enunciazione della soggettività nelle teorie e pratiche antropologiche. Da alcuni anni i suoi campi di interesse scientifico vertono sulle strategie di conversione religiosa e sull’esperienza turistica.
________________________________________________________________