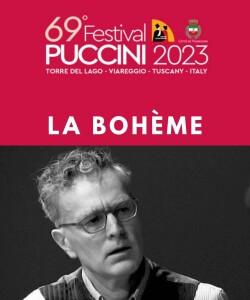di Aldo Aledda
Ciò che accade oggi in Italia, ossia che un partito politico che ha vinto le elezioni coltivi l’ambizione di rimanere quanto più a lungo al potere e per fare ciò cerchi di radicarsi il più possibile nella società, in fondo lo si è sempre fatto e visto fare. Anche nella prima Repubblica quando senza disporre del necessario consenso elettorale l’obiettivo era l’ “occupazione” della società, a fronte di un partito di maggioranza relativa che grazie ai valori cristiani aveva dimostrato di possedere un forte radicamento, l’avversario Comunista si poneva l’obiettivo della “conquista” del corpo sociale optando per una più gramsciana egemonia culturale e lasciando in pratica il compito di intervenire sulla “struttura”, ossia sulle leve del potere economico, alla Democrazia Cristiana: laddove quest’ultima si infilava nella gestione di banche, industrie e altri settori economici, il primo preferiva rafforzare la sua presenza nelle università, nei giornali, nelle case editrici e in tutti gli altri snodi della cultura e dell’informazione in cui poteva arrivare [1].
La convinzione era che il possesso del cuore della gente, con relativo rafforzamento e ampliamento del consenso, è possibile non tanto e non solo costituendo e fondando interessi materiali (in primis quelli clientelari) quanto soprattutto facendo leva sulla cultura, detto volgarmente puntando alla conquista delle “teste” [2]. In questo senso anche oggi non mancano i segnali di riproposizione di analoghe operazioni dal momento che gli ultimi vincitori dell’agone politico in qualche modo cercano di sostituire con uno proprio il marchio culturale progressista e di sinistra attualmente prevalente nella società italiana (cultura da cui proviene paradossalmente una parte discreta dello stesso personale politico che oggi si colloca a destra). Da qui la rinnovata centralità dei valori e del mondo della cultura e, più in generale, dell’avvio di complesse e sottili strategie di gestione.
Un primo cambio di passo mi sembra si possa già cogliere nell’affermazione di un nuovo lessico. A fare da apripista è stata la stessa vincitrice delle elezioni, Giorgia Meloni che, per quanto le riguarda (quindi dando un carattere apparentemente personale alla scelta), nell’assurgere alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato di preferire questa qualifica nella sua originaria versione maschile; una scelta non certo istituzionalmente scorretta nella misura in cui la carica è delineata in quei termini proprio nella Carta costituzionale (anche se vogliamo una prima avvisaglia della svolta in quell’area cultural-politica si era avuta, per così dire, ante marcia, con la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, nuova icona del successo femminile non solo in campo musicale, poi divenuta consulente dell’attuale ministro della cultura, che esprimeva la volontà di preferire per sé la qualifica di “direttore”).
A onore del vero queste scelte sarebbero giustificate dal fatto quasi inoppugnabile che, nel passaggio dal maschile al femminile, alcuni termini subiscono un’indubbia svalutazione. Un caso di scuola è proprio quello di “maestro”, che reso al maschile farebbe pensare per lo più a un signore in frac che dirige un ensemble di professori di musica, mentre al femminile il pensiero sembrerebbe correre più facilmente a una donna che si arrabatta davanti alla lavagna a gestire una classe di vivaci bimbetti; analogamente quando si parla di “cuoco” si pensa a un signore che si affaccia in tivù o nella sala del ristorante stellato in camice bianco e toque in testa a ricevere gli applausi dei clienti, mentre “cuoca” ricorda piuttosto la casalinga che, frustrata e magari in abiti più dimessi, sfaccenda tutti i giorni dietro i fornelli a sfamare la famiglia. Nella migliore delle ipotesi le donne che preferiscono la versione maschile di questi vocaboli più che abdicare alle proprie lotte di genere sembrerebbero spinte dall’esigenza di raggiungere più rapidamente obiettivi di potere e di soddisfazione professionale, che altrimenti con l’altro approccio terminologico in un mondo egemonizzato da maschi starebbero continuamente a sbattere contro il tetto di vetro che si ritrovano sulla testa.
In questo senso risulta abbastanza secondario che così facendo non si tiene conto delle battaglie femministe e femminili che da tempo hanno preferito rivoluzionare autonomamente il ruolo del proprio genere proprio a partire dal linguaggio, sia pure a costo di affrontare un percorso più lungo e tortuoso. Ed è qui che passa una prima e più sottile discriminante fra conservazione e innovazione sul piano culturale e politico. Infatti, avendo sullo sfondo questi valori e questi problemi, riportare la donna al ruolo di tradizionale di madre, genitrice e angelo della casa, con l’uomo che più di essa deve provvedere alle necessità materiali, costituisce un valore fondante del conservatorismo politico e culturale alla luce del quale pare più opportuno che i ruoli sociali tra i due sessi rimangano quelli già biologicamente stabiliti, per cui la donna che opta per questa versione è disposta a mantenere in un secondo piano tutto ciò che conduce a un’autonoma definizione della propria dimensione individuale e sociale. Certo, in questo caso la complessità non manca, come pure le ragioni per schierarsi legittimamente da una parte o dall’altra a seconda dei gusti.
Le innovazioni nel linguaggio non si limitano ai problemi di genere giacché più sottile e sintomatico di una cultura politica che si vuole trasformare, lo è ancora di più cercare di rivedere un certo lessico istituzionale, iniziando con quel termine che da decenni ormai è definito “Paese” (pare utilizzato per la prima volta dagli studiosi francesi, ma ampiamente diffuso nei Paesi anglosassoni con la traduzione “country”) con l’altro più stagionato di “Nazione”; esso pure, se vogliamo, non meno legittimo e forse anche tecnicamente più corretto del primo. Ma anche in questo caso il diavolo si nasconde nei dettagli. Infatti, l’utilizzo di questa parola ai giorni nostri suona incorretto solo politicamente nella misura in cui il termine si rifà a un’origine e a un ordine sociale che nella storia si è presentato in un’era molto circoscritta, sia pure relativamente recente, ma che, con tutto il suo carico di significati identitari, etici, razziali e religiosi, dal punto di vista dei valori al giorno d’oggi appare del tutto desueto, anche perché siamo entrati in un’era di rivoluzione geopolitica caratterizzata dall’incidenza più che delle “nazioni” coloniali di un tempo, come Francia, Inghilterra e Spagna, per esempio, troppo circoscritte per territorio e popolazione, da più vaste aggregazioni nazionali come gli Usa, la Russia, la Cina e l’India e la stessa Unione Europea se riuscisse a darsi un’unità politica ed economica maggiore superando i limiti delle vecchie e gloriose “nazioni” di un tempo che la compongono e che anche oggi vorrebbero continuare a fare i solisti nel concerto mondiale.
Quindi, benché il termine “nazione” appaia istituzionalmente ancora attuale in tutta la sua solennità e la carica simbolica come testimonia la sua presenza nei documenti storici e giuridici che stanno alla base del nostro ordinamento e di quello internazionale (non senza contraddizioni e coabitazioni quando si parla, per esempio, di “Europa di popoli” e non di “nazioni”, ma anche di “Nazioni unite”), in realtà più che il sostantivo oggi trova un impiego più accettato l’aggettivo (per cui abbiamo senza problemi l’“inno nazionale”, l’“interesse nazionale”, l’“economia nazionale”, l’“orgoglio nazionale” nei diversi campi, e così via). L’ambiguità e l’intersecazione di significati di questa preferenza terminologica, su cui nessuno pubblicamente e ufficialmente avanza riserve, sta proprio nell’intento di infilare nella società un cuneo costituito da un termine, “nazione” appunto, che sia capace di veicolare tutta una specifica cultura politica che sta dietro il suo suffisso “ismo”, dimostrazione ne sia che un importante studio sull’argomento, L’idea di nazione di Federico Chabod, sia stato utilizzato come traccia negli esami di maturità del 2023, sia pure ambiguamente giacché il valente studioso valdostano si limita a una ricostruzione storica del suo uso e del suo significato che non legittima affatto l’uso corrente. Chi ne sostiene l’utilizzo evidentemente è indifferente che alcuni valori non siano più in linea con le conquiste della modernità in campo sociale, come la difesa esplicita dei confini o la purezza razziale, ma è più interessato a farli avanzare dietro la copertura di altri che appaiono ancora condivisi nel tipo di società in cui viviamo, come il mantenimento dei principi cristiani, la difesa della famiglia tradizionale, ecc. confidando forse che, grazie a questi, si potrebbero sdoganare sia pure alla lontana anche i primi (come di fatto è avvenuto, per esempio, con i decreti sull’immigrazione e relativa difesa dei confini, con i discorsi e le misure rivolte a rimediare allo spopolamento senza ricorrere agli stranieri ma puntando tutto sulla fertilità delle donne che vivono nella “nazione”, ecc.).
 Orbene, questo nuovo lessico (o vecchio rivisitato, se si preferisce) ha la possibilità di tradursi e penetrare più profondamente nella cultura quotidiana quanto più circola nella comunicazione istituzionale ed è destinato a radicarsi soprattutto quanto più con apparente asetticità se ne trasferisce l’uso nel gergo tecnico dei provvedimenti legislativi e amministrativi (in modo tale che anche opinionisti e alti funzionari dello Stato possano fungere da altoparlanti). In buona sostanza tutti i segnali ci dicono che siamo in presenza di un’operazione culturale propedeutica a un’affermazione politica, come la giudicava appunto il grande storico valdostano, Chabod, che, analizzando il passaggio da “nazione culturale” a nazione “territoriale”, sosteneva testualmente che «i titoli culturali servono da documenti giustificativi per il sorgere anche della seconda [ossia quella “territoriale», N. d. A.] [3].
Orbene, questo nuovo lessico (o vecchio rivisitato, se si preferisce) ha la possibilità di tradursi e penetrare più profondamente nella cultura quotidiana quanto più circola nella comunicazione istituzionale ed è destinato a radicarsi soprattutto quanto più con apparente asetticità se ne trasferisce l’uso nel gergo tecnico dei provvedimenti legislativi e amministrativi (in modo tale che anche opinionisti e alti funzionari dello Stato possano fungere da altoparlanti). In buona sostanza tutti i segnali ci dicono che siamo in presenza di un’operazione culturale propedeutica a un’affermazione politica, come la giudicava appunto il grande storico valdostano, Chabod, che, analizzando il passaggio da “nazione culturale” a nazione “territoriale”, sosteneva testualmente che «i titoli culturali servono da documenti giustificativi per il sorgere anche della seconda [ossia quella “territoriale», N. d. A.] [3].
Da qui si comprendono molti dei posizionamenti di uomini politici e di cultura, giornalisti e comunicatori legati all’attuale maggioranza di governo che sottilmente o più esplicitamente intervengono, come si dice in gergo calcistico, “a gamba tesa” sulla gestione della cronaca culturale del Paese in questa fase storica e che spesso sono inseguiti nella loro isteria da certa stampa di sinistra che continua ad abbaiare contro la presunta natura “fascista” di quella cultura politica non rendendosi conto, secondo me, che questo è stato posto come un falso bersaglio su cui scaricare a vuoto gli strali dell’avversario, mentre quello vero e più insidioso è di collocare, ancora a parere di chi scrive, il movimento su quel filone di autoritarismo politico più o meno soft che oggi si afferma nella politica internazionale come alternativo alle democrazie occidentali e va da Orban a Erdogan, da Putin a Al-Sisi, da Trump a Netanyahu o Bolsonaro, da Modi a Xi [4].
Affrontando il problema da un altro punto di vista, non posso sfuggire alla sensazione che l’approccio o l’interesse politico in funzione di una metamorfosi culturale in fondo poggia sulla natura in qualche modo bifronte della nozione di cultura. Questa, da un lato, attraversa i secoli e combatte il passare del tempo imponendosi essenzialmente come “conservazione” di valori da salvaguardare per il benessere di una comunità (e del prodotto letterario o artistico); e ciò sia ai livelli della cultura cosiddetta alta sia di quelle espressioni antropologiche che oggi costituiscono una risorsa del nostro Paese, anche nei costumi e nelle usanze delle comunità più piccole. Da qui l’origine di una sorta di clientelismo culturale, fatto principalmente di nomine e di destinazione di risorse, che oggi privilegia soprattutto chi si riconosce nei valori politicamente conservatori (di recente è stato oggetto di proteste di parlamentari dell’opposizione che un’importante ministro del governo in carica abbia assicurato tutta una serie di sindaci sul fatto che li avrebbe tenuti presente nella distribuzione dei fondi relativi al cosiddetto “turismo delle radici” che appunto ha la finalità di valorizzare le espressioni culturali locali).
A questa nozione si oppone quella della “provocazione” che di solito agisce nell’immediato nell’opera d’arte, in genere quando viene presentata la prima volta oppure se diviene nel tempo sistematica icona di trasgressione volta a combattere pregiudizi, credenze e modi prevalenti di essere e di vedere le cose in tutte le epoche. Va da sé che attorno a queste due caratteristiche della cultura ruota, sia pure per contrapposte ragioni, il mondo della conservazione politica e quello cosiddetto progressista. La cosa, tuttavia, in Italia diviene un po’ più complicata (e gli utilizzi pertanto più strumentali) nella misura in cui, per esempio, la necessità e il dovere di “conservare” quello che è il più grande patrimonio culturale del mondo diviene la preoccupazione di tutti (non a caso il titolo è riservato da sempre a chi è preposto istituzionalmente alla cura e alla gestione di queste risorse), col risultato in termini di conta politica che magari chi canta e celebra le virtù popolari vota a sinistra e chi è cantato e celebrato preferisce guardare un po’ più a destra. E, tra poco, vedremo quale uragano si formi quando queste opposte correnti si scontrano in aria.
La contrapposizione dialettica di questi fattori la si vede da uno sguardo alla produzione culturale di alto livello, che ci induce a ritenere che oggi noi siamo diventati più conservatori di cultura che creatori. Che ciò accada perché siamo in possesso di un’eredità culturale talmente vasta sovrastante e impegnativa che ci spinge a comportarsi come l’erede scanzonato che ha il solo obiettivo di godersela e conservarla, senza preoccuparsi di alimentarla, potrebbe essere una spiegazione. In questo modo approfitteremmo di questo privilegio per vivere solo di luce riflessa senza accorgerci di quanto in realtà faccia scadere nel ridicolo e nel contraddittorio intestarsi troppo a lungo i meriti di altre generazioni, senza darsi da fare per alimentarli. Neanche all’osservatore più distratto del grande patrimonio artistico e culturale italiano sfugge che esso è solo frutto del lascito dei re etruschi, degli imperatori romani, dei papi, dei dogi di Venezia e di Genova, dei granduchi di Milano e Firenze, dei Borboni, oltre che di infinite altre elaborazioni locali. Infatti, dopo lo splendore ininterrotto della cultura classica, di quella medievale, comunale, rinascimentale e barocca, assai di meno ha fatto il Paese per meritare il titolo di “grande”, soprattutto da quando è stata edificata la “nazione” col Regno d’Italia nel 1861.
Non si può dire che la contraddizione in qualche modo non sia avvertita, ma alla maniera non certo degna di un “grande Paese”. In altre parti del mondo ci si rende conto che per meritare questo titolo, finanze locali permettendo, non si può limitare ad adagiarsi su un glorioso passato ma occorre in qualche modo dimostrare di esserne sempre all’altezza, come fa, per esempio, la Francia che ha sempre inseguito la grandeur parigina già a metà Ottocento con i lavori di ristrutturazione della città da parte del prefetto Haussmann, voluti da Napoleone III, che oggi ne fanno la città più visitata al mondo, poi con la Tour Eiffel per l’Esposizione internazionale del 1900 (che registrò all’epoca ben 50 milioni di visitatori), più di recente con le Centre Pompidou, la Piramide del Louvre (il primo museo del mondo) e mai cesserà di coltivare quella che considera la sua vocazione a essere “grande”.
Da qui qualche sprazzo di idea nostrana nell’inseguire questo mito è tornato di recente, per esempio con la vecchia idea di realizzare un Ponte nello stretto di Messina, che faccia passare alla storia i suoi costruttori come è accaduto per quelli del Duomo di Milano o del Colosseo e dei moderni realizzatori del Golden Bridge di San Francisco, del ponte Verrazzano di New York, o di quello cinese di Runyand di Nanchino [5] (certo, poi attenzione alle “figuracce”: la stampa internazionale dopo la caduta del Ponte Morandi non si è lasciata sfuggire a proposito di realizzazioni italiane nel rapporto vecchio/nuovo che mentre quelle moderne cadono dopo mezzo secolo il tetto del Pantheon di Roma rimane sempre lì da quasi duemila anni, che metaforicamente appunto esprime il rapporto che esiste tra eredità culturale e velleità moderne in uno stesso Paese). Poi certo, alla lunga, viste anche le difficoltà oggettive, si cade nel paradosso.
Se l’obiettivo, per esempio, di un rinnovato attivismo culturale è fare in modo che i visitatori rimangano affetti da una sorta di sindrome di Stendhal di massa davanti all’immagine di un “grande” Paese caratterizzato anche dalle possenti realizzazioni della modernità, credo che di lavoro da fare, almeno per ciò che ci riguarda, ne rimanga in abbondanza. Al momento, infatti, è difficile che i viaggiatori di tutto il mondo che oggi circolano volentieri in Italia si convincano che la grandezza del Paese vada oltre la contemplazione del proprio passato: nel presente i luoghi sacri della nostra cultura, da Roma a Napoli, sono assediati dai segni del “grandezza” moderna, fatta di scenari urbani degradati per le montagne di rifiuti, i servizi e i mezzi pubblici lenti e deteriorati se non funzionanti in epoca di intensi flussi turistici anche per l’infausta coincidenza con un calendario scandito da scioperi e inconvenienti di vario genere, a tacere dei singhiozzi dei servizi sanitari e dell’ordine pubblico che meritano a questo Paese ben altri titoli che quello di grande [6]. Certamente gli stranieri, tornando al proprio Paese, accanto all’idea della grandezza nazionale delle ere passate non potranno fare a meno di portarsi appresso anche quella della inadeguatezza attuale della nostra “nazione” alla sua gloriosa tradizione (come si evince anche dai commenti che giornalisti e intervistatori televisivi raccolgono dagli stranieri in visita in Italia soprattutto quando fuggono da incendi, eruzioni di vulcani, smottamenti di terreni, ritardi di treni e chiusura di aeroporti).
Con queste premesse il clima estivo ha incominciato a surriscaldarsi grazie soprattutto a due episodi, che pur avendo in apparenza poco di politico nella sostanza, nella forma si sono tramutati in altrettante piccole tempeste in un bicchiere d’acqua, costituendo però anche interessanti casi di studio per misurare la temperatura politica rispetto al tema dei beni culturali nel nostro Paese.
Il primo ha visto protagonista il ministro della cultura italiano che, in un’intervista televisiva che è rimbalzata anche all’estero (come può testimoniare chi scrive che allora si trovava oltreconfine), ha ammesso candidamente, da membro della giuria del premio Strega, di non avere letto i libri in concorso che poi ha votato. Questa sembrerebbe, dunque, la verità anche se successivamente gli uffici stampa ministeriali hanno cercato di minimizzare l’affermazione parlando non tanto di mancata lettura del materiale in concorso quanto di un rimando (frainteso) del ministro a un approfondimento dei testi che sarebbe intervenuto sicuramente in seguito (sic!).
Tuttavia, più della cosa già di per sé abbastanza grave è stato non avere avuto il coraggio di ammettere ciò che molti anche non addetti ai lavori da tempo sanno (o comprendono), ossia che il re è nudo giacché è raro che dei giurati dei premi letterari leggano i libri in concorso per una prima e banalissima ragione che non ne avrebbero il tempo (essendo oltretutto impegnatissimi in altri campi, come il ministro in questione) e, poi, perché il materiale che affluisce è eccessivo (per quanto nell’organizzazione ci siano degli sherpa che fanno un imponente lavoro di scrematura). Da qui la seconda ragione, più seria. Episodi di questo genere non aiutano la nostra produzione letteraria di alto livello, in cui il giudizio verte su piani sempre troppo diversi da quelli strettamente letterari, in primo luogo quello economico che si manifesta già nello scontro tra case editrici per accaparrarsi il premio, anche se troppo spesso si dimentica si tratta di aziende per le quali il libro è un prodotto da promuovere e vendere allo stesso modo di un frigorifero o di un marchio di birra. Dopo di che si passa all’incidenza dei fattori politici, alla luce dei quali non è casuale che i commenti che seguono ai risultati di una finale, quando non si tratti di concorsi di saggistica, poco si soffermino sul valore letterario del testo e del suo autore (ma d’altronde vi è una tale schiera di correttori bozze e di scrittori che sorveglia e perfeziona il testo dell’opera da lanciare che anche una minima approssimazione in questo campo risulterebbe inaspettata quanto quella di un automobile che, per ipotesi, passando nella catena di montaggio per le mani esperte di tutta una serie di tecnici e di operai, si portasse dietro qualche difetto); piuttosto si sta attenti che rispecchino gli orientamenti politici più in voga in quel momento.
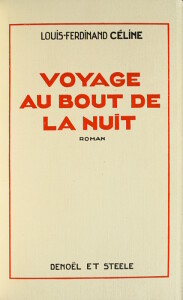 In questa logica di largo successo sono apparsi in passato i lavori che si sono iscritti preferibilmente nel filone della critica al fascismo o al nazismo, meglio se riferiti alla Shoah, oppure si sono mostrati più sensibili alle vicende migratorie e ai cambiamenti climatici, ma ancora di più trovano consenso se privilegiano questioni di genere, tutte cose sul piano politico e sociale di per sé valide e degne di apprezzamento. In realtà la moderna logica economica del best seller contrasta con la storia e la tradizione delle affermazioni letterarie che soltanto il trascorrere del tempo giudica e consacra, con letture, riletture, analisi critiche, mode, ecc. dalle quali soltanto, e difficilmente da altro, emerge il valore di un’opera. Se è vero che, anche in epoca moderna alcuni lavori poi passati alla storia ebbero un successo immediato come La montagna magica di Thomas Mann, altri autori come James Joyce incontrarono forti difficoltà a pubblicare pietre miliari come l’Ulisse, che soltanto nel 1922 trovò nella piccola editrice “Shakespeare and Company” di Parigi il coraggio necessario di stampare un lavoro apparentemente così astruso oppure Celine che riuscì a pubblicare fortunosamente e quasi anonimamente con Gallimard il suo primo libro, Voyage au bout de la nuit.
In questa logica di largo successo sono apparsi in passato i lavori che si sono iscritti preferibilmente nel filone della critica al fascismo o al nazismo, meglio se riferiti alla Shoah, oppure si sono mostrati più sensibili alle vicende migratorie e ai cambiamenti climatici, ma ancora di più trovano consenso se privilegiano questioni di genere, tutte cose sul piano politico e sociale di per sé valide e degne di apprezzamento. In realtà la moderna logica economica del best seller contrasta con la storia e la tradizione delle affermazioni letterarie che soltanto il trascorrere del tempo giudica e consacra, con letture, riletture, analisi critiche, mode, ecc. dalle quali soltanto, e difficilmente da altro, emerge il valore di un’opera. Se è vero che, anche in epoca moderna alcuni lavori poi passati alla storia ebbero un successo immediato come La montagna magica di Thomas Mann, altri autori come James Joyce incontrarono forti difficoltà a pubblicare pietre miliari come l’Ulisse, che soltanto nel 1922 trovò nella piccola editrice “Shakespeare and Company” di Parigi il coraggio necessario di stampare un lavoro apparentemente così astruso oppure Celine che riuscì a pubblicare fortunosamente e quasi anonimamente con Gallimard il suo primo libro, Voyage au bout de la nuit.
In questo senso la grande fioritura di premi letterari del nostro tempo, inserita nella logica della storia della letteratura, è solo il trionfo dell’effimero, con gli scrittori che, in omaggio a una moda molto vicina all’instant book di marca anglosassone che fa tendenza in questo campo, trascorrono il proprio tempo nelle tivù, a dare interviste, a presentare e promuovere libri, se vogliamo in modo abbastanza diverso dai nomi classici della letteratura mondiale di tutti i tempi in cui poeti e scrittori erano personaggi spesso schivi, concentrati sul proprio lavoro, autentici giacimenti minerari la cui ricchezza solo col tempo si riusciva a portare alla luce e spesso non prima della morte. Un effimero, quindi, per stare dentro il nostro discorso, che si nasconde ancora di più nell’inseguimento della moda politica e sociale del momento che magari fa vendere all’inizio centomila copie di un libro a la page o un milione di dischi, ma che poi segna il lento e graduale oblio dell’autore (fatto queste cui l’editore è abbastanza indifferente posto che gli interessa rientrare il prima possibile nelle spese e nel profitto). In questo senso possiamo dire che il matrimonio tra il narcisismo e l’aspirazione al successo degli autori e le esigenze economiche delle aziende del settore e degli apparati che governano questi processi (compresi i mezzi di informazione anche nella misura in cui favoriscono la presentazione di libri tra compagnoni) trovano il proprio collant proprio nell’ideologia e nella sfera politica che, soprattutto in un Paese come l’Italia, cerca di dettare legge anche in questo campo.
Certamente il destino dell’arte e della letteratura è anche quello, come dimostrano queste ultime vicende letterarie, di divenire oltre che “creazione” anche salutare “provocazione”, agendo da coscienza critica rispetto a temi del proprio tempo. Come pure è altrettanto vero che la partigianeria politica camuffata da scelta ideologica di fondo con l’intento di nobilitare i dintorni, soprattutto quando si scivola sul politicamente corretto nell’affidarsi a unica tendenza letteraria (sesso e cronaca nera, per esempio) tante volte nasconda solo povertà creativa. Sarò facile profeta, quindi, se prevedo che le prossime provocazioni dei successi letterari – sempre permanendo l’attuale quadro politico e in un mondo immutato di agenti letterari e editori interessati al successo istantaneo del prodotto intellettuale – che in qualche modo contano sull’appoggio di strumenti di propaganda, saranno più “complessi” e “pluralisti”, per esempio, nei confronti del passato fascista, e saranno più propensi a difendere i valori della famiglia tradizionale oltre che più ottimisti rispetto al tipo di società, quieta, orgogliosa e più omologata e scettica anche rispetto alle ragioni scientifiche dei cambiamenti climatici?
Dopo i tentativi di inquinare le più impermeabili arti figurative (laddove pare che non si riesca ad andare oltre la presentazione di un qualsiasi pittore del Quattro/Cinquecento italiano in veste attuale, senza peraltro poter mettere i bikini le fanciulle della Primavera del Botticelli o coprire le pudenda al David di Donatello), la riserva di caccia più battuta è divenuta l’opera lirica, sicuramente anche per i numerosi punti di attacco che presenta con le varie forme d’arte, e quindi più persone e più interessi coinvolti (e costi enormi di produzione su cui fare leva). Ed è qui che si colloca il secondo episodio che porto all’attenzione del lettore e che ha dominato l’estate cultural-politica del nostro Paese. Ci riferiamo alla direzione della Bohéme avvenuta a Torre del Lago, patria di Puccini e ora sede del relativo Festival, da parte del maestro Alberto Veronesi che, non volendo vedere quello che per lui era un abominio scenico, ha preferito dirigere l’orchestra bendandosi gli occhi (formula che evidentemente ha giudicato fortunata estendendola poi all’esecuzione di una “Traviata” a Vibo Valenzia, seguito in questo mascheramento da orchestrali e cantanti). Di certo ciò non è accaduto solo perché si tratta di uno spartito che gli esecutori conoscono talmente a memoria da non aver bisogno di leggerlo (come capita, per esempio, ordinariamente ai Wiener austriaci che vanno direttamente all’esecuzione, tanto sono bravi e preparati, per cui agli eventuali cantanti che devono accompagnare è concessa solo la prova al pianoforte), piuttosto mi sembra che questo episodio sia emblematico della svalutazione di un prodotto artistico aggravato anch’esso dal combinato diabolico delle contrapposte strumentalizzazioni politiche.
Per la cronaca pare che il regista e lo sceneggiatore abbiano voluto ambientare la vicenda dell’opera pucciniana in un clima di contestazione sessantottina, che i maligni ritengono fosse più consona al loro orientamento ideologico, con mani alzate e pugni chiusi nell’intento di renderla più accessibile a un pubblico che, per via forse della colorazione politica prevalente della zona, egualmente era considerato meglio disposto ad apprezzare la trovata. Che tutta l’organizzazione che sta a monte del festival non avrebbe avuto obiezioni di natura politica alla scelta probabilmente era stato messo nel conto, come pure sembra acclarato che il maestro Veronesi, messo per tempo a conoscenza della scelta registica, non abbia mosso alcuna obiezione almeno fino alla data della rappresentazione. Il fatto nuovo è stato che questa è intervenuta in un momento in cui il clima politico del Paese stava cambiando rispetto all’epoca in cui erano state programmate queste soluzioni sceniche e lo stesso Veronesi pare che non avesse fatto mistero di condividerlo in pieno accettando di candidarsi per F.d.I. in una competizione elettorale amministrativa.
Siccome conseguenza di questo rapportarsi alla politica “politicante” è il nascere di una schizofrenia che finisce per condizionare tutti i comportamenti, laddove ad assunzioni di posizioni e di petizioni di principio seguono ripensamenti, smentite, licenziamenti, ricorsi, riassunzioni, azioni giudiziarie, richieste di risarcimento danni, ecc. ecc., anche in questo caso le iniziative del Comitato organizzatore e quelle del contestatore delle scene ispirate al Sessantotto parigino sono state inghiottite dal gorgo della polemica politica che non ha salvato temi, contenuti e realizzazioni. Così ancora una volta il pesante approccio politico all’arte e alla cultura non cessa di manomettere e fare danni, anche nella misura in cui il “politicamente corretto” trova sempre meno consenso in valenti artisti, anzi li spinge a reagire. In questo caso non si è trattato solo di Veronesi (che si è affrettato a fondare una organizzazione rivolta alla tutela dell’opera lirica) ma anche del “maestro” Beatrice Venezi, icona del nuovo corso (autrice di una recente e politicamente “scorretta” rivisitazione dell’“Inno a Roma” di Puccini, all’epoca fatto subito proprio dal regime fascista, quando l’autore ormai aveva abbandonato questa valle di lacrime). Non c’è dubbio che il conformismo imperante induca chi non ne vuole fare parte, non solo per reazione ma anche per opportunismo (tempo fa un direttore d’orchestra bolognese, molto attivo all’estero, mi confidò che in Italia d’altronde lavora solo chi ha le giuste maniglie politiche), a esplorare versanti politici opposti passando dalla diatriba culturale alla rissa politica alla ricerca gli uni del profitto e della gloria effimera e gli altri del voto alle prime competizioni elettorali di passaggio. Salvo, poi, i primi cadere nell’oblio dopo essersi acquistati la villa in Toscana o in Veneto e i secondi dimezzare il consenso dopo aver cercato di governare il Paese per una stagione.
Ho già analizzato su questa rivista [7] i danni che sta producendo proprio all’opera lirica la pretesa di innestare significati che sono cari più che altro ai registi (e impressionano i sovrintendenti) soprattutto quando il delirio solipsistico di costoro pretende di fare leva sul politicamente corretto col pretesto di rendere il prodotto culturale più “attuale” e più “accessibile” al pubblico moderno, qualunque cosa ciò voglia dire (beati i tempi in cui un Luciano Pavarotti imponeva ai teatri che lo scritturavano il direttore d’orchestra, il regista e i colleghi che lo dovessero affiancare che registravano il successo sicuro rispetto al silenzio attuale dei cantanti che si lasciano sopraffare dalle soluzioni registiche anche a costo di vedere naufragare lo spettacolo). Ho già avuto l’occasione di segnalare il nonsense di codeste manomissioni del prodotto artistico, che non fanno altro che danneggiarlo senza arrecare vantaggio ad alcuno, anzi scadendo in una parodia che arreca danno anche alle battaglie più serie che certe conquiste sociali vorrebbero mettere al centro dell’attenzione. Come ho osservato nell’articolo citato a proposito di un “Nabucco” rappresentato all’Arena di Verona, in cui mentre in scena andavano le Cinque Giornate di Milano l’orchestra e i cantanti dicevano e facevano un‘altra cosa, più appropriata al testo di carattere biblico musicato da Giuseppe Verdi, anche in questa “Bohème” di Torre del Lago pare sia stato preso un analogo abbaglio. Un critico musicale si è divertito a dimostrare come, a prescindere dalla scelta politica di sinistra nella scenografia e nella regia, su quanto dicevano e facevano gli attori-cantanti nel primo atto nulla succedesse o si vedeva sulla scena, tanta era la preoccupazione di mostrare solo pugni chiusi e bandiere rosse. Così gli spettatori scorrendo i testi sopra il sipario saranno rimasti sicuramente perplessi nel sentire un Rodolfo che sosteneva di guardare «nei cieli bigi fumar da mille comignoli Parigi» senza che nulla del genere si intravedesse della Ville Lumière, mentre Marcello che, assiderato dal freddo, decideva di attizzare «quel poltrone di un vecchio caminetto ingannatore che [secondo Rodolfo, N.d.A.] vive in ozio come un gran signor» sacrificando un suo quadro di soggetto biblico non si capiva in quale stufa, come vuole il libretto, o qualsivoglia arnese con analoga funzione potesse consumare il suo delitto artistico; e, ancora di più, quando tutta la combriccola di artisti squattrinati decide di darsi appuntamento la notte di Natale al Caffè Momus, di quel locale non appare alcuna traccia nella relativa scena del secondo atto. Quindi, non è facile capire dove si andrà a finire con un Puccini trascinato a destra e a sinistra.
Ormai, e non solo in Italia purtroppo, dove la moda in effetti è stata importata, pare che la musica e la rappresentazione sul palcoscenico prendano sempre più strade opposte. Un esempio su come sul fenomeno stia agendo sempre più il sottile veleno della politica lo si è avuto anche nella versione dell’“Aida” recentemente rappresentata per il centenario dell’Arena di Verona. Quando un giornalista radiotelevisivo alla notizia che sulle lance dei soldati in scena invece che le punte erano state issate delle mani (presentata questa delle mani, per inciso, come una grande scoperta in un sarcofago egiziano dall’importante giornalista scientifico televisivo che in quel momento indottrinava il pubblico del parterre, anche se non accennava che questo presunto unicum è ampiamente diffuso nell’archeologia della “Terra del Fuoco” tanto che le mani aperte compaiono anche nei più banali oggetti di souvenir); orbene nello stesso momento un suo collega fuori campo, deliziato dalla notizia che erano stati eliminati gli strumenti di guerra coglieva l’occasione per esprimere una sua generica contrarietà al loro utilizzo alludendo probabilmente al fatto che lui non approvava l’invio di armamenti in Ucraina e quindi apprezzava un’edizione così ripulita e aggiornata dell’opera verdiana. Non sfugge che anche qui si è voluto lanciare un messaggio politico chiaramente antioccidentale e anti Nato, rivolto non solo al pubblico dell’Arena ma anche al milione mezzo di telespettatori che seguiva a casa la trasmissione (reputati al solito facilmente manipolabili dagli artefici di questi programmi), ma che era in evidente contraddizione col contenuto dell’opera dove echeggiano inni alla guerra, alla vittoria, alla grandezza dell’Egitto culminando nella celebre marcia trionfale che nulla di pacifico cerca di dimostrare [8]. Uno storico della musica, commentando l’episodio, ha giustificato gli organizzatori dicendo che è giustificato usare tutti i mezzi per avvicinare il pubblico all’opera lirica…
Se vogliamo l’intenzione di attirare pubblico di per sé è buona ma non tutti i mezzi per raggiungere questo obiettivo lo sono e meno che mai quelli del “politicamente corretto” (o del suo contrario come quando alcuni registi ebbero l’idea di mostrare discinte le protagoniste di “Traviata” o “Carmen” per solleticare un po’ più gli spettatori costringendo i direttori musicali a cercare cantanti che più per le doti vocali si distinguessero per quelle fisiche, com’è noto cosa non facile nel mondo delle cantanti liriche). Tuttavia, nei casi che trattiamo la rappresentazione appare troppo condizionata da meschine strategie politiche prevalentemente rivolte all’occupazione di poltrone per essere abbastanza credibile. Se questo è vero da un lato, dall’altro vi è il destinatario del messaggio, cui questo non è detto che arrivi come desidera il manipolatore di turno. Non sfugge, come nel caso della Bohème, che questo obiettivo sia stato fissato facendo la leva sui gusti, spesso molto particolari sia sul piano politico sia su quello personale di singoli registi e scenografi (come capita spesso con gli orientamenti sessuali trasgressivi, il cui valore per esempio si vorrebbe trasmettere a chi assiste allo spettacolo), ma che alla fin fine lasciano indifferente la maggior parte della popolazione. A parte che c’è da chiedersi se davvero si pensa di attrarre all’opera una fetta importante di italiani attraverso contenuti tutto sommato superficiali (perché letteralmente stanno solo alla superficie dell’evento culturale rappresentato), per quanto siano mascherati da “impegno” politico e culturale riproponendo direttamente o indirettamente temi e problemi su cui sono bombardati tutti i giorni dall’informazione e dai media e su cui verosimilmente hanno avuto tutto il tempo di farsi un’idea. In questo senso non si è mai visto mettere nel conto che probabilmente quell’audience reagirebbe con fastidio all’ossessione degli allestitori dello spettacolo di riproporre al limite della parodia una Carmen o un Otello che agitano problemi seri come la violenza sulla donna o assistere a un Nabucco o un’Aida trasformati in opera buffa da chiavi rivoluzionarie o pacifiste appiccicate a sputo.
Certo l’opera lirica è adusa a trasformazioni ed evoluzioni e, nella sua storia, ha conosciuto svolte con battaglie feroci tra innovatori e conservatori. Tuttavia essa, al momento attuale presenta uno statuto e un ordine ben assestato e codificato. Così nel panorama moderno, cui noi ci riferiamo, manca per esempio l’elemento sorpresa che nell’opera d’arte è quello che sovrintende a tutte le reazioni. Infatti, se in generale può presentarsi come tale una pellicola cinematografica o un libro che si legge per la prima volta, lo stesso elemento manca del tutto nell’opera lirica giacché tranne qualche novità moderna (ma quasi tutte quelle che oggi stanno in repertorio hanno superato questo scoglio all’epoca delle prime rappresentazioni), incontrano un pubblico che magari le ha viste decine di volte, conosce a memoria arie e melodie mentre la vicenda in sé non presenta per lo spettatore alcuna sorpresa (e meno che mai interesse). Ciò che può sorprendere è la novità del cast oppure le soluzioni scenografiche e registiche, laddove queste ultime sono comunque elementi accessori, come ho già detto, valore aggiunto e non costitutivo del prodotto artistico. Quindi, se qualcuno si volesse avvicinare per la prima volta a questo genere di spettacolo verosimilmente si affretterebbe a mettersi nel tempo più rapido possibile in linea col tipo di pubblico tradizionale. Certo, anche l’opera lirica nel tempo può variare gli elementi di interesse, attrarre più per certi aspetti che per altri, e spesso a seconda delle persone. Sta nella logica delle cose ed è sempre accaduto. Ma non si può snaturare del tutto, come mostra il percorso storico in cui è riuscita a mantenere la sua integrità e anche quelli nuovi in cui si è infilata che mostrano una linearità e vanno in ben altre direzioni di quelle volute dai registi che attualmente operano nel ramo.
 L’opera lirica, negli ormai tre/quattro secoli in cui è sorta e ha dominato le scene ha conosciuto traversie e continue evoluzioni e mode anche negli aspetti meno sostanziali. Spettacolo relativamente di massa nell’Europa del XVIII e XIX secolo costituiva un costume e uno svago non solo per la tradizionale nobiltà e l’emergente borghesia che affollava i teatri con intendimenti non sempre artistici, ma anche per il popolo che ne apprendeva le melodie soprattutto attraverso le bande musicali e i suonatori di organetto locali. Le cronache del tempo ci narrano che il pubblico schiamazzava nel corso delle rappresentazioni, si portava da mangiare, molti per tutta la durata dello spettacolo giocavano a carte nel ridotto del teatro e rientravano in sala solo quando venivano cantate le romanze per applaudire o fischiare i cantanti. I cronisti dell’epoca tramandano che, nei teatri francesi, tra il pubblico girassero spesso i moschettieri infastidendo e minacciando il pubblico. Qualche volta si doveva chiamare la polizia per ristabilire l’ordine. La bagarre di certe rappresentazioni è passata alla storia. La prima del “Barbiere di Siviglia” di Rossini, al teatro Argentina a Roma nel 1816, si risolse in un’autentica cagnara organizzata dai fan di Paisiello (autore di un precedente “Barbiere”) che sentendosi minacciati dalla concorrenza fecero di tutto per affossare l’opera del giovane sfidante; nondimeno i tre colpi di tamburo che precedono la sinfonia della “Gazza ladra”, sempre di Rossini, furono inseriti all’ultimo momento per disorientare i detrattori del maestro pesarese che, essendosi preparati a fischiare al levarsi della prima nota della sinfonia, furono zittiti da quell’espediente.
L’opera lirica, negli ormai tre/quattro secoli in cui è sorta e ha dominato le scene ha conosciuto traversie e continue evoluzioni e mode anche negli aspetti meno sostanziali. Spettacolo relativamente di massa nell’Europa del XVIII e XIX secolo costituiva un costume e uno svago non solo per la tradizionale nobiltà e l’emergente borghesia che affollava i teatri con intendimenti non sempre artistici, ma anche per il popolo che ne apprendeva le melodie soprattutto attraverso le bande musicali e i suonatori di organetto locali. Le cronache del tempo ci narrano che il pubblico schiamazzava nel corso delle rappresentazioni, si portava da mangiare, molti per tutta la durata dello spettacolo giocavano a carte nel ridotto del teatro e rientravano in sala solo quando venivano cantate le romanze per applaudire o fischiare i cantanti. I cronisti dell’epoca tramandano che, nei teatri francesi, tra il pubblico girassero spesso i moschettieri infastidendo e minacciando il pubblico. Qualche volta si doveva chiamare la polizia per ristabilire l’ordine. La bagarre di certe rappresentazioni è passata alla storia. La prima del “Barbiere di Siviglia” di Rossini, al teatro Argentina a Roma nel 1816, si risolse in un’autentica cagnara organizzata dai fan di Paisiello (autore di un precedente “Barbiere”) che sentendosi minacciati dalla concorrenza fecero di tutto per affossare l’opera del giovane sfidante; nondimeno i tre colpi di tamburo che precedono la sinfonia della “Gazza ladra”, sempre di Rossini, furono inseriti all’ultimo momento per disorientare i detrattori del maestro pesarese che, essendosi preparati a fischiare al levarsi della prima nota della sinfonia, furono zittiti da quell’espediente.
Naturalmente non erano solo queste ragioni a rendere il pubblico dell’opera così sanguigno, ma altre più serie e non meno sentite delle prime ne stavano alla base e riflettevano gli orientamenti delle varie scuole musicali dell’epoca. Per esempio, nel caso del Barbiere rossiniano, si contestava non tanto l’utilizzo di un testo di Paisiello (era prassi comune dei musicisti in epoca barocca fino alle soglie dell’Ottocento utilizzare i testi “base” predisposti da librettisti di fama come Metastasio) quanto la “rivoluzione” imposta dal ventiquattrenne musicista alla scuola napoletana che rompeva lo schema fisso dell’opera articolata in romanze (Rossini nel “Barbiere” li limita a scriverne appena sei, una per protagonista) frantumando l’esecuzione in duetti, terzetti, quartetti e concertati finali col coro. L’opera lirica, già riformata da Gluck, imboccò definitivamente questa strada sostituendo gradualmente il recitativo cosiddetto “a chitarra” con pezzi integralmente musicati, come si vede anche nel “Barbiere” rossiniano, che preparavano all’ascolto delle romanze, vale a dire tutta la parte dialogica quasi recitata in prosa (che permane, per esempio, nella versione originale della Carmen di Bizet e più chiaramente la si scorge in alcune opere di Mozart, come il “Flauto Magico”, ancora legate al tradizionale Singspiel tedesco e la cui armonizzazione era affidata a musicisti secondari). Rivoluzione questa che fu completata da Giuseppe Verdi che musicava il libretto dall’inizio alla fine dando valore a ogni declamazione (come accadde per la celeberrima strofa della Traviata, “Amami Alfredo quant’io t’amo, addio!” che è assurta quasi al ruolo di aria autonoma al pari di quelle più lunghe e celebrate di tutto il melodramma). Analogo naufragio toccò proprio a opere come “Traviata” che, alla prima, fu un fiasco, pare per il soggetto ritenuto troppo contemporaneo, e alla “Madama Butterfly” di Puccini, forse per una cattiva suddivisione in atti dell’opera in cui il secondo risultava troppo lungo e pesante.
Fu solo, col ritorno di Arturo Toscanini in Italia dopo la Guerra e dall’auto esilio che si era imposto col regime fascista (esempio di corretto utilizzo della propria persona in chiave politica e non dell’oggetto del suo lavoro) che, divenuto direttore musicale della Scala, impose alle rappresentazioni operistiche quell’assetto meno popolare che oggi presentano: luci spente, silenzio e raccoglimento per ascoltare e gustare un’opera d’arte, niente deliri da stadio per i cantanti ma compostezza nell’approvazione o nella disapprovazione del lavoro (spesso guidati dalla “claque”, con qualche eccezione consentita al “loggione”). D’altronde tutto spingeva da quel momento alla ricerca della qualità delle rappresentazioni, pur lasciando spazio alla creatività individuale e al caso come chiave del successo (la stessa carriera di uno dei più fieri avversari del Regime all’estero iniziò casualmente quando a Rio de Janeiro essendosi ammalato il direttore dell’orchestra, l’organizzatore dell’evento si rivolse ai componenti di quest’ultima chiedendo se per caso ci fosse qualcuno che conoscesse talmente bene l’Aida che si doveva rappresentare quel giorno al punto di dirigerla: unico ad alzare la mano fu un giovane violinista diciottenne, Toscanini, che così ottenne l’incarico e iniziò una prestigiosa carriera) .
Il Novecento è stato il secolo in cui, finita l’era dei grandi compositori, l’elaborazione artistica si è spostata sull’esecuzione (dopo Puccini, Strauss, Leoncavallo, Mascagni e Janacek, poco si è visto che valesse soprattutto l’epoca romantica e la nuova scuola verista, meno che mai all’altezza si sono rivelati i tentativi dei dodecafonici di segnare una svolta).
La cura degli spettacoli si è trasmessa anche alle scenografie apparse più grandiose e appropriate ai teatri sempre più grandi che si andavano costruendo (magari dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale) o ristrutturando, capaci di ospitare migliaia di spettatori rispetto alle poche centinaia dei secoli precedenti (il Met di New York ne contiene quasi 4000, inclusi un paio di centinaia di posti in piedi). Ciò si tramutava in quel miglioramento e nella maggiore professionalità che caratterizza tuttora le rappresentazioni: le orchestre, passate dai trenta/quaranta elementi delle epoche precedenti agli ottanta/cento attuali sono molto più professionali con esecutori che sono autentici musicisti (Verdi andava di matto se vedeva ragazzi nell’orchestra, nessun dilettantismo insomma!, ma ha sostenuto qualcuno che se avesse visto come oggi le orchestre rendono la sua musica rimarrebbe sorpreso ed estasiato); i cantanti sono passati da quelle voci possenti dell’Ottocento che li facevano raccogliere dalle chiese o dalle strade dove si esibivano e non sempre conoscevano la musica ma cantavano solo in funzione dell’acuto finale (i tenori, letteralmente sono coloro che “tengono” la nota, appunto) a professionisti che oggi hanno alle spalle anche dieci anni di studio, tra Conservatorio, laurea, Master, tirocini; il direttore d’orchestra dal vecchio batteur de mesure (ossia colui che si limitava a battere i tempi per l’orchestra) si è dimostrato, soprattutto attraverso i “grandi” come Toscanini, Walter, Von Karajan, Kleiber, Muti, Boulez, Levine, ecc., un fecondo intellettuale, un leader capace di accollarsi e rendere organica tutta la concertazione dell’opera. La figura del regista è stata introdotta relativamente più tardi con il compito, accanto allo sceneggiatore, di rendere più teatrale lo spettacolo, ma fu con l’avvento di Franco Zeffirelli e di Giorgio Strehler che questo divenne per l’opera un valore aggiunto e di grande rispetto, al punto che ancora si parla di una Traviata di Zeffirelli, resa magistralmente anche in pellicola, come tante altre opere liriche, dal grande regista. Oggi il ruolo eccessivo attribuito ai registi quasi in concorrenza con i direttori d’orchestra e quello dei cantanti, ormai scomparsi dai cartelloni e concepiti da alcuni maestri come meri strumenti del complesso orchestrale, sta conducendo l’opera a uno snaturamento che non so quanto le farà del bene.
L’opera lirica è certamente un’operazione culturale complessa, ma prima di tutto è un prodotto musicale di alto livello perché reca la firma di grandi musicisti: da Mozart a Beethoven, da Bizet a Gounod, da Wagner a Strauss, da Mussorgski a Tchaikovsky, da Rossini a Verdi, ecc. In questo senso non può essere concepita da registi politicizzati alla stregua di certa musica contemporanea che tante volte si riduce a mero discorso politico e sociale con accompagnamento musicale, gradito sicuramente da chi condivide quelle posizioni politiche, forse anche genere musicale, ma difficilmente catalogabile come opera d’arte degna dei geni che hanno segnato la prima (da qui il dubbio su certe contaminazioni attuali che il mondo dell’opera non difende come invece fa quello delle arti figurative qualora qualcuno cercasse di accostare Michelangelo o Raffaello con qualche moderno imbrattatele). Certamente l’approccio all’opera lirica, magari anche solo dal punto di vista musicale, per certi versi risulta più semplice perché in fondo ci si trova davanti a uno spettacolo abbastanza popolare con melodie rese altamente orecchiabili dai compositori, mentre per altri diviene più complesso (e completo) se si guarda all’insieme in cui entrano altri aspetti dello spettacolo e dell’arte. Intanto il teatro, l’opera è recitazione e rappresentazione (Giuseppe Verdi, per esempio, preferiva essere ricordato più come uomo di teatro che come musicista), i cui testi affondano in quelli dei più grandi autori della letteratura (Shakespeare, Hugo, Schiller, Tolstoj, ecc.) letti, riletti e resi in versi da librettisti di grande valore come Scribe, Cammarano, Boito, Giacosa… difficilmente qualcuno oserebbe avvicinarsi all’opera lirica senza una conoscenza sia pure approssimata delle sue fonti. Poi, essendo spettacolo, non si può non tenere conto della coreografia, in cui non ci si è risparmiati affidandola spesso a grandi maestri, in Italia da De Chirico ai fratelli Pomodoro.
Dico questo perché, tornando al pubblico che, con gli specchietti per allodole, si pensa di attrarre, in realtà la sua selezione risulta più complessa di quanto non possa sembrare a certi organizzatori di teatro e della Rai dei nostri giorni. Chi assiste a questo spettacolo, come per altri campi della cultura, tolto qualche curioso o turista o esibizionista di prime, cerca di comportarsi in genere da persona informata e preparata. Se non altro perché si tratta di partecipare a un evento culturale che non può essere affrontato con leggerezza, ma richiede pazienza e resistenza fisica, considerata la durata e gli orari tardi in cui vengono offerti gli spettacoli, in cui il massimo dell’eroismo sappiamo che lo si ha a Bayreuth, il tempio wagneriano con i sedili di legno che richiede una pazienza particolare davanti alle oltre cinque ore in cui può durare un’opera del maestro tedesco, che pochi come Angela Merkel, assidua frequentatrice, possiedono.
Quindi quale sarebbe il pubblico da attrarre con espedienti che vengono presentati modernamente, tutti basati sulla superficialità e affidati a nomi illustri del varietà e del giornalismo ma che poco appaiono preparati su ciò di cui hanno avuto il compito? In questi casi il target rimarrebbe quello del curioso che si dovrebbe comportare come chi si reca per esempio al cinematografo preparato alla sorpresa della trama e attirato dalla bravura degli attori e del regista, per giunta disposto, nel caso dell’opera, a stare buono masochisticamente per ore ad ascoltare cose che poco capisce o gradisce anche per mancanza di preparazione musicale. Credo proprio di no. Oltretutto non bisogna trascurare l’effetto opposto, ossia il disamoramento del pubblico tradizionale, rappresentato dal nocciolo duro degli abbonati e degli spettatori internazionali che davanti alla prospettiva di andare in teatro per ascoltare solo della musica a fronte di una scenografia e rappresentazione repulsiva a quel punto preferirebbero starsene in casa col disco o vedersi un dvd dove l’opera è resa in chiave più tradizionale.
Per chi ha un po’ di esperienza di questa forma d’arte, quando il pubblico lascia queste rappresentazioni la sensazione è che appaia colpito più dalla parte musicale che dalla vicenda in sé e solo limitatamente dagli altri elementi esteriori, come scenografia e regia. Perciò, quando esce dall’ascolto di una Carmen è difficile che si lasci andare in considerazioni sulla procacia della protagonista o dalla Bohème si lamenti per la fine che ha fatto Mimì o quanto poco sensibile sia stato Rodolfo o se alzandosi dal posto dopo un Rigoletto quanto cinico si sia rivelato il Duca di Mantova, ingenua Gilda e sfortunato il protagonista, ma quanto bene hanno reso gli interpreti, quell’aria, quel passaggio, quel duetto e così via. E aggiungerei rispetto alla regia e alla scenografia, quando se ne parla lo si fa quasi sempre dopo averne avvertito il fastidio oppure per riderci sopra, in particolare se la cura del “politicamente corretto” e dei tentativi di attualizzare scadono nella parodia, come quando Desdemona reagisce da femminista puntando la pistola, inventata alcuni secoli dopo, contro Otello o i prodi guerrieri guidati da Radames tornano vincitori dopo avere piegato il fiero popolo etiope che “si era ridestato” con le lance dove invece delle punte avevano fissato delle mani, infischiandosi del proposito inconscio del regista che questo potrebbe essere ottenuto dagli ucraini contro i russi se rinunciassero agli armamenti italiani. Quindi non è questa la via per attrarre consenso all’opera, come stranamente sostiene quello storico della musica che giustifica la Bohème sessantottina (e che domani sarà ambientata su Marte), magari davanti a un pubblico che, per anagrafe, ha conosciuto meglio di lui quel periodo storico – e quindi ha capito che non c’entrava nulla col soggetto operistico – mentre lo studioso probabilmente ne ha letto solo sui libri. La strada della cultura è lunga e complessa e non si può pensare di accorciarla con espedienti spesso condotti sull’orlo del ridicolo, ma solo aiutando a percorrerla in termini di impegno e di fatica. L’arricchimento culturale di un popolo non può avvenire con scorciatoie semplicistiche e slogan, ma se si vuole che sia profondo e che ne rimanga un’impronta occorre non nascondere l’asperità del percorso che caratterizza ogni processo di apprendimento.
La variabile politica si fa sentire di più quando si passa ad altre riflessioni. L’opera lirica per parte sua si presenta, quindi, come un prodotto complesso per le sfaccettature artistiche e culturali, dove entrano musica, recitazione, e anche tensione dell’oggetto (certo più avvertita all’epoca delle prime rappresentazioni che oggi e in questo senso se ne comprende lo sforzo di renderla “attuale” sfrondandola di certe vetustà), che impone a chi la gusta conoscenza e informazione, in cui diviene importante anche cogliere aspetti di universalità che l’arte naturalmente possiede senza che nessuno debba necessariamente prendere per mano alcuno. Ma è anche un prodotto molto costoso rispetto al quale la politica, soprattutto in Paesi come l’Italia che si distinguono per mancanza di risorse a fronte di un ingente patrimonio culturale da conservare, non può essere assente. Ed è proprio questo aspetto su cui è continuata la diatriba del festival pucciniano, quando da qualche parte politica si è domandato ai responsabili quanto era costata, chi ha speso e chi ha guadagnato. I fatti inconfutabili sono che un’orchestra (che non può essere sostituita da una base musicale) e un coro sono composti rispettivamente dagli ottanta ai cento elementi, che vanno tutti regolarmente stipendiati tutto l’anno. Direttore, regista e cantanti sono retribuiti in base alle loro tariffe e alla loro fama (ma anche per i comprimari, ossia i cantanti che svolgono ruoli secondari e di poche battute vanno rispettate le retribuzioni sindacali), poi in busta paga ci sono i figuranti ed eventualmente anche il corpo di ballo.
Ma dietro tutto ciò sta un’imponente macchina organizzativa fatta di macchinisti e di costumisti che lavorano tutto l’anno per preparare scene e costumi, i cui numeri sono rispettabili. Una guida del teatro Colon di Buenos Aires, il più grande dell’America latina, ci spiegava come la “pancia” del principale teatro argentino allungasse i suoi sotterranei fino al centro della capitale occupando qualche migliaio di lavoratori nel preparare scenari e costumi. Il Metropolitan di New York, il cui bilancio dovrebbe essere pari a quello dei dieci più grandi teatri del mondo (compresa la Scala), se non ricordo male dà lavoro a circa diecimila persone, ha una propria radio e trasmette le sue prime su settanta grandi schermi dei teatri del mondo in versione cinematografica, il tutto caratterizzato da una gestione altamente manageriale che punta a vendere fino all’ultimo biglietto il posto in teatro giacché la parola deficit in quei contesti economici è quasi sconosciuta, come pure il sostegno pubblico (lì certo non avrebbe spazio un regista per le cui fantasie i falegnami devono creare un centinaio di mani da issare sulle lance). In Italia, se i teatri lirici non fossero finanziati dallo Stato, dalle regioni e dai comuni, dovrebbero chiudere bottega. Ma anche su questo aspetto non sarebbe male mettere un po’ di ordine e tagliare spese superflue, soprattutto quelle relative alle scenografie, se non si vuole che un domani l’opera per mancanza di fondi si riduca a una rappresentazione concertistica (e ricordo che una volta, per ragioni professionali, il presidente di un teatro, disperato, me ne sottopose la gestione che era da mettersi le mani nei capelli per l’abbondanza di irregolarità amministrative e contabili oltre che ipotesi di reati penali di falso ideologico e materiale, cose che poi erano messe tutte al riparo destinando una decina di file omaggio a tutte le personalità che in modo o nell’altro avrebbero potuto mettere le mani nella gestione qualora qualcuno avesse fatto denunce).
Per finire, questo ci aiuta a capire perché il primo omaggio gli enti lirici lo debbano alla politica. Ma pure tutta l’arte deve inchinarsi a questa, che un po’ spiega l’esistenza dell’omologazione culturale e la scarsa produttività. Politica che significa troppe cose. Prima di tutto consenso, che avviene soprattutto interferendo nelle scelte di chi deve produrre e interpretare (dai sovrintendenti e i direttori artistici ai cantanti e agli orchestrali); poi significa “politicamente corretto”, che non è sbagliato in senso assoluto ma è giusto solo nella misura in cui è opportuno porre standard e barriere a chi vorrebbe riportare indietro le lancette dell’orologio delle conquiste sociali o toccare argomenti delicati in modo dissacrante qualora questo avvenisse, ma lo è quando si scade nel luogo comune e nella spocchia intellettuale. Politica è, infine, anche il tentativo di svuotare il prodotto artistico e culturale, strumentalizzandolo in funzione di una polemica politica contingente, come i casi che abbiamo illustrato.
Andando un po’ alle conclusioni, non si può evitare di chiedersi a chi e a che cosa giovi la politicizzazione costante nell’uso dei beni culturali. Di sicuro non aiuta a formare il consenso giacché il pubblico che frequenta, per esempio, i musei (non parliamo degli occasionali turisti che visitano di corsa senza vedere nulla) e ancora di più i teatri dell’opera, è un pubblico prevalentemente conservatore in materia di gusti culturali che poi orienta il suo voto a destra nella misura in cui ritiene che “conservare” sia sempre meglio in qualsiasi campo, soprattutto in economia, e a sinistra in virtù del fatto che in quest’area comunque si raccoglie la maggior parte dell’intellighenzia nazionale. Quindi a poco serve la produzione di significati modernisti e accattivanti intorno ai lavori di autori che il più delle volte hanno elaborato cose ben precise, assestate nella storia della cultura e del pensiero a fronte di un pubblico già inquadrato ideologicamente, o almeno il gioco non vale la candela. Nessun tardo epigono della contestazione sessantottina sposterà un voto dalla sua parte del pubblico che si reca a Torre del Lago per gustare le melodie pucciniane, come nessuno è così sprovveduto culturalmente da votare a destra solo perché un ministro si è lanciato ad affermare che Dante Alighieri è all’origine di quel tipo di cultura e pochi staranno perplessi se entrare o meno in un museo perché la pubblicità stabilisce che Caravaggio è sempre attuale e moderno. Ma il danno che fa un siffatto approccio politico superficiale a un settore come quello dell’opera lirica, come abbiamo visto, oltre che creare disgusto e confusione, è incommensurabile.
In conclusione, possiamo dire che la politica ha sempre intrecciato la sua storia con quella dell’arte e dello spettacolo. Almeno da quando Il consigliere di Augusto, Mecenate, finanziava le arti e gli artisti e, prima ancora, i governanti di tutti i Paesi facevano sforzi immensi per lasciare ai posteri tracce del loro passaggio, da Ramses II a Pericle. Anche la storia del grande patrimonio artistico italiano si snoda lungo le sorti delle dinastie che hanno governato il Paese, come quella dei Medici a Firenze e dei Papi e dei grandi cardinali a Roma, che amavano le grandi realizzazioni architettoniche e solevano circondarsi di artisti e di opere d’arte. Egualmente noto è che tutto ciò fu reso possibile dalla floridezza delle casse statali, dai traffici e dei commerci (come fu per i mercanti veneziani e liguri o i banchieri fiorentini e lombardi imitati oggi dalle aziende che nel mondo occidentale detraggono dalle tasse gli investimenti in campo culturale, laddove è possibile, come in Italia grazie alla legge cosiddetta del mecenatismo) o quanto meno dell’entità delle altrui ricchezze depredate (come fecero l’Inghilterra coloniale e la Francia napoleonica, a tacere della Germania nazista) o delle elemosine dei fedeli con l’obolo di San Pietro, senza dimenticare le popolazioni sottomesse che venivano tartassate e ridotte alla fame per consentire queste realizzazioni. Il patrimonio artistico, dunque, è anche questo. Quando guardiamo incantati le grandi opere del passato spesso dimentichiamo quale fermento ci fosse dietro, e con esso anche lavoro servile sottopagato, schiavitù e sacrificio di vite umane e ancora meno opposizioni parlamentari, uffici di bilancio o corti dei conti che imponessero un alt alle spese. Rispetto a tutto questo il presente, anche con le sue basse e meschine strumentalizzazioni politiche, dal punto di vista dell’etica pubblica ha fatto dei passi in avanti. Oggi, l’interesse politico appare volgersi essenzialmente in due direzioni: occupazione di posti e poltrone e raccolta del consenso.
Dal primo punto di vista si va incontro alla comprensibile esigenza di attori, cantanti e artisti in genere di lavorare, ossia di campare e vendere il proprio prodotto. Perciò, sapendo che il potere politico può soddisfare meglio di altri questa necessità, costoro si prestano facilmente a iscriversi ai partiti, alle associazioni politiche e culturali che gravitano intorno alle forze politiche, ad accettare candidature alle elezioni o esibirsi gratuitamente alle feste di partito, e così via. Per gli artisti ciò significa aggiungere lavoro alla gavetta e ai compromessi cui occorre assoggettarsi per raggiungere la vetta o semplicemente per lavorare. E allora, esclusi i grandi protagonisti della scena internazionale che hanno un loro mercato e che non si fanno avvicinare abitualmente dai politici (a meno che non siano di altissimo livello, come capita nelle campagne presidenziali americane in cui scendono in campo i grossi calibri di Hollywood o del rock internazionale), la disponibilità a frequentare a farsi vedere in giro con costoro accade anche ai livelli più elevati di direttori di musei, sovrintendenti e direttori d’orchestra, aspiranti consiglieri di amministrazione e direttori di enti lirici, musei, festival, rassegne culturali e artistiche, premi letterari, ecc. che per coltivare meglio le relazioni si prestano a fare da spettatori e da claque nelle riunioni e nelle assemblee di partito o da testimonial alle esibizioni degli sponsor politici in cui fanno da volto rassicurante e popolare con la loro presenza. E proprio con queste ultime attività la variabile (o intrusione) politica funziona da catalizzatore di consenso: farsi vedere in giro negli eventi e nella massima confidenza con i beniamini del pubblico indubbiamente fa salire la popolarità del politico che ne sfrutta la luce riflessa.
Un discorso particolare, che prescinde dal coinvolgimento più diretto dei protagonisti dello spettacolo, è quello che coinvolge la cultura più in generale per fissare o rovesciare tavole di valori, nel qual caso gli esponenti della cultura coinvolti non debbono recitare un ruolo passivo bensì quello più attivo di innovatori di modi di essere e di apparire nella società, dettare mode, imporre nuovi linguaggi, ecc. Abbiamo visto che una sorta di discriminante in questo campo è data dalla costruzione e dalla fissazione di limiti attraverso il “politicamente corretto” da parte soprattutto delle forze progressiste. Questa prassi si è imposta nella società tradizionale in questi ultimi decenni con la forza dei produttori della cultura, dell’arte e dello spettacolo, per lo più in veste di avanguardie culturali nei temi e le battaglie più disparate riguardanti l’aborto, la liberazione della donna, i gay, la salvaguardia del pianeta e del clima, ecc. Queste avanguardie hanno sorvegliato che fosse fissata anche informalmente e mai superata una sorta di soglia, nel linguaggio e nei concetti comuni, al di sotto della quale non si sarebbe mai dovuto scendere, ma hanno determinato anche una reazione opposta nei settori non solo più conservatori, ma anche quelli più semplicemente infastiditi dall’omologazione culturale che si veniva così a creare e che politicamente cercavano di imporre le correnti progressiste. In questo modo tutto il discorso politico viene riportato alla dicotomia conservazione/progresso nella diatriba destra/sinistra in cui ciascuna di queste ultime categorie, in realtà, cerca di rovesciare l’altra a proprio favore (e allora sarà interesse dei partiti conservatori, per esempio, dimostrare che tali sono solo quelle che si ispirano alle ideologie otto/novecentesche ormai passate di moda e quelli di opposizione cercare di convincere l’elettorato che le prime fanno solo della archeologia politica). In questo caso diviene fondamentale soprattutto il ruolo di registi e attori di quel grande strumento che è il cinema in cui il ribaltamento di convincimenti generali può essere studiato a tavolino e degli opinionisti che, attraverso lo strumento della vecchia carta stampata o quello più nuovo del web o dei media, possono orientare il lettore o l’ascoltatore da una parte o dall’altra.
Quindi che fare, se non accettare realisticamente e il meno acriticamente possibile la variabile politica nell’arte e nella cultura cercando di tutelare il più possibile la libertà artistica e mantenere la propria indipendenza di giudizio senza perdere il gusto per il bello e l’umano che tutto ciò offre?
Dialoghi Mediterranei, n. 63, settembre 2023
Note
[1] La strategia di occupazione del potere della Democrazia Cristiana dal Dopoguerra fin dall’inizio colpì molti analisti politici, sia in ambito cattolico anche in senso critico come Ruggero Orfei, L’occupazione del potere. I democristiani ‘45/’75, Milano, Longanesi 1976; sia a sinistra, per esempio, con Giuseppe Tamburrano, L’iceberg democristiano. Il potere in Italia oggi domani, Milano, SugarCo, 1974.
[2] Nella “Proposta di progetto a medio termine” del Pci, Pubblicata da Editori Riuniti nel 1977, con introduzione di Giorgio Napolitano, si delineava già quel processo di cambiamento della società che il partito avrebbe avviato gli anni seguenti e, in particolare, parlando di educazione e cultura, dopo averli definiti “valori autonomi” e la seconda come “valore primario”, invita a «rompere con la tendenza a collocare le attività ai margini dello sviluppo del paese»: 28 (che in fondo era concezione marxiana della cultura come sovrastruttura). Nella seconda parte, “politiche dello sviluppo civile” il programma entra più nel dettaglio delle iniziative da adottare nella scuola, nell’università e nella cultura in genere.
[3] Federico Chabod, L’idea di nazione, Bari, Laterza 2023: 67. In realtà proprio nella parte finale del suo lavoro, lezioni tenute intorno al 1940, prima che si cogliesse in tutta la sua drammaticità l’estremizzazione dei nazionalismi, lo stesso storico avanza alcune riserve sulle derive di questa concezione. Nelle successive redazioni delle lezioni tenute nel 1940, lo stesso autore ha integrato chiarito meglio certe affermazioni perché non potessero mostrare ambiguità di sorta. Pertanto, ogni tentativo di trarre qualche legittimazione, sia pure indiretta, dalle analisi del grande storico mi sembra abbastanza inopportuna giacché le sue analisi sono volte solo alla ricostruzione del percorso storico che ha seguito l’affermazione dell’idea di nazione in epoca moderna, a partire dal Medioevo in poi, nel contesto culturale italiano e occidentale.
[4] Sull’avanzare nella società italiana di una cultura inizialmente fascista evolutiva, ma in realtà autoritaria e identitaria non è una scoperta recente. Già nel 1999 se ne accorse Roberto Chiarini, La lunga marcia della destra italiana. L’integrazione passiva di alleanza nazionale in “Nuova Storia contemporanea” Anno III n. 5 sett-ott.1999: 79-102, che passa da un ruolo antisistemico alla ricerca di una legittimazione all’interno del sistema con una propria cultura i cui riferimenti culturali sarebbero addirittura Tocqueville, Popper, Giddens, Touraine, Pasolini accanto ai tradizionali Celine, De Maistre, Nietzsche, Schmitt e altri.
[5] Ma, a prescindere che mentre capisco a che cosa servivano quelle due opere sopracitate intendo meno quale interesse possano avere i siciliani a recarsi così di fretta a Reggio Calabria e i calabresi a Palermo, quando le direttrici di movimento di queste due regioni dal Dopoguerra in poi sono chiaramente manifestate da Roma in su, dalle migrazioni agli affari, alla politica…perfino alla criminalità, la domanda sta sempre dove si troverebbero i soldi e capacità realizzatrici in una situazione politica, economica e sociale in cui le disponibilità finanziarie sono assolutamente inferiori da quelle che in proporzione caratterizzarono le varie compagini politiche e amministrative nel territorio in altre epoche storiche (pensiamo alla ricchezza dei banchieri lombardi e fiorentini, alla prosperità della repubblica veneziana, alle disponibilità pontificie per tacere delle risorse senza limiti degli imperatori romani). Troppo importante appare che molti oggi si chiedano se non ci sarebbero altre cose da fare prima sia in Sicilia sia in Calabria…ma è evidente che il bisogno di lasciare un’impronta vasta della propria esistenza e una traccia del passaggio di una cultura, prima di tutto politica, sia superiore a tutto e sia troppo importante per non apparire slegati da un passato con cui si vorrebbe rivendicare una continuità e fondare pure un’identità.
3 Nella Capitale, per esempio, gli amministratori si sono convinti che si poteva ovviare a questa contraddizione mettendo, come si suole dire, la polvere sotto il tappeto, ossia limitandosi a ripulire il centro storico in modo che tutta la città si specchiasse in esso pur lasciando la periferia nel degrado, magari nella speranza che lì non arrivasse alcuna traccia dei viaggiatori: non si erano fatti i conti che ormai nel centro si fermano solo i turisti benestanti, mentre gli altri, che costituiscono la maggior parte del flusso, preferiscono le sistemazioni logistiche più economiche che si trovano proprio nelle parti più periferiche di Roma che si vorrebbero nascondere perché è più evidente il degrado urbano, come mostra l’affollamento delle metropolitane e dei mezzi pubblici che da quelle portano i visitatori a Fontana di Trevi, a Piazza di Spagna, ecc..
[7] Aldo Aledda, Turismo e populismo culturale. Il caso dell’Opera lirica in “Dialoghi Mediterranei” n.50, settembre 2022.
[8] A onore del vero non tutte le produzioni dell’Arena di Verona hanno mostrato la tendenza a farsi manipolare da registi e commentatori tendenziosi, proprio quelle successive all’Aida si sono rivelate impeccabili e ineccepibili anche sotto il profilo registico e scenografico, segnatamente il Barbiere di Siviglia di Rossini e la madama Butterfly e la Tosca di Puccini, rispetto alle quali registi e scenografi si sono rivelati veramente un valore aggiunto.
_____________________________________________________________
Aldo Aledda, studioso dell’emigrazione italiana con un’ampia esperienza istituzionale (coordinamento regioni italiane e cabina di regia della prima conferenza Stato-regioni e Province Autonome -CGIE), attualmente è Coordinatore del Comitato 11 ottobre d’Iniziativa per gli italiani nel mondo. Il suo ultimo libro sull’argomento è Gli italiani nel mondo e le istituzioni pubbliche (Angeli, 2016). Da attento analista del fenomeno sportivo ha pubblicato numerosi saggi e una decina di libri (tra cui Sport. Storia politica e sociale e Sport in Usa. Dal big Game al big Business, finalisti premio Bancarella e vincitori Premio letterario CONI); ha insegnato Storia all’Isef di Cagliari e nelle facoltà di Scienze motorie a Cagliari, Roma e Mar del Plata in Argentina.
______________________________________________________________