di Maria Rosaria La Morgia
«Sia che si consideri l’Italia dall’alto verso sul basso sia da occidente verso oriente e viceversa, il centro che separa e insieme unisce le due parti, il giunto che con la propria stabilità e il proprio carattere massivo e al tempo stesso sintetico e inclusivo garantisce la distinzione e la possibilità di dinamica articolazione, di movimento dunque, tra le differenti parti o sezioni è l’Appennino abruzzese».
Dell’importanza della montagna e, in particolare, dell’Appennino abruzzese Franco Farinelli si è occupato in molti suoi scritti, tra gli ultimi il volume “La lezione dell’Abruzzo” (edito da Textus). Farinelli è uno dei più importanti geografi italiani, per molto tempo ha insegnato all’estero, in Europa e nelle Americhe, radici abruzzesi è nato a Ortona, è stato ordinario di Geografia all’Università di Bologna dove ha anche diretto il dipartimento di Filosofia e comunicazione. Professor Farinelli la “centralità” dell’Appennino abruzzese non è solo geomorfologica?
«Cominciamo col dire che per comprendere la montagna abruzzese bisogna far giustizia dei luoghi comuni che ancora circolano a proposito, più in generale, della montagna mediterranea. E che rimontano al troppo fortunato schema messo a punto da Fernand Braudel nella sua opera-della-vita, quel Il Mediterraneo e il mondo mediterraneo all’epoca di Filippo II apparso all’inizio della seconda metà del secolo passato: opera che Delio Cantimori giudicava il “Via col vento” dal punto di vista delle fonti storiografiche, e che anche sotto il profilo della realtà geografica lascia molto a desiderare. E dove l’Abruzzo figura come parte di un dominio d’altitudine la cui unica funzione è quella di essere “rifugio contro i soldati e i pirati”, cioè “mondo a parte dalle civiltà”, dunque “costretta a vivere delle proprie risorse”, in assenza “dei contatti e degli scambi fuori dai quali non c’è civiltà rinnovata”. Diciamolo perciò subito: nel caso abruzzese sono quasi inservibili le tradizionali categorie che fin qui hanno governato la riflessione storiografica relativa all’antico “Mare Nostrum”, e sono difficilmente applicabili senza correttivi anche quelle valide per il complesso del nostro Mezzogiorno. È vero che l’arco appenninico abruzzese include le montagne più alte e impenetrabili dell’Italia peninsulare, e costituisce nel complesso la maggior massa montuosa della catena. Il predominio locale dei grandi e compatti individui orografici è così pronunciato che Ignazio Silone considerava i singoli massicci (“i personaggi più prepotenti della vita abruzzese”) i veri protagonisti della storia della regione, agenti arcigni del suo isolamento e del suo interno frazionamento, della sua intima mancanza di unità e di conseguenza della sua strutturale estroversione: al punto che l’autentico centro funzionale della regione (Napoli, Roma) è sempre risultato esterno alla regione stessa. Tutto ciò è vero, ma allo stesso tempo le cose sono un po’ più complicate, È vero cioè che il rilievo rappresenta la ragione più profonda della vita della nostra regione. Al suo interno però la compartimentazione e lo spezzettamento delle cellule fisiografiche non si traducono affatto nell’isolamento, come Braudel e Silone vorrebbero. Questo è vero soltanto a scala intraregionale. A scala interregionale, invece, ne risulta la più energica immissione dello spazio abruzzese all’interno dei grandi circuiti economici e culturali mediterranei ed europei, oltre che italiani. Basti soltanto pensare alla fondazione dell’Aquila, la nascita cioè intorno alla metà del Duecento e nel cuore del dominio montano ma lungo la “via degli Abruzzi”, l’arteria angioina dell’oro e della lana, di un vero comune d’impianto borghese: il fatto politico-sociale più atipico di tutto il meridione di quel tempo, come ha fatto rilevare Francesco Sabatini. Oppure basterà ricordare il pieno inserimento della montagna aquilana nella grande rete moderna delle merci e della moneta, come attestato nel Cinquecento dalla presenza nel capoluogo delle agenzie dei Fugger e dei Welser, cioè dei più importanti banchieri dell’epoca, attirati dallo zafferano e dalla ricchezza dell’industria armentaria: ricchezza che sugli Altipiani Maggiori d’Abruzzo, continuerà fino al Settecento a depositarsi, come a Pescocostanzo, nella crescente magnificenza delle chiese. E si potrebbe davvero continuare nel citare prove del fatto che, se poco poco la considerazione esce dal riduttivo e interno aspetto topografico, la centralità della regione abruzzese non è di natura semplicemente fisiografica, ma storica, economica e culturale “a parte intera”, come Braudel avrebbe detto».
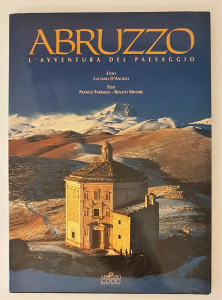 Negli scritti e nelle interviste lei più volte ha parlato di paesaggio. E ha dedicato molta attenzione al versante meridionale del Gran Sasso, all’altipiano di Navelli, ai campi aperti. Che cosa ci raccontano e qual è oggi il loro significato?
Negli scritti e nelle interviste lei più volte ha parlato di paesaggio. E ha dedicato molta attenzione al versante meridionale del Gran Sasso, all’altipiano di Navelli, ai campi aperti. Che cosa ci raccontano e qual è oggi il loro significato?
«Il versante meridionale del Gran Sasso è l’esempio di una sistemazione insediativa unica in tutto l’ambito mediterraneo. A 1500 metri d’altezza ci sono da secoli comunità vivacissime e il paesaggio continua a restituirci un’organizzazione che altrove è stata completamente cancellata, quella dei campi aperti. Una struttura fondata sulla solidarietà, viene usata secondo le esigenze della collettività (diritto di passaggio, irrigazione ecc.), non è mai soltanto privata: i confini esistono in quanto vengono trasgrediti collettivamente. Si tratta di forme consuetudinarie e comunitarie che sono state fondamentali. Ci sono i campi aperti, ma c’è anche il grande tratturo che li attraversa ovvero qui c’è stata una coesistenza tra stanziali e nomadismo. Quel contrasto feroce che nei secoli ha animato tutto il Mediterraneo, il conflitto tra agricoltori e pastori, ha trovato una conciliazione formidabile in Abruzzo. C’è, dunque, un’archetipica capacità di conciliare due generi di vita che altrove hanno prodotto effetti cruenti».
Lei ci sta dicendo che la montagna abruzzese con la sua storia può aiutarci a trovare nuovi modelli di vita. Dobbiamo essere capaci di reinventare. Più volte lei ne ha parlato, ha scritto che la globalizzazione ci ha costretto a reinventare la Terra, in che senso?
«La vera rivoluzione è avvenuta nel luglio del 1969: mentre tutti stavamo col naso all’insù per contemplare lo sbarco sulla Luna, due computer iniziavano a dialogare, tra Washington e Los Angeles si scambiavano dati. Nasceva la rete, il dispositivo che ha distrutto l’assetto moderno del mondo costringendoci a fare i conti con il fatto che la terra è funzionalmente una sfera. Oggi spazio e tempo sono residuali, l’economia del mondo funziona all’unisono come un tutt’uno. Ci sono ancora i bilanci statali, ma non esiste l’economia statale. Oggi non c’è Stato che non sia in crisi in quanto ‘Stato’. Uno dei primi effetti della globalizzazione è la scoperta che la gente si muove, mentre tutta la modernità si è fondata sul presupposto che il soggetto stesse fermo. Il nostro pensiero è ancora legato alla mappa, è ancora bidimensionale, invece abbiamo bisogno di pensare in termini sferici e per farlo dobbiamo tornare agli antipodi. Occorre riconcettualizzare il nostro pianeta e resettare gli elementi rimettendoli insieme in forma diversa. È un compito enorme, ma per rovesciare un modello devi capire come è fatto, si tratta di attingere al passato».
 Che ruolo potrebbero avere le montagne e i luoghi interni, marginalizzati dalla modernità, in questa fase di crisi del nostro modello di sviluppo?
Che ruolo potrebbero avere le montagne e i luoghi interni, marginalizzati dalla modernità, in questa fase di crisi del nostro modello di sviluppo?
«Il versante meridionale del Gran Sasso è la sede di una particolarissima architettura campestre e di una sistemazione insediativa unica, per motivazioni allo stesso tempo storiche e geografiche, in tutto il Mediterraneo, un complesso che combina lineamenti molto diffusi in passato nelle pianure dell’Europa continentale con una morfologia davvero unica. Verso il culmine calcareo delle tre cordigliere abruzzesi (così, per la loro vicinanza al mare le chiamava Mario Ortolani, da cui ho appreso la geografia della mia regione) il coltivo è disarticolato in senso verticale da una minuta tettonica di frattura, e l’intervento successivo del carsismo ne ha esasperato lo smembramento, attraverso la moltiplicazione su vari livelli di piccoli e grandi bacini chiusi alluvionati, che salgono dai 950 m nel territorio di Calascio ai 1700 della Fossa di Paganica e localmente sono chiamati “piani”: veri e propri agri alimentari, che assicurano sul loro orlo la vita di popolosi villaggi a quote che di norma sono deserte o scarsamente abitate in tutta l’area mediterranea. È il trionfo del paesaggio dell’openfield, come viene chiamato nella letteratura internazionale, dei “campi aperti”, che distinguono lo stile insediativo dell’intero dominio montano dell’Abruzzo: quasi totale assenza di case sparse, abitati accentrati, assenza di recinzioni di qualsivoglia natura tra un campo e l’altro, foggia tendenzialmente nastriforme, spesso molto accentuata, degli appezzamenti. Dal punto di vista genetico tale paesaggio riflette un sistema agronomico e un complesso di rapporti di produzione fondato su pratiche comunitarie (rotazione obbligatoria delle colture) e sulle connesse servitù (di passaggio, di pascolo, d’irrigazione) d’origine medievale, altrove da tempo scomparse ma che qui, seppure in veste residuale e fossilizzata, ancora permangono, o almeno hanno lasciato tracce ancora molto evidenti. È davvero un peccato che non sia mai stato fatto nulla per la preservazione di questo scenario davvero unico al mondo. E lo stesso discorso vale, sempre sul versante meridionale del Gran Sasso, per lo spettacolo (che l’occhio esperto ancora coglie, specie tra Navelli e Barisciano) dei campi aperti compiantati a mandorlo fiduciosamente allineati lungo i bordi del grande tratturo che dall’Aquila conduceva a Foggia, il cui profilo è ancora a brani leggibile. Anche in questo caso, alla base di tale originalità, anzi unicità, vi è la particolare complessiva architettura della nostra regione, cui si aggiunge quella delle regioni circostanti: la prossimità delle ampie e vuote distese erbose della Puglia e del Lazio ha molto attutito in passato la feroce rivalità tra contadini e pastori altrove (si pensi all’esempio sardo) invece molto diffusa. Un esempio di come l’archetipica capacità abruzzese di conciliare generi di vita differenti si fondi non soltanto su di una specifica e articolata complessione territoriale, ma anche sulla strutturale apertura verso l’esterno dell’intero quadro regionale. Tutte realtà che oggi andrebbero riapprese, perché distruggendo gli spazi statali, la globalizzazione che avanza ci risospinge per un verso in direzione delle culture e dei valori locali, vale a dire in direzione della rivalorizzazione degli antichi modelli. Se non altro dal punto di vista della ricostituzione di una autentica memoria territoriale da interrogare per far fronte al nuovo che avanza. Come ha scritto Edgar Morin: “tutto ciò che esiste è l’improbabile che hic et nunc diventa necessario”. Vale a dire: l’unica possibilità che abbiamo, in termini collettivi, per limitare l’imprevedibilità dei guai consiste nel fare il più possibile chiarezza sulle ragioni costitutive non soltanto del presente, ma anche dei luoghi. Far fronte al globale vuol dire prima d’altro riformulare il rapporto tra i luoghi e lo spazio. E per far questo abbiamo urgenza di ricostituire tutta la nostra memoria».
 Lo spopolamento delle zone interne rappresenta un problema grave e una grande sfida al nostro modello di civiltà. Da non più di vent’anni se ne parla, si sono susseguite diverse iniziative, ma le politiche territoriali o non ci sono state o si sono rivelate inadeguate. La pandemia e il ricorso al lavoro a distanza hanno rilanciato un dibattito che sembra asfittico nella sua retorica del ritorno ai paesi. Lei che ne pensa?
Lo spopolamento delle zone interne rappresenta un problema grave e una grande sfida al nostro modello di civiltà. Da non più di vent’anni se ne parla, si sono susseguite diverse iniziative, ma le politiche territoriali o non ci sono state o si sono rivelate inadeguate. La pandemia e il ricorso al lavoro a distanza hanno rilanciato un dibattito che sembra asfittico nella sua retorica del ritorno ai paesi. Lei che ne pensa?
«Come sempre accade, bisogna distinguere. Wittgenstein sosteneva che “le parole sono una pellicola sotto la quale si agita un’acqua profonda”. Il limite consiste nel pensare ai paesi (ai luoghi) come se nulla dovesse cambiare, cioè nell’illusione che esistano porzioni magari piccole del mondo dove il suo funzionamento possa essere diverso da quello che vale altrove, al riparo. Questo di certo non si dá, proprio perché oggi vivere in città o in campagna non è dal punto di vista dei servizi così differente com’era una volta. E questo accade perché sia la città che la campagna, sia la pianura che parte della montagna sono catturate all’interno di un’unica Rete. Così si crede che sia funzionalmente equivalente una collocazione rispetto all’altra, mentre resterebbe alquanto diversa la qualità della vita di campagna rispetto a quella urbana sotto il profilo della disponibilità dei beni non riproducibili già citati. Il che è vero, almeno per il momento, a patto però di mantenere coscienza dell’unicità del dominio informatizzato e del suo ruolo preponderante che perciò sorpassa ed avvolge, cioè determina, ogni restante aspetto della vita, imponendo la necessità di una nuova visione del mondo in grado di ricomprendere all’interno di un’unità le diversità funzionali del mondo di ieri che non esiste più, e che non può tornare. Il passato ci affascina soltanto perché già sappiamo come va a finire, cioè perché ci lascia tranquilli. Ma bisogna pensare il futuro, che già esiste e non riusciamo ancora a scorgere proprio perché pensiamo secondo i vecchi termini. Il telelavoro segnala appunto l’avvento di una nuova modalità di stare al mondo, la comprensione e l’accettazione della quale implica una serie di irreversibili modifiche strutturali del nostro agire e delle nostre modalità di relazione. Tali modifiche richiedono logiche e comportamenti irriducibili all’estensione o alla generalizzazione degli atteggiamenti che già conosciamo. A proposito di retorica (e del senso profondo delle parole) esiste oggi anche quella relativa al “nuovo Rinascimento” verso il quale saremmo incamminati. Essa è cattiva nella misura in cui non ci si preoccupa di specificarla, e funziona da semplice alone suggestivo. Ma per un verso coglie nel vero, quando si richiama ad un’epoca, quella tra Quattro e Cinquecento, in cui il pensiero riuscì davvero, muovendo dal materiale impatto rivoluzionario di nuove tecnologie, a produrre i nuovi modelli teorici e i nuovi assetti pratici di cui l’umanità (almeno quella occidentale) aveva bisogno. Oggi dovremmo fare lo stesso».
È possibile pensare a un modello di territorio unitario non pensando più montagna e città in contrapposizione o in alternativa?
«Certo che è possibile. Se pensassimo il contrario saremmo già finiti. Si spiegava già nel Codice di Diocleziano: il territorio è l’ambito definito dall’esercizio del potere politico. Ne va dunque della esistenza di quest’ultimo. L’idea che oggi abbiamo del rapporto tra città e campagna deriva in sostanza dal marxismo e dal maoismo del secolo scorso, per i quali la loro relazione era univoca, e fondata sullo sfruttamento della seconda da parte della prima. Il che per l’epoca moderna è in buona parte vero. Ma in precedenza, a partire dall’antichità, altri modelli funzionavano, e ancora oggi in molte parti del mondo funzionano. E nella misura in cui, in generale, sia la campagna che la città sono sottomesse al controllo della stessa Rete, sono ambedue condizionate da un ambito rispetto al quale la loro storica differenza perde molto del suo valore, a parte quello topografico. D’altronde, constatare oggi che la maggior parte della popolazione mondiale abita in città significa già riconoscere in sostanza che tra città e campagna non vi è più nessuna differenza sostanziale. Il che non è certo una novità assoluta. Nella regione dove abito, l’Emilia-Romagna, fino ad un secolo fa ad esempio le campagne erano molto più industrializzate delle città, e questo fin dall’epoca romana. Città e campagna insomma sono l’effetto di polarizzazioni territoriali mutevoli nel corso del tempo, e non è vietato pensare che di qui a qualche tempo esse saranno sostituite da altri concetti, dal riconoscimento di altre forme di realtà. Spero anzi, per il futuro dell’intelligenza umana, che sia proprio così».
La rilettura del paesaggio può aiutare ad affrontare il futuro con più conoscenze, con più sapienza?
«È l’unica possibilità che abbiamo, l’unica via d’uscita. Se noi fossimo in grado di leggere quelle forme che oggi sopravvivono di ciò che è stato e di comprenderle per reinventarle saremmo davvero a buon punto. Qui però si apre un altro discorso e riguarda sia la crisi del pensiero europeo che l’abisso che si è spalancato tra la conoscenza e la politica».
Dialoghi Mediterranei, n. 53, gennaio 2022
______________________________________________________________
Maria Rosaria La Morgia, giornalista professionista, laureata in Filosofia (Roma – La Sapienza), ha lavorato in Rai fino al 2017, prima come programmista – regista dopo essere stata tra i vincitori del concorso del 1978, poi come giornalista nella redazione Tgr di Pescara e per un breve periodo anche in quella del TG2 a Roma. Tra le pubblicazioni: Contributo alla storia orale delle contadinanze frentane (Rivista Abruzzese 1978); C’era una volta l’Abruzzo (Medium 1985); La Buona Salute, medici medicina e sanità nell’intervista con Silvio Garattini (Tracce 1997); Terra di Libertà, coautrice con Mario Setta (Tracce 2015); Sul cammino della modernità, a cura di Franca de Leonardis e Fabrizio Masciangioli (Rubbettino 2017). Attualmente è cultrice della materia presso la cattedra di Antropologia culturale dell’Università D’Annunzio, collabora con le riviste Leggendaria e Rivista Abruzzese, è presidente dell’Associazione Culturale “Il Sentiero della Libertà – Freedom Trail”.
_____________________________________________________________










