di Enzo Pace
Le Nouvel Observateur del 22 novembre scorso ha pubblicato una densa intervista di Farhad Khosrokhavar su quanto accade in Iran. Khosrokhavar, sociologo di origini iraniane e dal 1998 directeur d’études all’école des hautes études di Parigi, torna a riflettere su un tema a lui caro: la tanatocrazia del regime degli ayatollah. Ne aveva parlato già nel libro L’islamisme et la mort (1995) e nell’altro Les nouveaux martyrs d’Allah (2002, tradotto in italiano). In questo ultimo testo egli aveva coniato la nozione di martiropatia, una malattia sociale i cui primi sintomi si manifestano durante la (vera) prima guerra del Golfo, quella fra Iran e Iraq (1980-88), scoppiata appena un anno dopo l’instaurazione della Repubblica islamica sotto la guida di Khomeyni.
Nell’intervista, Khosrokhavar ricorda che l’ideologia di morte ispira sin dall’inizio il regime nato dalla rivoluzione del 1978. La radice va cercata nell’escatologia sciita, in particolare nella dottrina teologica dell’imam nascosto. Vale la pena ricordarne alcuni fondamentali dogmi, che il sociologo franco-iraniano per ragioni di spazio non ha potuto richiamare.
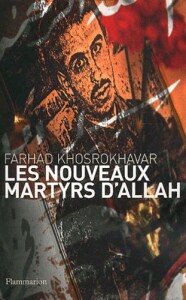 Con la sconfitta militare subita dal partito di ʽAli (shiat ʽAli, da qui il nome sciiti) nel 680 della nostra era si chiude la grande discordia (al-fitna al-kubra) sulla successione del Profeta Muhammad, morto nel 632. Essa produce una frattura a tutt’oggi insanabile della prima comunità musulmana, quella fra i sunniti e appunto gli sciiti (circa il 10% degli 1,8 miliardi di persone di fede islamica nel mondo). Questi ultimi, sconfitti, vivranno per un lungo tempo (circa duecento anni) in clandestinità ai margini territoriali dei primi imperi musulmani. Si rifiuteranno di chiamare i loro capi califfi per sottolineare la distanza dai loro avversari sunniti. Preferiranno quello di imam. Questa parola in arabo significa “colui che sta davanti”, una guida. Nel sunnismo l’imam è un funzionario che ha il compito di guidare la preghiera collettiva. Per gli sciiti, l’imam, invece, è al tempo stesso guida spirituale e politico, capo supremo, depositario del potere religioso e di quello mondano. Un potere ab-solutus, nel senso pieno del termine, giacché trasmesso per linea di sangue direttamente da Muhammad a suo cugino e cognato ʽAli, sposo di Fatima, figlia del Profeta.
Con la sconfitta militare subita dal partito di ʽAli (shiat ʽAli, da qui il nome sciiti) nel 680 della nostra era si chiude la grande discordia (al-fitna al-kubra) sulla successione del Profeta Muhammad, morto nel 632. Essa produce una frattura a tutt’oggi insanabile della prima comunità musulmana, quella fra i sunniti e appunto gli sciiti (circa il 10% degli 1,8 miliardi di persone di fede islamica nel mondo). Questi ultimi, sconfitti, vivranno per un lungo tempo (circa duecento anni) in clandestinità ai margini territoriali dei primi imperi musulmani. Si rifiuteranno di chiamare i loro capi califfi per sottolineare la distanza dai loro avversari sunniti. Preferiranno quello di imam. Questa parola in arabo significa “colui che sta davanti”, una guida. Nel sunnismo l’imam è un funzionario che ha il compito di guidare la preghiera collettiva. Per gli sciiti, l’imam, invece, è al tempo stesso guida spirituale e politico, capo supremo, depositario del potere religioso e di quello mondano. Un potere ab-solutus, nel senso pieno del termine, giacché trasmesso per linea di sangue direttamente da Muhammad a suo cugino e cognato ʽAli, sposo di Fatima, figlia del Profeta.
Gli sciiti, dopo la débacle subito dall’esercito sunnita, non si disperderanno; continueranno a sperare nella rivincita, affidandosi alla guida degli imam che si succederanno dal 680 all’874, per linea di parentela maschile: dal primo ʽAli ai suoi due figli Hasan e Huseyn (questi sarà ucciso nella battaglia di Kerbala nel 680 e sarà d’allora, assieme alla figura paterna, considerato martire della causa sciita) sino al dodicesimo. Quest’ultimo salirà al potere ancora bambino e nell’874 morirà in circostanze oscure. Non aveva, dunque, un successore legittimo. Un’altra prova drammatica per una minoranza malvista e perseguitata. Di nuovo, per la comunità sciita poteva essere l’inizio della sua fine, invece, la solidarietà di gruppo prevarrà grazie al rito e al mito: da un lato, le pratiche rituali che fanno memoria del martirio dei capi e, dall’altro, il racconto escatologico secondo cui l’ultimo imam non è morto, ma si è solo occultato alla vista degli esseri umani. Un giorno tornerà a rendersi visibile nella figura apocalittica del Salvatore (al-Mahdi), l’imam degli Ultimi Tempi, quando l’umanità sarà chiamata al giudizio finale e agli sciiti sarà resa giustizia.
 La passione e morte dei capi-martiri sono ancora oggi celebrati durante il mese di Muharram con un’intensità emotiva che per tredici giorni è raccontata e messa in scena in tutti i suoi drammatici eventi nelle hussayniye (oratori destinati proprio alla commemorazione e alla lettura della passione dei martiri) [1]. Sia le pratiche di autolesionismo (autoflagellazione), proibite per legge in Iran, ma non negli altri Paesi dove lo sciismo è presente, come, per esempio, in Iraq o in Bahrein e in Arabia Saudita, dove nelle regioni orientali di al-Qaif e al-Hasa si concentra il 15% della popolazione sciita del Regno, sia il rituale del battersi fortemente il petto da parte di giovani uomini disposti in cerchio, strettamente uniti, sono espressioni di solidarietà nel dolore e nel lutto per la perdita dei loro capi. Nelle processioni che si svolgono nelle vie dei principali quartieri e dei borghi risuona il grido secco dei battenti e dei flagellanti (laddove possono ancora ferirsi con fruste e lame taglienti): eccoci siamo pronti al sacrificio.
La passione e morte dei capi-martiri sono ancora oggi celebrati durante il mese di Muharram con un’intensità emotiva che per tredici giorni è raccontata e messa in scena in tutti i suoi drammatici eventi nelle hussayniye (oratori destinati proprio alla commemorazione e alla lettura della passione dei martiri) [1]. Sia le pratiche di autolesionismo (autoflagellazione), proibite per legge in Iran, ma non negli altri Paesi dove lo sciismo è presente, come, per esempio, in Iraq o in Bahrein e in Arabia Saudita, dove nelle regioni orientali di al-Qaif e al-Hasa si concentra il 15% della popolazione sciita del Regno, sia il rituale del battersi fortemente il petto da parte di giovani uomini disposti in cerchio, strettamente uniti, sono espressioni di solidarietà nel dolore e nel lutto per la perdita dei loro capi. Nelle processioni che si svolgono nelle vie dei principali quartieri e dei borghi risuona il grido secco dei battenti e dei flagellanti (laddove possono ancora ferirsi con fruste e lame taglienti): eccoci siamo pronti al sacrificio.
La dottrina della temporanea occultazione del dodicesimo imam sarà elaborata lungo un arco di quasi cento anni e servirà non solo a offrire una prospettiva escatologica a una comunità logorata dalle sconfitte e dalle violente umiliazioni patite da parte dei califfi sunniti, ma anche a legittimare la funzione di chi è investito del compito d’interpretare i segni che annunciano il ritorno dell’imam nascosto. Nel tempo intermedio dell’attesa dell’imam-Salvatore, un ceto di specialisti nella lettura dei segni di Dio (ayat Allah) si affermerà. La figura degli ayatollah si imporrà come il depositario di un potere e di un sapere religiosi fondamentale per il popolo credente; essi eserciteranno il loro potere vicario (in assenza dell’imam) in condizione di monopolio, giacché gli ayatollah svilupperanno una conoscenza esoterica dei significati nascosti nei sacri testi, una conoscenza, per definizione, non accessibile a tutti. Da qui, emergerà un’istituzione clericale, che non ha eguali nel mondo sunnita [2].
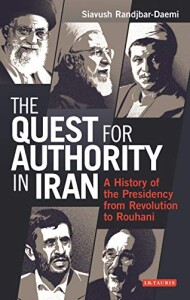 Ho voluto ricordare brevemente tutto ciò, perché nella storia religiosa dello sciismo, la figura degli ayatollah non è stata pensata all’inizio come quella di un teologo-giurisperito, gravato del compito non solo di leggere i segni dei tempi (ultimi), ma anche di stabilire il primato della legge di Dio sulle leggi degli uomini. Tale funzione emergerà molto più tardi, nel XVIII secolo.
Ho voluto ricordare brevemente tutto ciò, perché nella storia religiosa dello sciismo, la figura degli ayatollah non è stata pensata all’inizio come quella di un teologo-giurisperito, gravato del compito non solo di leggere i segni dei tempi (ultimi), ma anche di stabilire il primato della legge di Dio sulle leggi degli uomini. Tale funzione emergerà molto più tardi, nel XVIII secolo.
Anche quando lo sciismo sarà riconosciuto nel XVI secolo come religione di Stato dalla dinastia dei Safavide, che creerà un potente impero islamo-persiano dal 1501 al 1736, gli ayatollah ricopriranno un ruolo importante dal punto di vista spirituale e legale, ma tenendosi a debita distanza dalle stanze del potere. Acquisiranno in compenso beni immobili e terreni, otterranno finanziamenti da parte dello Stato, apriranno fondazioni caritatevoli e istituzioni di alta formazione in scienze religiose, saranno sì presenti come consiglieri ascoltati nelle corti degli shah (i re in persiano), ma non pretenderanno di sostituirsi al principe o all’imperatore nel governo politico dello Stato.
La svolta si verificherà, quando prevarrà la linea teologica e giuridica sostenuta dall’ayatollah Muhammad Akmad Bihbihani, detto l’Unico (Wahid) (1706-1791), il quale ridurrà al silenzio (anche con azioni di forza) le altre scuole di pensiero che allora esistevano tra in Iran, Iraq e Bahrein. Parliamo della disputa fra Usuli e Akhbari [3]. Ridotta all’essenziale, l’idea che passa e diventa egemone è che le due fonti del diritto islamico (Corano e Hadith, rispettivamente testo sacro e tradizione orale) possano essere interpretate, perché soprattutto la seconda fonte (Hadith) riflette diverse tradizioni ermeneutiche ed esegetiche spesso non concordi fra loro. Il giurisperito è chiamato, perciò, a fissare i principi generali (i fondamenti: usuli) del diritto religioso da cui poi derivare, grazie al ragionamento, la normativa da applicare ai casi che si presentano mutevolmente nella società umana nei tribunali e davanti al legislatore. Per garantire, tuttavia, che tale modo di procedere razionale possa essere ritenuto valido dal punto di vista teologico e non risultare arbitrario, Bihbihani sosteneva che fosse necessario affidarsi a una figura autorevole, a un primus inter pares, riconosciuto da tutti gli ayatollah come uomo pio, integerrimo, sapiente in teologia e in giurisprudenza.
 Viene disegnata così per la prima volta la figura del marja’ al taqlid (letteralmente colui che è degno d’imitazione), un conoscitore dei principi generali del diritto islamico, dotato di un particolare carisma che gli viene riconosciuto dalla comunità. Conseguenza: ogni interpretazione della Legge divina che tale personaggio stabilisce non deve essere considerata un parere autorevole, ma una decisione indubitabile. Chi ne dubitava era da considerarsi, secondo la scuola usuli, un miscredente (kafir), un apostata passibile di pena di morte. Tali idee si imporranno gradualmente, nel vuoto di potere che si creerà dopo la fine dell’impero safavide e troveranno udienza presso la corte della dinastia dei Qajar (1794-1925), grazie al ruolo giocato da un convinto seguace della dottrina usuli, Mulla Ahmadi Naraqi (1770-1830), a cui si deve l’idea che il giurisperito è un ispirato da Dio e che, dunque, ha il diritto-dovere di fare le leggi degli uomini. A lui si deve il principio del velayat-i faqih (del primato del giurisperito) che, a sua volta, Khomeyni eleverà a principio costituzionale della Repubblica islamica nel 1979.
Viene disegnata così per la prima volta la figura del marja’ al taqlid (letteralmente colui che è degno d’imitazione), un conoscitore dei principi generali del diritto islamico, dotato di un particolare carisma che gli viene riconosciuto dalla comunità. Conseguenza: ogni interpretazione della Legge divina che tale personaggio stabilisce non deve essere considerata un parere autorevole, ma una decisione indubitabile. Chi ne dubitava era da considerarsi, secondo la scuola usuli, un miscredente (kafir), un apostata passibile di pena di morte. Tali idee si imporranno gradualmente, nel vuoto di potere che si creerà dopo la fine dell’impero safavide e troveranno udienza presso la corte della dinastia dei Qajar (1794-1925), grazie al ruolo giocato da un convinto seguace della dottrina usuli, Mulla Ahmadi Naraqi (1770-1830), a cui si deve l’idea che il giurisperito è un ispirato da Dio e che, dunque, ha il diritto-dovere di fare le leggi degli uomini. A lui si deve il principio del velayat-i faqih (del primato del giurisperito) che, a sua volta, Khomeyni eleverà a principio costituzionale della Repubblica islamica nel 1979.
Ciò che vediamo oggi in Iran, dunque, non è il risultato di un avvitamento su se stesso di un regime teocratico sempre più autoritario. Piuttosto parlerei della parabola finale di un pensiero teologico che si è imposto in epoca moderna (dalla seconda metà del Settecento) su altre correnti di pensiero presenti ancora oggi nel mondo sciita e che ha finito per trasformare una rivoluzione politica di vasta portata, quella anti-Pahlavi fra il 1977 e il 1978, in un laboratorio costituzionale e sociale dove accelerare gli Ultimi Tempi, plasmando un uomo nuovo (che si redime e si prepara all’avvento del Salvatore) in una società del sacrificio in attesa di riscatto. Il riscatto sociale si sublima così in una società-monacale, dove prevale il lamento, il dolore, il vittimismo e dove i corpi (soprattutto, quello della donna) devono essere disciplinati, mortificati ad majorem Dei gloriam. La rivoluzione sociale castrata da Khomeyni non coinciderà certo con la spiritualizzazione della politica, che Michel Foucault [4], inviato speciale del Corriere della Sera a Teheran nei giorni dei grandi tumulti, vorrà vedere dietro i mantelli neri svolazzanti degli ayatollah.
 In verità, con la conquista a furor di popolo del potere da parte di Khomeyni, erano presenti tutti i germi di una necropolitica [5]. Khosokhavar la chiama tanatocrazia, ma, in buona sostanza, la stessa cosa, giacché l’ayatollah Khomeyni aveva in mente un progetto politico che incarnava (dalla carta costituzionale agli abiti del cuore e delle menti da inculcare con la disciplina di massa a tutto il popolo) l’unità spirituale e morale di una società adunata attorno a chi la conduceva verso il punto finale dell’avvento del Mahdi. La gloriosa rivoluzione politica per Khomeyni era un potente segno della fine della grande occultazione, la luce stava per trionfare sulle tenebre, non certo l’apertura di una via islamica alla democrazia.
In verità, con la conquista a furor di popolo del potere da parte di Khomeyni, erano presenti tutti i germi di una necropolitica [5]. Khosokhavar la chiama tanatocrazia, ma, in buona sostanza, la stessa cosa, giacché l’ayatollah Khomeyni aveva in mente un progetto politico che incarnava (dalla carta costituzionale agli abiti del cuore e delle menti da inculcare con la disciplina di massa a tutto il popolo) l’unità spirituale e morale di una società adunata attorno a chi la conduceva verso il punto finale dell’avvento del Mahdi. La gloriosa rivoluzione politica per Khomeyni era un potente segno della fine della grande occultazione, la luce stava per trionfare sulle tenebre, non certo l’apertura di una via islamica alla democrazia.
La necropolitica khomeynista, dunque, nasceva da una visione escatologica che, pur appartenendo a tutta la tradizione sciita [6], esasperava oltre ogni limite l’idea che sino al ritorno dell’imam nascosto (alla fine dei tempi) stare sulla terra significa vivere nel lutto, soffrendo nel ricordo del martirio dei grandi capi spirituali e politici, imitandone, se necessario, la disponibilità al sacrificio della vita per il trionfo della verità, mandando a morte senza pietà chi osa mettere in discussione le regole rigoriste e puritane che occorre seguire per prepararsi all’avvento del Salvatore. La repressione della gioia di vivere, di cui parla Khosorkhavar rimpiangendo un tempo in cui alla radio sentiva le voci di famose cantanti, è una tragica conseguenza di questa visione apocalittica del mondo, divenuta una camicia di forza ormai insopportabile per gran parte delle nuove generazioni che non hanno memoria né della rivoluzione del 1978 né della drammatica guerra Iran-Iraq e dei tanti allora loro coetanei [7] che andarono a morire al fronte o camminando, come martiri inermi, sui campi minati dall’esercito di Saddam Husseyn.
Dialoghi Mediterranei, n. 59, gennaio 2023
Note
[1] Per una plastica rievocazione di tali riti, E. Canetti, Massa e potere, Milano, Adelphi, 176-186 e A. Nesti, L’Ashura e i giorni del Muharram: da una religione della giustizia a una religione del lamento? In ID. (a cura di), Laboratorio Iran, Milano, Franco Angeli 2003: 106-112.
[2] R. Guolo, La via dell’imam, Roma-Bari, Laterza, 2007.
[3] Per una ricostruzione più precisa dei termini della disputa rinvio a G.R. Scarcia, Intorno alla controversia Akhbari e Usuli presso gli imamiti di Persia, “Rivista di Studi Orientali”, 1959, 33, 211-250, R. M. Gleave, The Akhbari – Usuli Dispute and the Early Akhbari School, in Scripturalist Islam, Leiden, Brill, 2007, 1-30 e A. Amin-Moezzi, Il Corano silente, il Corano parlante, Roma, Istituto per l’Oriente, 2018. Mentre la parola usuli significa fondamenti, l’altra akhbari vuol dire letteralmente notizie, informazioni e rinvia all’idea che sia il Corano sia soprattutto i Hadith siano parole rivelate da prendere alla lettera.
[4] M. Foucault, Taccuino persiano, Milano, Guerini e Associati, 2007 (a cura di R. Guolo e R. Panza).
[5] Questo concetto è stato proposto da A. Mbembe, Necropolitics, Durham, Duke University Press, 2019.
[6] Vale la pena ricordare che a Najaf, città irachena assieme a Karbala considerate sante da tutti gli sciiti del mondo, risiede ʽAli al-Sistani (novantaduenne), marja’al-taqlid, universalmente riconosciuto come tale (contrariamente alla figura dell’attuale guida suprema Khamenei in Iran), il quale non ha mai fatto mistero di essere stato in completo disaccordo con la visione escatologico-politica di Khomeyni. Non a caso, nel suo viaggio apostolico in Iraq nel marzo del 2021, papa Francesco si è recato nella sua modesta abitazione a Najaf per incontrarlo.
[7] Faccio riferimento al movimento Basij al-Mostazafin (letteralmente Mobilitazione degli Oppressi) creato nel 1979 da Khomeyni e utilizzato appieno per incitare i giovanissimi militanti di tale movimento a combattere il nemico iracheno. Su questo movimento si vedano A. Ostovar, Iran’s Basij, “Middle East Journal”, 2013, 67 (3): 345-361, S. Golkar, Captive Society: The Basij Militia and Social Control in Iran, Wahington DC, Woodrow Wilson Center Press, 2015, S. Randjbar-Daemi, The Quest for Authority in Iran, London, Tairus, 2018 e M. Ladier-Fouladi, La république islamique d’Iran vue de l’intérieur, Vulaines-au-Seine, éditions du Croquant, 2020.
_____________________________________________________________
Enzo Pace, è stato professore ordinario di sociologia e sociologia delle religioni all’Università di Padova. Directeur d’études invité all’EHESS (Parigi), è stato Presidente dell’International Society for the Sociology of Religion (ISSR). Ha istituito e diretto il Master sugli studi sull’islam europeo e ha tenuto il corso Islam and Human Rights all’European Master’s Programme in Human Rights and Democratisation. Ha tenuto corsi nell’ambito del programma Erasmus Teaching Staff Mobility presso le Università di Eskishehir (Turchia) (2010 e 2012), Porto (2009), Complutense di Madrid (2008), Jagiellonia di Cracovia (2007). Collabora con le riviste Archives de Sciences Sociales des Religions, Social Compass, Socijalna Ekologija, Horizontes Antropologicos, Religiologiques e Religioni & Società. Co-editor della Annual review of the Socioklogy of Religion, edito dalla Brill, Leiden-Boston, è autore di numerosi studi. Tra le recenti pubblicazioni si segnalano: Cristianesimo extra-large (EDB, 2018) e Introduzione alla sociologia delle religioni (Carocci, 2021, nuova edizione).
______________________________________________________________








