«Stirpe miserabile ed effimera, figlia del caso e della pena, perché mi costringi a dirti ciò che per te è vantaggioso non sentire? Il meglio è per te assolutamente irraggiungibile: non essere nati, non essere, essere niente. Ma la cosa in secondo luogo migliore per te è morire presto».
Una sentenza terribile – trascritta da Honderlin – senza un barlume di speranza per il genere umano, quella che il saggio Sileno, con un grido lacerante e tragico, riversa sull’inebetito re Mida sfinito dalla corsa nella foresta per raggiungerlo.
Una verità tragica, quella proferita non a caso da un satiro, divinità minore dei boschi, di natura selvaggia e lasciva, seguace di Dioniso. Una condanna senza appello che disvela la sete irrefrenabile di dominio dell’uomo sull’uomo, e dell’uomo, consapevole della sua inadeguatezza, nei confronti dell’ambiente naturale.
Una progressione prima timida, poi sempre più spregiudicata, a partire dalle scoperte scientifiche, quella del genere umano, che brandendo le sue protesi tecniche, si è fatta nel corso del Novecento esponenziale e devastante. È stata la volontà dell’uomo, sempre più arrogante e incontrollata, per brama di potere, a violentare senza limiti Madre Terra, trascinandola impietosamente nelle trasformazioni dell’artificiale in tutte le sue declinazioni. Una corsa sfrenata per inseguire il mito dello sviluppo senza limiti, un mostro che ha finito con il divorare se stesso, con spreco delle risorse naturali, a fronte di un’esplosione demografica e dei conseguenti sconvolgimenti climatici.
Nel nome dei vitelli d’oro dell’economia, della finanza e del mitico capitale, ecco lo sviluppo della scienza e della tecnica, amplificata dall’immaginario consumistico. Ridotte in cenere le ideologie, i nuovi idoli seducenti del contemporaneo cui offrire liturgie e sacrifici hanno avuto la meglio, con accumulo di ricchezze a favore di pochi sacerdoti officianti. Una fede assoluta e cieca nella religione del progresso, certi che saremmo entrati presto nell’età dell’oro e della città ideale, raggiungendo la terra promessa del benessere e dell’uguaglianza sociale.
 E invece, l’homo sapiens ha obbligato «la terra nell’usura e nelle trasformazioni dell’artificiale – scrive Heidegger – oltre il cerchio delle possibilità che questa ha naturalmente sviluppato, verso ciò che non è più il suo possibile, e quindi è l’impossibile». In più, «il fatto che i piani e i dispositivi della tecnologia riescano in numerose invenzioni e producano continue innovazioni – continua Heidegger – non dimostra affatto che le conquiste della venerata tecnica rendano possibile anche l’impossibile».
E invece, l’homo sapiens ha obbligato «la terra nell’usura e nelle trasformazioni dell’artificiale – scrive Heidegger – oltre il cerchio delle possibilità che questa ha naturalmente sviluppato, verso ciò che non è più il suo possibile, e quindi è l’impossibile». In più, «il fatto che i piani e i dispositivi della tecnologia riescano in numerose invenzioni e producano continue innovazioni – continua Heidegger – non dimostra affatto che le conquiste della venerata tecnica rendano possibile anche l’impossibile».
E allora c’è da chiedersi, spinti dall’angoscia che emerge prepotente dai recessi dell’anima, perché questa folle corsa fino all’orlo del precipizio, per poi riscoprire lo sviluppo sostenibile, le energie rinnovabili, la green economy, la difesa della biosfera ferita a morte dalla ferocia umana, la salvifica digitalizzazione, e l’ordine imperativo di riduzione dell’emissione di CO2 nell’atmosfera. L’uomo aggirandosi fra le macerie fumanti, prende consapevolezza del disastro, e le ormai inadeguate istituzioni di rappresentanza e governo argomentano finalmente di transizione ecologica. E così tutto risuona come estrema ratio per rinnegare un modello di sviluppo globale rivelatosi fra secondo e terzo millennio catastrofico ed apocalittico.
Doppia e ambigua e sfuggente la natura dell’homo sapiens, capace di spiccare il volo in cielo o sprofondare con la stessa naturalezza nelle tenebre degli inferi. Forse una chiave di lettura c’è. «Privato ‘per natura’ della possibilità di essere d’accordo con la natura – annota Gehlen – l’uomo è da sempre come dire artificiale, perché incompleto, e dunque in perenne competizione con la natura, perché non conformato per un ambiente naturale, e di conseguenza non ha altra risorsa che trasformare con la sua intelligenza qualsivoglia stato di cose da lui incontrato nella natura».
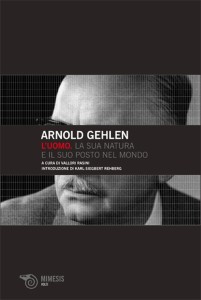 Ed è proprio per questo imprinting genetico-antropologico che «non si dà più per l’uomo una distinzione tra natura e cultura, perché la sua natura – osserva acutamente Gehlen – è la cultura, la coltivazione di una terra inospitale e inadatta, per cui la tecnica è insita già nell’essenza stessa dell’uomo». E la tecnica, nelle sue diverse accezioni, ha profondamente inciso, oltre che singolarmente anche sulla trascendenza, sugli equilibri naturali, con i salti di specie dei virus, e ancora in maniera prepotente anche sulla nozione di tempo, centrale e decisiva per i ritmi di vita di ogni cultura.
Ed è proprio per questo imprinting genetico-antropologico che «non si dà più per l’uomo una distinzione tra natura e cultura, perché la sua natura – osserva acutamente Gehlen – è la cultura, la coltivazione di una terra inospitale e inadatta, per cui la tecnica è insita già nell’essenza stessa dell’uomo». E la tecnica, nelle sue diverse accezioni, ha profondamente inciso, oltre che singolarmente anche sulla trascendenza, sugli equilibri naturali, con i salti di specie dei virus, e ancora in maniera prepotente anche sulla nozione di tempo, centrale e decisiva per i ritmi di vita di ogni cultura.
Al tempo ciclico delle società agro-pastorali, rispettosi del ‘tempo debito’ della semina e del raccolto, e della cura delle greggi, vera essenza dell’uomo e del suo legame con il cielo e la terra, si è sostituito il ‘tempo lineare’ e frenetico della modernità, il quale non solo prescinde dall’ambiente naturale, dalla tipicità del luogo, dall’antropizzazione storica del territorio, ma snatura, violenta i paesaggi, fino a mutare e dissacrare relazioni biologiche e codici genetici, rendendoci spaesati ed estranei nella terra dei nostri padri, oltre che mettere a rischio la sopravvivenza delle specie naturali, compresa quella umana.
Ed ora d’improvviso l’orizzonte già offuscato si è oscurato definitivamente o quasi, con una pandemia improvvisa e planetaria, che ha spazzato in un sol colpo le nostre illusorie e velleitarie certezze. Un virus regale, con tanto di corona, si è insinuato nelle nostre vite individuali e collettive, mettendo a nudo le nostre fragilità e paure, genetiche ed ancestrali, minando la svettante torre di Babele del progresso planetario.
Azzerando le relazioni consolidate e i ritmi di vita abituali, il coronavirus ha così sconvolto un ordine, ponendo fine o, per lo meno, mettendo in crisi profonda i legami interpersonali, collanti necessari per ogni società umana, che si ritenevano intoccabili e inalienabili. E ciò ha creato d’improvviso un vuoto, un’assenza, una perdita, e in definitiva una distanza mai sperimentata prima, che ci separa e ci esclude dagli altri, dalle abitudini sociali, commerciali, ricreative, sportive, culturali e dello spettacolo, insomma dai quei ritmi e rapporti di vita che ritenevamo ineluttabili e definitivi e non negoziabili, e oggi invece obliterati e interdetti.
Ed è proprio in questo sconvolgimento epocale innescato dalla pandemia, democratica e paritaria con l’intero genere umano, senza distinzione di etnia, cultura, fede religiosa e condizione economica e sociale, che il coronavirus ha dispiegato – mutuando quanto scrive Umberto Galimberti sul Sacrificio – «il suo enigma, che è poi l’enigma della vita stessa, in ciò che ha di irrappresentabile: la morte!».
 Dinnanzi ad un nemico invisibile, insidioso e quanto può letale, che ci abita a suo piacimento, gli uomini di scienza ci richiamano al distanziamento, a rinunciare al costitutivo codice di comunicazione non verbale, dunque ai contatti fisici, agli indispensabili gesti affettivi e relazionali, insomma al corpo sociale che definisce lo status antropologico dell’uomo.
Dinnanzi ad un nemico invisibile, insidioso e quanto può letale, che ci abita a suo piacimento, gli uomini di scienza ci richiamano al distanziamento, a rinunciare al costitutivo codice di comunicazione non verbale, dunque ai contatti fisici, agli indispensabili gesti affettivi e relazionali, insomma al corpo sociale che definisce lo status antropologico dell’uomo.
Ma oltre la cortina delle narrazioni delle cronache giornalistiche quotidiane fitte di statistiche, e dunque di numeri di contagi, ricoveri, decessi, cui si oppone ora l’esercito dei vaccini, si agitano oscuri e inquietanti fantasmi. Non si può essere certo indifferenti al dramma delle morti in solitudine, delle generazioni over ottanta sterminati, dei nonni dimenticati colpevolmente nei ghetti-residenze dai nomi spesso romantici e fiabeschi, tipo “come d’incanto”, “Collereale”, che svaniscono nel nulla.
Tante e davvero angoscianti sono le storie familiari dolorose di morte, che lambiscono le nostre fragili esistenze, unite sempre e comunque da un comune e ineludibile destino. Partecipi certo emotivamente alle perdite di affetti e legami familiari altrui, ci allontaniamo però in fretta dai lutti vicini e lontani, per esorcizzare come possiamo il nemico subdolo, illudendoci di tenerlo lontano dal nostro quotidiano.
Ma forse, oltre l’istintivo e superficiale cordoglio necessario a consolarci o, di contro, il vano tentativo a occultarlo, a volte in maniera sbrigativa ed ipocrita, bisogna spingere, io credo, lo sguardo e il pensiero oltre, alla ricerca, magari, di un sapere antico perduto. E ciò per tentare di capire meglio il doloroso presente, illuminando in profondità, se possibile, i recessi più oscuri delle nostre smarrite e dolenti anime. E tra le tante possibili riflessioni sul tema, una cruciale credo si imponga, quella sul concetto di cultura in relazione alla malattia e al sapere medico, e come oggi, in tempi di pandemia, si configura nei suoi drammatici e irrisolti nodi sul doppio versante del vissuto individuale e della sanità pubblica.
E così appare davvero illuminante evidenziare che «presso i primitivi che conoscevano il corpo e non l’organismo, la malattia – evidenzia Galimberti – aveva un significato sociale, e come tale era qualcosa che si poteva scambiare con il gruppo. La malattia dunque non era vissuta individualmente, ma scambiata come tutte le cose in quell’ordine simbolico che faceva di ogni evento una relazione sociale ricca di senso».
Il male del corpo, oggi incarnato dal coronavirus, da sempre minaccia incombente per l’uomo, nella cultura antica, dalla quale trarre insegnamento oggi in tempi di pandemia, era infatti interpretato e vissuto «non come una lesione organica che investe un individuo, ma come una rottura, uno squilibrio nello scambio sociale».
Da sempre sospesa in quel territorio di confine tra vita e morte, dunque ambivalente, la malattia è stata sottratta al corpo sociale, e offerta in esclusiva a quel sapere medico «che è nato quando, contrapponendo la vita alla morte, ha infranto per sempre – scrive Galimberti – l’ambivalenza del loro scambio simbolico nell’equivalenza generale della salute». Uno spartiacque, questo, culturalmente e metodologicamente decisivo, dove «il corpo del malato da soggetto delle pratiche sciamaniche e della medicina popolare, diventa oggetto da affidare alla scienza medica».
 E allora ecco le terapie intensive destinate ai contagiati di coronavirus dei nostri ospedali, dove isolare e distanziare sono le regole inflessibili, necessarie ma disumane. E allora, oltre ogni ordinaria degenza ospedaliera, che può diventare occasione per riscoprire i propri corpi e non solo gli organi patologici, stabilendo insospettate relazioni sociali e pratiche di umanità e solidarietà, il coronavirus ha messo a nudo il fatto che oggi più che mai «lo sguardo medico non incontra il malato ma la sua malattia – aggiunge Galimberti – e nel suo corpo non legge una biografia ma una patologia». Ed ecco scomparire, sotto il dominio dei segni sintomatici e del quadro clinico, imposto dal protocollo medico, la cornice degli affetti familiari. Espropriato della sua malattia, il malato si abbandona così nelle mani del medico, che agendo come «funzionario della scienza ignora il corpo perché conosce solo l’organismo».
E allora ecco le terapie intensive destinate ai contagiati di coronavirus dei nostri ospedali, dove isolare e distanziare sono le regole inflessibili, necessarie ma disumane. E allora, oltre ogni ordinaria degenza ospedaliera, che può diventare occasione per riscoprire i propri corpi e non solo gli organi patologici, stabilendo insospettate relazioni sociali e pratiche di umanità e solidarietà, il coronavirus ha messo a nudo il fatto che oggi più che mai «lo sguardo medico non incontra il malato ma la sua malattia – aggiunge Galimberti – e nel suo corpo non legge una biografia ma una patologia». Ed ecco scomparire, sotto il dominio dei segni sintomatici e del quadro clinico, imposto dal protocollo medico, la cornice degli affetti familiari. Espropriato della sua malattia, il malato si abbandona così nelle mani del medico, che agendo come «funzionario della scienza ignora il corpo perché conosce solo l’organismo».
Deportato a causa del contagio in una dimensione «di spazio-tempo, dove tutto funziona sotto la minaccia della morte, il paziente si percepisce, rispetto alla sua malattia, come un fatto esteriore, perché non solo il mondo della sua vita si interrompe, ma con le sue abitudini, le sue disposizioni, la sua età, i suoi affetti, lui stesso diventa un fatto accidentale rispetto alla lettura medica che si chiude sul suo corpo per aprirsi al suo organismo» (Galimberti).
A questa impietosa e drammatica realtà, che entra nelle nostre case dalla “scatola delle immagini del mondo”, si oppongono però sguardi che ascoltano, sguardi che parlano, una pietas insospettata, un’umanità di affetti e solidarietà, che è l’antidoto antico contro tutte le epidemie a tutte le latitudini storiche e culturali. Straordinaria occasione quella offerta dalla pandemia, per rigenerare a fondo le società malate, che hanno bisogno di «un futuro sostenibile e amichevole, guidato dalla decrescita, – scrive Latouche – in rado di liberarci dall’incubo dell’iperproduttivismo e dal compulsivo consumismo, capace di reincantare il mondo e riguadagnare e ampliare la nostra capacità di meravigliarci per la sua bellezza», ponendo al centro l’uomo e la sua sete di armonia con sé stesso e il mondo.
Dialoghi Mediterranei, n. 48, marzo 2021
Riferimenti bibliografici
Heidegger M., Essere e tempo, Utet Torino 1978
Honderlin F., Sul tragico, Feltrinelli Milano 1989
Galimberti U., Idee: il catalogo è questo, Feltrinelli Milano 1992
Gehlen A., L’uomo, la sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis Milano 1983
Latouche S., Come reincantare il Mondo, Bollati Boringhieri Torino 2020
______________________________________________________________
Mario Sarica, formatosi alla scuola etnomusicologica di Roberto Leydi all’Università di Bologna, dove ha conseguito la laurea in discipline delle Arti, Musica e Spettacolo, è fondatore e curatore scientifico del Museo di Cultura e Musica Popolare dei Peloritani di villaggio Gesso-Messina. È attivo dagli anni ’80 nell’ambito della ricerca etnomusicologica soprattutto nella Sicilia nord-orientale, con un interesse specifico agli strumenti musicali popolari, e agli aerofoni pastorali in particolare; al canto di tradizione, monodico e polivocale, in ambito di lavoro e di festa. Numerosi e originali i suoi contributi di studio, fra i quali segnaliamo Il principe e l’Orso. Il Carnevale di Saponara (1993), Strumenti musicali popolari in Sicilia (1994), Canti e devozione in tonnara (1997); Orizzonti siciliani (2018).
_______________________________________________________________








