Alcuni giorni fa sono stati resi noti i dati relativi al 2014 elaborati dall’Istat nel rapporto Noi Italia dal quale si apprende che il prodotto interno lordo (PIL) pro capite del Mezzogiorno è risultato pari a quasi la metà di quello del Nord-ovest del Paese: leggasi euro 16.761 contro 30.821. É questo il nocciolo duro di ciò che ancora oggi, dopo quasi 150 anni, intendiamo per «questione meridionale» o il differenziale in vile denaro è solo la crosta di un fenomeno molto più complesso?
Questi ed altri interrogativi trovano risposta nel libro di Salvatore Lupo, La Questione. Come liberare la storia del Mezzogiorno dagli stereotipi (Donzelli 2015), sul tema della ‘Questione’ e degli stereotipi che nel tempo si sono addensati e cristallizzati attorno ad essa. Va detto innanzitutto che le 203 pagine hanno il merito di essere un concentrato invidiabile di analisi e di spunti di riflessione come raramente accade anche consultando monografie ben più corpose e ambiziose. Peraltro, sulla storia del Mezzogiorno e sulla questione meridionale la bibliografia esistente è poderosa; districarsi nel lungo e ricco dibattito nel quale si sono cimentati studiosi di diverse discipline, politici e intellettuali, dalla seconda metà dell’800 ai giorni nostri, è operazione impegnativa. Non a caso lo stesso Autore dichiara di considerare questo suo ultimo contributo come «punto terminale dei miei studi più o meno antichi»; riflessione per tappe avviata sin dal 1990 con il saggio I proprietari terrieri del Mezzogiorno nel volume collettaneo Storia dell’agricoltura italiana in età contemporanea, a cura di Piero Bevilacqua, per l’editore Marsilio.
Il testo si articola in tre densi capitoli preceduti da un’introduzione immediatamente esplicativa: il Mezzogiorno e la grande discussione pubblica chiamata «questione meridionale» sono stati caricati progressivamente di ogni genere di simbologia, includendovi fenomeni eterogenei (economici, civili e culturali) che hanno portato ad una lettura distorta della realtà. Ad esempio, storici ed economisti autorevoli concordano nel riconoscere i progressi compiuti dalle regioni meridionali, dall’Unità ad oggi per mirare ad affiancarsi al Centro-nord non solo in termini di Pil pro-capite ma anche di capitale sociale (livello di istruzione, mortalità infantile, vita media, emancipazione femminile ecc.). Ciò significa – spiega Lupo – «che il Mezzogiorno, tra momenti di divergenza e convergenza con il Settentrione, ha partecipato del cento cinquantennale trend di sviluppo del paese nel suo complesso». Ne consegue che anche il Sud è andato avanti dal 1861 in poi, pur se non ha raggiunto il Nord; ma se così è, perché – si chiede l’Autore – il progredire del Sud rispetto al suo passato non ha formato oggetto di valutazione ed anzi continua ad essere rimosso? «Per il fascino della grande metafora dualista che sta dietro e sotto la questione meridionale: progresso vs. arretratezza, modernità vs. arcaismo, civilizzazione vs. barbarie». Questa contrapposizione nasconde o, nella migliore delle ipotesi, sottovaluta l’esistenza di differenze regionali e sub-regionali in tutto il Paese e non soltanto al Sud.
Il lavoro di decostruzione di questo impianto-stereotipo è già iniziato alcuni decenni fa, prima con le lucide intuizioni di Rosario Romeo e Gastone Manacorda, poi, più compiutamente, con gli approfondimenti della successiva generazione di storici e scienziati sociali attorno alla rivista «Meridiana» e all’Istituto meridionale di scienze sociali (IMES). Un pregevole lavoro di indagine e rielaborazione collettiva – che ha visto impegnato sin dalla fondazione della rivista lo stesso Lupo – il cui frutto principale è stato quello di considerare il Mezzogiono «al pari di un qualsiasi luogo di questo mondo, come un frammento della modernità». L’assimilazione, per esempio, del borghese agrario meridionale allo stereotipo totalizzante del proprietario latifondista assenteista ha impedito di discernere e di studiare con la dovuta attenzione le esperienze e le iniziative in diverse aree del Meridione prodotte da una borghesia moderna, colta e intraprendente che è esistita e ha espresso modernità al pari di quella continentale meglio conosciuta.
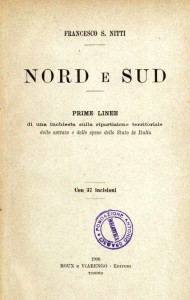 L’Autore, quindi, procede nel suo ragionamento dall’esordio della ‘Questione’, focalizzata nel dibattito pubblico come «sociale» sin dal 1875, alle controversie regionaliste tra ‘800 e ‘900 che sancirono la formalizzazione dell’espressione «questione meridionale», per finire con l’analisi del ruolo svolto e delle riflessioni compiute da quattro grandi intellettuali di diversa estrazione e formazione politica: Nitti, Salvemini, Dorso e Gramsci. È già in quella stagione e da quelle discussioni che Lupo individua i «luoghi polemici più consolidati», per esempio: la struttura sociale meridionale considerata ancora feudale; le politiche economiche governative accusate di danneggiare sempre il Mezzogiorno da parte di quanti nel tempo si sono ispirati a opposti principi, «libero-scambisti in età postunitaria, protezionisti alla fine del secolo, timidamente interventisti in età giolittiana»; come pure la tesi riguardante la classe dirigente meridionale «incapace di porsi il problema dell’interesse generale». L’operazione di decodifica condotta dall’Autore implica, perciò, che i protagonisti chiamati in causa vengano innanzitutto collocati e contestualizzati nel tempo e nello spazio con le rispettive differenze, talvolta vistose. L’opinione corrente «li ha tutti retrospettivamente arruolati nello stesso esercito del meridionalismo, ma la verità è che loro non definivano se stessi meridionalisti e non erano definiti come tali».
L’Autore, quindi, procede nel suo ragionamento dall’esordio della ‘Questione’, focalizzata nel dibattito pubblico come «sociale» sin dal 1875, alle controversie regionaliste tra ‘800 e ‘900 che sancirono la formalizzazione dell’espressione «questione meridionale», per finire con l’analisi del ruolo svolto e delle riflessioni compiute da quattro grandi intellettuali di diversa estrazione e formazione politica: Nitti, Salvemini, Dorso e Gramsci. È già in quella stagione e da quelle discussioni che Lupo individua i «luoghi polemici più consolidati», per esempio: la struttura sociale meridionale considerata ancora feudale; le politiche economiche governative accusate di danneggiare sempre il Mezzogiorno da parte di quanti nel tempo si sono ispirati a opposti principi, «libero-scambisti in età postunitaria, protezionisti alla fine del secolo, timidamente interventisti in età giolittiana»; come pure la tesi riguardante la classe dirigente meridionale «incapace di porsi il problema dell’interesse generale». L’operazione di decodifica condotta dall’Autore implica, perciò, che i protagonisti chiamati in causa vengano innanzitutto collocati e contestualizzati nel tempo e nello spazio con le rispettive differenze, talvolta vistose. L’opinione corrente «li ha tutti retrospettivamente arruolati nello stesso esercito del meridionalismo, ma la verità è che loro non definivano se stessi meridionalisti e non erano definiti come tali».
Entrando nel vivo dei temi affrontati, quello iniziale del divario e del dualismo economico-produttivo tra le due aree del Paese viene analizzato da Lupo richiamando anche gli studi degli storici dell’economia che negli ultimi anni hanno sgombrato il campo dai numerosi idola quali, ad esempio, quello della spiccata vocazione industriale settentrionale che dall’Unità in avanti avrebbe relegato il Meridione a una definitiva subordinazione manifatturiera e ad un’assegnazione di ruolo di “campagna” arretrata… a tempo indeterminato. «Gli industriali del Nord non erano in grado di fare concorrenza a nessuno. […] il vero problema storico del 1861 e del ventennio successivo non riguarda la (breve) distanza tra Nord e Sud Italia ma la distanza (grande) tra l’Italia e i paesi progrediti».
L’agricoltura italiana, come mostrano le elaborazioni storico-statistiche più affidabili, nei quattro decenni postunitari avrebbe contribuito alla formazione del prodotto interno lordo nazionale più dell’industria e la quota derivante dalle campagne del Mezzogiorno (con una forte espansione del vigneto, degli agrumi, delle ortalizie) sarebbe rimasta in sostanziale equilibrio con quella ottenuta dalle colture estensive del settentrione. Laddove, invece, i primi analisti del divario (Franchetti, Sonnino, Villari, Fortunato) colgono pienamente nel segno – come riconosce l’Autore – è sul tema delle disuguaglianze sociali, molto maggiori al Sud che al Centro-nord. Ciò nonostante, nessuno di loro utilizzò mai l’espressione «questione meridionale»; erano dei moderati che avevano interpretato prima e meglio dei progressisti la questione sociale: «Abbiamo qui un nuovo territorio simbolico, il sociale, su cui si costruisce l’idea nuova di un territorio fisico, il Mezzogiorno» e, soprattutto, matura il disincanto rispetto all’idea romantico-risorgimentale della nazione e rispetto alle politiche liberiste che da sole vantavano di poter garantire sviluppo economico diffuso; si acquisiva per la prima volta la consapevolezza che non fosse più sufficiente creare ricchezza nazionale senza preoccuparsi di avvantaggiare tutti i ceti sociali.
Di estremo interesse appaiono ancora le considerazioni di Lupo sugli assetti della proprietà terriera nel Mezzogiorno modificatisi lungo tutto l’800 con le leggi eversive della feudalità, con la legge Corleo del 1862 di cessione in enfiteusi redimibile delle terre dell’asse ecclesiastico siciliano e, più in generale, con le vendite all’asta di terre demaniali: «Lo Stato pretendeva coi suoi provvedimenti di favorire l’incontro tra la terra e il capitale vendendo terreni demaniali, ma era lo Stato stesso a rastrellare i capitali in possesso degli imprenditori agricoli meridionali […] distogliendoli dall’impiego produttivo in agricoltura, aggravando dunque la sottocapitalizzazione delle aziende». L’Autore si interroga sull’effettivo conseguimento dell’obiettivo di democratizzazione della proprietà o, al contrario, sul rafforzamento dell’oligarchia dei possidenti che quelle quote ricompravano dai piccoli proprietari aggiudicatari; nonché se le politiche demanialistiche abbiano favorito e incentivato le trasformazioni fondiarie. Il suo punto di approdo sul tema appare molto equilibrato e prudente, di non sottovalutazione dell’intervento pubblico, «veicolo di mobilità in una situazione storica in cui, come sappiamo, sul mercato la terra – fonte della ricchezza e del prestigio – era poca e cara»; e, soprattutto, invita a considerare la casistica in rapporto alla diversità «dei contesti locali», a distinguere tra aree a coltura estensiva e quelle in via di trasformazione. Ciò consente di valutare la consistenza, vera o presunta, del drenaggio di capitali compiuto dallo Stato a danno dell’agricoltura meridionale: «Alcuni indizi suggeriscono che in molti casi (ad esempio per quanto attiene alla legge Corleo) i canoni, già formalmente bassi, non siano stati in pratica corrisposti per nulla».
Ma quando l’espressione «questione meridionale» irrompe e si impone nel dibattito? Certamente si deve a Giustino Fortunato l’introduzione nel 1904 del termine «dualismo» con riferimento alle diverse disponibilità di risorse naturali tra Nord e Sud, ed è dello stesso anno il suo scritto La questione meridionale e la riforma tributaria. È l’alba del ‘900 e il confronto di opinioni si carica sempre più di toni polemici molto aspri, assumendo come dato la dicotomia «civilizzazione-arcaismo» facendo così riferimento a caratteristiche identitarie attribuibili rispet- tivamente al Nord e al Sud: «la mente va agli antropologi che in questo stesso momento portano la questione sul terreno della razza, e misurano crani, e ragionano di atavismi etnici, in modo da stabilire scientificamente il perché i meridionali siano così predisposti a comportamenti antisociali o criminali tout court».
Entrano in scena altri quattro importanti protagonisti della discussione sul Mezzogiorno a cavallo tra i due secoli, Colajanni, De Viti de Marco, Nitti e Salvemini tutti meridionali «rappresentativi di varie borghesie e tradizioni politiche provinciali del Sud», di area radicale o socialisteggianti. Salvemini pubblicava nel 1900 il suo saggio La questione meridionale e il federalismo al quale avrebbero attinto in molti e a lungo per condividere la sua lapidaria sintesi delle relazione economica determinatasi tra le due aree del Paese: “la ricchezza del Nord è prodotta dalla miseria del Sud”, «indicando le ricerche di Nitti come quelle che hanno “luminosamente documentato” tale verità».
Anche l’analisi che Lupo conduce sulle aree di mobilitazione politica in Sicilia (e in Puglia) appare molto convincente perché considera l’alto livello di politicizzazione e di consenso popolare al socialismo – come già si era visto con la crescita esponenziale del movimento dei Fasci – unitamente al dato altrettanto rilevante che la classe dirigente dell’Isola aveva espresso due capi di governo quali Crispi e Rudinì, fatti questi che «non vanno considerati isolatamente, ma nella loro reciproca interazione». Questa significativa capacità di mobilitazione politica popolare e contadina, osserva l’Autore, rivela anche aspetti sorprendenti perché non si tratta solo di braccianti ma pure di burgisi, cioè del ceto medio contadino che prendeva in affitto spezzoni di latifondo e che confliggeva con i grandi gabelloti. Saranno anche loro ad animare il movimento contadino nell’organizzare la cooperative agricole e le affittanze collettive.
L’ultimo capitolo è dedicato ai decenni tra le due guerre durante i quali si realizzò la rapida conversione – sostenuta dalla finanza pubblica – dell’apparato industriale verso i settori trainanti della metallurgia, della meccanica e della chimica. «Quanto al Mezzogiorno agricolo – osserva Lupo – sin dal 1914 vennero a mancare d’un tratto le condizioni che avevano determinato quel tanto (o quel poco) di prosperità di cui aveva goduto». La guerra e l’emorragia migratoria soprattutto verso il continente americano avrebbero prodotto il resto dei danni, più «di quanto mai avesse fatto una tariffa protezionistica o un trattato di commercio sfavorevole», fino alla disastrosa seconda guerra mondiale alla cui vigilia il Paese si trova in una condizione di massimo differenziale economico-sociale tra Sud e Nord.
La rilettura del pensiero gramsciano che l’Autore considera come «il campione di un pensiero marxista eretico, o soltanto critico» si concentra innanzitutto sul suo scritto del 1926, rimasto incompiuto perché interrotto dall’arresto, Alcuni temi sulla quistione meridionale, che ritiene autobiografico e in parte anche autocritico. Gramsci avverte l’imminente disfatta politica dovuta «al fatto che il corporativismo/settentrionalismo operaio ha gettato in braccio al nemico la maggioranza delle masse lavoratrici (i contadini)» e che nessuna rivoluzione avrebbe avuto possibilità di successo escludendo il Mezzogiorno e, quindi, senza la costruzione del blocco sociale operai-contadini; unione che proprio pseudo meridionalisti avevano pregiudicato. Da lì i giudizi gramsciani su Sonnino e Franchetti «borghesi intelligenti» il cui programma «non ebbe mai nemmeno l’inizio di un’attuazione»; Fortunato viene considerato un «operoso reazionario»; Nitti come «il miglior agente del capitalismo settentrionale». Gramsci prende le distanze anche dalle proposte di Salvemini per il Mezzogiorno il quale affidava «la soluzione del latifondo al mercato e non a una riforma agraria. Nei confronti della lotta di classe nutre le stesse diffidenze nutrite dagli altri liberisti e regionalisti» e riteneva di poter liberare energie nuove mediante l’adozione del suffragio universale, per frantumare il meccanismo oligarchico che legava proprietari terrieri e borghesia professionale.
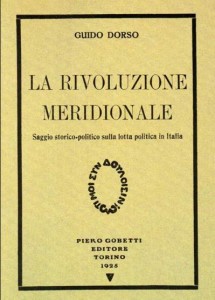 Ma Gramsci si discosta anche dalle ipotesi regionaliste o dalle indicazioni di Guido Dorso miranti a creare «un partito autonomista meridionale, o almeno una fede- razione di partiti regionali» (p. 180) convinto di poter fermare l’ingranaggio economico-politico che aveva soggiogato il Sud riducendolo alla stregua di mercato coloniale. Cioè spiega la simpatia di Dorso per il Partito sardo d’azione. Per Gramsci, invece, la soluzione «è demandata al Partito comunista: partito rivoluzionario e nazionale (nonché internazionalista), che vuol essere per definizione operaio pur ritenendo di dover dare tutto il possibile spazio ai contadini meridionali in tutte le possibili organizzazioni “di massa”». Ma già mentre scrive sulla questione meridionale, è consapevole del fatto che i comunisti italiani non solo non riusciranno a fare proseliti tra i contadini del Sud, ma stavano perdendo nelle roccaforti operaie settentrionali: «Qui siamo alla principale distinzione tra Dorso e Gramsci. Il primo guarda al fascismo senza particolare allarme […] senza capire che, al contrario, rappresenta la conclusione della stagione rivoluzionaria. Il secondo è ben consapevole che a quel punto “gli operai” sono stati pesantemente “battuti”». Inoltre, rispetto agli altri autori, Gramsci smantella lo schema del dualismo economico-territoriale individuando il ruolo fondamentale degli intellettuali «nel determinare meccanismi di egemonia all’interno dei singoli gruppi sociali e nella relazione tra di essi. L’idea è che il potere funzioni sempre per blocchi, nell’ultimo paese dell’Italia del Sud come a Detroit».
Ma Gramsci si discosta anche dalle ipotesi regionaliste o dalle indicazioni di Guido Dorso miranti a creare «un partito autonomista meridionale, o almeno una fede- razione di partiti regionali» (p. 180) convinto di poter fermare l’ingranaggio economico-politico che aveva soggiogato il Sud riducendolo alla stregua di mercato coloniale. Cioè spiega la simpatia di Dorso per il Partito sardo d’azione. Per Gramsci, invece, la soluzione «è demandata al Partito comunista: partito rivoluzionario e nazionale (nonché internazionalista), che vuol essere per definizione operaio pur ritenendo di dover dare tutto il possibile spazio ai contadini meridionali in tutte le possibili organizzazioni “di massa”». Ma già mentre scrive sulla questione meridionale, è consapevole del fatto che i comunisti italiani non solo non riusciranno a fare proseliti tra i contadini del Sud, ma stavano perdendo nelle roccaforti operaie settentrionali: «Qui siamo alla principale distinzione tra Dorso e Gramsci. Il primo guarda al fascismo senza particolare allarme […] senza capire che, al contrario, rappresenta la conclusione della stagione rivoluzionaria. Il secondo è ben consapevole che a quel punto “gli operai” sono stati pesantemente “battuti”». Inoltre, rispetto agli altri autori, Gramsci smantella lo schema del dualismo economico-territoriale individuando il ruolo fondamentale degli intellettuali «nel determinare meccanismi di egemonia all’interno dei singoli gruppi sociali e nella relazione tra di essi. L’idea è che il potere funzioni sempre per blocchi, nell’ultimo paese dell’Italia del Sud come a Detroit».
In sintesi conclusiva, Lupo offre una rilettura della ‘Questione’ sicuramente alternativa a quella che egli definisce sin dalle prime pagine il mainstream storiografico ed è già questa una valida ragione per leggere il libro. Ma è anche un ottima occasione per tornare alle opere degli autori richiamati e analizzati nel testo disponendo adesso di un’ulteriore chiave interpretativa.
Dialoghi Mediterranei, n.19, maggio 2016
_______________________________________________________________
Rosario Lentini, studioso di storia economica siciliana dell’età moderna e contemporanea. I suoi interessi di ricerca riguardano diverse aree tematiche: le attività imprenditoriali della famiglia Florio e dei mercanti-banchieri stranieri; problemi creditizi e finanziari; viticoltura ed enologia, in particolare, nell’area di produzione del marsala; pesca e tonnare; commercio e dogane. Ha presentato relazioni a convegni in Italia e all’estero e ha curato e organizzato alcune mostre documentarie per conto di istituzioni culturali e Fondazioni. È autore di numerosi saggi pubblicati anche su riviste straniere. Il suo ultimo studio edito da Torri del Vento è dedicato alla Storia della fillossera nella Sicilia dell’800.
________________________________________________________________









