di Antonino Cusumano [*]
Tutto è stato detto sul Mediterraneo. Tutto è stato raccontato e rappresentato. Parola e concetto “buoni da pensare”, paradigma ideologico, passepartout teorico, campo e modello di applicazione di metodologie e categorie interpretative, spazio e oggetto di comparazione, topos nell’immaginario, chiave di lettura politica, laboratorio culturale. Tutto sembra essere passato, depositato e coagulato in questo mare stretto, nelle cui acque si sono sfidati e rimescolati storia e mito, memorie e utopie. «Il mare dell’interscambio fra le varie culture e religioni – lo ha definito Franco Ferrarotti (2020) – un luogo in cui più viva, polisemica e plurilinguistica, è cresciuta e si è sviluppata la presenza umana da tempo immemorabile».
Geografi, filosofi, storici e antropologi si sono adoperati per perimetrarne l’area, definirne l’identità, individuarne le caratteristiche, conoscerne le strutture, le fratture e le dinamiche interne. Hegel riconosce la cifra e lo spirito dell’Occidente in questo mare che è «l’asse della storia del mondo. Tutti i grandi Stati della storia antica giacciono intorno a questo ombelico della terra» (Hegel 1994: 234). Gli studi e i discorsi intorno al Mediterraneo si sono a lungo esercitati nella ricerca di quell’omogeneità che ne certifichi l’unità, di quella specificità che ne assicuri la riconoscibilità.
Gli storici – da Braudel a Abulafia, per citare solo i due studiosi più noti del Novecento – ne hanno ricostruito itinerari e rotte, vicende politiche e militari, guardando all’apporto determinante delle città e delle genti di mare nei processi temporali di lunga durata e negli spazi di una globalizzazione ante litteram. Ampi scenari e grandi affreschi dispiegano e spiegano la complessità di un mondo che per le variabili ambientali e antropiche ha plasmato e ospitato più civiltà, più culture, più umanità. Un universo sistemico che ha inglobato nella comune dimensione geografica segnata dal mare le terre di popoli diversi, le storie degli uomini stanziati tra Africa, Asia ed Europa. Tre continenti e un unico grande ponte che lungo l’asse Oriente/Occidente ha contribuito alla diffusione di beni e tecniche, saperi, religioni, lingue. Non le acque del mare in sé ma il loro movimento, le loro onde lunghe e brevi, le navigazioni di altura e di cabotaggio, quanto hanno trasportato, messo in contatto, trasformato. In altre parole sono i naviganti, i mercanti, i marinai, i pescatori che su questo mare hanno costruito la rete di connessione tra le diverse città costiere, tra le popolazioni diverse. Sono loro che hanno dato corpo e vita a quella “aria di famiglia” che si percepisce nei porti bagnati dal Mediterraneo, a quel gioco di specchi o di sguardi incrociati che descrivono «un sistema di differenze complementari» (Bromberger 2012: 103).
 Quel che dall’Impero Romano abbiamo ereditato col nome di “Mare Nostrum” non ha mai davvero formato un’unità territoriale politicamente e culturalmente organica e tanto meno coesa. Il Mediterraneo ha conosciuto discontinuità e linee di faglia, grandi e drammatiche cicatrici, essendo stata frontiera tra ortodossie e scismi religiosi, epicentro di conflitti politici e militari, teatro in cui si sono consumate guerre da corsa e tratte degli schiavi, conquiste coloniali e lotte di liberazione. Questo mare che oggi ci pare stretto e chiuso era in passato un mondo, il mondo. «Il Mediterraneo di Augusto e di Antonio – ha scritto Braudel (1992: 31-32) – quello delle crociate o anche quello delle flotte di Filippo II era cento, mille volte più grande di quanto appaia oggi quando viaggiamo attraverso lo spazio aereo o marino. Parlare del Mediterraneo storico significa dunque – primo pensiero e cura costante – restituirgli le sue dimensioni autentiche, immaginarlo in una veste smisurata. Da solo, costituiva in passato un universo, un pianeta». E in questa amplissima latitudine il mare univa «un insieme di insiemi», i ricchi empori dell’antichità e le aree sacre dei culti, le grandi vie di comunicazione e le terre del grano e della vite e degli ulivi, le città portuali e le campagne, le montagne e i deserti.
Quel che dall’Impero Romano abbiamo ereditato col nome di “Mare Nostrum” non ha mai davvero formato un’unità territoriale politicamente e culturalmente organica e tanto meno coesa. Il Mediterraneo ha conosciuto discontinuità e linee di faglia, grandi e drammatiche cicatrici, essendo stata frontiera tra ortodossie e scismi religiosi, epicentro di conflitti politici e militari, teatro in cui si sono consumate guerre da corsa e tratte degli schiavi, conquiste coloniali e lotte di liberazione. Questo mare che oggi ci pare stretto e chiuso era in passato un mondo, il mondo. «Il Mediterraneo di Augusto e di Antonio – ha scritto Braudel (1992: 31-32) – quello delle crociate o anche quello delle flotte di Filippo II era cento, mille volte più grande di quanto appaia oggi quando viaggiamo attraverso lo spazio aereo o marino. Parlare del Mediterraneo storico significa dunque – primo pensiero e cura costante – restituirgli le sue dimensioni autentiche, immaginarlo in una veste smisurata. Da solo, costituiva in passato un universo, un pianeta». E in questa amplissima latitudine il mare univa «un insieme di insiemi», i ricchi empori dell’antichità e le aree sacre dei culti, le grandi vie di comunicazione e le terre del grano e della vite e degli ulivi, le città portuali e le campagne, le montagne e i deserti.
Gli antropologi – soprattutto quelli di origine anglosassone che per primi hanno studiato le società mediterranee negli anni del secondo dopoguerra (Pitt-Rivers, Redfield, Davis, Banfield), – ci hanno consegnato un quadro culturale in gran parte articolato sui temi dell’onore e della vergogna, del familismo e del clientelismo, della parentela e del patronage, una attenta lettura particolarmente rivolta alla vita delle piccole comunità, costruita su alcune dicotomie oppositive: pubblico/privato, centro/periferia, moderno/arcaico. Utili riferimenti per orientarsi nella conoscenza di una realtà, però, ben più complessa e frastagliata di quella rappresentata da schematismi etnocentrici e generalizzazioni etniche assolutizzanti. L’Altro che gli antropologi hanno creduto di vedere e di descrivere era spesso in realtà il riflesso della loro immagine rovesciata, l’ingannevole e deformata rappresentazione di società che credevano compatte ed erano stratificate, che giudicavano stazionarie, immobili e amorali laddove erano invece dentro regimi temporali, etici e culturali diversi. Più recentemente la decostruzione di queste tesi in una prospettiva comparativa ha dimostrato la fragilità e la parzialità del concetto di etnia, tanto più se applicato a una area di forte e ininterrotta circolazione umana e di intensi traffici economici e culturali. A fronte di un profondo ripensamento critico delle categorie di analisi, quel Mediterraneo che si credeva miticamente unito e omogeneo in una visione reificata dell’identità, è oggi un concetto ancora “buono da pensare” ma è un oggetto di studio più problematico e antropologicamente più difficile da definire.
Che cosa è dunque il Mediterraneo? Se nessuno me ne chiede, lo so bene: ma se volessi darne spiegazione a chi me ne chiede, non lo so. Parafrasando Agostino d’Ippona e il suo interrogativo sul tempo, potremmo forse giustificare l’insufficienza e l’inadeguatezza delle risposte possibili a chi si chiede cosa sia il Mediterraneo, a chi vuole comprendere la sua plurima identità dentro una univoca definizione. La verità è che chi vi abita tende a definirsi marsigliese o genovese prima ancora che francese o italiano, essendo le città portuali nella storia mediterranea e nella vita delle popolazioni poli e nodi centrali di reti di connessioni, di visioni del mondo, di orizzonti di senso. Non la geografia certo, ma gli uomini, la loro mobilità, la loro socialità, le loro attività hanno contribuito a determinare ciò che diciamo essere mediterraneo, dal momento che «tutte le identità delineate su base geografica sono più fragili di quanto possa suggerire l’inflessibile retorica della cartografia» (Herzfeld 2007: 251)
Nulla è più geograficamente definita e paradossalmente nulla è più sfuggente dell’immagine del Mediterraneo, di un mare che non è soltanto un mare perché nessun altro spazio è probabilmente più denso di storia e di retoriche, di letteratura e di stereotipi, di miti e di contraddizioni. Polisemico e policentrico – nei complicati e ripetuti passaggi da aggettivo a sostantivo e poi di nuovo aggettivo fino al più recente sostantivo “Mediterraneismo” –, il Mediterraneo si è caricato di una pluralità di segni e di simboli, di sguardi esotici, di investimenti estetici e di tesi ideologiche. Sia esso alternativo alla “modernità” atlantica, metafora del pensiero “meridiano”, sia rappresentato come fronte dell’arretratezza e della subalternità ovvero laboratorio di nuovi rinascimenti e argine del locale contro l’omologazione al globale, il Mediterraneo, al di là di ogni costrutto grammaticale e culturale, sembra associato ad un eterno ed eguale destino essendo eminentemente lo spazio elettivo di transiti e di transumanze, di esili e di asili, di nomadismi e movimenti umani. Ieri come oggi. Non un luogo comune ma se mai un luogo in comune. Un luogo in cui sembrano sfumare le appartenenze e mescolarsi le vecchie carte delle identità nazionali in un bricolage che descrive una rete ordita da mille fili, un patchwork screziato e cangiante.
«Il mondo mediterraneo si offre come punto di osservazione ideale per studiare il problema di come comunità che appartengano a religioni, lingue, etnie e tradizioni diverse possono e riescono a interagire reciprocamente nel tempo. Poche aree al mondo possono uguagliare la densità storica, l’eterogeneità e la complessità dell’interazione sociale che, in conseguenza dell’alto grado di vicinanza e della mobilità geografica, sono emerse nel mondo mediterraneo» (Molho 2002: 29-30). Le vie di terra e di mare tra le diverse e opposte sponde hanno messo in contatto convertiti e rinnegati, coloni e colonizzati, viaggiatori e contrabbandieri, pellegrini e guerrieri, missionari e predoni. Un’umanità composita ed eterogenea di naviganti, nomadi e migranti di cui ancora la storiografia poco ha scritto, come lo stesso Giuseppe Galasso alcuni anni fa ammetteva: «Il movimento delle persone nell’area del Mediterraneo è, in generale, meno conosciuto del movimento delle merci, delle navi, degli altri mezzi di trasporto e, anche, meno conosciuto del movimento delle idee e del propagarsi di fedi religiose, correnti politiche, mentalità e comportamenti» (Galasso 2006: 209).
 Eppure, se c’è un dato connotativo e distintivo, un fattore strutturale e strutturante che identifica nei tempi lunghi della storia l’ecosistema mediterraneo è da ricercare nelle forme pluridirezionali e plurisecolari delle migrazioni, in quella trama di connettività umane e culturali che ha tenuto insieme nord e sud, est e ovest delle rive di questo “continente liquido”, incastonato tra tre continenti. Crocevia antichissimo, in cui – come ha scritto Braudel (1987: 8) – «da millenni tutto vi confluisce, complicandone e arricchendone la storia», cuore del Vecchio Mondo, il bacino del Mediterraneo – «una fenditura della crosta terrestre» – è da sempre snodo di circolazione degli uomini e dei beni, delle tecniche e dei simboli, delle religioni e delle lingue. Nessun altro paesaggio e passaggio geografico può più compiutamente rappresentare il paradigma delle interazioni umane, la metafora del viaggio e dei traffici, il primato delle relazioni e dello scambio. Terra e mare formano un sistema indivisibile, una connessione fisica e antropologica tra i molti qui e i tanti altrove.
Eppure, se c’è un dato connotativo e distintivo, un fattore strutturale e strutturante che identifica nei tempi lunghi della storia l’ecosistema mediterraneo è da ricercare nelle forme pluridirezionali e plurisecolari delle migrazioni, in quella trama di connettività umane e culturali che ha tenuto insieme nord e sud, est e ovest delle rive di questo “continente liquido”, incastonato tra tre continenti. Crocevia antichissimo, in cui – come ha scritto Braudel (1987: 8) – «da millenni tutto vi confluisce, complicandone e arricchendone la storia», cuore del Vecchio Mondo, il bacino del Mediterraneo – «una fenditura della crosta terrestre» – è da sempre snodo di circolazione degli uomini e dei beni, delle tecniche e dei simboli, delle religioni e delle lingue. Nessun altro paesaggio e passaggio geografico può più compiutamente rappresentare il paradigma delle interazioni umane, la metafora del viaggio e dei traffici, il primato delle relazioni e dello scambio. Terra e mare formano un sistema indivisibile, una connessione fisica e antropologica tra i molti qui e i tanti altrove.
Spostare dalla terra al mare lo sguardo per guadagnare una prospettiva talassocentrica significa dunque riconoscere una nuova centralità al ruolo delle traversate e degli spostamenti, siano essi stagionali, circolari o unidirezionali, vuol dire raccontare le esperienze umane di quanti hanno intrapreso viaggi, hanno ripercorso rotte già tracciate o altre ne hanno scoperto. Più che alla vita degli imperi e delle grandi potenze marittime va posta attenzione alle vicende – fortunate o dolorose, avventurose, a volte rocambolesche – che gli uomini hanno vissuto sul mare o attraverso il mare, partendo o tornando, lavorando o combattendo, viaggiando o fuggendo. Portando con loro nella navigazione e scambiando nei porti con gli altri lingua, fedi, costumi, tradizioni, memorie. Nulla a che vedere con il concetto reificato e oggi politicamente deformato di etnia in un contesto in cui le culture sembrano mutuare la plasticità e la mobilità del mare.
Nel segno non delle addizioni ma delle ibridazioni il modello mediterraneo – se di modello possiamo parlare – va letto come sistema di influenze e confluenze, di innesti e contaminazioni, così che sulle rive di questo mare nessuno – qualunque sia stata la sua origine – è mai stato davvero estraneo o spaesato poiché tutti i paesaggi si richiamano l’un l’altro in un gioco di rifrazione fisica, simbolica e sentimentale. «Le culture delle società mediterranee – ha scritto l’antropologa Amalia Signorelli – sono tutte culture reciprocamente ibridatesi, prodotte e riprodotte dallo svolgimento plurisecolare di relazioni interne all’area mediterranea stessa, ma collegate, anche in questo caso da secoli, con più ampi sistemi di relazioni di scala continentale, intercontinentale, mondiale» (Signorelli 2007: 333). Da qui l’ispirazione cosmopolita che nonostante guerre e secessioni questo breve tratto di mare ancora conserva nella sua perenne vitalità.
 Che le dinamiche migratorie siano strumenti conduttori e fondanti della fenomenologia dei rapporti tra i popoli e delle transazioni sociali e culturali è in tutta evidenza dimostrato dai fatti della storia mediterranea che per ogni evento di guerra o di conflittualità, per ogni episodio di tensione e di attrito, per ogni atto di violenza coloniale, ha comunque prodotto trattati commerciali, imprese di cooperazione economica, matrimoni misti e comunità multietniche. «Mare per eccellenza – per usare le parole di Cacciari (1997:16) – l’archi-pélagos, il luogo della relazione, del dialogo, del confronto tra le molteplici isole che lo abitano: tutte dal Mare distinte e tutte dal Mare intrecciate; tutte dal Mare nutrite e tutte nel Mare arrischiate». Braudel, del resto, annotava che il Mediterraneo è mare da costeggiare da promontorio a isola, da isola a promontorio, per una navigazione di cabotaggio, di porto in porto, che ha favorito la formazione di un mosaico di società pluriculturali, destinate a vivere per secoli in regime di commistione e promiscuità. «Un mare – ha scritto Caterina Resta – in continuo dialogo con la terra che lo confina, lo costeggia, lo tiene a freno, lo contiene, insinuandosi in esso con i suoi promontori, frastagliandolo con le sue insenature e i suoi golfi, disseminandolo di isole e penisole» (Resta 2012: 22).
Che le dinamiche migratorie siano strumenti conduttori e fondanti della fenomenologia dei rapporti tra i popoli e delle transazioni sociali e culturali è in tutta evidenza dimostrato dai fatti della storia mediterranea che per ogni evento di guerra o di conflittualità, per ogni episodio di tensione e di attrito, per ogni atto di violenza coloniale, ha comunque prodotto trattati commerciali, imprese di cooperazione economica, matrimoni misti e comunità multietniche. «Mare per eccellenza – per usare le parole di Cacciari (1997:16) – l’archi-pélagos, il luogo della relazione, del dialogo, del confronto tra le molteplici isole che lo abitano: tutte dal Mare distinte e tutte dal Mare intrecciate; tutte dal Mare nutrite e tutte nel Mare arrischiate». Braudel, del resto, annotava che il Mediterraneo è mare da costeggiare da promontorio a isola, da isola a promontorio, per una navigazione di cabotaggio, di porto in porto, che ha favorito la formazione di un mosaico di società pluriculturali, destinate a vivere per secoli in regime di commistione e promiscuità. «Un mare – ha scritto Caterina Resta – in continuo dialogo con la terra che lo confina, lo costeggia, lo tiene a freno, lo contiene, insinuandosi in esso con i suoi promontori, frastagliandolo con le sue insenature e i suoi golfi, disseminandolo di isole e penisole» (Resta 2012: 22).
Fitto reticolo di differenze più che mera sovrapposizione di somiglianze, la supposta identità del Mediterraneo probabilmente consiste proprio nell’esser costitutivamente non identica a se stessa, e la sua sostanziale unità sarebbe data non solo dalla centralità e prossimità geografica ma anche e soprattutto dagli esiti delle traversate e dei contatti, dall’articolarsi e disarticolarsi delle negoziazioni e delle contaminazioni, dagli incontri tra gli uomini prima ancora che tra le civiltà, da quella incessante mobilità che nei modi di una primigenia globalizzazione ha descritto una formidabile circolarità di traiettorie e di rotte, ha attraversato in profondità le acque di questo mare interno e ha segnato le vite individuali e i destini di città e collettività. Fin dall’età omerica, la navigazione dei mercanti e quella dei coloni partiti per fondare comunità agricole si sono infatti intrecciate e reciprocamente sostenute, alimentate, corroborate.
Forse nessuno meglio di Odisseo incarna lo spirito inquieto dell’erranza e dell’oltranza, la figura dell’uomo mediterraneo con le sue audacie e le sue astuzie, la nostalgia e l’ingegno, il peregrinare tra nòstos e éxodus, tra il salpare e il restare. «Tra terra e mare, il viaggio di Ulisse è davvero mediterraneo, una grandiosa epopea delle sue coste frastagliate e dei suoi promontori, delle sue insenature e dei suoi stretti, della straordinaria fioritura di isole, da Ogigia, l’isola di Calipso, a Scheria, la terra dei Feaci, alla Sicilia o alla stessa Itaca, per citare le più note» (Resta 2012: 26). L’eterno ritorno nelle acque già solcate e nei porti conosciuti oppone il Mediterraneo alla sfida dell’ignoto e dell’incerto che spinge ai confini dell’Atlantico “per l’alto mare aperto”. A guardar bene oltre il mito, al di là delle pagine del più grande romanzo di formazione, il viaggio tra le rive mediterranee è sempre un periplo, anche quando le traversate collegano città e sponde lontane. «Il Mediterraneo – ha scritto Braudel (1992: 51) – è un insieme di vie marittime e terrestri collegate tra loro, e quindi di città che, dalle più modeste alle medie, alle maggiori si tengono tutte per mano. Strade e ancora strade, ovvero tutto un sistema di circolazione. È attraverso tale sistema che possiamo arrivare a comprendere fino in fondo il Mediterraneo, che si può definire, nella totale pienezza del termine, uno spazio-movimento»
Più che alle nazioni, come ha insegnato Matvejevic, i migranti sentono di appartenere alle città, alle singole comunità di origine e di insediamento che, pur distinti e distanti nelle carte geografiche, attraverso di loro si relazionano, si strutturano, si saldano. Da qui la formazione di identità miste, quelle comunemente definite col trattino, che hanno accompagnato le vicende migratorie di non poche popolazioni mediterranee.
La figura dell’homo viator nella quale oggi con qualche approssimazione si identifica il trasmigrante, colui che nel contesto contemporaneo sembra sfidare i confini per posizionarsi “nel mezzo”, in betwixt and between, ovvero nella particolare condizione liminale caratterizzata da interdipendenza e affiliazione a più località di riferimento, questo soggetto che gli studiosi hanno estrapolato dalle dinamiche della cosiddetta postmodernità è forse da ricondurre al modello storico delle migrazioni mediterranee, a quei movimenti di uomini che non hanno mai cessato di essere agenti di una “globalizzazione popolare”, di una potente spinta alla dislocazione. Certo, oggi la facilità dei mezzi di comunicazione e di trasporto, le innovazioni tecnologiche e l’ampliamento del mercato internazionale del lavoro hanno provocato la velocità degli spostamenti, l’enorme incremento delle opportunità di contatto e di interscambio, la pratica diffusa del nomadismo e del transnazionalismo. Tuttavia, sembra che nella storia del Mediterraneo tutto sia già accaduto, che nel suo laboratorio umano e culturale sia possibile individuare i nessi che spiegano e legano nello stesso spazio e nello stesso tempo nostos ed exodus, emigrazione e immigrazione, le dinamiche del passato e le tendenze del presente.
La verità è che le migrazioni, in quanto eventi endemici e connaturati nella storia degli uomini, sono fatti sociali totali e hanno il potere epifanico di portare in superficie quanto matura e si agita nel profondo delle società, sia di quelle di origine che di quelle di arrivo, essendo vettori rivelatori e catalizzatori delle loro pulsioni, contraddizioni, aspirazioni. L’intuizione di Marx, secondo il quale gli uomini fanno la storia ma non sanno di farla, può forse risolversi nel processo carsico messo in moto da una oggettiva forza centrifuga volta a generare e secondare le spinte di accelerazione e di trasformazione, la connaturata mobilità dei popoli, le grandi migrazioni che altro non sono che una componente essenziale e strutturale del ricambio demografico, sociale, economico e antropologico dell’umanità. Una forza non meccanica né deterministica, non estranea certo alla volontà degli uomini, ma ad essa complementare e agente irriflessa, eredità di quel nomadismo consustanziale alla evoluzione della specie, fattore propulsivo e moltiplicatore di tendenze e influenze.
I migranti, oggi come ieri, per il fatto che per loro oggettiva vocazione allontanano ciò che è a loro vicino e avvicinano quanto è a loro lontano, operano come potenti cunei di penetrazione nel territorio e di connessione tra comunità e località, alimentando le attività di interscambio e di interdipendenza, dando e ricevendo beni materiali e immateriali: oggetti, cibi, tecniche, costumi e simboli. Per quanto sia, in tutta evidenza, diseguale e asimmetrico nel gioco dei poteri il rapporto che essi stabiliscono con i cittadini, le culture a contatto producono comunque mediazioni, negoziazioni, contaminazioni, attraversamenti, riposizionamenti.
Nulla è dunque, nelle dinamiche antropologiche delle migrazioni, riconducibile a schematismi unilaterali e unidirezionali e tutto invece va declinato e risolto nel segno della reciprocità, della trasversalità, della congiunzione più che della disgiunzione. Ecco perché non ci può essere alcuna cesura o discontinuità nella lettura dei due fenomeni complementari e consustanziali, quali l’emigrazione e l’immigrazione, non solo nel caso in cui interessano e coinvolgono la stessa figura, emigrato prima di essere immigrato, ma più in generale perché interagiscono, s’influenzano e si spiegano vicendevolmente, in una sorta di meccanico feedback, dal momento che quel che accade nel luogo di arrivo ha le sue cause e le sue conseguenze nella società di partenza, e viceversa. Così che il qui e il là sono esperiti e vissuti come referenti spaziali e temporali concomitanti e contestuali, come luoghi e vicende che abitano e si snodano dentro un’unica storia condivisa.
Fermo restando dunque lo specifico dello status di straniero, la figura del migrante oggi si colloca in uno spazio d’azione e di intraprendenza più ampio rispetto al passato, all’incrocio tra pratiche, modelli e norme riconducibili a più mondi culturali, non solo a quello d’origine e a quello di insediamento, di cui partecipa nei modi e nelle forme declinate nel tempo della globalizzazione. Non più necessariamente vocato all’alternativa tra assimilazione ed esclusione, né più soltanto destinato a essere considerato un trapiantato nel regime del multiculturalismo che accetta e rispetta le differenze solo nella loro esplicita e reciproca separatezza, chi emigra lungo le rotte transnazionali tende ad essere piuttosto impegnato in una sorta di bricolage, un lavoro di mediazione e traduzione, di scomposizione e ricomposizione di elementi diversi tratti sia dal Paese originario sia da quello di adozione sia da altri luoghi immateriali o immaginari, in un gioco di appartenenze plurime percepite non già come perdite né come repliche ma come risorse plastiche, opzioni aperte, posture mobili e fluttuanti.
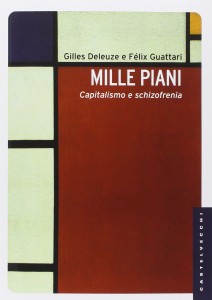 Nel sistema reticolare o rizomatico, per usare le parole di Gill Deleuze (1987), che le migrazioni comunque producono nonostante i cippi e i muri innalzati dalle politiche nazionali, si esprimono le soggettività degli stranieri che tessono legami, connettono spazi, rimodulano e rinnovano il loro patrimonio culturale, costruiscono ricongiungimenti familiari e catene parentali, elaborano dispositivi di mutuo sostegno, attivano rimesse, dispiegano network e strutture associative, creano circuiti di economia etnica transnazionale. Non c’è probabilmente manifestazione più esplicita della soggettività dei migranti della loro inventiva imprenditoriale, della loro capacità di investire e intraprendere tra due mondi (Ambrosini 2009), di capitalizzare le risorse etniche per avviare esercizi commerciali, negozi di phone center, di money trasfert, di articoli esotici, ristoranti, piccoli market, cucine di strada.
Nel sistema reticolare o rizomatico, per usare le parole di Gill Deleuze (1987), che le migrazioni comunque producono nonostante i cippi e i muri innalzati dalle politiche nazionali, si esprimono le soggettività degli stranieri che tessono legami, connettono spazi, rimodulano e rinnovano il loro patrimonio culturale, costruiscono ricongiungimenti familiari e catene parentali, elaborano dispositivi di mutuo sostegno, attivano rimesse, dispiegano network e strutture associative, creano circuiti di economia etnica transnazionale. Non c’è probabilmente manifestazione più esplicita della soggettività dei migranti della loro inventiva imprenditoriale, della loro capacità di investire e intraprendere tra due mondi (Ambrosini 2009), di capitalizzare le risorse etniche per avviare esercizi commerciali, negozi di phone center, di money trasfert, di articoli esotici, ristoranti, piccoli market, cucine di strada.
In questa prospettiva che tiene insieme quanto si tende a separare, il Mediterraneo eminentemente plurale si offre come osservatorio privilegiato per decostruire le vecchie mappe d’interpretazione delle migrazioni e per tentare modelli euristici di comparazione interculturale. Nell’orizzonte di questo mare l’emigrante di ieri e l’immigrato di oggi sono distinguibili solo nel tempo dal respiro breve, nella misura evenemenziale dei fatti. Se però spingiamo lo sguardo un po’ più in là della urgente contingenza, se prendiamo a prestito le categorie braudeliane della lenta e lunga durata, allora ci accorgiamo che gli attuali flussi che dalla sponda meridionale approdano in Sicilia altro non sono che un’onda superficiale del più grande e incessante movimento di uomini che da millenni percorre in più direzioni questo spazio, da sempre «polo di attrazione e di acculturazione», per usare le parole di Maurice Aymard.
Se le traversate hanno conosciuto nel tempo traiettorie di segno opposto, la Sicilia è stata al centro di questa intensa mobilità, soglia mobile dell’Europa ma anche porta di accesso per l’Africa settentrionale. La storia non torna mai sui propri passi ma frequenta spesso gli stessi luoghi. Così, nella dimensione transfrontaliera del Mediterraneo, l’immigrazione maghrebina oggi nelle città siciliane può configurarsi come un ritorno, se consideriamo che nell’827 gruppi di berberi provenienti dall’antica Ifriqiya sbarcarono nell’Isola per avviarne la conquista. Ma può contestualmente essere letta come un effetto di rifrazione della presenza dei siciliani in Tunisia, documentata già nelle pagine del Decamerone di Boccaccio, dove si ha notizia di pescatori cristiani trapanesi che vivevano e lavoravano nella musulmana Ifriqiya. Durante la lunga guerra da corsa, prìncipi e tonnaroti, uomini d’affari e corallari, vescovi e poeti siciliani, passati per disgrazia in terra maghrebina, vi si sono lungamente trattenuti fino ad eleggerla a loro seconda patria. E più recentemente, dalla seconda metà dell’Ottocento fino alla prima metà del Novecento, i siciliani hanno dato vita ad una popolosa e laboriosa comunità.
Che la Tunisia sia stata terra d’immigrazione italiana e soprattutto siciliana è storia che nella letteratura dell’emigrazione è rimasta ai margini. Eppure solo l’esperienza in Argentina è paragonabile a quella tunisina, per densità di permanenza, di contatti e di penetrazione economica e culturale. L’Africa maghrebina fu a lungo percepita come il naturale prolungamento della penisola e delle isole, assumendo i contorni di una terra promessa ove cercare fortuna. Capo Bon era raggiunta da panteschi e trapanesi a bordo di piccole imbarcazioni a vela e la migrazione che aveva un carattere spontaneo sfidava spesso i limiti della legalità. Il fenomeno, conosciuto come la kharqa ovvero la traversata, non si arrestò nemmeno in epoca fascista, quando era di fatto proibito l’espatrio. Siciliana è stata la comunità straniera più numerosa stabilmente insediata già a partire dalla seconda metà del secolo XIX in Tunisia, prima che questa diventasse protettorato francese. Perfino sotto la dominazione coloniale, i siciliani occuparono uno spazio sociale e culturale non trascurabile tra colonizzatori e colonizzati.
I pescatori mazaresi e tunisini che oggi dalla stessa imbarcazione gettano insieme le reti nello stesso mare ripetono, senza averne forse memoria né consapevolezza, i gesti di un’antica alleanza, replicano in fondo gli invisibili segni e disegni della storia, riannodano i fili di quel pendolarismo costante e reversibile che ha tessuto una trama plurisecolare di transazioni e mutualità. Rispetto al passato sono probabilmente diverse la natura e le cause dei flussi, come diverso è sicuramente il peso degli effetti demografici ed economici delle attuali migrazioni, in cui crescente è il protagonismo delle donne, inedito e rilevante il numero dei rifugiati di guerra e dei minori non accompagnati, inquietante il ruolo esercitato dalla criminalità organizzata nel traffico di esseri umani. Tuttavia quella via stretta, denominata canale di Sicilia o di Tunisi a secondo della riva da cui si guarda, continua ad essere snodo centrale di un sistema reticolare complesso, di uno spazio itinerante che, nonostante tutto, rimuove confini e sbarramenti, sposta orizzonti e frontiere.
 Se è vero che esiste e persiste tanto Islam in Sicilia, è dunque ancor più vera e ampiamente accertata la presenza di tanta Sicilia nell’Islam, nonostante la generale rimozione della memoria storiografica e culturale. Nella fluidità dei confini descritti nel Mediterraneo, nelle attività commerciali come nella vita quotidiana l’ibridismo di Oriente e Occidente ha a lungo parlato una lingua franca che mescolava l’arabo e il siciliano. A Lampedusa, più volte contesa e al centro ieri come oggi di rotte, approdi e traversate, era una grotta sacra dedicata alla vergine Maria dove, fino alla metà del secolo XVI, marinai cristiani e musulmani offrivano preghiere ed ex voto. Perfino, dunque, nelle pratiche di culto la Sicilia ha conosciuto significative esperienze di accoglienza e di tolleranza. Più ampiamente, nel Mediterraneo la questione oggi quanto mai arroventata e distorta dei rapporti tra Islam e Occidente è stata sempre risolta nella logica del pragmatismo e dell’umanesimo. A quanti sostengono l’incompatibilità delle culture, la loro irriducibile inconciliabilità va probabilmente ricordata l’esperienza della civiltà arabo-normanna che nella storia siciliana costituisce la pagina più nobile e più illustre. Va sicuramente richiamata la lezione di Michele Amari che ci ha insegnato che l’Islam non è l’Altro, essendo stato a lungo parte costitutiva di quell’amalgama felice che ha prodotto l’irripetibile koinè culturale trapassata nella filosofia, nelle arti, nella letteratura e nelle scienze.
Se è vero che esiste e persiste tanto Islam in Sicilia, è dunque ancor più vera e ampiamente accertata la presenza di tanta Sicilia nell’Islam, nonostante la generale rimozione della memoria storiografica e culturale. Nella fluidità dei confini descritti nel Mediterraneo, nelle attività commerciali come nella vita quotidiana l’ibridismo di Oriente e Occidente ha a lungo parlato una lingua franca che mescolava l’arabo e il siciliano. A Lampedusa, più volte contesa e al centro ieri come oggi di rotte, approdi e traversate, era una grotta sacra dedicata alla vergine Maria dove, fino alla metà del secolo XVI, marinai cristiani e musulmani offrivano preghiere ed ex voto. Perfino, dunque, nelle pratiche di culto la Sicilia ha conosciuto significative esperienze di accoglienza e di tolleranza. Più ampiamente, nel Mediterraneo la questione oggi quanto mai arroventata e distorta dei rapporti tra Islam e Occidente è stata sempre risolta nella logica del pragmatismo e dell’umanesimo. A quanti sostengono l’incompatibilità delle culture, la loro irriducibile inconciliabilità va probabilmente ricordata l’esperienza della civiltà arabo-normanna che nella storia siciliana costituisce la pagina più nobile e più illustre. Va sicuramente richiamata la lezione di Michele Amari che ci ha insegnato che l’Islam non è l’Altro, essendo stato a lungo parte costitutiva di quell’amalgama felice che ha prodotto l’irripetibile koinè culturale trapassata nella filosofia, nelle arti, nella letteratura e nelle scienze.
Nella consapevolezza che nell’incontro tra culture nulla si cancella del tutto e, nel tempo lungo delle generazioni, le differenze si rielaborano e si riplasmano attraverso un originale processo di lenta negoziazione e di splendido sincretismo, Amari ha voluto significativamente definire la presenza degli arabi non già semplicemente “in Sicilia” ma “di Sicilia”. E arabi siciliani ovvero siciliani arabi, o più precisamente siquillyani, furono i costruttori di quella specifica immagine universale dell’Isola, che fece dire a Sciascia che i siciliani cominciarono a comportarsi da siciliani solo dopo la conquista araba. Lo stesso Amari (1854) si chiedeva: «Perché rinnegare le glorie degli arabi, se i francesi tengono tanto a quelle dei franchi, gli inglesi a quelle dei sassoni, e anche l’origine longobarda è un vanto in Italia? Or la Sicilia senza arabi forse sarebbe restata quel che fu ed è la Calabria (…). Gli arabi – arabi e berberi uniti in un’unica nazione – occuparono questo suolo, vi si stabilirono, s’incorporarono una parte dei vinti; si suddivisero in piccoli principati, e così diminuirono la forza politica, ma accelerarono i progressi della civiltà e poi, riannodati di nuovo sotto un principato straniero e cristiano, ne costituirono la principale forza. Perché Palermo fu la capitale della Sicilia e dei domini continentali? Perché Palermo era l’importanza della Sicilia musulmana e non altro. Sia dunque un po’ meno nemica degli arabi».
Così scriveva Amari più di centocinquanta anni fa, ma sembrano le sue parole rivolte a noi contemporanei e a noi siciliani in particolare, e assumono il significato di un monito, di un’esortazione. Se la Sicilia non è soltanto Occidente ma è prima di tutto Mediterraneo, lo abbiamo appreso dal padre degli arabisti, che ha ampiamente e definitivamente documentato il radicamento dell’Isola nella casa dell’Islam (dar al-islam), alle porte dell’Oriente. A rileggere oggi la sua Storia dei musulmani di Sicilia, che Vittorini definì «una seduzione del cuore», si disvela in tutta la sua complessità l’intensa trama di relazioni che attorno all’Isola araba e normanna si sono diramate, per almeno cinque secoli, lungo le vie del Mediterraneo. Nella storia narrata da Amari la Sicilia, più della Spagna, ha avuto in quei secoli un ruolo centrale di crocevia, diventando prima araba restando latina e dopo normanna rimanendo araba. Non è senza significato che a Palermo si parlassero e si usassero a lungo nelle istituzioni e negli atti formali tre lingue: il latino, il greco e l’arabo.
Nella prospettiva braudeliana della lunga durata – dal tempo di Asad Ibn al Furàt che ha aperto la strada all’occupazione araba fino all’età di Federico II e alla dominazione sveva – l’Isola ha conservato la sua centralità nell’area mediterranea, con la sua eminente funzione di mediazione, in continuità con la remota antichità, di fondamentale cerniera e anello di congiunzione tra aree comunicanti, di ponte e frontiera (thaghr) tra mondi, passaggio aperto, paesaggio vivificato da intensi processi osmotici. Non sappiamo se l’età che chiamiamo arabo-normanna fu l’ultima delle civiltà classiche o forse la prima delle civiltà moderne. Sappiamo che quel trattino univa ciò che oggi teniamo separato, faceva dialogare mondi che ci ostiniamo a dichiarare inconciliabili, rappresentando la prova inconfutabile che le civiltà non sono incompatibili ma se mai incomparabili. Nel mosaico dei popoli a contatto in cui è possibile identificare la cartografia del Mediterraneo, la Sicilia è stata essa stessa un mosaico di culture ora giustapposte ora sovrapposte, cumulate e stratificate che ne hanno fatto un “continente in miniatura”, secondo la nota definizione di Braudel. Non idilliche fusioni, dunque, né le improbabili omogeneità di certe retoriche mediterraneiste ma congiunzioni, coesistenze, convivenze, esperienze storiche che fanno delle diverse realtà modelli antropologici e osservatori privilegiati «per studiare come le culture si fanno simili e come si differenziano» (Signorelli 2007: 333).
 Da un’estremità all’altra del Mediterraneo quel che la storia delle migrazioni e delle interazioni tra popoli e civiltà aveva fatto incontrare e amalgamare tende oggi a disfarsi rovinosamente. Gli etnocentrismi reciproci, i fondamentalismi e i sovranismi imperanti hanno nel nostro secolo prodotto opposte cecità, simmetrici strabismi, profondi malintesi e insanabili fratture tra diversi modi di vedere, di pensare, di rappresentare l’Altro. Di «sguardi mutilati» ha scritto lo studioso iraniano Daryush Shayegan. Segnatamente – tra il Tigri e l’Eufrate, tra il Mar Rosso e il Golfo Persico, tra il Mediterraneo e l’altopiano iraniano – Oriente e Occidente oggi si guardano e si toccano ma stentano a dialogare, qui sembrano precipitare e coagulare le divisioni e contrapposizioni geopolitiche e militari, i pregiudizi culturali e le incomprensioni secolari. Vocaboli, immagini, categorie concettuali e narrazioni fondate sullo schema irriducibile di un dualismo manicheo hanno attraversato e permeato la storia del Medio Oriente colonizzato, frammentato, spartito ed egemonizzato da oligarchie economiche al potere e da aristocrazie sociali.
Da un’estremità all’altra del Mediterraneo quel che la storia delle migrazioni e delle interazioni tra popoli e civiltà aveva fatto incontrare e amalgamare tende oggi a disfarsi rovinosamente. Gli etnocentrismi reciproci, i fondamentalismi e i sovranismi imperanti hanno nel nostro secolo prodotto opposte cecità, simmetrici strabismi, profondi malintesi e insanabili fratture tra diversi modi di vedere, di pensare, di rappresentare l’Altro. Di «sguardi mutilati» ha scritto lo studioso iraniano Daryush Shayegan. Segnatamente – tra il Tigri e l’Eufrate, tra il Mar Rosso e il Golfo Persico, tra il Mediterraneo e l’altopiano iraniano – Oriente e Occidente oggi si guardano e si toccano ma stentano a dialogare, qui sembrano precipitare e coagulare le divisioni e contrapposizioni geopolitiche e militari, i pregiudizi culturali e le incomprensioni secolari. Vocaboli, immagini, categorie concettuali e narrazioni fondate sullo schema irriducibile di un dualismo manicheo hanno attraversato e permeato la storia del Medio Oriente colonizzato, frammentato, spartito ed egemonizzato da oligarchie economiche al potere e da aristocrazie sociali.
A guardare oggi questo mare ci chiediamo dove sia andato a finire il Mediterraneo raccontato da Braudel, quello spazio tra sponde che sotto cieli diversi aveva orizzonti incrociati, frontiere permeabili, aree ospitali e franche, sistemi e reti di connessioni, approdi e sicuri ripari da scontri. Uno sfondo comune abbracciava i popoli che lo attraversavano, uno spirito d’inclusione tacitamente dialogico ne animava e informava le comunità e le culture che, pur misurandosi nelle asimmetrie dei poteri e nelle tensioni dei conflitti, si riconoscevano nelle differenze in un gioco di specchi che rendeva complementari le identità di ciascuna. Senza cadere nell’essenzialismo di interpretazioni retoriche di stampo eurocentrico, il Mediterraneo è memoria di una storia plurisecolare di incontri tra mare e terra, di passaggi e sconfinamenti, di società di confine forgiate dalla mobilità. Non ci sono parole più efficaci e illuminanti di quelle di Braudel per esprimere compiutamente questo concetto: «Il Mediterraneo non è neppure un mare, è un complesso di mari, e di mari ingombri di isole, tagliati da penisole, circondati da coste frastagliate. La sua vita è mescolata alla terra, la sua poesia è più che a metà rustica, i suoi marinai sono contadini, è il mare degli oliveti e delle vigne quanto degli stretti battelli a remi o dei navigli rotondi dei mercanti, e la sua storia non è separabile dal mondo terrestre che l’avvolge più di quanto non lo sia l’argilla dalle mani dell’operaio che la modella» (Braudel, 1976: XXIII-XXIV).
Cos’è oggi diventato la talassa degli antichi Greci, il grembo materno in cui si ricoveravano gli esuli, l’arcipelago di isole disseminate che dispiegavano contatti tra i popoli, intrecciavano traffici e scambi tra corsari e coloni, naviganti e mercanti, viaggiatori e pellegrini? Che ne è oggi delle città-mondo, quelle descritte da Boccaccio nel Decamerone o da Amitav Ghosh nel Medioevo dei suoi racconti, quando il Mediterraneo era crocevia di un fitto reticolo di relazioni tra continenti e le migrazioni erano libera e vitale circolazione di uomini tra sponde di terre comunicanti e non flussi di clandestini da controllare, frenare, arrestare? Cosa è rimasto dell’orizzonte dell’immaginario, della memoria condivisa di simboli e della tradizionale coesistenza di valori culturali pur nelle varietà di storie e civiltà tra l’Oriente e l’Occidente di questo mare? Come è possibile che questo antico spazio di transiti fecondi di uomini e cose, di mercanzie e di lingue, di idee e di dèi, sia diventato area periferica e marginale, Colonne d’Ercole di una Fortezza da presidiare e da difendere, tragico Vallo costruito sull’acqua per fermare i fuggiaschi, gli affamati, i disperati?
 Quanto sta accadendo nel Mediterraneo, oggi tornato ad essere epicentro gravitazionale della storia mondiale, è l’esito drammatico della rovinosa implosione degli equilibri geopolitici, effetto perverso di una globalizzazione distorta ma anche conseguenza della negazione e della torsione della lunga tradizione transfrontaliera di libera mobilità degli uomini come dei beni materiali e immateriali. «Dopo la caduta del Muro di Berlino, il confine principale tra il mondo di qua e il mondo di là cade proprio tra le onde di quello che, fin dall’antichità, è stato chiamato Mare di mezzo». Così Alessandro Leogrande, nell’ultimo suo reportage narrativo La frontiera (2018: 40), in cui scrive di «una faglia sotterranea che taglia in due il Mediterraneo da est a ovest. Dal Vicino Oriente fino a Gibilterra». Nel tempo greve e confuso che stiamo vivendo il Mediterraneo sembra infatti essersi trasformato in un tragico teatro in cui si rappresenta lo scenario dei confini e delle frontiere nel cuore di una nuova “guerra fredda” tra il Nord e il Sud del mondo.
Quanto sta accadendo nel Mediterraneo, oggi tornato ad essere epicentro gravitazionale della storia mondiale, è l’esito drammatico della rovinosa implosione degli equilibri geopolitici, effetto perverso di una globalizzazione distorta ma anche conseguenza della negazione e della torsione della lunga tradizione transfrontaliera di libera mobilità degli uomini come dei beni materiali e immateriali. «Dopo la caduta del Muro di Berlino, il confine principale tra il mondo di qua e il mondo di là cade proprio tra le onde di quello che, fin dall’antichità, è stato chiamato Mare di mezzo». Così Alessandro Leogrande, nell’ultimo suo reportage narrativo La frontiera (2018: 40), in cui scrive di «una faglia sotterranea che taglia in due il Mediterraneo da est a ovest. Dal Vicino Oriente fino a Gibilterra». Nel tempo greve e confuso che stiamo vivendo il Mediterraneo sembra infatti essersi trasformato in un tragico teatro in cui si rappresenta lo scenario dei confini e delle frontiere nel cuore di una nuova “guerra fredda” tra il Nord e il Sud del mondo.
Il mare nostrum rischia di diventare un mare monstrum. Forse, mai come oggi, appare dilaniato da una frammentazione molecolare di tutte le sovranità, da una violenta destrutturazione e ridefinizione di muri e fili spinati, dalla infinita ed epocale diaspora di una umanità in drammatica e disperata fuga dai focolai di guerra, dal Sahel al Corno d’Africa, dal Medio Oriente al Golfo Persico. Cosa ne è della Siria, dell’Iraq, della Libia, dell’Eritrea, della Somalia o dello Yemen? Tra decapitazioni, esecuzioni di massa e riduzioni in schiavitù per opera dei jihadisti, barbarie ed eccidi tra le diverse forze in conflitto, quali esiti avrà il gioco al massacro per la supremazia territoriale, la lotta per il potere tra sunniti e sciiti, tra sunniti e sunniti, la folle rincorsa alla ripulsa e all’orrore? Nella galassia islamica quali e quanti califfi sono legittimati? E, soprattutto, nel piano bellico contro i “crociati” e l’Impero del Male che ruolo occupa ancora la questione palestinese? E infine quante potenze – arabe e non arabe, occidentali e non – sono in competizione per il predominio e il controllo sull’insoluto e insolubile puzzle mesopotamico? Non sappiamo dare una risposta persuasiva a nessuno di questi interrogativi. Sappiamo che va combattuta la terribile potenziale alleanza tra i trafficanti che hanno il monopolio dei viaggi per mare e i jihadisti impegnati a conquistare territori. Sappiamo che le guerre producono esodi e campi profughi, che le persecuzioni generano smembramenti familiari e migrazioni, che la desertificazione avanza ed espelle masse di diseredati, di giovani che cercano una via di fuga, sfuggono a stento al mattatoio libico, sfidano il mare, attraversano a piedi l’Europa, saltano muri e scavalcano reticolati.
Attorno a questo Mediterraneo travolto e stravolto da strategie politiche e militari estranee alla volontà delle popolazioni civili, ancora una volta vittime di una Storia di crimini e di soprusi, nella totale assenza dell’Europa e delle sue istituzioni, il contesto globale offre l’immagine screziata di un patchwork, di un mondo balcanizzato, senza centro e senza radicamento, che nell’immaginario mitico delle religioni ritrovate, rinsanguate o asservite sembra voler ricercare un orizzonte di senso alla logica totalizzante dell’economicismo e alla crisi occidentale di identità e di autorità. La teologia al posto della secolarizzazione, il sovranismo come argine alla globalizzazione, l’etnicismo come antidoto alla omologazione, l’endogamia come estremo riparo.
Mentre l’Europa balbetta e si divide, si consuma la più grande tragedia umanitaria dal dopoguerra ad oggi. Un crimine senza nome. Una deportazione invisibile e inenarrabile. Un genocidio di desaparecidos. Nella trincea scavata dal Vecchio Continente a protezione della Fortezza, precipitano nel buio dei fondali come in un’oscura foiba migliaia di profughi che tentano la traversata. Nel mondo capovolto che abitiamo si fa la guerra ai migranti che fuggono dalle guerre, si combattono i poveri e non la povertà, si stigmatizzano le diversità per legittimare le disuguaglianze e si criminalizzano le solidarietà per giustificare le risoluzioni più ciniche.
«Dalle coste dell’Africa dove sono nato – scriveva Albert Camus – si vede meglio il volto dell’Europa. E – aggiungeva – si sa che non è bello». L’Europa vista dal Mediterraneo è un mito e un tradimento, una speranza e una disillusione. Paradossalmente i migranti, che sono la cicatrice più profonda della globalizzazione e il fardello più riprovevole della coscienza europea, sono anche agenti e referenti di un protagonismo transcontinentale e transculturale, possono essere la forza, l’occasione, la spinta, il movente per riappropriarci di un’idea dell’Europa che abbiamo perduto, possono rappresentare la leva che la storia sta adottando per dare una svolta alla politica della comunità europea perché finalmente assuma un orizzonte che vada al di là degli egoismi nazionali, recuperi la sua vocazione originaria e torni a guardare al Mediterraneo. «Solo un’Europa capace di riconoscere nel Mediterraneo la propria culla e di tornare a rivolgersi a quelle sponde da troppo tempo relegate a sua dimenticata periferia, potrebbe davvero ritrovare il suo ‘naturale’ (dal punto di vista geostorico) baricentro, quel mare in cui specchiarsi non solo con nostalgico rimpianto per la perduta centralità nella storia del mondo, ma con l’orgogliosa consapevolezza di costituire un grande spazio capace di esercitare il proprio ruolo di neutralizzazione dei conflitti, scongiurando il pericolo di uno scontro di civiltà» (Resta 2012:104).
Fulcro generatore di nuova storia, luogo di grande sperimentazione politica e culturale, questo mare ha plasmato civiltà che offrono un modello antropologico diverso rispetto a quello ispirato all’individualismo e alla omologazione. L’umanesimo incarnato nei valori dello scambio e del dono, dell’ospitalità e della tolleranza, della spiritualità e della ritualità costituisce un prezioso capitale culturale la cui eredità va difesa e diffusa, un patrimonio di memorie, di tradizioni e di legami che non saremmo disposti a dissipare sol che riconoscessimo che, in fondo, tra le onde di quel mare è il ricordo delle acque amniotiche da cui ha avuto origine il nostro essere europei.
A fronte delle cupe fobie occidentali, delle logiche di esclusione e di discriminazione elette a sistema di legge e di pattugliamento militare, contro i sovranismi che vorrebbero confinarci nel più arido e asfittico isolamento con la chiusura dei porti e il respingimento dei migranti, contro la visione neocarolingia di un’Europa asserragliata dietro una inutile e miope trincea, la lezione del Mediterraneo è quanto mai preziosa e attuale. Ci insegna che in questo mare, da sempre attraversato da corsari e da crociati, da pirati e da schiavi, da coloni e da pescatori, tensioni e guerre non hanno mai fermato quel movimento umano che ne ha per secoli avvicinato le sponde. Ci ricorda con le parole di Matvejevic (1991:18) che «i suoi confini non sono definiti né nello spazio né nel tempo. Non sappiamo come fare a determinarli e in che modo: sono irriducibili alla sovranità o alla storia, non sono né statali né nazionali: somigliano al cerchio di gesso che continua ad essere descritto e cancellato, che le onde e i venti, le imprese e le ispirazioni allargano o restringono».
 Nel coacervo dei ghetti in cui la canea anti immigrati vorrebbe rinchiuderci, rischiamo di rimuovere dal codice naturale la millenaria legge del mare che impone il salvataggio senza preoccuparsi del passaporto di chi sta affogando, espelliamo dal nostro patrimonio identitario proprio quel che ci fa eminentemente mediterranei, sostanzialmente umani. A quanti ritengono di dover liberare il Mare Nostrum dai “barbari” che tentano l’arrembaggio alle nostre coste e dai loro facinorosi complici intenti a soccorrerli, vanno richiamate le parole che Claudio Magris ha scritto in quello splendido breviario che è L’infinito viaggiare (2005: XIII-XIV): «Alle genti di una riva quelle della riva opposta sembrano spesso barbare, pericolose e piene di pregiudizi nei confronti di chi vive sull’altra sponda. Ma se ci si mettesse a girare su e giù per un ponte, mescolandosi alle persone che vi transitano e andando da una riva all’altra fino a non sapere più bene da quale parte e in quale paese si sia, si ritrova la benevolenza per se stessi e il piacere del mondo».
Nel coacervo dei ghetti in cui la canea anti immigrati vorrebbe rinchiuderci, rischiamo di rimuovere dal codice naturale la millenaria legge del mare che impone il salvataggio senza preoccuparsi del passaporto di chi sta affogando, espelliamo dal nostro patrimonio identitario proprio quel che ci fa eminentemente mediterranei, sostanzialmente umani. A quanti ritengono di dover liberare il Mare Nostrum dai “barbari” che tentano l’arrembaggio alle nostre coste e dai loro facinorosi complici intenti a soccorrerli, vanno richiamate le parole che Claudio Magris ha scritto in quello splendido breviario che è L’infinito viaggiare (2005: XIII-XIV): «Alle genti di una riva quelle della riva opposta sembrano spesso barbare, pericolose e piene di pregiudizi nei confronti di chi vive sull’altra sponda. Ma se ci si mettesse a girare su e giù per un ponte, mescolandosi alle persone che vi transitano e andando da una riva all’altra fino a non sapere più bene da quale parte e in quale paese si sia, si ritrova la benevolenza per se stessi e il piacere del mondo».
Andare da una riva all’altra è sempre stato pratica quotidiana di vita mediterranea. Ecco perché se c’è un cittadino di questo mare esso è da identificare nel migrante, nel profugo, nel giovane richiedente asilo, figura esemplare della postmodernità, impegnata ad appagare ansie di libertà e di riscatto, modellando in maniera attiva quel processo di mobilità destinato ad autoalimentarsi. A dare energia e slancio alle loro partenze è forse quella «capacità di avere aspirazioni», di cui scrive Appadurai (2014: 258), una «capacità di orientamento nutrita dalla possibilità di fare congetture e confutazioni sul mondo reale», un bagaglio culturale su cui è possibile costruire e definire l’orizzonte delle aspettative. In fuga da guerre o stretto dalla fame, egli è comunque soggetto dotato di agency, di volontà, di personalità, di risorse umane, vocato ad immaginare nuove vite possibili, determinato nelle azioni e sostenuto da un certo protagonismo, non un individuo privo di identità, passivamente sballottato ed eterodiretto dal destino potente e cogente. La sua fuga dalla catastrofe è anche desiderio di opporsi, di andare altrove, di cercare altro, spesso contro ogni evidenza, desiderio destinato a non essere addomesticato, verosimilmente proprio a causa delle condizioni estreme in cui nasce e si alimenta.
Con le vite scampate dei fuggiaschi giungono dal mare le energie di un mondo che non si piega alla rassegnazione, la sofferenza e la vitalità di una umanità destinata ad abitare e rinsanguare l’esausto ed estenuato continente europeo ripiegato nella sua inarrestabile china non solo demografica. Giungono le vite di giovani donne e i progetti di vita che portano nel loro grembo, le vite nascenti offerte in pegno per una promessa di riscatto, la speranza di un investimento nell’unico capitale posseduto: quello umano. Paradossalmente ne è prova la sfida drammatica che si consuma nelle acque del Mediterraneo, dove, nonostante l’azione di respingimento e di contrasto concertata dagli Stati europei, sono più forti del rischio del rimpatrio e della stessa paura della morte le ragioni del vivere, del progettare la propria vita, del decidere del proprio futuro.
Sfugge ai più quanto questo nostro presente sia già denso di avvenire, quanto sia profonda nel tempo e nello spazio l’irruzione di quel sesto continente dai confini mobili, composto da uomini, donne e bambini. Né si ha chiara percezione della “crescita del grano”, come direbbe Lévi-Strauss, del profilo di nuovi orizzonti che si delinea nel panorama demografico e antropologico delle nostre società, nel paesaggio umano e culturale delle nostre città. Da un lato i migranti in lunga fila e senza bagagli, che arrivano dal mare e chiedono asilo, dall’altro gli immigrati già insediati e radicati con le famiglie, i figli, le nuove generazioni scolarizzate e socializzate. Degli uni e degli altri i vissuti sono oggettualizzati o reificati, la soggettività è oscurata, minimizzata o contraffatta dalle rappresentazioni costruite dalle retoriche politiche e disseminate nel senso comune. Privi di potere contrattuale e senza capacità di resistenza e di negoziazione nelle dinamiche di relazione con istituzioni e comunità di accoglienza, gli individui sono assimilati e sussunti nelle astratte appartenenze etniche e nelle non meno astratte categorie collettive delle identità burocratiche: richiedenti asilo, profughi o migranti economici. Sono soggetti in debito, questuanti, o semplicemente africani, senegalesi, sudanesi, ghanesi, tunisini, ecc., vittime di cui avere pietà se naufraghi annegati nelle traversate, clandestini tout court se salvati e sopravvissuti.
La verità è che i migranti sono soggetti per antonomasia fuori posto, simbolicamente e spesso fisicamente fuori dalle mura, in esubero, senza alcun riferimento territoriale, figure liminari e per questo oggetto di retoriche in costrutti linguistici che parlando di loro parlano di noi. Non si sottolinea mai abbastanza la funzione specchio del fenomeno migratorio, destinato a riflettere le dinamiche sociali e culturali che interessano non solo le comunità dei migranti ma anche quelle dei cosiddetti autoctoni, dal momento che l’osservatore è egli stesso parte dell’osservazione, per usare le parole di Lévi-Strauss, e nel tentativo di conoscere l’altro non si conosce in verità che se stessi. Ecco perché lo studio della morfologia e dell’evoluzione dell’immigrazione offre la possibilità di riflettere, nel duplice senso ottico e mentale, su quello che sta accadendo davanti a noi ma anche e soprattutto dentro di noi.
Perché i migranti ci guardano e ci dicono chi siamo. Guardano al Vecchio continente come alla terra promessa, aspirano all’Europa con speranza e con fiducia e ci dicono quanto debole e ipocrita sia l’europeismo che proclamiamo, quel patrimonio di valori democratici e di diritti sociali di cui ci vantiamo, quanto contraddittorio sia il nostro modo di essere eredi delle costituzioni liberali, delle convenzioni internazionali di Ginevra, dei princìpi universali ispirati alla solidarietà e all’umanesimo.
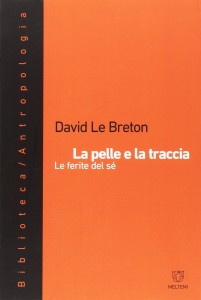 Dentro quel sesto continente che, in una sorta di deriva tettonica, incessantemente avanza, si sposta, si muove, alla ricerca non solo del pane ma della pace, della libertà e della dignità, ci sono gli individui, le persone, c’è l’irriducibile singolarità, incomprensibile in quanto mera espressione etnico-culturale. Evaporate etnie e nazionalità, restano i loro corpi che, ci ricorda Benedict Anderson (1996), non sono soltanto un’altra forma di merce. Essi portano con sé memorie e costumi, credenze ed usi, musiche e spiriti, oggetti e simboli. Essi infatti non hanno semplicemente un corpo, essi sono anche un corpo. E il corpo si fa parola, trasduttore di segni, incarna l’unico luogo su cui investire per affermare e testimoniare la propria esistenza, la propria volontà. Così, contro i tempi lunghi e insopportabili della permanenza nei CIE i migranti in una plateale dimostrazione autolesionistica hanno spesso deciso di cucirsi le labbra con ago e filo o di bruciarsi i polpastrelli delle dita per sottrarsi alla pratica delle impronte digitali, come a notificare l’esigenza di un riconoscimento alla rovescia. «Ricorrere al corpo in funzione “politica” equivale a compiere un percorso sacrificale. La ferita che ci si infligge è l’estremo tentativo per essere riconosciuti come soggetti e non più solo come detenuti o detenute (…). La ferita è una protesta che passa attraverso il corpo» (Le Breton 2005: 105-106). Il corpo piegato, piagato, violentato, prostituito è anche il prezzo da pagare per il viaggio, la traversata, il viatico per fuggire la morte e tentare la speranza di una nuova vita possibile. Il corpo ridotto a merce di scambio nel redivivo mercato degli schiavi altro non è che l’incarnazione di quella nuda vita, archetipo contemporaneo che – come scrive Agamben (1995: 6) – «sostituisce il biologico al sociale, confermando il primato della vita naturale sull’azione politica».
Dentro quel sesto continente che, in una sorta di deriva tettonica, incessantemente avanza, si sposta, si muove, alla ricerca non solo del pane ma della pace, della libertà e della dignità, ci sono gli individui, le persone, c’è l’irriducibile singolarità, incomprensibile in quanto mera espressione etnico-culturale. Evaporate etnie e nazionalità, restano i loro corpi che, ci ricorda Benedict Anderson (1996), non sono soltanto un’altra forma di merce. Essi portano con sé memorie e costumi, credenze ed usi, musiche e spiriti, oggetti e simboli. Essi infatti non hanno semplicemente un corpo, essi sono anche un corpo. E il corpo si fa parola, trasduttore di segni, incarna l’unico luogo su cui investire per affermare e testimoniare la propria esistenza, la propria volontà. Così, contro i tempi lunghi e insopportabili della permanenza nei CIE i migranti in una plateale dimostrazione autolesionistica hanno spesso deciso di cucirsi le labbra con ago e filo o di bruciarsi i polpastrelli delle dita per sottrarsi alla pratica delle impronte digitali, come a notificare l’esigenza di un riconoscimento alla rovescia. «Ricorrere al corpo in funzione “politica” equivale a compiere un percorso sacrificale. La ferita che ci si infligge è l’estremo tentativo per essere riconosciuti come soggetti e non più solo come detenuti o detenute (…). La ferita è una protesta che passa attraverso il corpo» (Le Breton 2005: 105-106). Il corpo piegato, piagato, violentato, prostituito è anche il prezzo da pagare per il viaggio, la traversata, il viatico per fuggire la morte e tentare la speranza di una nuova vita possibile. Il corpo ridotto a merce di scambio nel redivivo mercato degli schiavi altro non è che l’incarnazione di quella nuda vita, archetipo contemporaneo che – come scrive Agamben (1995: 6) – «sostituisce il biologico al sociale, confermando il primato della vita naturale sull’azione politica».
Sia esso profugo, rifugiato o semplicemente migrante, in cerca di asilo o di esilio, in rotta da guerre o dalla fame, la sua soggettività ha modo di esprimersi anche nella gestione degli spazi di residenza all’interno degli stessi Centri di accoglienza, nella appropriazione e personalizzazione degli ambienti, a dispetto del puro inquadramento come ospiti fruitori dei servizi assistenziali che il sistema prevede. In luoghi coatti, definitivamente temporanei, spazi confinati che riproducono al loro interno condizioni di vita ridotte all’essenziale, vite continuamente sospese fra le precarie alternative all’assistenza, in attesa di un riconoscimento di legittimità, in questa sorta di non luoghi, le cui denominazioni tradiscono i veri significati dell’accoglienza: centri di identificazione, di trattenimento, di espulsione, hotspot, in queste strutture, di fatto, di sorveglianza, di custodia e di controllo, in molti casi, gli stranieri hanno saputo rompere l’isolamento spaziale, l’indolenza delle burocrazie, l’interdizione all’accesso nel mondo del lavoro vissuta come condizione di vuoto, di dipendenza, di malessere esistenziale, attivando positive pratiche di solidarietà e di associazionismo, fino a tentare interessanti esperienze di autogestione. Case abbandonate sono state rimesse a posto e trasformate in alloggi per i rifugiati, mestieri tradizionali dismessi hanno conosciuto una ripresa grazie al loro apporto. Padroni della loro individualità, quasi sempre negata o mortificata da regole di un apparato che infantilizza, deresponsabilizza e cancella ogni traccia di umanità, i migranti possono assumere in determinati contesti rilevanti ruoli di cittadinanza attiva e guadagnare pubblica visibilità in rappresentanza di minoranze coese e strutturate. Possono tracciare precisi percorsi di riconoscimento attraverso l’efficace organizzazione delle consulte e la negoziazione collettiva dei diritti.
A fronte delle vite dei profughi strappate e pure incorporate alla morte, vite consumate nel trauma di una disperata fuga e nell’azzardo di una sfida e di una speranza, mentre i migranti ci guardano e ci aiutano a capire chi siamo e cosa stiamo diventando, non è forse inutile chiedersi su chi siamo davvero quando ci diciamo umani, quale senso dell’umano esprima oggi la cultura del nostro tempo, quale significato attribuire alle iniziative cosiddette umanitarie promosse dalle nostre istituzioni pubbliche, quale antropopoiesi, quale concetto cioè della vita umana stiamo lentamente costruendo, quale percezione e quale concezione della vita delle persone, della loro dignità, della loro umanità. Qualcosa che ha fatto dire al capo della Chiesa ortodossa di Atene Ieronymos che siamo ormai alla bancarotta dell’umanità. Sulle categorie umano/non umano si giocano ancora la materializzazione e la traduzione di una arcaica discriminante: inclusione/esclusione, che produce e riproduce i rapporti di potere. C’è da chiedersi se è ancora possibile accettare e rispettare l’esistenza di forme di umanità diverse da quelle ci somigliano, se c’è spazio gli altri, per l’universalità dell’uomo nella sua complessità e varietà di vite e di culture, per l’idea stessa di appartenenza comune e di un destino condiviso del genere umano.
E pure dall’esperienza dei migranti, dalle loro storie e dal loro sguardo proiettato su più mondi e più larghe visioni, è possibile imparare a riappropriarci di quel senso del vivere e quel sentimento dell’umano che stiamo perdendo o abbiamo in parte perduto. Nei profughi sopravvissuti al mattatoio libico e al naufragio in mare la vita e la morte sembrano reciprocamente sostenersi e alimentarsi, nel paradosso di un cortocircuito che richiama alla mente la nota formula di Eraclito: «vivere di morte, morire di vita». Esperire la convivenza con la morte equivale a plasmare una soggettività esercitata alla resilienza, all’epifanica scoperta di nuove identità, di nuove forme elementari e radicali dell’uomo e del suo stare nel mondo. Se nessuna legge può insegnare a essere e diventare uomini, forse siamo chiamati a riscoprirne le ragioni e le mozioni proprio attraverso la prossimità con le vite dei migranti, di quanti cioè hanno contiguità e confidenza con la morte, non ne hanno paura nella sfida quotidiana dell’esistere.
Naufragi e speranze, sogni e tragedie, viaggi di un’umanità stivata come carne da macello in piccole barche o carrette, fughe e approdi nelle notti senza luna, tra il pericolo delle burrasche e quello dei blocchi delle guardie costiere, odissee di migranti gettati in mare dai Caronte di turno, morti a un metro dalla riva o sopravvissuti grazie a rocamboleschi salvataggi: tutto questo sarebbe incomprensibile se non ci fosse la forza propulsiva di un progetto, di un desiderio, di una volontà. In quanto doloroso strappo ed oneroso costo, rischio e sfida altissimi, l’emigrazione è per sé stessa l’esito di un atto intenzionale, di una sofferta risoluzione, di un piano di responsabilità individuale. «Quei barconi e il loro carico – ha scritto Amalia Signorelli (2007: 329) – contribuiscono, più del turismo o della circolazione delle informazioni ufficiali, a costruire uno spazio di incontri, scambi, circolazione di corpi, parole e cose. Scambi sempre asimmetrici e spesso iniqui, ma concreti, empiricamente esperibili».
E in questo mare Mediterraneo antico e sempre nuovo, in cui tutto è accaduto, anche quello che deve ancora accadere, frontiere porose e confini di ferro sono destinati ad essere perennemente sfidati, attraversati, scavalcati. Perché qui è cominciata la storia delle civiltà e da qui passa ancora il destino dell’umanità. Qui si sono incontrati Oriente e Occidente, ebrei, cristiani e musulmani, e qui sono costretti a dialogare Nord e Sud del mondo, tra aspre conflittualità e civili urbanità, dispiegando e incrociando dialetticamente emigrazione e immigrazione, le memorie del passato e i nomadismi del presente, gli Ulisse di ieri e di oggi. Orizzonti incrociati di flussi e riflussi ininterrotti tra sponda e sponda, di viaggi e di peregrinazioni, di fughe e di umane speranze.
Dialoghi Mediterranei, n. 51, settembre 2021
[*] Per gentile concessione dell’editore si pubblica il testo che è apparso tradotto in russo nella rivista Etnografia (Этнография) del Museo di Antropologia e Etnografia “Pietro il Grande” (Kunstkamera) dell’Accademia Russa delle Scienze (San Pietroburgo) (lista SCOPUS), n.1, 2021 (11): 56 -83.
Riferimenti bibliografici
Agamben G., Homo sacer, Einaudi Torino, 1995
Amari M., Storia dei Musulmani di Sicilia, II ed. a cura di C. A. Nallino, ed. Romeo Prampolini Catania, v.1, 1933 (ed. orig. 1854).
Ambrosini M. (a cura), Intraprendere fra due mondi, il Mulino Bologna, 2009.
Anderson B., Comunità immaginate, Manifestolibri Roma, 1996
Appadurai A., Modernità in polvere. Dimensioni culturali della globalizzazione, Bollati Boringhieri Torino, 2001
Appadurai A., Il futuro come fatto culturale. Saggi sulla condizione globale, Raffaello Cortina Milano, 2014
Augè M., L’antropologo e il mondo globale, Raffaele Cortina Milano, 2014
Aymard M., Migrazioni, in F. Braudel, Mediterraneo, Bompiani Milano, 1992: 219-241
Braudel F., Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, Einaudi Torino, vol. 1, 1986
Braudel F., Il Mediterraneo, Bompiani Milano, 1992
Bromberger C., Alle origini dell’etnologia del mondo mediterraneo nella tradizione francese, in D. Albera, A. Blok, C. Bomberger (a cura), Antropologia del Mediterraneo, Guerini scientifica, Milano 2007: 92-103.
Cacciari M., L’Arcipelago, Adelphi Milano, 1997
Camus A., Lo straniero, Bompiani Milano, 2005
Cassano F., Il pensiero meridiano, Laterza Bari Roma, 2005
Castles S., The Factors that Make and Unmake Migration Policies, in Rethinking Migration. New Theoretical and Empirical Perspectives, a cura di A. Portes, J. De Wind, Berghahn Books, New York & Oxford, 2007: 29-61.
De Certeau M., L’invenzione del quotidiano, Edizioni Lavoro Roma, 2001.
Deleuze G., Guattari E., Millepiani: capitalismo e schizofrenia, Istituto Enciclopedia Italiana Roma, 1987.
Ferrarotti F, La vocazione interreligiosa e interculturale del Mediterraneo, in “Dialoghi Mediterranei”, n. 42, marzo 2020.
Galasso G., La mobilità delle persone nel Mediterraneo. Qualche osservazione preliminare, in “Mediterranea. Ricerche storiche”, anno III, n.7, agosto 2006: 209-212.
Guarracino S., Mediterraneo. Immagini, storia e teorie da Omero a Braudel, Bruno Mondadori Milano, 2007.
Hegel G. W. F., Lezioni sulla filosofia della storia, vol. I, trad. it. G. Calogero-C. Fatta, la Nuova Italia, Firenze, 1994.
Herzfeld M., Le rifrazioni etnografiche ed epistemologiche dell’identità mediterranea, in D. Albera, A. Blok, C. Bomberger (a cura), Antropologia del Mediterraneo, Guerini scientifica, Milano 2007: 250-263
Le Breton D., La pelle e la traccia. Le ferite del sé, Meltemi Roma, 2005.
Leogrande A., La frontiera, Feltrinelli Milano 2018
Lévi-Strauss C., Antropologia strutturale, Il Saggiatore Milano, 1945.
Lévi-Strauss C., L’antropologia di fronte ai problemi del mondo moderno, Bompiani Milano, 2017
Magris C., L’infinito viaggiare, Mondadori Milano, 2005
Matvejevic P., Mediterraneo. Un nuovo breviario, Garzanti Milano 1991
Molho A., Comunità e identità nel mondo mediterraneo, in Conflitti, migrazioni e diritti dell’uomo. Il Mezzogiorno laboratorio di un’identità mediterranea, a cura di M. Aymard e F. Barca, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2002.
Resta C., Geofilosofia del Mediterraneo, Mesogea, Messina 2012
Shayegan D., Lo sguardo mutilato. Schizofrenia culturale: paesi tradizionali di fronte alla modernità, Ariele Milano, 2015.
Signorelli A., Postfazione a Antropologia del Mediterraneo, a cura di D. Albera, A. Blok, C. Bomberger, Guerini Scientifica Milano, 2007: 327-342.
Tedesco F., Mediterraneismo. Il pensiero antimeridiano, Meltemi Roma, 2017.
Wallerstein I., Il sistema mondiale dell’economia moderna, il Mulino Bologna, 1982.
______________________________________________________________
Antonino Cusumano, ha insegnato nel corso di laurea in Beni Demoetnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo. La sua pubblicazione, Il ritorno infelice, edita da Sellerio nel 1976, rappresenta la prima indagine condotta in Sicilia sull’immigrazione straniera. Sullo stesso argomento ha scritto un rapporto edito dal Cresm nel 2000, Cittadini senza cittadinanza, nonché numerosi altri saggi e articoli su riviste specializzate e volumi collettanei. Ha dedicato particolare attenzione anche ai temi dell’arte popolare, della cultura materiale e della museografia. È autore di diversi studi. Nel 2015 ha curato un libro-intervista ad Antonino Buttitta, Orizzonti della memoria (De Lorenzo editore). La sua ultima pubblicazione, Per fili e per segni. Un percorso di ricerca, è stata edita dal Museo Pasqualino di Palermo (2020).
______________________________________________________________









