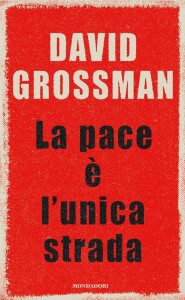Contemplando le proprie rovine
Ogni forma di trauma genera una serie di reazioni immediate: urgenza, dolore, disperazione, incredulità e spaesamento. Spesso la sua gravità rende difficile per le persone colpite riconoscere la realtà di ciò che sta accadendo: si fa «fatica a credere ai propri occhi», dice Stanley Cohen (2008), e questo vale sia per i singoli che per la collettività. Si avvia, cioè, un «periodo di latenza» (Djament-Tran, Reghezza-Zitt 2012), la cui durata varia in base a numerosi fattori fisici e sociali: dalla gravità del danno all’intensità della vulnerabilità, dalle retoriche mediatiche e politiche alla minaccia di ulteriori rischi. In questo periodo di inerzia, osserva Pierre George (1960: 2), sembra «que chaque pays [contemple] avec stupeur l’immensité de ses ruines»[1].
È un periodo di disorientamento e confusione, ma non è un periodo vuoto, perché si è alla ricerca di senso. In un resoconto del terremoto in Cile del 2010, pubblicato sul “New York Times”, lo scrittore Ariel Dorfman (2010) scrisse: «Like all major misfortunes, the current tragedy of Chile can be seen as a test, a chance to ask ourselves who we really are, what really matters as we rebuild, not only our wrecked hospitals and broken roads and fractured bodies, but our damaged identity» [2].
Questa impossibilità di esprimere il proprio stato d’animo si ritrova nei testi più intimi e nei silenzi più profondi di israeliani ed ebrei che ho incrociato negli ultimi sei mesi dal 7 ottobre 2023, in cui emerge la percezione che il tempo si sia dilatato e lo spazio rimpicciolito: molti sono ancora a quel giorno, oppure vedono ovunque le macerie dei kibbutz assaliti dai miliziani di Hamas. Lo si avverte nelle parole del rabbino Pierpaolo Punturello (2024), in una puntata del suo podcast in spagnolo: «6 meses de ira, dolor, impotencia, esperanza, activismo, guerra, defensa, indiferencia y odio antisemita. 6 meses durante los cuales protestamos, gritamos, luchamos, colocamos carteles con los rostros de los hombres, mujeres y niños secuestrados por Hamás» [3]. Ma anche in quelle della rabbina Delphine Horvilleur (2024), nel cui ultimo libro offre un ritratto vivido e toccante della difficoltà di pronunciare il dolore, dacché la sua scrittura è uno sforzo di dare voce all’indicibile, di trovare un senso nel non-senso, di tentare un dialogo con elementi e aspetti diversi della propria esistenza, al fine di interrogarsi sulla propria identità.
 Horvilleur fa ricorso ad un’espressione yiddish che affonda nei suoi ricordi d’infanzia: «Oy a brokh’», letteralmente “che maledizione”, ma in un’accezione che somiglia più al “mah” di chi alza le spalle tra sconforto e ostinazione: «Ces quelques syllabes charriaient de vieilles légendes, transmises presque religieusement, de génération en génération: la conscience du malheur et le devoir d’y survivre, le souvenir de tragédies et le refus de se laisser raconter par elles» (ivi : 12) [4].
Horvilleur fa ricorso ad un’espressione yiddish che affonda nei suoi ricordi d’infanzia: «Oy a brokh’», letteralmente “che maledizione”, ma in un’accezione che somiglia più al “mah” di chi alza le spalle tra sconforto e ostinazione: «Ces quelques syllabes charriaient de vieilles légendes, transmises presque religieusement, de génération en génération: la conscience du malheur et le devoir d’y survivre, le souvenir de tragédies et le refus de se laisser raconter par elles» (ivi : 12) [4].
La medesima fatica è manifestata da David Grossman nel suo ultimo libro uscito in Italia, quando scrive: «Guardo le facce delle persone. Sconvolte. Spente. Il cuore è oppresso da un’angoscia costante. Continuiamo a ripeterci a vicenda: un incubo, un incubo inaudito. Non ci sono parole per descriverlo. Le parole non riescono a contenerlo. È una sensazione profonda di tradimento» [5].
L’impatto del trauma è devastante e la sua elaborazione – lenta e dolorosa – attraversa varie fasi: dalla sorpresa all’incredulità, dall’ansia al terrore, dalla melanconia all’angoscia. Il percorso passa per la narrazione traumatica, vera e propria finestra sul dolore, ossia una «messa in comune del dramma» (Langumier 2008: 47) con cui si convogliano le emozioni e si dà voce a sentimenti complessi e spesso difficili da gestire, usando un linguaggio particolarmente intenso e viscerale che riflette la profonda sofferenza e la desolazione vissuti dall’individuo.
Il libro di David Grossman, La pace è l’unica strada, edito da Mondadori a fine marzo 2024, raccoglie otto articoli pubblicati prima e dopo la strage compiuta da Hamas il 7 ottobre 2023, un evento che lo scrittore assimila a una voragine apertasi in seno alla realtà e che ha risucchiato l’intero Paese. Questi articoli, originariamente apparsi su diverse testate giornalistiche come “Corriere della Sera” e “la Repubblica”, offrono una panoramica lucida e appassionata del conflitto israelo-palestinese e delle sue implicazioni sulla società israeliana. Il contributo fondamentale dell’opera risiede nella sua capacità di combinare l’analisi politica con la profonda sensibilità umana di Grossman. L’autore, da sempre fervido sostenitore della coesistenza tra Israele e Palestina, non si limita a esporre le proprie convinzioni, ma offre al lettore una serie di spunti di riflessione su temi cruciali come la democrazia, la sicurezza e il futuro dei due popoli.
Pur essendo composto da articoli pubblicati in momenti diversi, il libro presenta una coerenza interna notevole, grazie al filo conduttore rappresentato dalla ferma opinione di Grossman della necessità della pace. Gli eventi tragici del 7 ottobre conferiscono al volume una drammatica attualità, rendendola una lettura imprescindibile per chiunque voglia comprendere le dinamiche di quel conflitto e della sua più recente e terribile recrudescenza nel sud di Israele e nella Striscia di Gaza.
Degli otto articoli, sei sono stati scritti prima dell’attacco di Hamas, mentre due sono successivi; tutti sono pubblicati in ordine cronologico, tranne l’ultimo, datato 2022, che forse è il testo più alto perché dedicato al “diritto alla felicità”. Come tasselli di un mosaico complesso, gli articoli di Grossman offrono una finestra privilegiata sulla realtà israeliana, intrecciando riflessioni profonde su temi cruciali quali il conflitto con i palestinesi, la democrazia e l’identità nazionale. La sua voce, carica di realismo e speranza, risuona come un monito a non cedere alla rassegnazione, ma a lottare per un futuro migliore.
Grossman denuncia con determinazione il circolo vizioso di violenza che imprigiona Israele e Palestina in una spirale di dolore e sofferenza (nel capitolo “Ogni spada è un’arma a doppio taglio”): «la vera lotta oggi non è tra arabi ed ebrei, ma fra quanti – dalle due parti – anelano a vivere in pace in una convivenza equa e quanti – dalle due parti – si nutrono psicologicamente e ideologicamente di odio e violenza». La forza militare, lungi dal rappresentare una soluzione, alimenta solo il ciclo di vendetta e odio, ostacolando la costruzione di una pace duratura. Grossman lo afferma da una prospettiva laica, ma una sfumatura simile è sottolineata anche dall’orizzonte religioso di Horvilleur (2024: 133-134) la quale avverte «du danger que court Israel chaque fois qu’il se sent infaillible», dacché lei condanna «la politique du gouvernement israélien en place, son arrogance, et l’hubris de force et de puissance qu’il cultive, par vois de certains ministres. Leur culte de la terre et de la suprématie religieuse est, à mon sens, aux antipodes de ce que la sagesse juive nous a enseigné» [6].
Questo rischio è avanzato da Grossman nei due capitoli scritti nella primavera del 2023, sia sul piano interno, sia per quanto riguarda la relazione con i palestinesi. L’autore esprime profonda preoccupazione per la deriva autoritaria in atto in Israele, alimentata dalle politiche del governo Netanyahu (“Il pericolo della dittatura”), e stigmatizza l’occupazione dei Territori Palestinesi, ritenuta una violazione dei principi ebraici di giustizia e compassione (“Che cos’è uno Stato ebraico?”), ma soprattutto un ostacolo insormontabile sulla via della pace.
Nel primo caso, Grossman considera il tentativo del Primo Ministro di asservire la Magistratura al potere politico come una chiara minaccia alla democrazia e allo stato di diritto, che getta un’ombra inquietante sul futuro del Paese. Tuttavia, Grossman non cede alla disperazione e intravede una speranza nella mobilitazione popolare e nel riaffiorare di un senso di appartenenza comune (che poi riprende anche nel capitolo “Il destino della nostra democrazia”, del luglio 2023). Quelle proteste oceaniche – ritornate con forza dal marzo 2024, in verità mai fermate nonostante lo stato di guerra – sono per l’autore un atto di resistenza e un’affermazione di fede in un futuro più giusto.
Ma l’avvenire dell’area dipende anche da una vera riconciliazione con il popolo palestinese, che Grossman auspica basata sul riconoscimento reciproco e sulla creazione di due Stati indipendenti. Si tratta di una visione ispirata ai valori di equità e rispetto, che si contrappone all’attuale situazione di disuguaglianza e oppressione, ma che interroga anche un’identità in trasformazione tra passato e presente. Ne “La fragilità di Israele” (agosto 2023), Grossman analizza la trasformazione dell’identità israeliana: da pionieristica e dinamica a più cupa e timorosa, individuando le cause di tale destabilizzazione sociale nell’aumento delle disparità, nella crescita del razzismo e nell’erosione dei valori fondanti di quella società. Evidentemente, l’autore invita a un risveglio collettivo e a un impegno per ricostruire un Israele più giusto e sicuro, riscoprendo le radici ebraiche di pietà e uguaglianza per immaginare e costruire un futuro rinnovato. Per agire bisogna avere fede nella speranza. Ma come avere fiducia nel domani quando si è circondati da macerie?
I due capitoli successivi – “Il sabato nero” e “Ricorderemo i loro volti”, entrambi apparsi su “la Repubblica”, il 12 ottobre e il 17 novembre 2023 – sono gli unici scritti dopo la strage compiuta da Hamas e risuonano come un monito nella memoria collettiva di Israele, una forma di commemorazione solenne delle vittime del “sabato nero”, appunto, un omaggio commovente a chi ha perso la vita in un atto di violenza inaudita, un sacrificio che segnerà per anni, forse decenni, il destino del Paese: «l’identità israeliana d’ora in poi includerà anche il trauma dell’ottobre 2023».
Con parole lucide e incisive, Grossman descrive la tragica sequenza degli eventi; l’orrore dell’attacco terroristico viene dipinto trasmettendo al lettore la gravità delle conseguenze e la profonda costernazione della comunità colpita: «In questi giorni, in queste notti, ci muoviamo come sonnambuli. Cerchiamo di resistere alla tentazione di guardare i video degli orrori, di dare ascolto alle voci che girano. Sentiamo filtrare la paura in chi, per la prima volta dopo cinquant’anni – dalla guerra del Kippur –, riconosce con terrore il primo segno di una possibile sconfitta». Il dolore e la disperazione di chi ha perso i propri cari si fanno tangibili, creando un’atmosfera di profonda commozione. Le testimonianze di familiari e amici delle vittime sono piene di lacrime e di rabbia, ma anche di ricordi preziosi e di un desiderio di giustizia che non può essere soffocato. Il loro dolore diventa un grido collettivo che scuote le coscienze e spinge a riflettere sulla fragilità della vita, sulla crudeltà insensata della violenza e sulle responsabilità politiche che hanno preparato e permesso lo scatenarsi dell’orrore.
In mezzo al dolore e alla desolazione, Grossman celebra il coraggio e l’eroismo di coloro che hanno messo a rischio la propria vita per salvare altri, proteggere i propri cari e dare un barlume di speranza in un momento di buio: «Ogni persona che si è salvata è la storia di un miracolo e una storia di intraprendenza e coraggio. Un’infinità di miracoli, un’infinità di atti di eroismo e sacrificio da parte di soldati e civili, ciascuno dei quali è anche un monito alla sventatezza criminale dei vertici delle forze di sicurezza, che per anni hanno persuaso se stessi e noi che non c’era nessuno più forte e più sofisticato di Israele in quest’area del mondo, e che nessuno era più esperto di tattiche militari».
La dedizione e l’altruismo offrono un esempio di come, anche di fronte alla tragedia, l’umanità possa brillare con forza inaspettata, così come le enormi responsabilità politiche accumulate negli ultimi decenni da parte di chi «non ha mai perso occasione di dichiarare quanto Israele fosse forte, risoluto e, soprattutto, pronto, pronto ad affrontare qualsiasi pericolo». Erano illusioni, spaventose illusioni, dice Grossman, pagate con la vita dalle persone che ballavano al Nova Festival e dagli abitanti dei kibbutz dei dintorni.
L’autore, però, invita a guardare tutte le responsabilità e, con decisione, afferma: «Ma non inganniamoci, non facciamo confusione: con tutta la rabbia che possiamo nutrire nei confronti di Netanyahu, dei suoi accoliti e della sua strada, non è Israele ad aver commesso delle atrocità in questi giorni. È Hamas. L’occupazione è un crimine, ma immobilizzare centinaia di civili, bambini, genitori, vecchi e malati e poi passare dall’uno all’altro per sparargli a sangue freddo è un crimine più atroce».
Il rischio concreto, dice Grossman, è che questa tragedia contribuisca ad alimentare il già ampiamente rodato circolo vizioso dell’odio e della violenza: «Israele dopo la guerra sarà molto più di destra, militante e anche razzista». Dunque, si domanda: «è davvero andata perduta per sempre, o si è congelata per molti anni, la minuscola possibilità di un dialogo vero, della riconciliazione con l’esistenza dell’altro popolo?».
 Lo scrittore dice che le morti, pur tragiche e inaccettabili, del “sabato nero” non sono state vane, ma hanno rafforzato il senso di unità nazionale, dopo anni di polarizzazione sociale e di frattura politica. Tuttavia, non si fa illusioni, perché dovranno passare molti anni prima che si possa pensare a una riconciliazione. Si tratta di compiere un lavoro certosino a più livelli: da quello interno israeliano (a cui ha dedicato la maggior parte del libro) a quello interno palestinese [7], fino a quello degli equilibri internazionali regionali [8].
Lo scrittore dice che le morti, pur tragiche e inaccettabili, del “sabato nero” non sono state vane, ma hanno rafforzato il senso di unità nazionale, dopo anni di polarizzazione sociale e di frattura politica. Tuttavia, non si fa illusioni, perché dovranno passare molti anni prima che si possa pensare a una riconciliazione. Si tratta di compiere un lavoro certosino a più livelli: da quello interno israeliano (a cui ha dedicato la maggior parte del libro) a quello interno palestinese [7], fino a quello degli equilibri internazionali regionali [8].
Come Dorfman, citato all’inizio di questo contributo, osserva che il catastrofico sisma cileno può essere «un’occasione per chiederci chi siamo veramente», allo stesso modo Grossman inserisce in più pagine alcune considerazioni simili: chi ha visto l’orrore del 7 ottobre «non riuscirà più a vivere come prima», pertanto «non saremo più come eravamo», ma allora «chi saremo quando ci risolleveremo dalle ceneri e torneremo alle nostre vite?», «chi saremo, che persone saremo dopo questi giorni, dopo aver visto quello che abbiamo visto?».
C’è da ricostruire una relazione, un patto, una fiducia; e questo comporta una grande responsabilità, richiede sensibilità, empatia e una sorta di “superamento della storia”: bisogna riuscire a camminare con una candela in mano mentre è in corso una violenta tempesta, ha detto David Grossman in tv [9]. La candela rischia di spegnersi, eppure bisogna fare di tutto per evitare che quella fiammella si estingua, soprattutto dopo il 7 ottobre, soprattutto perché non c’è alternativa a un percorso di pace. Allo stesso concetto ha dedicato dei versi il poeta palestinese Mahmoud Darwish, che in chiusura della sua celebre “Pensa agli altri” scrive: «Quando pensi agli altri lontani, pensa a te stesso. / (Dì a te stesso: se solo potessi essere una candela nel buio!)»[10].
 L’ascolto come pratica di pace
L’ascolto come pratica di pace
Il libro di Grossman si chiude con un capitolo scritto due anni prima: si tratta del discorso tenuto alla cerimonia di consegna del Premio Erasmus ad Amsterdam, il 29 ottobre 2022, e riguarda il “diritto alla felicità”. Dopo tante pagine di orrore e desolazione, la felicità. Sembra una dissonanza o un paradosso, eppure Grossman sostiene che è la vera aspirazione universale a cui tutti tendono, un sogno che gli è stato suggerito prima da una frase di Arthur Rubinstein ascoltata da bambino, poi dalla Dichiarazione di indipendenza americana, e che oggi identifica come uno dei diritti inalienabili degli esseri umani.
È quando ha sentito parlare di felicità dal celebre pianista che ha deciso di essere un artista: «La letteratura, la scrittura, mi hanno insegnato il piacere di fare qualcosa di raffinato e di preciso in un mondo denso e torbido». La dimensione della creazione permette di affrontare «il c’è e il non c’è», la dualità dell’esistenza e della perdita [11], della completa negazione della vita e, al tempo stesso, dell’intenso sentimento di vitalità e positività: una contrapposizione che lui ritiene l’essenza della vita umana.
Per Grossman, la scrittura rappresenta una fonte di grande gioia e di profonda soddisfazione. Pur non negando che la scrittura possa comportare sofferenza e dolore, l’autore la considera un mezzo per confrontarsi con la realtà in modo autentico e significativo, perché permette di esplorare la complessità dell’animo umano e di superare pregiudizi e stereotipi, favorendo la comprensione verso il prossimo e la capacità di pensare e di agire con partecipazione anche in circostanze difficili. È, quindi, anche un modo per “riparare un mondo diviso”, ad esempio accontentandosi di poco e senza cedere alla disperazione, come Etty Hillesum, donna ebrea che durante la Shoah mantenne la sua libertà interiore anche nelle condizioni più avverse: una forma di resistenza alla tirannia che ancora oggi rappresenta un modello di coraggio e di speranza, quello di chi non smette di pensare e di avere un cuore sensibile, aperto, vulnerabile.
L’ascolto dell’altro – altro nel tempo, nello spazio, nelle idee, nell’appartenenza – è una delle capacità fondamentali per l’antropologia culturale, con cui si può cogliere la complessità delle esperienze umane, di entrare in empatia con l’altro e di costruire una consapevolezza del mondo sociale. Ascoltare e comprendere le storie, le emozioni e le esperienze di vita delle persone è il solo modo con cui raggiungere una conoscenza olistica e non etnocentrica che consenta di comprendere le prospettive altrui. L’ascolto attento e rispettoso è fondamentale per creare relazioni paritarie e di fiducia, ma anche per realizzare una società più inclusiva, che superi pregiudizi e stereotipi, che valorizzi la diversità e che si faccia sorprendere dalla serendipità.
 Impegno, concentrazione, empatia, ma anche sospensione del giudizio e riflessività sono parte di un processo tutt’altro che passivo: l’ascolto in antropologia è una forma di immedesimazione e di riduzione della “distanza”; è un guardare con gli occhi dei nativi, un concedersi reciprocamente che va oltre la ricerca etnografica, ma modella un percorso che vale anche a scala più grande, cioè sociale e politica. Viene in mente un altro importante scrittore israeliano, Amoz Oz, che in Contro il fanatismo (2015: 14) ricorda come, essendo cresciuto in un contesto di ambivalenza e ambiguità, ad un certo punto della sua giovinezza si fosse reso conto che i suoi «dintorni fossero zeppi di aspiranti riformatori dell’ordine universale, idealisti, ideologi, ciascuno con la sua personale formula per una redenzione istantanea. Erano tutti dei gran parlatori, nessuno mai che ascoltasse».
Impegno, concentrazione, empatia, ma anche sospensione del giudizio e riflessività sono parte di un processo tutt’altro che passivo: l’ascolto in antropologia è una forma di immedesimazione e di riduzione della “distanza”; è un guardare con gli occhi dei nativi, un concedersi reciprocamente che va oltre la ricerca etnografica, ma modella un percorso che vale anche a scala più grande, cioè sociale e politica. Viene in mente un altro importante scrittore israeliano, Amoz Oz, che in Contro il fanatismo (2015: 14) ricorda come, essendo cresciuto in un contesto di ambivalenza e ambiguità, ad un certo punto della sua giovinezza si fosse reso conto che i suoi «dintorni fossero zeppi di aspiranti riformatori dell’ordine universale, idealisti, ideologi, ciascuno con la sua personale formula per una redenzione istantanea. Erano tutti dei gran parlatori, nessuno mai che ascoltasse».
Evidentemente, ascoltare David Grossman significa esplorare la complessa e sfaccettata identità israeliana, interrogandosi sulle sue radici, sulla sua evoluzione e sulle sue sfide future, sia sul piano politico-democratico, sia su quello della convivenza, coabitazione e pace. La comprensione reciproca e la com-passione riecheggiano le riflessioni degli antropologi sul ruolo dell’alterità nella costruzione della cultura e dei rapporti sociali, passando dall’elaborazione del trauma collettivo all’influenza della memoria in un contesto di guerra e di violenza. Ascoltare chi si oppone alle forme di oppressione e di discriminazione che alimentano il conflitto è in linea con la prospettiva critica dell’antropologia sulle relazioni di potere e le gerarchie, e forse può rappresentare anche una sfumatura essenziale per passare dalla “antropologia della violenza e della guerra” ad una “antropologia della pace e della convivenza”. Questa, dice Martin Hébert (2006), presuppone non solo la comprensione delle molteplici forme di violenza strutturale, diretta o simbolica, ma anche della loro articolazione all’interno dei gruppi umani, al fine di affrontare almeno tre grandi sfide: la definizione di obiettivi chiari, in particolare sulle caratteristiche della pace nelle società; il fondare la sua azione, spesso soggetta a urgenza, su dati empirici rigorosi; il trovare un equilibrio tra l’impegno pratico per la promozione della pace e l’analisi critica propria di una disciplina scientifica. Si tratta di sfide certamente difficili e scoraggianti, eppure non insormontabili per un’antropologia contemporanea “per” la pace.
Dialoghi Mediterranei, n. 67, maggio 2024
Note
[1] Traduzione in italiano: «Che ogni paese [contempli] con stupore l’immensità delle sue rovine».
[2] Traduzione in italiano: «Come tutte le grandi disgrazie, l’attuale tragedia del Cile può essere vista come un test, un’occasione per chiederci chi siamo veramente, cosa conta davvero mentre ricostruiamo, non solo i nostri ospedali distrutti, le strade dissestate e i corpi feriti, ma la nostra identità danneggiata».
[3] Traduzione in italiano: «6 mesi di rabbia, dolore, impotenza, speranza, attivismo, guerra, difesa, indifferenza e odio antisemita. 6 mesi durante i quali abbiamo protestato, gridato, combattuto, affisso manifesti con i volti di uomini, donne e bambini rapiti da Hamas».
[4] Traduzione in italiano: «Queste poche sillabe portavano con sé antiche leggende, trasmesse quasi religiosamente, di generazione in generazione la consapevolezza della sventura e il dovere di sopravvivere ad essa, il ricordo delle tragedie e il rifiuto di lasciarsi raccontare da esse».
[5] Il capitolo si intitola “Il sabato nero” ed è originariamente apparso su “la Repubblica” il 12 ottobre 2023, con il titolo “Il mio cuore è oppresso. Vivo l’incubo di un popolo tradito dalla politica”.
[6] Traduzione in italiano: Horvilleur avverte «del pericolo che Israele corre ogni volta che si sente infallibile», dacché lei condanna «la politica dell’attuale governo israeliano, la sua arroganza e lo sfoggio di forza e potenza che coltiva, per voce di alcuni ministri. Il loro culto della terra e della supremazia religiosa è, a mio avviso, agli antipodi di quanto ci ha insegnato la saggezza ebraica».
[7] A pagina 30, l’autore invita a un senso di responsabilità condiviso: «come israeliano, non ho il diritto di fare prediche [ai palestinesi], ma come essere umano esigo che si comportino in modo umano ed etico».
[8] Grossman fa riferimento agli accordi bilaterali di normalizzazione tra Israele e Marocco, Emirati Arabi e Arabia Saudita, che sono un buon segno, eppure producono «una pace tra ricchi», perché i palestinesi sono stati poco presenti in quei negoziati.
[9] Ospite de “Il cavallo e la torre”, trasmissione televisiva condotta da Marco Damilano su Rai 3, puntata del 22 marzo 2024.
[10] La poesia di Darwish è piuttosto diffusa sul web, tuttavia ne esistono anche delle versioni cartacee, come nell’omonima pubblicazione del 2024 presso Lorusso Editore, in italiano, oppure all’interno della raccolta “Comme des fleurs d’amandiers ou plus loin”, in francese, presso Actes Sud (2007).
[11] La perdita a cui fa riferimento Grossman è quella di suo figlio Uri, morto nell’agosto 2006 nell’ultimo giorno di guerra combattuta allora da Israele in Libano.
Riferimenti bibliografici
S. Cohen, Stati di negazione. La rimozione del dolore nella società contemporanea [2001], Roma, Carocci, 2008.
G. Djament-Tran, M. Reghezza-Zitt (a cura di), Résiliences urbaines. Les villes face aux catastrophes, Paris, Le Manuscrit, 2012.
A. Dorfman, Solidarity can help Chile prevail, in “CNN”, 2 marzo 2010: http://edition.cnn.com/2010/OPINION/03/02/dorfman.chile.earthquake.unity/index.html
P. George, Problèmes géographiques de la reconstruction et de l’aménagement des villes en Europe occidentale depuis 1945, in “Annales de Géographie”, vol. 69, n. 371, 1960.
D. Grossman, La pace è l’unica strada, Milano, Mondadori, 2024.
M. Hébert, Paix, violences et anthropologie, in Une anthropologie de la paix?, numero monografico di «Anthropologie et Sociétés», vol. 30, n. 1, 2006.
D. Horvilleur, Comment ça va pas? Conversations après le 7 octobre, Parigi, Grasset, 2024.
J. Langumier, Survivre à l’inondation. Pour une ethnologie de la catastrophe, Lione, ENS éditions, 2008.
A. Oz, Contro il fanatismo [2002], Milano, Feltrinelli, 2015.
P. Punturello, Hijos de Hashem, hijos nuestros, puntata del 7 aprile 2024 del podcast «Boker tov Boker or», Spotify: https://open.spotify.com/episode/6atSmydQduEaDIieVffeJV
______________________________________________________________
Giovanni Gugg, dottore di ricerca in Antropologia culturale è assegnista di ricerca presso il LESC (Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative) dell’Université Paris-Nanterre e del CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) e docente a contratto di Antropologia urbana presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università “Federico II” di Napoli. Attualmente è scientific advisor per ISSNOVA (Institute for Sustainable Society and Innovation) e membro del consiglio di amministrazione del CMEA (Centro Meridionale di Educazione Ambientale). I suoi studi riguardano il rapporto tra le comunità umane e il loro ambiente, soprattutto quando si tratta di territori a rischio, e la relazione tra umani e animali, con particolare attenzione al contesto giuridico e giudiziario. Ha recentemente pubblicato per le edizioni del Museo Pasqualino il volume: Crisi e riti della contemporaneità. Antropologia ed emergenze sanitarie, belliche e climatiche.
______________________________________________________________