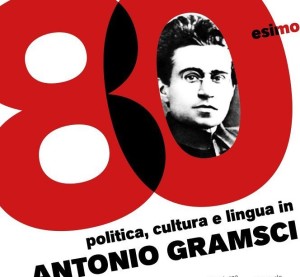di Angelo Villa
Punto primo. Non ricordo più, credo si trattasse di un linguista, abbia detto che il linguaggio era cosa troppo importante per essere lasciata o, si potrebbe forse dire, abbandonata ai linguisti. Il linguaggio e quindi la lingua, in un senso più preciso e puntuale, non è una cosa tra le altre. Più precisamente, non è una cosa, cioè un oggetto materiale. Il fatto che non lo sia e che, quindi, non sia chiaramente identificabile in quel senso, non depone in favore della sua scarsa o relativa importanza; al contrario la lingua, realtà invisibile, è manifestazione fondamentale che organizza le nostre vite, il rapporto con il corpo, con gli altri, con il mondo.
La lingua fa l’umano, gli umani fanno la lingua. Impossibile pensare l’una senza l’altro, e viceversa.
Da qui due immediate conseguenze. La prima: la lingua non è un’entità fissa, immobile. Essa si dispiega e si sviluppa nella storia stessa. O meglio, la condiziona e ne è condizionata. Seconda conseguenza. La questione o la “quistione”, come direbbe Gramsci che fu linguista prima che militante comunista, del linguaggio è a tutti gli effetti un problema che tocca il sociale, nel suo assetto specifico. Per essere ancora più radicali, possiamo dire: la questione della lingua è una questione strettamente politica. Grave l’ignorarlo, il sottovalutarlo. Né più, né meno. Ridurla a un fenomeno genericamente sociologico, quasi evidenziandone gli aspetti meramente fenomenologici, significa non cogliere la portata operativa che le è propria, la sua funzione nella costituzione di ciò che fa o non fa legame sociale.
Il linguaggio, e in questo non dico nulla di nuovo, non è uno strumento, un semplice mezzo. Interessante è, tutt’al più, capire come lo si è dimenticato. Come, insomma, è via via scomparsa qualsiasi traccia di una riflessione sistematica sul rapporto tra linguaggio e società, tra linguaggio e saperi, tra linguaggio ed etica e via di questo passo. Da dove è cominciata questa disattenzione? Da dove è sorto un tale disinteresse? Non vi è già qui il manifestarsi di una pericolosa latitanza di quello che dovrebbe essere un lavoro critico di analisi, di interrogazione del modo in cui si sviluppano discorsi, si promuovono, più o meno esplicitamente, le culture e le ideologie?
Negli anni sessanta, per fare un esempio, significativo fu il dibattito che insorse tra Pasolini e Calvino, il primo si spendeva, lottava per l’espressività linguistica; il secondo si spinse sino a denunciare quella che designò come antilingua. Sosteneva l’autore di Palomar: «chi parla l’antilingua ha sempre paura di mostrare familiarità e interesse per le cose di cui parla…».
Indipendentemente da chi avesse ragione o meno, come ricorda giustamente Berardinelli, tale dibattito era l’indice o, se vogliamo, il sintomo positivo, di un’estrema sensibilità in materia. Mi verrebbe da dire: una avvertita disponibilità, fomentata dal necessario tentativo (o desiderio?) di tenere in relazione il linguaggio e l’esperienza, vivificando insieme l’uno e l’altro.
Da allora, come si suole dire, molta acqua è passata sotto i ponti, forse anche molta negligenza, penso in particolare allo strutturalismo, alla lingua “fascista” di Barthes, alle teorie decostruzioniste di Derrida, alla festa del significante della Cixous e a chi più ne ha, ne metta… Ma, mi sembra che quella sensibilità cui accennavo è progressivamente venuta meno e l’attenzione, mi verrebbe da dire la cura, nei confronti del linguaggio sia scomparsa.
Ci si ritrova un po’ come nella cupa lettera a lord Chandlos di Hugo von Hofmannsthal, amico di Walter Benjamin, dove chi scrive denuncia la crisi che investe la sua relazione con il dire, con le parole che hanno smarrito il loro senso, specie quelle astratte che si sfanno in bocca «come funghi ammuffiti». Il quadro è negativo, decisamente melanconico. Se la lingua si svuota, si anestetizza, anche la vita, di conseguenza, ne paga il prezzo.
 Punto secondo. Il linguaggio è trama sottile. La sua crisi riflette una crisi o, se non vogliamo essere obbligatoriamente pessimisti, una trasformazione sociale più ampia, che il linguaggio agevola, frena, a seconda. Faccio una considerazione che giunge direttamente dalla clinica. Penso sia un riscontro che ha una conferma a livello ampio, e non solo in Italia, intendo. Vado di fretta. Se esiste un elemento che connota le forme attraverso le quali si palesa oggi il malessere nella nostra società, dai bambini agli adulti, esso rinvia alla centralità che vi prende il corpo. Si legga: il corpo reale. In un certo senso, rispetto ai tempi eroici della scoperta freudiana, si potrebbe sostenere che il corpo ha sostituito l’inconscio. La differenza, anche a livello terapeutico, è sostanziale. L’inconscio parlava, eccome! Nei sogni, nei lapsus, nei sintomi…Come anche nell’isteria, il corpo preso in considerazione era un corpo avvolto nel linguaggio, sino al punto da mettere in imbarazzo la clinica medica. Era un corpo traslato, inventato dal significante. Ora, questo corpo attuale è, invece, un corpo muto, un corpo che tace. E che si impone non con la parola, ma con l’evidenza, o sociale (gli agiti) o medica (malattie e dipendenze). È un corpo che duole o che fa problema, fa urlare, disperare, ma è silente. A suo modo, è un linguaggio, ma privo di parola. Talvolta orfano di un pensiero.
Punto secondo. Il linguaggio è trama sottile. La sua crisi riflette una crisi o, se non vogliamo essere obbligatoriamente pessimisti, una trasformazione sociale più ampia, che il linguaggio agevola, frena, a seconda. Faccio una considerazione che giunge direttamente dalla clinica. Penso sia un riscontro che ha una conferma a livello ampio, e non solo in Italia, intendo. Vado di fretta. Se esiste un elemento che connota le forme attraverso le quali si palesa oggi il malessere nella nostra società, dai bambini agli adulti, esso rinvia alla centralità che vi prende il corpo. Si legga: il corpo reale. In un certo senso, rispetto ai tempi eroici della scoperta freudiana, si potrebbe sostenere che il corpo ha sostituito l’inconscio. La differenza, anche a livello terapeutico, è sostanziale. L’inconscio parlava, eccome! Nei sogni, nei lapsus, nei sintomi…Come anche nell’isteria, il corpo preso in considerazione era un corpo avvolto nel linguaggio, sino al punto da mettere in imbarazzo la clinica medica. Era un corpo traslato, inventato dal significante. Ora, questo corpo attuale è, invece, un corpo muto, un corpo che tace. E che si impone non con la parola, ma con l’evidenza, o sociale (gli agiti) o medica (malattie e dipendenze). È un corpo che duole o che fa problema, fa urlare, disperare, ma è silente. A suo modo, è un linguaggio, ma privo di parola. Talvolta orfano di un pensiero.
Una retorica, specie psicoanalitica, si è ormai consumata. Ciò fa sì che l’interpretazione stessa suoni ridondante, come se il paziente dicesse: “io lo sapevo già…”. Parola che si presenta quasi come inutile, prima di farvi ricorso. Esiste la sofferenza, ma le parole che potrebbero curarla appaiono in affanno, erose dal dire comune, dalla volgarità esplicativa… Edipo è passato di moda, se ne sta tutto solo e triste a Colono. Rimane il dolore, nel corpo.
La clinica è uno degli specchi tra i più fedeli e incontrovertibili di una società. La sua verità, in effetti. Ora, la crisi che la lingua attraversa è una crisi che partecipa intimamente della modalità che la specifica. Se, come si è detto, la lingua non è né una cosa, né uno strumento, la lingua è, innanzitutto, rappresentazione. Non è la realtà, ma la via attraverso la quale la realtà, e anche il reale lacaniano, diventa accessibile. Ma, insistiamo, la rappresentazione non è l’oggetto.
La crisi del linguaggio, del suo potere, è la crisi della rappresentazione. Anche, in senso lato. L’esigenza di “verità”, di “oggettività”, di “fatti e, nelle relazioni, di un amore che non è parole, ma contatto, coccole o altro ancora è solo un risvolto dell’intera faccenda. La parola, d’altronde, vive di un rapporto stretto con la credenza, in senso lato, ma anche in senso stretto. La parola ha forza nella misura in cui si coglie la differenza tra la chiacchiera e il dire, nella misura in cui, si crede, cioè si attribuisce un peso ad essa. Proprio perché la parola rappresenta, essa non è. Per farla essere, occorre accordargli un valore, un senso.
Proseguiamo: la crisi della parola è crisi della rappresentazione, la crisi della rappresentazione è crisi della dimensione dell’alterità. Parola e alterità si corteggiano reciprocamente, nel suggerire, alludere…Ecco il punto cui la crisi della lingua ha condotto. Si è sostituita alla dimensione dell’alterità quella inquietantemente immaginaria della differenza. O, mi si passi il gioco di parole, della diffidenza che ne consegue, causa la deriva narcisistica che la differenza, anzi la sua esacerbazione, ostentazione porta con sé.
Ma, l’alterità non è la differenza. La prima mira aldilà dello specchio, la seconda si ferma allo specchio, persa nei suoi riverberi narcisistici. Il linguaggio, alla moda, segue la corrente. Promuove le gergalità, il “fra noi”, ma solo fra noi, ci si intende. La strada è tracciata: semplificare il linguaggio semplificando la realtà, oggettivare l’uno, oggettivando l’altro. I mass media sponsorizzano l’eloquio più triviale, più vicino alla “gente”…Errore grossolano, quello di ridurre l’oralità al parlato. E poi, il parlato allo scritto, come da sms di routine…
L’impoverimento del linguaggio comporta la rescissione del legame che la lingua intrattiene con il non conosciuto, con l’impossibile, con il mistero… Alla fine quel che non si nomina si dimentica, quel che non si nomina non si rielabora…. E così via. Lo svuotamento del linguaggio è la perdita della sua potenzialità comunicativa, poetica. Una questione che non riguarda solo i poeti, ovviamente…
Punto terzo. La messa in questione dell’alterità è parte integrante di una lettura storica della storia, specie sviluppata in un senso moralistico. Capace cioè di ostinarsi a non volerne vedere la complessità, la tragicità che la caratterizza, come ineludibile manifestazione dell’uomo. Si tende, in questo caso, a far d’ogni erba un fascio. Quasi, per così dire, a prescindere.
Il tema è, chiaramente, ampio e non può essere certo affrontato in poche righe. Mi limito solo a segnalare l’associazione (implicita o esplicita) che ne deriva, in molta retorica, tra alterità e trauma. Tale per cui la condizione per evitare traumi, foss’anche nel processo educativo, è quella di sopprimere l’alterità, quasi abolendola.
Ma, eliminare alterità e trauma vuol dire tentare di espellere dalla scena quel riferimento alla storia che supporta l’alterità, relegando la storia nel passato, quale infida produttrice di senso. Se ne deducono, quanto meno, un paio di conseguenze. La prima: se la storia sta sullo sfondo di tutti i traumi personali e sociali, l’alternativa alla storia non può che risultare il richiamo liberatorio alla natura. Un’ideologia naturalista attraversa manifestazioni di sapere più disparate, quasi un filo rosso che tiene insieme i riferimenti più diversi. Sia religiosi, vedi talune derive islamiche, così come Deleuze o Foucault…. Ma, persino Bolbwy, in psicologia. Il naturale (ammesso che esista) si pone come un obiezione alle vacillazioni, alle ambiguità e ai drammi dello storico. La triade che in Occidente sostiene il paradigma “naturalista” è costituita, in particolare dai nomi di Rousseau, Spinoza, Nietzsche… Se l’alterità, immersa e sostenuta dalla storia, può essere fraintesa, non così è la natura (o, rovesciandolo la prassi scientifica…) che rende il discorso inutile, poiché, nel suo silenzio o nella sua inoppugnabile evidenza, parla da sé.
La seconda conseguenza: l’effetto di questa sorta di sostituzione causale ha come ritorno quello di privare il linguaggio della sua potenzialità espressiva, proprio laddove è sollecitato a indicare, alludere. Magari a sostenere un’identità. Si tratta qui di ricondurre la dinamica rappresentativa a una logica meramente segnica. Così o il linguaggio tende a una sua (ideologica) assolutizzazione, vedasi il richiamo di un’autrice come la Butler al linguaggio cosiddetto performativo di Austin, il quale (non a caso) ritiene parassitario, sic!, il linguaggio poetico… o altrimenti, ma sono due volti di un’unica figura, a un godimento letterale della lingua stessa. Quella che Lacan chiamava la “lalingua”. Joyce, ma qui senza Joyce, senza la sua azione poetica, il suo gioco di articolazione e disarticolazione del rapporto tra suono e senso, tra significante e significato. La poetica, infatti, è un’attività del linguaggio, un movimento che mette bene in luce qual è la posta in gioco del linguaggio, della storicità, cioè il soggetto. Henri Meschonnic docet.
 Quarto punto. La riduzione della lingua a segno presuppone che l’oggetto stesso che la parola mira si oggettivi ulteriormente a sua volta. A far sì che esso corrisponda a un ben chiaro “è questo”, o “è quello”. O, per l’appunto, come sancisce il naturalismo, “è così perché è così”, punto. L’evidenza ideologica della supposta realtà come obiezione al senso. O, meglio, a quel che è il senso, vale a dire la ricerca storica del senso. Ricerca che si compie, che passa attraverso la lingua, come processo creativo, non istituito, ma istituente.
Quarto punto. La riduzione della lingua a segno presuppone che l’oggetto stesso che la parola mira si oggettivi ulteriormente a sua volta. A far sì che esso corrisponda a un ben chiaro “è questo”, o “è quello”. O, per l’appunto, come sancisce il naturalismo, “è così perché è così”, punto. L’evidenza ideologica della supposta realtà come obiezione al senso. O, meglio, a quel che è il senso, vale a dire la ricerca storica del senso. Ricerca che si compie, che passa attraverso la lingua, come processo creativo, non istituito, ma istituente.
Gramsci puntava a far diventare, a rileggere soggettivamente quel che è “oggettivo”. Ora, siamo nel movimento opposto. L’esito che ne deriva sulla destituzione di uno spazio comune di dibattito e conflitto è, mi pare, sotto gli occhi di tutti. La fine dell’ideologia è la nuova veste che l’ideologia assume. Dunque, la consegna è o la chiacchiera o, di fatto, il silenzio. Chi osa dire? Andar contro forme di istituzionalizzazione di discorsi pietrificati, già stabiliti e benedetti a destra o a sinistra? Anti dogmi più pesanti dei dogmi stessi?
La sagra delle identità, la difesa spasmodica del proprio ghetto, auto generatosi e saldamente difeso, ne è la prova. Spirito di Lasch, se ci sei, da qualche parte nell’ aere, batti un colpo!
Anche il discorso religioso fa, in ogni caso, la sua parte. Non esistono lingue sacre, le lingue sono un prodotto degli uomini. Choubachy ha scritto un prezioso libretto sulla lingua araba, dal titolo La sciabola e la virgola. La lingua del Corano è all’origine del male arabo? L’idolatria della lingua la feticizza. Rende un pessimo servizio al divino, a quell’oggetto misterioso e necessario che è, nella sua inattingibile assenza, metafora esemplare dell’origine poetica del linguaggio. Secondo Ibn Arabi Dio disse: «Ero un tesoro nascosto e ho desiderato essere conosciuto. Così, ho creato le creature in modo d’essere conosciuto da loro». Mistero che genera mistero, ricerca. Una storiella ebraica racconta che Dio nel paradiso terrestre ha creato una sola cosa: il punto interrogativo. Il resto è idolatria.
Per associazione, mi torna alla mente un passaggio, lucidissimo, di Lacan: «Alla concupiscenza che brilla negli occhi del vecchio Karamazov quando interroga il figlio: “Dio è morto allora tutto è permesso”, quest’uomo, lo stesso che sogna il suicidio nichilista dell’eroe di Dostoevskij, o che si costringe a soffiare nel pallone nietzschiano, risponde con tutti i suoi mali come con tutti i suoi gesti: “Dio è morto, più niente è permesso”» (Scritti, Einaudi 1974: 124).
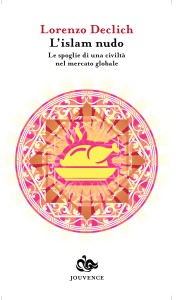 Quinto punto. Orwell in 1984, Klemperer nella realtà terribile dei campi di concentramento, hanno ben mostrato cos’è, cosa può fare o servire una lingua. Il problema, a mio avviso, non sono gli anglicismi. Certo, di per sé irritanti. Essi sono una palese manifestazione del nostro inguaribile e patetico provincialismo. Come già in un celebre vecchio film con Alberto Sordi o in una nota canzone di Renato Carosone. Gli italiani sono così, sono più europeisti degli altri, più americani (oh yeah!) degli americani stessi, nella misura in cui paiono vivere con disagio la propria storia, desiderosi di scimmiottare quella degli altri. Più avanti, più “alla moda”, come recitano i mass media e come essi contribuiscono a colonizzare l’immaginario.
Quinto punto. Orwell in 1984, Klemperer nella realtà terribile dei campi di concentramento, hanno ben mostrato cos’è, cosa può fare o servire una lingua. Il problema, a mio avviso, non sono gli anglicismi. Certo, di per sé irritanti. Essi sono una palese manifestazione del nostro inguaribile e patetico provincialismo. Come già in un celebre vecchio film con Alberto Sordi o in una nota canzone di Renato Carosone. Gli italiani sono così, sono più europeisti degli altri, più americani (oh yeah!) degli americani stessi, nella misura in cui paiono vivere con disagio la propria storia, desiderosi di scimmiottare quella degli altri. Più avanti, più “alla moda”, come recitano i mass media e come essi contribuiscono a colonizzare l’immaginario.
La lingua è questione delicata, ribadiamolo. Chiama a fare i conti con la storia, con l’identità. Il problema è, in verità, molto meno semplice di quello che appare. I localismi ne sono un aspetto significativo. È di sinistra, il basco? La politica che ne è scaturita o la sua difesa risponde a una logica reazionaria, dove l’identità è esasperata, non senza violenza? Così il catalano? È diverso da un certo culto leghista che privilegia i dialetti, le parlate tradizionali? Come distinguere, se occorre distinguere? Come articolare una simile tematica? In fondo, non è deprimente scimmiottare Hallowen? Bacetto scherzetto? Che idiozia!
Come muoversi, in quest’ambito? Una questione cui la logica capitalista è del tutto insensibile, poiché l’importante, in definitiva, è vendere e il resto è del tutto secondario. Montalban segnala la contraddizione paradossale dei conflitti culturali in Spagna, sottolineando come tutti vedessero poi in tv gli stessi programmi, la stessa paccottiglia americana, tradotta però, a seconda, ora in catalano, ora in basco…. O, ancora, il bellissimo libro di Lorenzo Declich: L’islam nudo. Le spoglie di una civiltà nel mercato globale.
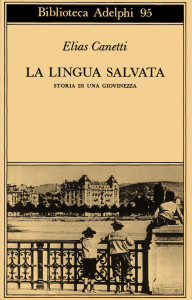 Ora, venendo agli anglicismi. La questione non è l’inglese, lingua che la stragrande maggioranza di quelli che ricorrono agli anglicismi non conoscono, ma una stereotipizzazione segnica del linguaggio. Un impoverimento comunicativo che fa molto lingua del comando, del padrone e quindi frettolosa e adialettica. Come le faccine, i cuoricini e altre baggianate del genere. Insisto, la questione non è l’inglese ma la sua stessa brutalizzazione, poiché non stiamo parlando né di Shakespeare, né di Virginia Woolf e nemmeno di Louise Gluck, vincitrice dell’ultimo Nobel. Cito da October: “…/ you are not alone,/ the poem said, /in the dark tunnel”
Ora, venendo agli anglicismi. La questione non è l’inglese, lingua che la stragrande maggioranza di quelli che ricorrono agli anglicismi non conoscono, ma una stereotipizzazione segnica del linguaggio. Un impoverimento comunicativo che fa molto lingua del comando, del padrone e quindi frettolosa e adialettica. Come le faccine, i cuoricini e altre baggianate del genere. Insisto, la questione non è l’inglese ma la sua stessa brutalizzazione, poiché non stiamo parlando né di Shakespeare, né di Virginia Woolf e nemmeno di Louise Gluck, vincitrice dell’ultimo Nobel. Cito da October: “…/ you are not alone,/ the poem said, /in the dark tunnel”
Come diceva Elias Canetti, autore dello splendido La lingua salvata: «Nulla l’uomo teme più dell’essere toccato dall’ignoto». La mortificazione della lingua ne è il sintomo?
Dialoghi Mediterranei, n. 49, maggio 2021
_____________________________________________________________
Angelo Villa, psicanalista, docente presso la Scuola di specializzazione in psicoterapia di Milano. Ha lavorato come psicologo clinico per istituzioni pubbliche e, in particolare, per il trattamento clinico dei pazienti di fede musulmana, nonché come consulente di progetti in ambito sociale. È autore di numerosi testi specialistici. La sua ultima pubblicazione è L’origine negata. La soggettività e il Corano, edita da Mimesis.
_______________________________________________________________