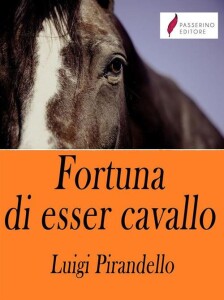La novella: Fortuna d’esser cavallo
Pubblicata originariamente sul Corriere della sera del 23 novembre 1935, Fortuna d’esser cavallo, di Luigi Pirandello, viene poi inserita nella raccolta postuma di novelle Una giornata, del maggio 1937. Il contesto della storia è indefinito ma sembra la campagna di un sobborgo siciliano in un’epoca coeva all’autore. Il protagonista è il cavallo del titolo.
La narrazione, svolgendosi in tempo reale, inizia con la descrizione dell’ambiente da cui il cavallo è stato escluso. Sta fuori da una tenuta vecchia e consunta, con l’acciottolato logoro e la porta all’ingresso ammuffita. Anche la serratura della porta è arrugginita, e la casa è la più vecchia di tutto il sobborgo. Con questa descrizione di vecchiezza e abbandono, il narratore spiega che il cavallo, già da parecchie ore, è stato chiuso fuori dalla sua stalla e lasciato fuori dalla proprietà, di fronte all’ingresso, nudo: non ha neanche la sella né la capezza, né briglia né bisaccia. Chiuso fuori dalla stalla, probabilmente perché vecchio e non più utile dato che il padrone è andato a vivere in un altro paese, il povero cavallo è stato lasciato lì, alla vista, affinché, chi vuole, ne faccia ciò che ritenga meglio.
Nessuno però sa che farsene. All’animale, logorato dagli anni, indesiderabile per chiunque, non rimane che vagare nervosamente, inquieto, in cerca di cibo, ignaro di tutto ciò che gli accade intorno e delle reazioni delle persone al suo passaggio, essendo privo di autocoscienza. E, ci dice Pirandello, la fortuna di esser cavallo, che non sa né di esser cavallo né di avere una qualche fortuna, è proprio la mancanza di consapevolezza di tutto, cosa che lo rende insensibile ai colpi della sorte e a quello che, probabilmente, sarà il suo tragico destino: morire di consunzione, vecchio e solo.
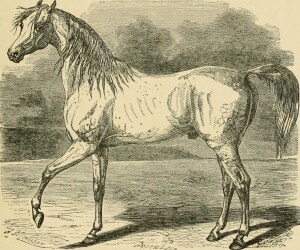
da The horse in the stable and the field: his varieties, management in health and disease, anatomy, physiology (1907)
La fortunata inconsapevolezza dei cavalli
Fortuna d’esser cavallo è un racconto breve, narrato da una voce extradiegetica che rimarca in continuazione che il protagonista è un essere privo di autocoscienza, con nessuna idea di sé: si potrebbe dire allora che non è una persona. La narrazione al tempo presente segue in presa diretta il vagare di questa creatura ignara di tutto, anche della propria fortuna.
Il narratore, mentre descrive ciò che l’animale fa, allo stesso tempo dà voce ai pensieri di chi, incontrando il cavallo, tra sé decide se reagire o no, per lo sgomento che suscita un equino che vaga senza padrone, senza direzione, senza scopo, insomma senza più quell’identità che un animale domestico non si dà da sé ma riceve dagli uomini. Il narratore, come un cronista che sta raccogliendo in diretta le testimonianze su questa bizzarria in atto, ci riporta man mano le informazioni che diversi passanti gli danno: in sostanza, il padrone ha tentato di vendere la bestia prima della partenza ma ha visto che non c’era interesse neanche dandolo a prezzo basso, nemmeno come regalo, e c’è chi, fra coloro che raccontano la faccenda al narratore-cronista, assicura di esser stato uno di quelli cui il cavallo è stato offerto in dono pur di sbarazzarsene.
Nello storyworld nel quale la vicenda è calata, il narratore conosce bene tanto l’universo che sta raccontando quanto le reazioni a quest’anomalia che si sta verificando, cioè un cavallo senza padrone né meta che vaga di propria (inconsapevole) iniziativa. Questo sobborgo è un mondo dei fatti virtualmente infinito (Giovannetti, 2021: 103) da cui il narratore entra ed esce muovendosi tra due livelli: l’interno, cioè dentro il cavallo, nel suo essere bestia incosciente mossa solo dall’istinto e dalla novità di non avere più un padrone (e senza che abbia alcuna idea su tutto ciò), e l’esterno, cioè le reazioni degli esseri umani all’anomalia sociale rappresentata da un equide a piede libero. In un «va-e-vieni incessante» (Lévi-Strauss, 1988: 214), Pirandello gestisce magistralmente prossimità e distanza in un dinamismo che diviene osservazione viva, mai statica (Montes, 2017), tanto di ciò che oggettivamente accade al povero animale quanto di ciò che il narratore suggerisce che l’animale possa provare.
 Se volessimo considerare il cavallo come personaggio pirandelliano a tutti gli effetti, potremmo dire che la sua identità sociale si è sgretolata, e che ciò, secondo Pirandello, è una cosa bellissima, a maggior ragione perché la bestia non se ne può dolere: non è consapevole né di aver mai avuto un’identità sociale né che essa si sia sgretolata. Ma si può parlare di identità sociale per un animale? Il cavallo è ritenuto un animale domestico perché, a differenza della zebra ad esempio, ha determinate caratteristiche che lo rendono ideale a interagire con l’uomo, direbbe Francis Galton, anche se di tutto ciò il buon cavallo non ha la minima idea, come ribadirebbe Luigi Pirandello. Mentre l’identità sociale è fatta (anche) da un fascio di rapporti obbligatori e appartenenze a varie categorie sociali (Goffman, 1981: 123): perciò un cavallo orfano di padrone, che si muove da solo e che in autonomia se ne va in cerca di cibo, non trova posto in un universo antropocentrico dove tutto deve avere una collocazione, un senso, e dove le bestie, in un modo o nell’altro, devono avere un inquadramento nella prospettiva dell’uomo, e nello specifico un’utilità se di animali domestici si parla.
Se volessimo considerare il cavallo come personaggio pirandelliano a tutti gli effetti, potremmo dire che la sua identità sociale si è sgretolata, e che ciò, secondo Pirandello, è una cosa bellissima, a maggior ragione perché la bestia non se ne può dolere: non è consapevole né di aver mai avuto un’identità sociale né che essa si sia sgretolata. Ma si può parlare di identità sociale per un animale? Il cavallo è ritenuto un animale domestico perché, a differenza della zebra ad esempio, ha determinate caratteristiche che lo rendono ideale a interagire con l’uomo, direbbe Francis Galton, anche se di tutto ciò il buon cavallo non ha la minima idea, come ribadirebbe Luigi Pirandello. Mentre l’identità sociale è fatta (anche) da un fascio di rapporti obbligatori e appartenenze a varie categorie sociali (Goffman, 1981: 123): perciò un cavallo orfano di padrone, che si muove da solo e che in autonomia se ne va in cerca di cibo, non trova posto in un universo antropocentrico dove tutto deve avere una collocazione, un senso, e dove le bestie, in un modo o nell’altro, devono avere un inquadramento nella prospettiva dell’uomo, e nello specifico un’utilità se di animali domestici si parla.
Infatti occorre contestualizzare: i modi di stare al mondo di alcuni non sono di certo quelli di altri, né le ecologie degli uni sono quelle degli altri, senza dubbio (Descola, 2011; Montes, 2017). La provincia siciliana di inizio XX secolo che Pirandello racconta ha un suo modo di concepire e rapportarsi agli animali, nella fattispecie ai cavalli, diverso da quello dei cowboy di fine Ottocento e da quello degli allevatori prussiani di metà Settecento. Quindi, in questo storyworld pirandelliano, un cavallo senza più utilità non ha scopo in quell’universo antropocentrico, la sua identità sociale è frantumata. Non può nemmeno essere paragonato a un gatto o un cane randagio, per differenze che il narratore spiegherà, perciò è qualcosa di ancora peggio. È un fallimento, perché la sua esistenza ha cessato di rispettare quel ruolo che, chi osserva la bestia in questo contesto storico-geografico, le attribuisce. È chiaramente un cavallo abbandonato perché troppo vecchio, ma non si tratta solo del fatto che ha cessato di assolvere alla propria funzione per l’età: ogni società ha i propri criteri per definire cosa sia un fallimento e come relazionarsi a esso (Bradatan, 2023: 159-161). Perciò questo equide, più se ne va a zonzo per conto proprio, più appare come un ridicolo (e inquietante) fallimento di ciò che un cavallo dovrebbe essere.
La caustica ironia di Pirandello, infatti, ci mostra l’utilitarismo umano, che dà visibilità alla bestia solo se questa può rendergli un servizio:
«Non mangiasse, un cavallo, ma mangia. E per il servizio che quello può ancora rendere così vecchio e malandato, siamo giusti, vi par che valga la spesa del fieno o anche di un po’ di paglia da dargli a mangiare?
Avere un cavallo e non saper che farsene, dev’esser pure un bell’impiccio» (Pirandello, 2011: 49-50).
Fingendo di cogliere e condividere la “ragionevolezza” degli uomini che non vogliono avere a che fare con una bestia inutile, il narratore, con ironia, interroga il lettore se non sia meglio usare spietatezza invece che pietà.
«Tanti, per levarselo, ricorrono al mezzo sbrigativo d’ucciderlo. Una palla di fucile costa poco. Ma non tutti hanno il cuore di farlo.
Resta però da vedere se non è più crudele abbandonarlo così» (Pirandello, 2011: 50).
In realtà l’equino protagonista, per quanto vecchio e stanco, si mostra reattivo, ad esempio guardando la porta di casa:
«Ma già s’è stancato di star ritto su le zampe e si piega con pena sui ginocchi per riposarsi a terra, sempre con la testa verso la porta» (Pirandello, 2011: 50).
 Il narratore comincia qui la sua riflessione su quale possa essere lo stato d’animo di un cavallo che non sembra abbia molto da vivere e che però, beato lui, non se ne rende conto. Dunque la voce narrante riflette su come esso viva questa condizione di strana, triste libertà. Si potrebbe dire che la riflessione si sposta, più in generale, sull’essere un cavallo in sé e per sé, in sostanza. E questo cavallo qui, con ogni probabilità, non è mai stato libero bensì sempre addomesticato fin dalla nascita, e quindi a maggior ragione non “sa” essere libero.
Il narratore comincia qui la sua riflessione su quale possa essere lo stato d’animo di un cavallo che non sembra abbia molto da vivere e che però, beato lui, non se ne rende conto. Dunque la voce narrante riflette su come esso viva questa condizione di strana, triste libertà. Si potrebbe dire che la riflessione si sposta, più in generale, sull’essere un cavallo in sé e per sé, in sostanza. E questo cavallo qui, con ogni probabilità, non è mai stato libero bensì sempre addomesticato fin dalla nascita, e quindi a maggior ragione non “sa” essere libero.
«Forse quello, nato in qualche stalla, libero non è stato mai. Sì, da giovane in campagna probabilmente, lasciato a pascolare sui prati. Ma libertà per modo di dire; prati chiusi da staccionate. Se pure c’è stato, che ricordo può più averne?» (Pirandello, 2011: 50).
Una creatura che non sa cos’è la libertà, né sa distinguere il fatto che adesso sia libera dal fatto che prima non lo era, è di fatto libera? Il narratore sembra fare del cavallo un exemplum della semplicità del vivere in sé e per sé, senza avere cognizione di sé. Dieci anni prima, tra il 1925 e il 1926, era uscito a puntate e poi in un unico volume Uno, nessuno e centomila, che del vivere senza idea di sé faceva l’ambizione massima. Se sia aspirabile vivere come un cavallo o se invece gli esseri umani sono fortunati ad avere coscienza di esistere e del fatto di essere liberi o meno, il narratore non lo dice, non ancora. Invece si sofferma sulle differenze tra cani e cavalli, e conseguentemente sul diverso modo degli uomini di trattarli, per risaltare le peculiarità equine. Il problema del cavallo è che, se anche magari esso non è cosciente di essere cavallo, lo sono gli altri, i quali si preoccupano proprio per le sue peculiarità:
«Un cavallo non è come un cane che può restar senza padrone, e, se va per via, nessuno ci fa caso. Un cavallo è un cavallo; e se non lo sa, lo sanno gli altri che lo vedono, il corpo che ha, molto molto più grande di quello d’un cane, ingombrante; un corpo che non riesce mai a ispirare un’intera confidenza e da cui tutti ci si guarda perché tutt’a un tratto, non si sa mai, uno sfaglio imprevedibile» (Pirandello, 2011: 51).
Il narratore, osservando i cavalli e paragonandoli ai cani, non solo ne evidenzia le problematiche ma è tentato quasi d’indagare l’interiorità degli equidi, per concludere che essa non è indagabile, infatti nessun cavallo in sé è prevedibile, né, in definitiva, controllabile.
«e poi con quegli occhi, con quel bianco che a volte si scopre feroce e insanguato; occhi così tutti specchianti, con un brio di guizzi e certi baleni, che nessuno comprende, d’una vita sempre in ansia, che può adombrarsi di nulla» (Pirandello, 2011: 51).
Se qui parlasse esplicitamente dei concetti di prossimità e distanza, Pirandello probabilmente direbbe che un cane è (o che almeno così sembra a noi, se ci pare) molto più prossimo a noi di quanto possa mai esserlo un cavallo. E sembra quasi volersi giustificare per la propria severità in questa disamina impietosa e timorosa della specie equina:
«Non è per ingiustizia. Ma non sono gli occhi d’un cane, umani, che chiedono scusa o pietà, che sanno anche fingere, con certi sguardi a cui la nostra ipocrisia non ha più nulla da insegnare.
Gli occhi d’un cavallo, ci vedi tutto, ma non ci puoi legger nulla» (Pirandello, 2011: 51).
Eppure, con questa insistita negazione dell’interiorità equina attraverso la descrizione di caratteristiche fisiche anche inquietanti quali gli occhi imperscrutabili, è come se la voce narrante volesse aiutare il lettore a intuire (o almeno a immaginarsi), poco per volta man mano che procede nella novella, l’atteggiamento di questo particolare cavallo, improvvisamente e inconsapevolmente libero nei confronti della vita. Non è la prima volta che il Pirandello narratore si sforza di contemplare la vita attraverso gli occhi, letterali e metaforici, di un animale, indubbiamente distante e Altro da noi:
«Infatti tante sue opere rientrano nella classificazione della favola filosofica perché si servono dell’animale per configurare un ventaglio di prospettive, di problematiche, e di idee che, nella storia, hanno sempre appassionato i pensatori. Basterebbe pensare a Fortuna d’esser cavallo, La rallegrata, Vittoria delle formiche, La tartaruga» (Zangrilli, 2001: 85).
 Oltre a essere fortunato di per sé in quanto cavallo, è fortunato anche di essere libero, ora che il padrone ha deciso di disfarsene e dato che nessun altro lo ha voluto, ma è una triste ironia perché, nel caso della povera bestia, la libertà si associa, in realtà, alla morte (Zangrilli, 2001: 138). Il narratore da subito insinua nel lettore il sospetto che il padrone, non riuscendo a dare il cavallo a nessuno, lo abbia a quel punto messo in libertà proprio affinché andasse incontro alla fine. In Cervantes, di cui lo scrittore di Girgenti è un fervido lettore, la libertà è cara tanto agli uomini quanto agli animali (Zangrillo, 2001: 146): nel caso dei cavalli però, e quindi anche del protagonista di questa favola filosofica, sembra che essi non siano in grado di comprendere né apprezzare questo dono.
Oltre a essere fortunato di per sé in quanto cavallo, è fortunato anche di essere libero, ora che il padrone ha deciso di disfarsene e dato che nessun altro lo ha voluto, ma è una triste ironia perché, nel caso della povera bestia, la libertà si associa, in realtà, alla morte (Zangrilli, 2001: 138). Il narratore da subito insinua nel lettore il sospetto che il padrone, non riuscendo a dare il cavallo a nessuno, lo abbia a quel punto messo in libertà proprio affinché andasse incontro alla fine. In Cervantes, di cui lo scrittore di Girgenti è un fervido lettore, la libertà è cara tanto agli uomini quanto agli animali (Zangrillo, 2001: 146): nel caso dei cavalli però, e quindi anche del protagonista di questa favola filosofica, sembra che essi non siano in grado di comprendere né apprezzare questo dono.
Ed ecco allora un altro significato, più cupo, della fortuna di essere un cavallo: l’incoscienza della morte. Più l’equide assapora la libertà pur non comprendendola, e più si avvicina alla morte, poiché nessuno lo sfama, e l’inedia inizia a rodere: però esso non se ne rende conto, sente solo la fame. «Un viaggio segnico della ricerca della libertà primitiva» (Zangrilli, 2001: 139) inizia per l’animale, che cerca una compagnia che gli dia da mangiare nonché una reazione a questo nuovo, strano stato di cose. Poiché dall’abitazione un tempo familiare non esce nessuno di coloro che lo avevano mantenuto, e poiché non ha di che mangiare, il cavallo se ne va e inizia a vagare per le strade del sobborgo, in un viaggio in cerca di cibo. Questo viaggio però è anche la scoperta, tanto per il protagonista quanto per il lettore, della ferocia degli uomini, che gli negano il cibo e lo picchiano senza ragione, se non per il senso oscuro di minaccia che dà un cavallo che vaga autonomo senza padrone.
Dunque, da un punto di vista semantico (Baraldi, Corsi, Esposito, 1996: 201-202), l’identità sociale frantumata che in quel momento il povero cavallo mostra, viene sentita come disordine, imprevedibilità: cos’è un cavallo senza padrone, senza un riferimento umano, se non una creatura ambigua, familiare ma al contempo senza collocazione? E dunque, in questa ambiguità perturbante (Freud, 1919), essa afferisce più al mondo delle bestie selvagge, al regno del selvatico: per i gruppi umani che incontra, allora, è una minaccia. Per questo, il narratore Pirandello, giocando sul “sentimento del contrario” (illustrato nel saggio L’umorismo del 1908 e poi nell’edizione del 1920 col celebre esempio dell’anziana imbellettata), da un lato dà a più riprese una descrizione vivida, anche tenera, simpatica, della brava bestia, a tratti quasi umanizzata, così che il lettore provi empatia per essa, ma allo stesso tempo continua a rimarcare che la creatura non ha comunque idea di sé né coscienza, e che la sua fortuna, in fondo, è proprio questa: «non essere conscio né di cosa l’uomo gli fa né di andare incontro all’abisso della morte» (Zangrilli, 2011: 140).
 Il vecchio cavallo alla fine, seguendo gli odori e forse dei ricordi, riesce a trovare da mangiare dell’erba che cresce sulla proda del fiume, e davvero, sebbene sia chiaro che questo cibo è un ristoro momentaneo e che la libertà dell’animale è destinata a sfociare in una morte solitaria per inedia, nel quadro delineato nelle ultime frasi dal narratore ci si potrebbe chiedere quanto la nostra condizione sia migliore di quella animale. La vita umana è complicata, quella equina è semplice. Vitangelo Moscarda, per arrivare alla stessa “assenza da sé” in cui il cavallo è nato, deve fare tutto un percorso di auto-dissoluzione. Ma in fondo, non sono uomini e cavalli entrambi destinati alla dissoluzione e alla morte? Solo che i cavalli, beati loro, non lo sanno.
Il vecchio cavallo alla fine, seguendo gli odori e forse dei ricordi, riesce a trovare da mangiare dell’erba che cresce sulla proda del fiume, e davvero, sebbene sia chiaro che questo cibo è un ristoro momentaneo e che la libertà dell’animale è destinata a sfociare in una morte solitaria per inedia, nel quadro delineato nelle ultime frasi dal narratore ci si potrebbe chiedere quanto la nostra condizione sia migliore di quella animale. La vita umana è complicata, quella equina è semplice. Vitangelo Moscarda, per arrivare alla stessa “assenza da sé” in cui il cavallo è nato, deve fare tutto un percorso di auto-dissoluzione. Ma in fondo, non sono uomini e cavalli entrambi destinati alla dissoluzione e alla morte? Solo che i cavalli, beati loro, non lo sanno.
Anzi, spesso gli uomini agiscono come stupidi bruti, resi ottusi dalla loro cattiveria, caratteristica tipica, per Pirandello, di certe precise categorie sociali, ossia ricchi possidenti e abbienti notabili di provincia, i quali spesso vengono equiparati dall’autore a figure del mondo animale, ma molte volte costoro sono peggio degli animali stessi (Zangrilli, 2001: 23). Il cavallo invece è allegoria dell’Altro dall’uomo, un’alterità forse non migliore né peggiore in senso assoluto, ma certamente libera dall’afflizione della coscienza di sé, tipica dell’identità in generale e dell’identità sociale nello specifico, con tutti i suoi legami e implicazioni.
Già tre decenni prima il narratore s’era avvalso di un equide, nella novella Un cavallo nella luna del 1907, per esprimere l’Altro, l’alterità rispetto all’uomo e dentro l’uomo:
«la bestia, infatti, è usata qui come simbolo tutto oggettivo, voce di quell’Altro che Lacan definisce “la voix de l’Incoscient” e che Pirandello chiama “l’antro della bestia” [nella novella Non è una cosa seria del 1910], “intendendo della bestia originaria acquattata dentro a ciascuno di noi, sotto tutti gli strati di coscienza che gli si sono mano a mano sovrapposti negli anni”. Così il cavallo non è, a differenza della mosca, uno strumento effettivo, sia pure casuale e misterioso, di morte, ed è il processo di simbolizzazione, innescato su un sensibilissimo substrato reale» (Nardi, 1981: 66).
Il cavallo dunque è anche, fra le varie cose, l’Altro che è “l’antro della bestia”, un essere che, acquattato dentro l’uomo, vorrebbe fargli smarrire la coscienza di sé per renderlo libero.
«Il “cavallo” nelle Novelle per un anno è presente sotto tre tipi diversi e fra loro contrastanti: una prima utilizzazione è quella puramente meccanica del cavallo come mezzo di trasporto […] cui si contrappone l’umanizzazione dell’animale, protagonista assoluto nell’apologo La rallegrata e nella «scenetta commovente» di Notizie dal mondo […] E si registra infine l’uso metafisico-simbolico del cavallo in Un cavallo nella luna, uso a sua volta sottilmente contrapposto al processo di identificazione allegorica uomo-animale [… come invece avviene in] Fortuna d’esser cavallo» (Nardi, 1981: 69).
Il finale è malinconico, anche se sembra un meritato (provvisorio) lieto fine per il povero equide che finalmente trova cibo. Il narratore sembra suggerire una risposta finalmente a questo interrogativo: qual è la condizione migliore, quella dell’uomo o del cavallo? Gli uomini sono fortunati ad avere coscienza di esistere, o la condizione equina è più desiderabile?
Di certo, il cavallo non lo sa, né ci riflette. «La sera è mite. Il cielo è stellato. Domani sarà quel che sarà. Non ci pensa» (Pirandello, 2011: 53).
Dialoghi Mediterranei, n. 67, maggio 2024
Riferimenti bibliografici
Baraldi C., Corsi G., Esposito E., Luhmann in glossario, F. Angeli, Milano 1996.
Bradatan C., Elogio del fallimento, trad. di O. Ellero, Il Saggiatore, Milano 2023.
De Michele F., Rössner M., Sorrentino A. (a cura di), Pirandello e l’identità europea, Metauro Edizioni, Pesaro 2007.
Ferrarotti F., Introduzione alla sociologia, Editori Riuniti, Roma 1981.
Freud S., “Das Unheimliche”, in Imago, vol. 5 (5-6), 1919: 297-394 (Il perturbante, a cura di C.L. Musatti, Theoria, Roma 1993).
Galton F., The First Steps Towards the Domestication of Animals. To Be Read Before the Ethnological Society (4 St. Martin’s Place, 8 p.m.) on Tuesday. Dec. 22, 1863, Leopold Classic Library, Victoria (Australia)(Fr 2017.
Giddens A., Sociologia, Il Mulino, Bologna 1994.
Giovannetti P., Il racconto. Letteratura, cinema, televisione, Carocci, Roma 2021.
Goffmann E., Relazioni in pubblico, Bompiani, Milano 1981.
Grignani M.A., “Innovazioni narrative negli ultimi romanzi di Pirandello”, in Lauretta E. (a cura di), Attualità di Pirandello, Metauro Edizioni, Pesaro 2008.
Lévi-Strauss C., Éribon D., Da vicino e da lontano, Rizzoli, Milano 1988.
Montes S., “Da vicino, da lontano. L’antropologia di Milan Kundera”, in Dialoghi Mediterranei n. 23, 1 gennaio 2017.
Nardi I., “Animali allegorici e animali simbolici nelle novelle di Pirandello”, in Inventario. Rivista di critica e letteratura fondata da Luigi Berti, n. 2, Editrice Gutenberg, Povegliano Veronese (VR), maggio-agosto 1981: 63-69.
Pirandello L., Ultime novelle, Rusconi Libri, Santarcangelo di Romagna (RN) 2011.
Pirandello L., Fortuna d’esser cavallo, Passerino editore, Gaeta, 2020
Zangrilli F., Il bestiario di Pirandello, Metauro Edizioni, Fossombrone (PS) 2001.
________________________________________________________
Claudio Gnoffo, dottorando in “Scienze Umanistiche” presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma e cultore di “Storia dell’Arte Medievale” presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo, è stato coordinatore nel 2022 del convegno internazionale “Realtà mediali. Sociologia, semiotica e arte negli immaginari e nelle rappresentazioni” e co-curatore del 1° volume tratto dal convegno, Realtà mediali. Medialità, arte e narrazioni, per UniPa Press; è inoltre autore di diversi articoli scientifici, fra cui, con regolarità dal 2019, per “Le nuove frontiere della scuola” de La Medusa Editrice.
______________________________________________________________