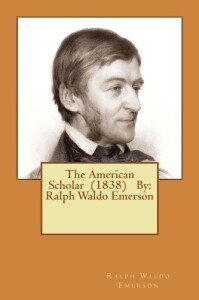di Giuseppe Pera [*]
Rethinking Identity
Rethinking Identity: un soggetto che non può non rimandare immediatamente un italianista, e per di più siciliano, all’Uno, nessuno e centomila di Pirandello, il quale fin dal titolo-manifesto del suo romanzo sull’identità indica il paradosso di ogni essere umano (Uno) di possedere infiniti aspetti in funzione degli infiniti sguardi portati dagli altri su di lui (centomila) e dunque di essere, in sostanza, nessuno. Evidente il presupposto gnoseologico kantiano in una tale concezione dell’identità individuale (la contrapposizione tra fenomeno e noumeno e l’inconoscibilità del secondo, la cosa in sé, ossia la vera essenza della realtà, di cui solo l’apparenza, il fenomeno, può essere conosciuto), che già Goethe, a una generazione di distanza da Kant, aveva così interpretato:
«Ogni essere vivente non è un singolo, ma una molteplicità: anche quando ci appare come individuo, resta sempre una riunione di esseri viventi autonomi».
Una tesi, questa, che circa un secolo più tardi anche Nietzsche avrebbe fatto propria e che avrebbe precisato altrettanto brevemente in questi termini: gli organismi sono definiti «in quanto centri di fini. Ma ci sono unità solo per il nostro intelletto. Ogni individuo ha in sé un’infinità di individui viventi» [1]. E così, inoltre, e per ritornare al romanzo, si esprimeva il contemporaneo di Nietzsche, Robert Louis Stevenson, drammatizzando esemplarmente lo stesso concetto nel suo celebre Lo strano caso del Dr. Jekyll e del Sig. Hyde [2]:
«l’uomo non è veracemente uno, ma veracemente due. E dico due, perché le mie conoscenze non sono giunte oltre. Altri seguiranno, altri porteranno avanti queste ricerche, e non è da escludere che l’uomo, in ultima analisi, possa rivelarsi una mera associazione di soggetti diversi, incongrui e indipendenti».
 Com’è noto, la ricerca successiva in questo campo, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, in particolare quella di Freud, avrebbe semplificato molto la questione proponendo una tripartizione della psiche umana, ma non si è pervenuti con ciò a una dimensione di certezza scientifica, come ci si sarebbe potuti aspettare, e quindi il problema non potrà dirsi unanimemente risolto – tanto è vero che le ricerche di Freud hanno poi preso innumerevoli direzioni – neppure nell’epoca del massimo trionfo della scienza, né, si può supporre, potrà mai esserlo, insieme a molte altre questioni fondamentali della vita, il che ci rimanderebbe ancora una volta alla gnoseologia kantiana, all’inconoscibilità del noumeno, la cosa in sé, l’essenza della realtà.
Com’è noto, la ricerca successiva in questo campo, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, in particolare quella di Freud, avrebbe semplificato molto la questione proponendo una tripartizione della psiche umana, ma non si è pervenuti con ciò a una dimensione di certezza scientifica, come ci si sarebbe potuti aspettare, e quindi il problema non potrà dirsi unanimemente risolto – tanto è vero che le ricerche di Freud hanno poi preso innumerevoli direzioni – neppure nell’epoca del massimo trionfo della scienza, né, si può supporre, potrà mai esserlo, insieme a molte altre questioni fondamentali della vita, il che ci rimanderebbe ancora una volta alla gnoseologia kantiana, all’inconoscibilità del noumeno, la cosa in sé, l’essenza della realtà.
Senonché, ci ricorda Borges, (e con ciò cominciamo a dare il primo accenno della sua visione teorica della letteratura di cui tratteremo), «the Greeks had a word for it», ossia, nei greci c’è sostanzialmente tutto, convinto com’è, Borges, che tutto in Occidente sia già stato pensato da loro, perché, sostiene, furono loro i primi a pensare, e forse a pensare tutto: i greci erano colti quando tutto l’Occidente era ancora barbaro. E a dargli ragione in questo caso (attraverso Schopenhauer, il loro humus comune), è il giovane Nietzsche che, nei suoi appunti per un saggio su Democrito (le cui opere Platone, significativamente, avrebbe voluto dare alle fiamme, cosa di cui si sarebbe poi incaricato il cristianesimo), scrive che il principio fondamentale di Democrito rimane: «la cosa in sé è inconoscibile» [3]. E così come Kant avrebbe ripreso questo concetto originale democriteo, Schopenhauer avrebbe ridefinito quello kantiano in un nuovo e terribile concetto – la cieca volontà della Natura – che Nietzsche, a sua volta, dopo averlo entusiasticamente accolto, com’è noto, avrebbe sviluppato diversamente nella sua “volontà di potenza”.
Vi è poi l’altro aspetto della questione dell’identità che – se finora ci siamo limitati ad alcuni accenni sulla sua ontogenesi – potremmo ora definire filogenetico: razziale, nazionale, sociale. Qual è, per esempio, l’identità di non dico un inglese, un francese, un tedesco, uno spagnolo, un italiano, ma, per semplificare un poco, di un lombardo, un toscano, un laziale, un siciliano? Dell’identità di quest’ultimo, e ancora per semplificare, potremmo provare a dire, approssimativamente, come variamente greco-romana e arabo-normanna, tralasciando così altre definizioni di sue possibili componenti come: sicula, sicana, elima (troiana), cartaginese, bizantina, sveva, francese, aragonese, spagnola e quant’altro, per restare sul piano storico (e, in parte, mitico). Se poi pensiamo al fatto che ognuna di queste definizioni potrebbe essere probabilmente scomposta in decine di altre, perdendoci naturalmente poi nell’indeterminatezza della preistoria, si capisce quanto possa essere riduttivo (e ridicolo) il richiamarsi oggi, per definire la propria identità collettiva, a una sola discendenza, come fanno certi gruppi politici contemporanei, per esempio lombardi (termine, etimologicamente, derivato da longobardo, ossia, in origine, membro di una tribù germanica ben distinta dai galli, o celti, che dir si voglia, nonché dagli eruli, gli ostrogoti, gli alamanni, i franchi, ecc.) che vorrebbero considerarsi eredi, contro ogni evidenza storica e ragionevolezza, dei soli celti…
 Sedicenti “popoli eletti”, “razze superiori”, “nazionalità” e perfino ridicole varietà regionali o sub-etnie “pregiate” (benché, si potrebbe dire, di origine assolutamente non controllata), chiaramente introducono – tutti, essendo la loro motivazione sempre identica – divisioni e discriminazioni conflittuali, che costituiscono in nuce ciò che oggi si definiscono come crimini contro l’umanità. Tutto può essere inventato e sostenuto, in ogni epoca e con ogni mezzo di comunicazione, sia attraverso una cosciente, rozza semplificazione, sia attraverso un’altrettanto colpevole e rozza ignoranza, trovando puntualmente ampio credito e fede cieca nella sottocultura delle masse variamente assoggettate e abbrutite, finché un Bardamu qualunque, ossia un Louis-Ferdinand Céline appena camuffato nella finzione letteraria, in un caffè di place Clichy, a Parigi, proprio alla vigilia dell’immane carneficina della Prima guerra mondiale, instillerà il dubbio ragionevole dell’inesistenza, per esempio, della ”razza francese” al suo interlocutore delle pagine iniziali del Voyage au bout de la nuit [4], Arthur Ganate, il quale, scandalizzato, tipicamente, come ogni buon nazionalista, così reagirà:
Sedicenti “popoli eletti”, “razze superiori”, “nazionalità” e perfino ridicole varietà regionali o sub-etnie “pregiate” (benché, si potrebbe dire, di origine assolutamente non controllata), chiaramente introducono – tutti, essendo la loro motivazione sempre identica – divisioni e discriminazioni conflittuali, che costituiscono in nuce ciò che oggi si definiscono come crimini contro l’umanità. Tutto può essere inventato e sostenuto, in ogni epoca e con ogni mezzo di comunicazione, sia attraverso una cosciente, rozza semplificazione, sia attraverso un’altrettanto colpevole e rozza ignoranza, trovando puntualmente ampio credito e fede cieca nella sottocultura delle masse variamente assoggettate e abbrutite, finché un Bardamu qualunque, ossia un Louis-Ferdinand Céline appena camuffato nella finzione letteraria, in un caffè di place Clichy, a Parigi, proprio alla vigilia dell’immane carneficina della Prima guerra mondiale, instillerà il dubbio ragionevole dell’inesistenza, per esempio, della ”razza francese” al suo interlocutore delle pagine iniziali del Voyage au bout de la nuit [4], Arthur Ganate, il quale, scandalizzato, tipicamente, come ogni buon nazionalista, così reagirà:
«Si donc ! qu’il y en a une ! Et une belle de race ! qu’il insistait lui, et même que c’est la plus belle race du monde et bien cocu qui s’en dédit ! » Et puis, le voilà parti à m’engueuler. J’ai tenu ferme bien entendu.
«C’est pas vrai ! La race, ce que t’appelles comme ça, c’est seulement ce grand ramassis de miteux dans mon genre, chassieux, puceux, transis, qui ont échoué ici poursuivis par la faim, la peste, les tumeurs et le froid, venu vaincus des quatre coins du monde. Ils ne pouvaient pas aller plus loin à cause de la mer. C’est ça la France et puis c’est ça les Français».
E questo, ovviamente, potrebbe valere non solo per la “razza francese” e la Francia, ma per qualunque “patrie n° 2”, come dice ancora Bardamu, fermo restando che in caso di guerra – e qui Bardamu allarga la questione ai suoi aspetti economico-sociali e religiosi i ricchi dirigenti, veri padroni della cosiddetta patria, sproneranno le masse ignare verso l’orribile carneficina, di cui soltanto gli stessi ricchi cinici dirigenti che hanno voluto la guerra saranno come sempre i beneficiari, al grido di «Vive la Patrie n° 1 ! Qu’on vous entende de loin ! Celui qui gueulera le plus fort, il aura la médaille et la dragée du bon Jésus ! Nom de Dieu !»
Come il già citato proverbio inglese “i greci avevano una parola per dirlo”, anche queste apparentemente eterogenee considerazioni di Bardamu non sono estranee alla concezione borgesiana della letteratura, o meglio, della cultura, come vedremo più oltre. Che la si tratti ontogeneticamente o filogeneticamente, come si intravede, la questione dimostra una grande complessità e una chiara impossibilità di giungere a una conclusione certa, o anche probabile, talché, anche per non allontanarmi troppo dalle mie attuali ricerche, preferisco circoscrivere l’argomento Rethinking identity all’identità del solo scrittore nel quadro della specifica concezione estetica di Jorge Luis Borges, così come può essere desunta dalle sue trenta Conversazioni con Osvaldo Ferrari, tenute nel 1984 alla Radio municipale di Buenos Aires, raccolte in volume l’anno seguente, e tradotto in italiano nel 1986 da Bompiani [5].
 Conversazioni con Osvaldo Ferrari
Conversazioni con Osvaldo Ferrari
Nato a Buenos Aires nel 1899, Borges compiva, all’epoca in cui si svolsero queste trenta conversazioni, ottantacinque anni, e sarebbe poi morto due anni più tardi a Ginevra, nel 1986, dove aveva vissuto in gioventù. Il suo unico interlocutore nel corso di queste trasmissioni, lo scrittore e giornalista argentino Osvaldo Ferrari, di cinquant’anni più giovane di Borges, assicura che la trascrizione dei trenta dialoghi è scrupolosamente letterale e che i temi non erano stati fissati in precedenza, ma sorsero spontaneamente. Vi si parla soprattutto di letteratura, naturalmente, e dei suoi classici, di filosofia, (e in particolare di morale), di cultura, religioni, mitologie, viaggi, paesi, della vita stessa di Borges e delle sue opere, con i suoi caratteristici temi, e dei suoi amici scrittori e intellettuali. Nella sua breve introduzione al volume, Borges afferma di intendere il dialogo come «un genere letterario a sé, un modo indiretto di scrivere», aggiungendo però che «dev’essere una ricerca; importa poco che la verità esca dalla bocca dell’uno e dell’altro […] quel che importa è giungere a una conclusione».
Se la riproposta, in sostanza, dei dialoghi platonici nell’era della comunicazione di massa è evidente, occorre tuttavia sottolineare, come fa Osvaldo Ferrari nella sua introduzione, che l’ambito in cui queste conversazioni si svolsero fu quello della congettura, dell’ipotesi. E si capisce, poiché una volta giunti alla conclusione, su una delle questioni fondamentali dell’umanità, che non gli dèi hanno creato gli uomini, bensì gli uomini hanno creato gli dèi, e che dunque, senza alcun’altra favola anestetica o rasserenatrice, parafrasando Lorenzo de’ Medici, “del mondo non v’è certezza”, la grande libertà di pensiero che ne deriva non può non esprimersi attraverso congetture. «L’ipotesi è la cosa più sicura – sostiene difatti Borges nella sua trentesima e ultima conversazione, tutto il resto è soggetto al caso […] Non ci restano che il caso e l’ipotesi». Senonché, da buon discendente, come Nietzsche, di pastori protestanti (nel suo caso metodisti, benché egli fosse di lontana origine ebraica portoghese), cui è rimasta di quella fede, insieme all’influenza calvinista ginevrina, oltre al tipico rigore morale (che egli contrappone all’”immoralità”, dice, del cattolicesimo), la sola credenza nella predestinazione (o almeno, così dice), che il calvinismo ha peraltro in comune con l’islam, Borges aveva aperto la sua breve introduzione con queste parole: «La nostra vita, allo stesso modo di questi dialoghi e di ogni cosa, è stata prefissata. Così anche i temi cui ci siamo avvicinati». Ora, il concetto della predestinazione, mi pare, escluda del tutto la casualità…
L’apparente contraddizione in cui Borges sembra incorrere, può forse essere attenuata dalla precisazione data nel seguente scambio con il suo interlocutore su questo stesso argomento. Spiega Borges:
«Tutto è stato fissato. […] Questo naturalmente non vuol dire che sia stato fissato da qualcuno. Perché c’è il rischio che si confondano le due idee: si può credere nella predestinazione senza supporre che essa sia conosciuta da qualcuno: qualcosa che avviene, piuttosto, per un giuoco fatale di effetti e di cause.
In tal caso questa conversazione sarebbe, come si diceva l’altra volta, cosmica cioè ordinata.
Certo. E quel ch’è peggio credo sia fissata da una macchina…»
“Le roi s’amuse”, scrive il curatore e traduttore italiano del volume, Francesco Tentori Montalto, proprio nell’incipit della sua nota introduttiva.
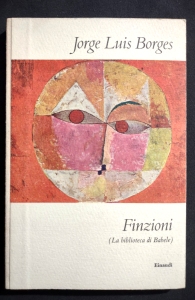 Fra i vari antenati di Borges, oltre ai portoghesi, agli spagnoli e agli argentini, vi furono anche degli avi inglesi, almeno fino a un bisnonno, di cui egli parla nelle sue conversazioni, che si laureò a Heidelberg sostenendo gli esami in latino, senza aver imparato il tedesco nel corso del suo lungo soggiorno in Germania. Tentori Montalto rileva nella sua nota introduttiva che il tono che Borges usa nelle sue conversazioni è «ironico, col senso dello ‘humour’ e il pregio (talora il vezzo, rivelato dal suo sottolinearlo) dell’understatement ereditato dagli avi britannici», e «nella scia dei suoi paradossi» si chiede perché mai Borges non potrebbe essere definito come «sostanzialmente uno scrittore inglese che si esprime in spagnolo», tanto più che «i suoi compagni di strada, i suoi simili, sono, oltre al prediletto Kipling, Chesterton, Shaw, Wilde, Wells e più indietro Swift, autori tutti la cui ironia, eccentricità, bizzarria riecheggiano in questo nipote di anglosassoni». E a questi nomi io aggiungerei pure – in relazione a questo stesso atteggiamento rilevato da Tentori Montalto – ma sul versante nordamericano, dei cui autori Borges aveva altrettanta familiarità, oltre al Mark Twain dalla proverbiale comicità, e i cui riflessi sono visibili in alcune divertenti battute di queste Conversazioni, anche il Benjamin Franklin che, giunto in Europa, si divertiva a raccontare ai suoi stupefatti interlocutori parigini che fra le tante meraviglie naturali del nuovo continente vi era quella straordinaria delle balene che rimontavano le cascate del Niagara con dei grandi salti fuor d’acqua proprio come dei salmoni…
Fra i vari antenati di Borges, oltre ai portoghesi, agli spagnoli e agli argentini, vi furono anche degli avi inglesi, almeno fino a un bisnonno, di cui egli parla nelle sue conversazioni, che si laureò a Heidelberg sostenendo gli esami in latino, senza aver imparato il tedesco nel corso del suo lungo soggiorno in Germania. Tentori Montalto rileva nella sua nota introduttiva che il tono che Borges usa nelle sue conversazioni è «ironico, col senso dello ‘humour’ e il pregio (talora il vezzo, rivelato dal suo sottolinearlo) dell’understatement ereditato dagli avi britannici», e «nella scia dei suoi paradossi» si chiede perché mai Borges non potrebbe essere definito come «sostanzialmente uno scrittore inglese che si esprime in spagnolo», tanto più che «i suoi compagni di strada, i suoi simili, sono, oltre al prediletto Kipling, Chesterton, Shaw, Wilde, Wells e più indietro Swift, autori tutti la cui ironia, eccentricità, bizzarria riecheggiano in questo nipote di anglosassoni». E a questi nomi io aggiungerei pure – in relazione a questo stesso atteggiamento rilevato da Tentori Montalto – ma sul versante nordamericano, dei cui autori Borges aveva altrettanta familiarità, oltre al Mark Twain dalla proverbiale comicità, e i cui riflessi sono visibili in alcune divertenti battute di queste Conversazioni, anche il Benjamin Franklin che, giunto in Europa, si divertiva a raccontare ai suoi stupefatti interlocutori parigini che fra le tante meraviglie naturali del nuovo continente vi era quella straordinaria delle balene che rimontavano le cascate del Niagara con dei grandi salti fuor d’acqua proprio come dei salmoni…
Del resto è Borges stesso, proprio nel corso delle sue conversazioni, a metterci in guardia, e più di una volta, a non prenderlo troppo sul serio, e a ripeterci di come sia stupito dell’attenzione, della considerazione e dei riconoscimenti che gli si accordavano nel mondo e che lui riteneva di non meritare, giustificando la cosa con l’essere diventato, dice, «una specie di superstizione internazionale». Ciò non toglie, scrive ancora Tentori Montalto, che egli sia «all’occorrenza pronto alla definizione e al giudizio netto, non equivoco», che per lui «nulla sia intangibile e che tutto è sempre in questione». Tuttavia Borges si credeva, dice, «pressoché incapace di pensare per mezzo di ragionamenti; io tendo a pensare per mezzo del mito o comunque dei sogni, per mezzo delle mie invenzioni», precisava, aggiungendo ai suoi mezzi anche l’intuizione. «Certo, so che l’altro sistema è più rigoroso e cerco di ragionare, quantunque dubiti di riuscirvi; ma mi si dice che sono capace di sognare, ed è quel che faccio». «In fin dei conti – conclude su questo punto, e anche questo non dovremmo dimenticarlo – non sono un pensatore, sono soltanto un narratore, un poeta» Un poeta, però, suggerisce Tentori Montalto – e sono perfettamente d’accordo con lui – che «nel fitto del suo universo di citazioni, riferimenti, paragoni, ricordi, procede con la sicurezza del veggente».
Ed è difatti proprio questa, per me, la ragione per cui la teoria della letteratura borgesiana – di cui, fra molti altri argomenti in queste Conversazioni, egli ci parla peraltro in un modo assolutamente non sistematico, ma, direi, semplicemente intuitivo, visionario, appunto, oltre che dall’interno stesso, dal profondo della letteratura, da “addetto ai lavori” e fra i più qualificati, data la sua dimensione di scrittore di particolare, grande statura –, questa paradossale, suggestiva visione che un letterato cieco, (come ciechi, la tradizione ci dice, se mai sono esistiti, erano Omero e Tiresia), ha potuto avere e ci dà della letteratura universale, mi affascina più di ogni altra teoria “scientifico-accademica” che conosca.
«Questa è dunque la patria», pensa Borges al suo ritorno a Buenos Aires, nel 1920, dopo aver trascorso molti anni in Europa, a Ginevra, dove fu educato, poi a Mallorca, dove visse per un anno, in seguito in Andalusia, la terra dei suoi antenati spagnoli, e infine a Madrid dove lo consideravano andaluso, dice, per via della cadenza che aveva preso in compagnia dei poeti sivigliani del gruppo ultraista. «Mi sto accomiatando da tutte le biblioteche d’Europa», aveva inoltre pensato partendo, e giunto in Argentina si sente come un esule, dice, come tutti gli argentini di origine europea, del resto, che egli considera «europei in esilio». Ma questa condizione, secondo lui, finisce per trasformarsi paradossalmente in un vantaggio, giacché non si è vincolati da alcuna tradizione locale e si eredita perciò “tutto l’Occidente” e gli permette così, proprio questo esilio, «di essere europeo in modo più ampio di coloro che sono nati in Europa». Ciò non vale solo per gli argentini, naturalmente, ma per tutte le Americhe, del sud, del centro e anche del nord, e difatti egli ritiene che il Ralph Waldo Emerson de The American Scholar pensasse alla questione esattamente allo stesso modo. Senza contare poi che in un Paese già di per sé cosmopolita come l’Argentina, la cui capitale, dice Borges, ha «la metà della popolazione italiana e l’altra metà spagnola», vi sia già per questo una certa «tendenza all’universale» (e qui si potrebbe ricordare anche la figura di Ernesto Che Guevara), abbiamo inoltre già visto che l’avere avuto degli antenati portoghesi, spagnoli, inglesi – cui si sono poi aggiunti illustri antenati argentini – aver ricevuto la propria formazione in Svizzera, ed essere vissuto anche in Spagna, sicuramente ha contribuito a rendere Borges cosmopolita in un modo del tutto naturale.
Figlio di un professore di psicologia, Borges lavora a lungo come impiegato in una piccola biblioteca comunale della capitale prima di abbracciare anch’egli la carriera dell’insegnamento come professore di letteratura inglese e nordamericana all’università di Buenos Aires. Poco oltre i cinquant’anni diviene, com’è noto, totalmente cieco, dopo non aver mai goduto nel corso della sua vita di una vista normale, e conclude la sua carriera come direttore della Biblioteca Nazionale di Buenos Aires. Se la sua prima raccolta poetica, Fervor de Buenos Aires, è pubblicata nel 1923, e alla poesia si accompagnerà in seguito e costantemente l’attività saggistica, egli giunse piuttosto tardi alla narrativa, verso i quarant’anni, per una sorta di “blocco” che riuscì finalmente a superare in un modo che gli sarebbe in seguito diventato peculiare, e che lasceremo raccontare a Italo Calvino, che lo considerava «un maestro dello scrivere breve», in una delle sue Lezioni americane [6], quella, precisamente, dedicata alla Rapidità:
«L’idea di Borges è stata di fingere che il libro che voleva scrivere fosse già scritto, scritto da un altro, da un ipotetico autore sconosciuto, un autore d’un’altra lingua, d’un’altra cultura, – e descrivere, riassumere, recensire questo libro ipotetico. Fa parte della leggenda di Borges l’aneddoto che il primo straordinario racconto scritto con questa formula, El acercamiento a Almotásim, quando apparve nella rivista “Sur” nel 1940, fu creduto davvero una recensione a un libro d’autore indiano».
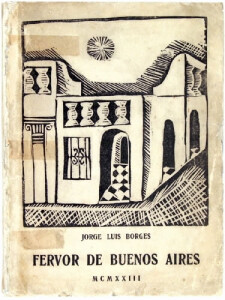 Il che non solo ci ricorda una delle prime manifestazioni di un altro autore geniale, Orson Welles, la cui famosa trasmissione radiofonica, tratta da La guerra dei mondi di Herbert George Wells, se non erro, su un’invasione di extraterrestri terrorizzò i radioascoltatori americani che la presero per vera, ma, curiosamente, la definizione che Calvino dà dell’invenzione di Borges, («l’invenzione di se stesso come narratore», «l’ultima grande invenzione d’un genere letterario a cui abbiamo assistito»), riecheggia quella che Borges stesso dà a quella di Kafka: «fu la grande invenzione di Kafka», le cui opere, dice, «presero a modello i paradossi di Zenone di Elea. L’idea, per esempio, della corsa infinita della tartaruga, il cui moto non raggiunge mai la sua meta». Un autore, Kafka, su cui ritorneremo, considerato da lui come un “classico”, ma nel senso tutto borgesiano e nuovo di questo termine, come vedremo, mentre di sé, con la solita modestia, diceva di essere un “classico minore”.
Il che non solo ci ricorda una delle prime manifestazioni di un altro autore geniale, Orson Welles, la cui famosa trasmissione radiofonica, tratta da La guerra dei mondi di Herbert George Wells, se non erro, su un’invasione di extraterrestri terrorizzò i radioascoltatori americani che la presero per vera, ma, curiosamente, la definizione che Calvino dà dell’invenzione di Borges, («l’invenzione di se stesso come narratore», «l’ultima grande invenzione d’un genere letterario a cui abbiamo assistito»), riecheggia quella che Borges stesso dà a quella di Kafka: «fu la grande invenzione di Kafka», le cui opere, dice, «presero a modello i paradossi di Zenone di Elea. L’idea, per esempio, della corsa infinita della tartaruga, il cui moto non raggiunge mai la sua meta». Un autore, Kafka, su cui ritorneremo, considerato da lui come un “classico”, ma nel senso tutto borgesiano e nuovo di questo termine, come vedremo, mentre di sé, con la solita modestia, diceva di essere un “classico minore”.
Dato ciò che precede, non ci sorprende che nella prefazione ai saggi di Altre inquisizioni [7], ancora Tentori Montalto definisca Borges come «uno scrittore di racconti che somigliano a saggi, di saggi che sembrano racconti». Sempre Tentori Montalto, poi, nella nota finale ai racconti de L’Aleph [8], raccoglie inoltre, per meglio precisare, svariate definizioni della critica internazionale sulla scrittura narrativa, spesso metafisica, di Borges che rappresenta, vi si legge, «un mondo fantastico governato dalla logica», una scrittura ricca di allusioni sul mistero dell’universo, a «realtà incomunicabili»; «un écrivain obsédé par les rapports du fini et de l’infini» e soprattutto dal tempo e l’eternità.
Ma per dare un solo, piccolo, esempio di uno dei suoi tipici soggetti a chi non li conosce ancora, e che ci introdurrà nel seguito immediato del nostro discorso, ecco l’Aleph, nel racconto eponimo della raccolta, definito come «uno dei punti dello spazio che contengono tutti i punti», «il luogo dove si trovano, senza confondersi, tutti i luoghi della terra, visti da tutti gli angoli». Più precisamente, si tratta di una sfera – che Borges stesso, co-protagonista del racconto, ha il privilegio di contemplare nella cantina della casa di un amico a Buenos Aires – una sfera, dunque, dal diametro «di due o tre centimetri», «il cui centro è dappertutto e la circonferenza in nessun luogo», di cui, altrove, nel racconto, si lascia intendere che potrebbe contenere addirittura tutto l’universo e nelle Conversazioni, a trentacinque anni dalla pubblicazione del racconto, Borges dice ancora dell’Aleph che è un “istante” in cui convergono «tutto il passato, tutto il presente e il futuro».
 Aleph, ricordiamolo, è la prima lettera dell’alfabeto ebraico, l’Alif in arabo, l’Alfa in greco, la lettera A del nostro alfabeto latino: è il principio, si potrebbe interpretare, di tutto il dicibile e soprattutto dell’indicibile – se, come dice Borges, «il linguaggio è molto povero paragonato alla complessità delle cose», o anche soltanto «paragonato alla nostra coscienza», e che esso non può assolutamente pretendere di esaurire la realtà, contrariamente a ciò che si immagina –: insomma, si potrebbe interpretare l’Aleph, questa tipica, suggestiva invenzione borgesiana, come l’universo prima del Big Bang o come una sua mise en abîme.
Aleph, ricordiamolo, è la prima lettera dell’alfabeto ebraico, l’Alif in arabo, l’Alfa in greco, la lettera A del nostro alfabeto latino: è il principio, si potrebbe interpretare, di tutto il dicibile e soprattutto dell’indicibile – se, come dice Borges, «il linguaggio è molto povero paragonato alla complessità delle cose», o anche soltanto «paragonato alla nostra coscienza», e che esso non può assolutamente pretendere di esaurire la realtà, contrariamente a ciò che si immagina –: insomma, si potrebbe interpretare l’Aleph, questa tipica, suggestiva invenzione borgesiana, come l’universo prima del Big Bang o come una sua mise en abîme.
Concezione del mondo e della vita
Alla base della concezione del mondo di Borges vi è l’opera di Arthur Schopenhauer (e, in secondo piano, quella di Swedenborg) che, dice, passò la vita a rileggere nel tedesco imparato a Ginevra, lingua che non avrebbe voluto dimenticare e che continuava ad esercitare proprio per poter leggere Schopenhauer nella versione originale, mentre di altre opere, come La divina commedia, per esempio, di cui aveva in casa dieci o dodici edizioni, fra le quali quella tradotta da Longfellow, o Le mille e una notte, di cui aveva letto sei o sette versioni, o l’Odissea, riteneva invece che il fatto di non conoscere le lingue in cui erano state scritte poteva essere un vantaggio in quanto consentiva di conoscere più versioni dello stesso testo. Ma si tratta, in questo secondo caso, di letteratura, non di filosofia.
Dell’universo, nel cui mistero egli ha cercato incessantemente di penetrare nel corso della sua lunga vita, Borges dice che non sappiamo nemmeno se sia cosmo o caos: «Un certo ordine insomma c’è – ammette – solo è un ordine piuttosto riservato, per così dire, un ordine segreto». Comunque sia, basta dargli un’occhiata, dice, «per rendersi conto che non vi regna certo la giustizia», né che abbia uno scopo finale; quanto al cosiddetto «altro mondo potrebbe non essere che una bella invenzione umana», afferma scetticamente, come il suo maestro Schopenhauer, il quale riteneva il cristianesimo soltanto “una favola ebraica”. Non sappiamo neppure se «l’universo appartiene al genere realistico o fantastico», dice inoltre da scrittore qual è, «perché se, come credono gli idealisti, tutto è sogno, allora ciò che chiamiamo realtà è essenzialmente onirico», come sosteneva ancora Schopenhauer stesso, sulla scia di Platone, parlando «dell’essenza di sogno di cui è fatta la vita»; e Borges ammette di arrivare a credere che per lui «l’espressione ‘la vita è sogno’ sia esattamente reale». La questione, semmai, prosegue nella sua congettura,
«è se ci sia un sognatore o se non si tratti, come dire, di un sognarsi. Cioè, se esista un sogno che sogna se stesso… forse il sogno è qualcosa d’impersonale, come la pioggia o la neve, come il mutare delle stagioni. Qualcosa che accade insomma, ma non che accade a qualcuno; questo significa che non c’è Dio ma c’è un vasto sogno che possiamo chiamare Dio, se vogliamo. La differenza dev’essere questa, mi pare».
Insomma per concludere su questo punto, Borges non è neanche sicuro che sia possibile anche solo avvicinarsi alla verità e, come il Socrate morente (raccontatoci da Platone nel Fedone), che ricordava al suo discepolo Critone di non dimenticare di offrire dopo la sua morte, secondo l’usanza, un gallo ad Asclepio per ringraziarlo di essere guarito dalla malattia della vita, egli sentiva, dice, «una certa impazienza» di risvegliarsi anche lui da questo “sogno”, sembrandogli che nel suo caso fosse durato già troppo, e con la «grande curiosità» che inoltre provava per questo «viaggio più lungo di ogni altro», confidava al suo interlocutore delle Conversazioni che vivere ancora «altri dieci anni» sarebbe stata per lui “una disgrazia”: «io spero di morire da un momento all’altro – dice candidamente – ci si stanca di vivere, sa».
Eppure Borges sembra avere amato molto questa vita di cui dice di essersi stancato e, come il Chesterton che cita, crede che «lo stesso fatto di stare ritti sulla terra, di vedere il cielo, d’essere stati innamorati, è aver ricevuto doni per i quali non si può cessare di essere grati». Anch’egli, dice, cerca di sentire in questo modo: «che si dovrebbe essere grati di tutto»; e persino la cecità che l’ha colpito, non la ritiene soltanto una disgrazia, ma, dice sorprendentemente, essa è «anche qualcosa che mi permette, mi facilita la solitudine, il pensare, l’invenzione di favole, la costruzione di poesie. E tutto questo è un bene. Ricordo quanto si dice del greco Democrito, che si strappò gli occhi perché la contemplazione del mondo esterno non lo distraesse. Ebbene, in una poesia ho detto: ‘ Il tempo è stato il mio Democrito’. È vero, sono cieco, ma forse questo non è solo tristezza».
Come gli stoici (ma già lo stesso Democrito lo pensava), Borges crede che la serenità sia il massimo bene raggiungibile nella vita umana e da quello che dice nelle sue conversazioni pare che, soprattutto in vecchiaia, essa non sia stata affatto assente dalla sua vita. Ma a differenza di Democrito – ed è sintomatico di quest’uomo (e della sua vita) che dice di aver perduto verso i cinquantacinque anni la sua “vista di lettore” – egli, confessa: «mi basta pensare ai libri, così vicini e così lontani da me, per desiderare di vedere. Arrivo a pensare che se riacquistassi la vista non uscirei di casa e mi metterei a leggere tutti i libri che ho qui e che conosco appena, quantunque li conosca attraverso la memoria, che modifica le cose». Una concezione simile, di una vita “consacrata” ai distinti piaceri della scrittura e della lettura, ossia, in generale, di una vita in cui prevale l’attività o la contemplazione artistica, ricordiamolo, rientra ancora una volta nella visione schopenhaueriana dell’universo, come uno dei due soli modi per sfuggire al dolore causato dalla cieca volontà, la seconda via di evasione essendo, com’è noto, la noluntas, ossia il rifiuto di ogni forma di vita attiva, come suggeriscono gli antichi testi indiani e il buddhismo.
Pur restando, come si è visto, ben all’interno della visione filosofica di Schopenhauer, da altri scrittori britannici, di cui era specialista, come abbiamo detto, Borges attinge una serie di concezioni che ci introducono alla sua idea dell’arte, della letteratura e dello scrittore. Da Thomas Carlyle, un altro calvinista che crede nella predestinazione, egli prende l’immagine secondo la quale, recita:
«la storia universale è un libro che siamo obbligati a leggere e a scrivere incessantemente e nel quale anche noi siamo scritti»;
ossia, commenta Borges, «non soltanto lo scriviamo e leggiamo, ma siamo noi stessi lettere di quel testo, giacché ciascuno di noi, per quanto modesto, fa parte della vasta criptografia che si chiama la storia universale».
Da William Butler Yeats, attinge la dottrina della “grande memoria”, ossia, che
«un poeta eredita la memoria dei padri, degli avi. Moltiplicando il fenomeno in progressione geometrica, possiamo dire che il poeta eredita la memoria dell’umanità, che gli viene rivelata»;
un concetto, questo, come si vede, non lontano da quello dell’inconscio collettivo junghiano, cui però Borges non accorda troppo credito, insieme alla psicanalisi freudiana, del resto, che rifiuta esplicitamente, quasi con disprezzo: cosa questa, si può facilmente supporre, che Freud non avrebbe mancato di mettere in relazione col fatto che il padre di Borges fosse un professore di psicologia.
Da Oscar Wilde, uno dei suoi scrittori preferiti, infine, prende l’idea, simile a quella dell’Aleph, che: «ogni uomo è, in ogni istante della sua vita, tutto ciò che è stato e tutto ciò che sarà».
Tuttavia, paradossalmente, Borges ritiene che se «forse il futuro è irrevocabile», non lo è però il passato, «giacché – dice – ogni volta che ricordiamo qualcosa lo modifichiamo, per povertà o ricchezza della nostra memoria, secondo come lo si voglia vedere». In ogni caso, e questa mi pare una delle più belle conclusioni a cui giunge, egli pensa che un vero poeta dovrebbe sentire «ogni istante della vita come poetico. Perché è un errore supporre che ci siano temi o momenti poetici: tutti i temi possono essere poetici […] tutto sta a vedere il quotidiano come poetico». E ciò, a suo avviso, fu dimostrato meglio di tutti dal Walt Whitman che si paragonò ad Adamo “di primo mattino”, il primo uomo nella sua scoperta del mondo e della vita.
L’arte, la letteratura e lo scrittore
“Art happens”, sostiene anch’egli Borges, citando il pittore statunitense James Abbot Whistler, «l’arte succede – spiega – accade, cioè l’arte è un piccolo miracolo che sfugge, in qualche modo, all’organizzata causalità della storia. Sì, l’arte accade – o non accade: questo non dipende dall’artista», e quale finalità potrebbe avere l’arte, risponde, se non la bellezza?
 E la letteratura universale, com’è noto, egli la concepisce, attraverso una delle sue tipiche immagini (La biblioteca di Babele è il titolo di un suo famoso racconto su questo tema), come una biblioteca infinita che abbraccia l’intero universo, ricordando stranamente con ciò, pur nella differenza dell’immagine, il Galileo che concepiva invece l’universo come un solo libro la cui lingua era la matematica, sulla scia, ancora una volta, di un greco, Pitagora, per il quale i numeri sono il principio di ogni cosa. Tuttavia, per infinita che sia la letteratura, o le possibili variazioni sugli stessi argomenti – come nella scultura, per esempio, le infinite statue equestri o in pittura le infinite vergini col bambino e le infinite crocefissioni – Borges ritiene che i suoi temi siano limitati:
E la letteratura universale, com’è noto, egli la concepisce, attraverso una delle sue tipiche immagini (La biblioteca di Babele è il titolo di un suo famoso racconto su questo tema), come una biblioteca infinita che abbraccia l’intero universo, ricordando stranamente con ciò, pur nella differenza dell’immagine, il Galileo che concepiva invece l’universo come un solo libro la cui lingua era la matematica, sulla scia, ancora una volta, di un greco, Pitagora, per il quale i numeri sono il principio di ogni cosa. Tuttavia, per infinita che sia la letteratura, o le possibili variazioni sugli stessi argomenti – come nella scultura, per esempio, le infinite statue equestri o in pittura le infinite vergini col bambino e le infinite crocefissioni – Borges ritiene che i suoi temi siano limitati:
«Ho pensato con frequenza che i temi della letteratura in fondo sono scarsi e che ogni generazione tenta leggere varianti, che ogni generazione riscrive nel dialetto della sua epoca quello che è stato scritto. E che ci sono, sì, piccole differenze ma queste assai importanti, almeno per noi […] forse la letteratura ripete sempre le stesse cose con un’accentuazione, una modulazione leggermente diversa. […] forse la letteratura è solo una serie di variazioni su pochi temi essenziali. Uno di questi temi, per esempio, sarebbe quello del ritorno, e l’esempio classico sarebbe l’Odissea».
E, possiamo aggiungere continuando la sua ipotesi, il massimo esempio delle innumerevoli variazioni contemporanee su questo tema sarebbe naturalmente l’Ulysses di James Joyce, la cui opera Borges definisce come «l’opera massima dell’espressionismo» (a sua volta definito come «il movimento estetico più importante» del Novecento, «molto più interessante del surrealismo o del cubismo, del futurismo, dell’imagismo» perché fu «una specie di rinnovamento totale delle lettere»), una straordinaria variazione, quella di Joyce, com’è noto, che riuscì a riscrivere genialmente i dieci anni dell’Odissea condensandoli tutti in una sola giornata dublinese.
Analogamente, Borges ritiene che l’universo personale di ogni scrittore sia abbastanza limitato, come dimostra, per esempio, nel caso della sua propria opera, la ricorrenza di alcuni temi specifici come tigri, labirinti, specchi e armi bianche. Ora, questi temi, egli sostiene, non è stato lui a sceglierli, ma, paradossalmente, sono stati questi temi stessi ad aver scelto lui, attraverso il sogno o, meglio, degli incubi ricorrenti. Sicché, dice, «uno scrittore deve lasciare che siano i temi a cercarlo, al principio anzi deve respingerli; poi, rassegnato, potrà scriverli per passare ad altri». Egli concepisce così il lavoro del narratore o del poeta (e poco importa la distinzione per lui, perché come Croce – da lui ritenuto come colui che «ha scritto forse più acutamente sull’estetica», e con il quale condivideva oltre al rifiuto della psicanalisi, una stoica morale laica – , Borges non distingueva la realizzazione dell’ispirazione poetica in una forma prosastica o in versi, dicendo di non sapere se ci fosse «una differenza essenziale tra la poesia e la prosa»), diciamo perciò che, quello dello scrittore, egli lo concepisce come un lavoro, afferma, sostanzialmente «di natura passiva; si ricevono doni misteriosi e poi si cerca di dar loro una forma, ma si comincia sempre da qualcosa che non siamo noi, qualcosa che gli antichi chiamavano la musa, gli ebrei lo spirito [e ad essi, quando poco dopo questa conversazione l’avrebbe scoperto, cominciando a studiarne la lingua e la letteratura, assocerà i giapponesi], e Yeats la grande memoria. La nostra mitologia contemporanea preferisce nomi meno belli, come la subcoscienza, il subcosciente collettivo e via dicendo, ma è sempre la stessa cosa – sostiene – si tratta sempre di qualcosa che sta al di fuori di noi».
Così, con questa visione della creazione letteraria, Borges poteva rispondere al suo interlocutore che gli chiedeva su che cosa stesse lavorando in quel momento, che stava scrivendo «un libro in versi» il cui titolo, confessa, «non m’è stato ancora rivelato»; e poi un libro di racconti fantastici, La memoria di Shakespeare, il cui racconto eponimo, dice, «mi fu rivelato da una frase di un personaggio di un sogno». La scrittura di Borges comincia perciò «con una specie di rivelazione. Uso questa parola in modo modesto, non presuntuoso –precisa – Qualcosa insomma mi viene dato; poi intervengo io, e forse a questo punto si rovina tutto…».
“Reality stranger than fiction”, ricorda ancora Borges a proposito del «qualcosa che sta al di fuori di noi» e che determina, secondo lui, la creazione letteraria; e non bisogna dimenticare, per capire bene la sua visione, che per lui, letteralmente, “la vita è sogno”, e cioè, “la realtà è sogno”, un sogno che alcuni, dice, ritengono di chiamare “Dio”. A questo detto anonimo Borges fa seguire poi il commento esplicativo che ne fece Chesterton, e che egli ammette di condividere, credendo nella sua giustezza: «la realtà è più strana della finzione» perché, spiega: «la finzione la creiamo noi, mentre la realtà è molto più strana perché la crea un altro, l’Altro: Dio».
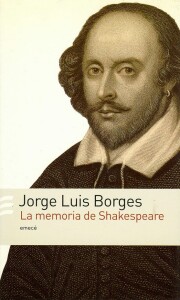 Non soltanto per Borges la vita è un sogno, dunque, come abbiamo visto, nel senso profondo, filosofico, platonico (un concetto ripreso poi, oltre che dalla filosofia idealistica, anche da Schopenhauer), più che in quello di Calderon de la Barca che, come lui, da artista, non fece altro che applicare, elaborandolo letterariamente, quel concetto nella sua celebre opera omonima, ma egli ritiene inoltre che i nostri sogni, quelli propriamente detti, «fan parte della realtà e possono intervenire in essa», e che, in particolare, l’atto dello scrivere possa essere identificato con quello di sognare (come sostiene peraltro anche Freud). A questo proposito egli ricorda un passo di Allison, pubblicato nello “Spectator”, intorno alla metà del Settecento (ma l’idea si trova già in Góngora), «nel quale si dice che quando sogniamo siamo insieme il teatro, gli attori, il dramma e l’autore. […] Ora, se davvero il sogno fosse una sorta di rappresentazione drammatica – ne conclude Borges – si avrebbe che esso è il più antico dei generi letterari; anteriore alla stessa umanità, giacché – come ricorda un poeta latino – anche gli animali sognano. Sarebbe un evento d’indole drammatica, un dramma nel quale si è autori, attori, e lo stesso teatro. Dunque di notte tutti in certo modo siamo drammaturghi». E a questo possiamo ancora aggiungere che, per via dello sdoppiamento, ma anche nel caso in cui non sogniamo noi stessi, ci si può immaginare anche come spettatori.
Non soltanto per Borges la vita è un sogno, dunque, come abbiamo visto, nel senso profondo, filosofico, platonico (un concetto ripreso poi, oltre che dalla filosofia idealistica, anche da Schopenhauer), più che in quello di Calderon de la Barca che, come lui, da artista, non fece altro che applicare, elaborandolo letterariamente, quel concetto nella sua celebre opera omonima, ma egli ritiene inoltre che i nostri sogni, quelli propriamente detti, «fan parte della realtà e possono intervenire in essa», e che, in particolare, l’atto dello scrivere possa essere identificato con quello di sognare (come sostiene peraltro anche Freud). A questo proposito egli ricorda un passo di Allison, pubblicato nello “Spectator”, intorno alla metà del Settecento (ma l’idea si trova già in Góngora), «nel quale si dice che quando sogniamo siamo insieme il teatro, gli attori, il dramma e l’autore. […] Ora, se davvero il sogno fosse una sorta di rappresentazione drammatica – ne conclude Borges – si avrebbe che esso è il più antico dei generi letterari; anteriore alla stessa umanità, giacché – come ricorda un poeta latino – anche gli animali sognano. Sarebbe un evento d’indole drammatica, un dramma nel quale si è autori, attori, e lo stesso teatro. Dunque di notte tutti in certo modo siamo drammaturghi». E a questo possiamo ancora aggiungere che, per via dello sdoppiamento, ma anche nel caso in cui non sogniamo noi stessi, ci si può immaginare anche come spettatori.
Non soltanto ogni uomo ha evidentemente «la capacità estetica, e precisamente drammatica, che richiede il sognare», dichiara inoltre Borges introducendo un altro sorprendente aspetto della sua visione della creazione letteraria, ma egli ha anche osservato, dice, «che la gente è sempre capace di frasi poetiche di cui non si rende conto». E ci racconta, per esempio, una conversazione udita un giorno in casa propria fra sua madre, che commentava la recente morte di una giovane parente, e la cuoca.
«E la cuoca disse, senza sapere che la frase era letteratura: “Ma signora, per morire bisogna solo esser vivi”. Bisogna solo… Non si rese conto che la frase era memorabile. Io la usai in seguito in un racconto. “Non occorre altro che esser vivi”: non occorre, poiché per la morte non occorre altro, questa di esser vivi è l’unica condizione richiesta. Credo che la gente usi continuamente frasi memorabili senza accorgersene. E forse la funzione dell’artista è di raccogliere queste frasi e tramandarle. […] diciamo un amanuense degli altri, un amanuense di tanti maestri. Forse l’importante è essere l’amanuense, non il creatore della frase».
Come si vede, insomma, in tutti e tre i casi, sia nella riscrittura di opere del passato («plagiare – riferisce Borges – è quello che ho sempre fatto»; ed egli ricorda inoltre che fino al Seicento «non si considerava il fatto di trasportare un verso dal latino a una lingua moderna un plagio, come ora si dice»), sia nell’ambito dell’ispirazione ricevuta nel sogno (quello propriamente detto o quello del quale, secondo lui, è fatta la vita), sia nella trascrizione di ciò che di poetico gli capita di udire, l’artista, nella visione estetica borgesiana, è sempre un amanuense, in certo modo, un semplice strumento passivo, e così difatti egli si descrive:
«io penso che il mio dovere di scrittore non è di scoprire temi nuovi né di inventare niente; debbo ripetere nel dialetto, diciamo così, del mio paese e della mia epoca certe poesie che si son sempre venute ripetendo con lievi variazioni che possono o no essere belle».
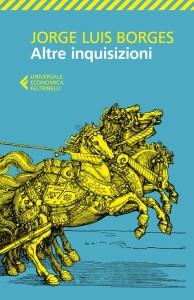 Ma la scrittura, come la lettura, e come in generale ogni altra produzione o fruizione estetica, è pur sempre una “passività” che può offrire un grande piacere e a volte anche gioia a chi la pratica: «Io a volte mi sento misteriosamente grato – confessa infatti Borges – Questo accade soprattutto quando mi sorprende la prima idea di qualcosa che poi sarà un racconto o una poesia; ho la sensazione che qualcosa mi sia data. Ma non so se questa cosa me la dà qualcosa o qualcuno, o se non sorga da me stesso». L’Altro, dunque, come si diceva più sopra, e comunque sia, qualunque cosa sia quest’Altro che ispira l’artista – la musa, lo spirito, la grande memoria, l’inconscio collettivo o individuale, o persino, perché no?, la stessa cieca volontà schopenhaueriana della Natura –, l’arte e la letteratura, oltre ad esprimere bellezza (trasmettendo con ciò, secondo Platone, una verità ultraterrena, «una rivelazione di ciò che oltrepassa i nostri sensi», dice Borges approvando), dovrebbero inoltre, sempre secondo Borges, cercare di liberarsi dal tempo, che è forse la principale delle ossessioni borgesiane, la condizione indispensabile, questa, per cui un’opera possa diventare classica nel senso particolare e nuovo che egli dà a questo concetto nell’ambito della sua visione della letteratura.
Ma la scrittura, come la lettura, e come in generale ogni altra produzione o fruizione estetica, è pur sempre una “passività” che può offrire un grande piacere e a volte anche gioia a chi la pratica: «Io a volte mi sento misteriosamente grato – confessa infatti Borges – Questo accade soprattutto quando mi sorprende la prima idea di qualcosa che poi sarà un racconto o una poesia; ho la sensazione che qualcosa mi sia data. Ma non so se questa cosa me la dà qualcosa o qualcuno, o se non sorga da me stesso». L’Altro, dunque, come si diceva più sopra, e comunque sia, qualunque cosa sia quest’Altro che ispira l’artista – la musa, lo spirito, la grande memoria, l’inconscio collettivo o individuale, o persino, perché no?, la stessa cieca volontà schopenhaueriana della Natura –, l’arte e la letteratura, oltre ad esprimere bellezza (trasmettendo con ciò, secondo Platone, una verità ultraterrena, «una rivelazione di ciò che oltrepassa i nostri sensi», dice Borges approvando), dovrebbero inoltre, sempre secondo Borges, cercare di liberarsi dal tempo, che è forse la principale delle ossessioni borgesiane, la condizione indispensabile, questa, per cui un’opera possa diventare classica nel senso particolare e nuovo che egli dà a questo concetto nell’ambito della sua visione della letteratura.
Ora, il migliore esempio contemporaneo di ciò che sostiene, l’abolizione del tempo nell’arte e nella letteratura, Borges lo trova nell’opera di Franz Kafka, che, secondo lui, può essere letta «astraendo dalle sue circostanze storiche», ossia, la Prima guerra mondiale e l’antisemitismo, cose che, ritiene, si sarebbero dovute riflettere nella sua opera, ma «se il lettore non lo sapesse non se ne avvedrebbe, poiché tutto fu tramutato da Kafka». A differenza di Joyce, che non fece parte del movimento, Kafka fu amico personale degli espressionisti e pubblicò alcuni suoi testi nelle loro riviste, alle quali Borges adolescente, nel 1916 o 1917 era abbonato; e fu proprio su una di quelle riviste, ricorda, che lesse per la prima volta un testo di Kafka.
«Ebbene, non avvertii niente – racconta – mi parve solo una cosa quieta, un po’ incolore, circondato com’ero da ogni sorta di splendori verbali degli espressionisti. Niente delle sue circostanze dunque affiora nella sua opera; Kafka sarebbe perciò il grande scrittore classico di questo nostro secolo tormentato. E forse sarà letto in futuro e non si saprà con certezza che scrisse all’inizio del secolo Ventesimo, che fu contemporaneo dell’espressionismo e della Prima guerra mondiale. Tutto questo può essere dimenticato: la sua opera potrebbe essere anonima, e forse col tempo meriterà di esserlo. È il massimo cui un’opera può aspirare, e che pochi libri raggiungono».
Perché questo punto finale della particolare visione estetica borgesiana – il culmine cui un’opera letteraria possa giungere trasformandosi paradossalmente in un’opera anonima – sia ancora più chiaro, occorre citare il nostro autore un po’ più a lungo su questo concetto:
«Quando si legge Le mille e una notte, si accetta l’Islam. Si accetta tutto, si accettano quelle fiabe ordite da generazioni come se fossero di un solo autore, o meglio come se non avessero autore. E in realtà l’hanno e non l’hanno, giacché un’opera tanto lavorata, tanto limata dalle generazioni, non appartiene più ad alcun individuo. Ora, nel caso di Kafka, è possibile che i suoi racconti facciano ormai parte della memoria umana. E potrebbe succedere ad essi quello che potrebbe succedere al Don Chisciotte per esempio: potrebbero perdersi tutti gli esemplari del Don Chisciotte, in spagnolo e nelle traduzioni; potrebbero perdersi tutti fino all’ultimo, ma la figura di don Chisciotte resterebbe a far parte della memoria dell’umanità. Quell’idea di un processo terribile, che va crescendo, infinito, che è la base dei suoi romanzi, che Kafka non volle pubblicare perché sapeva che erano incompiuti, che avevano il dovere di essere finiti… Il castello, Il processo, fan parte della memoria dell’uomo, possono essere riscritti con diversi nomi, con circostanze diverse; ormai l’opera di Kafka fa parte della memoria dell’umanità».
In conclusione, vi è, come si visto, nella teoria della letteratura di Borges, la presenza di alcuni ingredienti, per così dire, ormai “istituzionali”, occidentali, come, per esempio, il formalismo di chiara derivazione proppiana relativo alla limitatezza dei temi letterari e alle potenzialmente infinite variazioni su di essi, benché, naturalmente, non siano espressi con lo stesso rigore; ma vi sono anche ingredienti nuovi, si potrebbe dire non “accademicamente corretti”, che rendono questa visione così particolarmente suggestiva. Estrapolando un’ultima volta da questi ultimi nuovi ingredienti, che mi paiono perlopiù di origine orientale, vediamo di aggiungere qualcosa che potrebbe ulteriormente chiarire questo sorprendente nesso fra la classicità di un’opera letteraria, come è intesa da Borges in questa sua nuova accezione, e anonimato. Vi è poi in queste Conversazioni un’altra concezione dei classici, antichi e moderni, sostanzialmente tradizionale questa volta, perfettamente nominativa, di cui, anche, Borges tratta in una specifica trasmissione, e perciò non ce ne occuperemo qui.
Per ritornare alla questione dell’identità, con la quale abbiamo cominciato il nostro discorso, «se siamo qualcosa – sostiene Borges – siamo il nostro passato. […] Il nostro passato è la nostra memoria». E altrove dice che «il tempo è più reale di noi. Si potrebbe anche dire […] che la nostra sostanza è il tempo, che siamo fatti di tempo», ed egli ritiene che sia «un’ambizione dell’uomo […] l’idea di vivere fuori dal tempo», il che corrisponderebbe all’eternità, cosa che sorprendentemente afferma di aver sperimentato due volte in vita sua, «ma può essere stata una mia illusione – aggiunge – Non so quanto a lungo sia durata quell’esperienza, appunto perché ero fuori del tempo. E non posso neanche comunicarla, solo dire che fu molto bella».
Ora, questo annullamento dell’identità dello scrittore, poeta o narratore che sia, della sua memoria individuale, nel momento in cui la sua opera, liberatasi dal tempo e divenuta anonima entra nella grande memoria dell’umanità, questa nuova e originale versione della classicità letteraria universale suggeritaci da Borges, non mi sembra lontana da una delle tipiche immagini simboliche dell’esistenza umana presenti negli antichi testi religiosi indiani, quella, per esempio, delle acque di un torrente che si gettano, sparendo, nell’oceano, o dal concetto del nadir buddhista che tende al vuoto o al nulla come suo fine. Sicché il fatto di abolire il tempo nella propria opera significherebbe in sostanza annullare sé stessi per entrare anonimamente nell’immortalità della memoria dell’umanità.
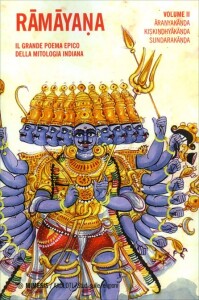 Occorre dire che Borges non si limitò alla religione e alla cultura indiana e al buddhismo che trovò nell’opera di Schopenhauer, ma approfondì la sua conoscenza dell’una (ancora in queste conversazioni dice che stava cercando qualcuno che gli potesse leggere un libro in tedesco sul Ramayana in due volumi) e dell’altro fino a scrivere su quest’ultimo un libro («di seconda o terza mano – afferma con la solita modestia – ma onestamente»), insieme a una collaboratrice, dal titolo Che cos’è il buddhismo, libro che fu addirittura tradotto in giapponese, cosa che egli così commenta con il suo tipico umorismo: «forse per dimostrare che noi occidentali non sappiamo niente di buddhismo». L’Oriente, in realtà, osserva Borges, «mi ha sempre interessato, fin da Le mille e una notte e dalla lettura di una poesia di Arnold sulla leggenda del Buddha». Direi dunque, concludendo su questo punto, che l’originalità della visione borgesiana della letteratura derivi proprio dal sincretismo cui abbiamo accennato, fra elementi occidentali e orientali, sul modello della filosofia di Schopenhauer, e che ritroveremo inoltre nella sua più generale concezione della cultura.
Occorre dire che Borges non si limitò alla religione e alla cultura indiana e al buddhismo che trovò nell’opera di Schopenhauer, ma approfondì la sua conoscenza dell’una (ancora in queste conversazioni dice che stava cercando qualcuno che gli potesse leggere un libro in tedesco sul Ramayana in due volumi) e dell’altro fino a scrivere su quest’ultimo un libro («di seconda o terza mano – afferma con la solita modestia – ma onestamente»), insieme a una collaboratrice, dal titolo Che cos’è il buddhismo, libro che fu addirittura tradotto in giapponese, cosa che egli così commenta con il suo tipico umorismo: «forse per dimostrare che noi occidentali non sappiamo niente di buddhismo». L’Oriente, in realtà, osserva Borges, «mi ha sempre interessato, fin da Le mille e una notte e dalla lettura di una poesia di Arnold sulla leggenda del Buddha». Direi dunque, concludendo su questo punto, che l’originalità della visione borgesiana della letteratura derivi proprio dal sincretismo cui abbiamo accennato, fra elementi occidentali e orientali, sul modello della filosofia di Schopenhauer, e che ritroveremo inoltre nella sua più generale concezione della cultura.
La cultura e la morale
Anche se l’universo e la storia non sembrano avere uno scopo, un’intenzione precisa e tanto meno un fine morale, Borges pensa che l’uomo debba sforzarsi di crederci, e non solo in un fine morale, ma anche in un fine estetico. Più precisamente egli vuole credere in «un’intenzione morale […] di ognuno di noi. E così fosse possibile aggiungere, come diceva William Blake, anche un’intenzione estetica: questo riferito agli individui, naturalmente». La sua fede nella cultura si giustifica con il fatto, afferma Borges solennemente, che essa è «la sola salvezza che abbiamo», a condizione però che sia associata alla morale e, come Kant, egli ritiene che avere un’etica sia più importante che avere una religione. L’etica è per lui “un istinto” presente in ogni uomo, mentre la religione, precisa, «si giustifica solo in relazione all’etica». A differenza della religione, ritiene che
«L’etica non occorre definirla; non consiste nei dieci comandamenti, è qualcosa che sentiamo quando operiamo. In capo a una giornata avremo preso senza dubbio molte decisioni morali; avremo dovuto scegliere – semplificando il tema – tra il bene e il male. E quando abbiamo scelto il bene, sappiamo di averlo scelto, e così quando scegliamo il male».
Un altro dovere dell’uomo, secondo Borges, e questo in un momento in cui, notava, «dappertutto prospera il nazionalismo», è di «realizzare, per quanto possibile, l’antico sogno greco di essere ‘cosmopoliti’, cioè cittadini del mondo», un sogno che così commenta:
«Dev’essere stato non poco paradossale quando fu detto, giacché i greci erano definiti dalla loro città natale: Talete di Mileto, Eraclito d’Efeso, Zenone d’Elea. Il salto è paradossale, tra il dire: sono cittadino – la città è una misura già più esigua rispetto a una nazione – e: sono cittadino del mondo, cosmopolita. Oggi dicendo cosmopolita pensiamo a un turista, a chi frequenta gli alberghi internazionali. Ma l’idea non è questa; l’idea è – come disse Goethe, che la tradusse in tedesco – quella di essere Weltbürger, cittadini del mondo, il che significa sentire che tutte le città sono la nostra patria, e io credo di essere arrivato a questo».
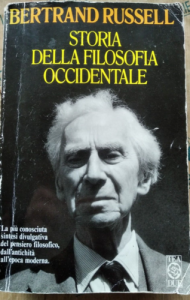 Abbiamo visto come ciò gli fu facilitato dalla sua stessa biografia, ma una tale evoluzione dell’umanità – nel senso concreto indicato, per esempio, dal Tribunale Russell per i crimini di guerra americani nel Vietnam (tuttora impuniti, ricordiamolo, come l’apartheid in Israele e la sua occupazione della Palestina, condannata dal mondo intero e sostenuta dai soli Stati Uniti, come, del resto, quella della Cecenia da parte dei russi, o del Tibet da parte dei cinesi, ecc., giusto per citare le tre principali potenze mondiali e la remora sionista – nell’accezione specificamente ittiologica del termine remora – della prima) o, più in generale, nel senso indicato da Amnesty International – purtroppo, non è ancora oggi molto comune, anzi, com’egli notava in seguito ai suoi frequenti viaggi degli ultimi anni della sua vita, come già si è detto, è ancora il nazionalismo a prosperare ovunque nel mondo, non solo, ma prosperano addirittura ancora più ridicole forme di reazionario regionalismo politico e di altrettanto ottuso e sanguinario settarismo religioso, come attualmente, in particolare, nel mondo musulmano, nonché, ancora, conflitti interreligiosi, dall’Indonesia e le Filippine alla Nigeria, per non parlare di quelli, innumerevoli, fra vere o false etnie in tutti i continenti.
Abbiamo visto come ciò gli fu facilitato dalla sua stessa biografia, ma una tale evoluzione dell’umanità – nel senso concreto indicato, per esempio, dal Tribunale Russell per i crimini di guerra americani nel Vietnam (tuttora impuniti, ricordiamolo, come l’apartheid in Israele e la sua occupazione della Palestina, condannata dal mondo intero e sostenuta dai soli Stati Uniti, come, del resto, quella della Cecenia da parte dei russi, o del Tibet da parte dei cinesi, ecc., giusto per citare le tre principali potenze mondiali e la remora sionista – nell’accezione specificamente ittiologica del termine remora – della prima) o, più in generale, nel senso indicato da Amnesty International – purtroppo, non è ancora oggi molto comune, anzi, com’egli notava in seguito ai suoi frequenti viaggi degli ultimi anni della sua vita, come già si è detto, è ancora il nazionalismo a prosperare ovunque nel mondo, non solo, ma prosperano addirittura ancora più ridicole forme di reazionario regionalismo politico e di altrettanto ottuso e sanguinario settarismo religioso, come attualmente, in particolare, nel mondo musulmano, nonché, ancora, conflitti interreligiosi, dall’Indonesia e le Filippine alla Nigeria, per non parlare di quelli, innumerevoli, fra vere o false etnie in tutti i continenti.
Tuttavia, sulla scia dello storico inglese Arnold Toynbee che considerava uno degli avvenimenti più importanti del Ventesimo secolo l’arrivo del buddhismo in Occidente, Borges ritiene che un giorno dimenticheremo di essere occidentali o orientali e che si sarà tutti uniti. Ora è vero che dal tempo in cui queste conversazioni ebbero luogo (1984) l’Europa dell’est non è più comunista e persino la Cina ancora comunista pare essersi convertita anch’essa, come l’Europa dell’est, al capitalismo, facendo così il suo ingresso nel grande mercato mondiale comune, ma non è certamente questa l’idea di unione fra Oriente e Occidente a cui Borges pensava. E, en passant, si può notare che se la storia, come Borges ritiene, non ha uno scopo, essa sembra tuttavia avere un’evidente ironia, come dimostrano le preoccupazioni di certi gruppi industriali occidentali, la cui produzione è stata delocalizzata nella Cina comunista, di veder boicottare i propri prodotti dai consumatori americani ed europei per protesta contro l’ignominioso sfruttamento del lavoro infantile in quelle fabbriche, e – l’avrebbe mai creduto Karl Marx? – questi stessi capitalisti occidentali sono costretti a far pressioni sui dirigenti comunisti cinesi affinché assicurino condizioni più umane ai loro lavoratori, possibilmente adulti, come se si fosse nella stessa Inghilterra del Sette-Ottocento studiata da Marx.
All’inizio del Novecento Borges ricorda che gli intellettuali argentini conoscevano tutti il francese, «non tanto da arrivare a parlarlo ma, cosa più importante – afferma – tutti potevano gustare direttamente la letteratura francese»; e gli rincresce molto che ora (ossia, già trent’anni fa), lo studio del francese sia stato sostituito da quello dell’inglese (e non solo in Argentina, possiamo aggiungere, ma nel mondo intero, perfino nella confinante Italia), benché l’inglese sia una lingua che egli confessa di amare molto e a cui personalmente deve di più che al francese. Ritiene questo fatto “deplorabile”, «perché il francese si studiava pensando alla cultura e alla letteratura francese, mentre ora l’inglese si studia non pensando a Emerson o a De Quincey, ma pensando agli affari, all’economia; lo si studia a fini commerciali. Sicché non so se si sia veramente passati da una lingua all’altra», e teme che il prossimo passo possa essere quello di passare «dall’inglese all’ignoranza».
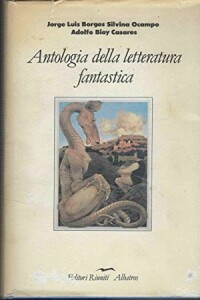 L’impegno dell’uomo di oggi, perciò, secondo Borges, è quello di opporre alla nuova barbarie del villaggio globale commerciale terrestre, o ad altre barbarie ancora peggiori, come quelle totalitarie, i valori di una cultura universale associata alla morale, come già si è visto, ossia, aggiunge in seguito, all’intelligenza. Perché contrariamente a ciò che si crede generalmente, sostiene – come già Socrate e Platone lo avevano sostenuto – il male e la cattiveria degli uomini sono il frutto dell’ignoranza, della stupidità e anche dell’ingenuità, mentre occorre intelligenza e cultura per agire moralmente. «Insomma io identifico la malvagità con la stupidità e la bontà con l’intelligenza. Questo di norma non si fa; si suppone che le persone buone siano sciocche».
L’impegno dell’uomo di oggi, perciò, secondo Borges, è quello di opporre alla nuova barbarie del villaggio globale commerciale terrestre, o ad altre barbarie ancora peggiori, come quelle totalitarie, i valori di una cultura universale associata alla morale, come già si è visto, ossia, aggiunge in seguito, all’intelligenza. Perché contrariamente a ciò che si crede generalmente, sostiene – come già Socrate e Platone lo avevano sostenuto – il male e la cattiveria degli uomini sono il frutto dell’ignoranza, della stupidità e anche dell’ingenuità, mentre occorre intelligenza e cultura per agire moralmente. «Insomma io identifico la malvagità con la stupidità e la bontà con l’intelligenza. Questo di norma non si fa; si suppone che le persone buone siano sciocche».
La cultura non può essere intesa senza l’etica, ossia l’intelligenza, non si stanca di ripetere Borges nelle sue conversazioni: «mi sembra che una persona colta debba essere morale», «altrimenti a che cosa può servire la cultura? Alla crudeltà?»
Concludiamo con una specie di bilancio che Borges ci dà brevemente dell’attività della propria vita rispondendo alla seguente domanda del suo interlocutore: Di lei si dice che è ormai un classico vivente. Lei che ne pensa?
«Si tratta di un generoso errore. Comunque, ho trasmesso l’amore per i classici ad altri. […] E anche l’amore per qualche classico recente, un po’ dimenticato […] per esempio, ho diffuso l’amore per Stevenson, per Shaw, per Chesterton, per Mark Twain, per Emerson, e questo è forse l’essenziale di quella che è stata la mia opera: l’aver diffuso quest’amore. E anche aver insegnato, che non è una cattiva cosa».
Altrove in queste Conversazioni, Borges confessava un altro motivo di soddisfazione nella realizzazione, insieme ad Adolfo Bioy Casares, di un’Antologia della letteratura fantastica,
«che fu una cosa importante, mi sembra, per la lingua spagnola, giacché si pensava alla letteratura soprattutto sotto la specie del realismo, e quell’antologia della letteratura fantastica venne a essere una libertà di sognare offerta ai lettori. Perciò credo che quel libro sia il più importante pubblicato da noi; poi venne un secondo volume, altrettanto importante, e grazie ad essi si aprirono vaste possibilità che furono ottimamente utilizzate in seguito. Così credo che, se non altro per l’Antologia della letteratura fantastica, noi abbiamo avuto un’influenza sulle diverse letterature che si servono dello spagnolo. Siamo stati, insomma, benefici».
Ora, oltre a ricordare il grande piacere e un nuovo modo di percepire la realtà lasciati in eredità ai lettori di tutte le lingue del mondo dalla sua straordinaria narrativa e saggistica, che è evidentemente la vera parte più importante della sua opera, cui si aggiunge anche la poesia, per completare un poco di più il bilancio dato più sopra, nuove possibilità mi pare che Borges le abbia aperte, ancora una volta, con questa sua nuova e suggestiva concezione della letteratura di cui si è cercato di dare il contorno in queste pagine.
Dialoghi Mediterranei, n. 60, marzo 2023
[*] Trascrizione e rielaborazione di un intervento pronunciato all’Institut Supérieur des Sciences Humaines de Médenine il 1° marzo 2013 al colloquio intitolato Rethinking Identity
Note
[1] Questa, come la precedente citazione di Goethe, in Friedrich Nietzsche, Appunti filosofici 1867-1869, Adelphi, 1993
[2] Lo strano caso del Dr. Jekyll e del Sig. Hyde, Einaudi, 1983
[3] Nietzsche, Op. cit.
[4] Gallimard, 2002
[5] Qui ci si riferisce alla sua seconda edizione nei Tascabili Bompiani, 2000
[6] Mondadori, 1993
[7] Feltrinelli 1997
[8] Feltrinelli 1998
_____________________________________________________________
Giuseppe Pera, ha insegnato lingua, letteratura e civiltà italiana in varie università francesi e tunisine, nonché all’Università e all’Accademia di Belle Arti di Palermo. Ha pubblicato in francese Pier Paolo Pasolini, l’intellectuel: critique littéraire et écrits politiques (1940-1960), Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq 1999. Altri saggi: Terzo millennio; Dantes noster est!. Si è occupato anche di letteratura nordamericana con un saggio su Charles Bukowski.
______________________________________________________________