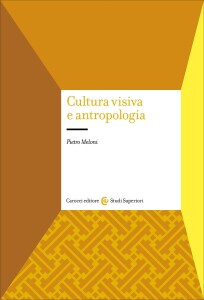Il recente libro di Pietro Meloni, Cultura visiva e antropologia (Roma, Carocci, 2023) si colloca in un robusto filone della produzione antropologica italiana – oltre che internazionale – degli ultimi vent’anni: la riflessione sulle immagini, intese nel duplice senso di fonti o risorse della ricerca e di suoi “oggetti”. Come altri contributi sul tema, anche quello di Meloni propone con lucidità la questione che mi preme di più discutere: la nostra disciplina è eccessivamente “logocentrica”? C’è una prevalenza del linguaggio rispetto alle immagini che ne impoverisce i risultati? C’è un autonomo potere conoscitivo delle immagini, una loro irriducibilità al linguaggio verbale, che andrebbe meglio riconosciuto e sfruttato?
 Prima di arrivare a questo, dirò intanto che il punto di forza e di originalità del libro sta proprio nel tentativo di tenere insieme l’analisi delle immagini come strumenti della ricerca e lo studio del ruolo che le immagini giocano nella cultura contemporanea – due aspetti che troppo spesso sono trattati separatamente. Da un lato, quindi, l’opera ripercorre la storia delle metodologie visuali della ricerca etnografica, come le fotografie, il cinema, i disegni o i grafici: è una storia ormai abbastanza nota, a partire dai precursori come Haddon, Malinowski e Boas, a Flaherty (l’autore di quel Nanook che è considerato il primo film etnografico in senso stretto), per arrivare a Rouch, a Mead e Bateson, al Bourdieu delle foto algerine; giungendo poi (forse con un salto troppo improvviso) a esempi contemporanei di foto, documentaristica e graphic novels di taglio etnografico. A tutto questo l’autore aggiunge esemplificazioni tratte dai propri lavori nel campo dell’antropologia del patrimonio, in particolare l’allestimento di un ecomuseo in Toscana (un contesto discusso più in profondità nel precedente libro di Meloni, Nostalgia rurale. Antropologia visiva di un immaginario contemporaneo, Milano, Meltemi, 2023).
Prima di arrivare a questo, dirò intanto che il punto di forza e di originalità del libro sta proprio nel tentativo di tenere insieme l’analisi delle immagini come strumenti della ricerca e lo studio del ruolo che le immagini giocano nella cultura contemporanea – due aspetti che troppo spesso sono trattati separatamente. Da un lato, quindi, l’opera ripercorre la storia delle metodologie visuali della ricerca etnografica, come le fotografie, il cinema, i disegni o i grafici: è una storia ormai abbastanza nota, a partire dai precursori come Haddon, Malinowski e Boas, a Flaherty (l’autore di quel Nanook che è considerato il primo film etnografico in senso stretto), per arrivare a Rouch, a Mead e Bateson, al Bourdieu delle foto algerine; giungendo poi (forse con un salto troppo improvviso) a esempi contemporanei di foto, documentaristica e graphic novels di taglio etnografico. A tutto questo l’autore aggiunge esemplificazioni tratte dai propri lavori nel campo dell’antropologia del patrimonio, in particolare l’allestimento di un ecomuseo in Toscana (un contesto discusso più in profondità nel precedente libro di Meloni, Nostalgia rurale. Antropologia visiva di un immaginario contemporaneo, Milano, Meltemi, 2023).
 Dall’altro lato, in un costante intreccio con le problematiche metodologiche, troviamo nel libro una sintesi concettualmente molto chiara di alcune tra le principali teorie sul significato culturale e sociale delle immagini. Ci incontriamo così con le analisi semiotiche, a partire da Barthes, e con le fin troppo abusate considerazioni di Benjamin sull’opera d’arte nell’epoca della sua riproduzione tecnica; con quelle etnografiche di Madianou e Miller sui polymedia, «media digitali che trasformano le relazioni interpersonali quotidiane»; con le teorizzazioni della agency delle immagini, culminanti con i lavori di Gell e Severi sui feticci, e con il concetto proposto da Bredekamp di “atto iconico” (i modi in cui le immagini agiscono nella realtà, non limitandosi a “rappresentarla”). E, ancora, non mancano le riflessioni di Baudrillard sui “simulacri”, né (un po’ troppo palesemente in omaggio al mainstream foucaultiano dell’antropologia contemporanea) le varie considerazioni sulle immagini come “dispositivi” di controllo disciplinare o biopolitico, veicoli di orientalismo e razzismo etc.).
Dall’altro lato, in un costante intreccio con le problematiche metodologiche, troviamo nel libro una sintesi concettualmente molto chiara di alcune tra le principali teorie sul significato culturale e sociale delle immagini. Ci incontriamo così con le analisi semiotiche, a partire da Barthes, e con le fin troppo abusate considerazioni di Benjamin sull’opera d’arte nell’epoca della sua riproduzione tecnica; con quelle etnografiche di Madianou e Miller sui polymedia, «media digitali che trasformano le relazioni interpersonali quotidiane»; con le teorizzazioni della agency delle immagini, culminanti con i lavori di Gell e Severi sui feticci, e con il concetto proposto da Bredekamp di “atto iconico” (i modi in cui le immagini agiscono nella realtà, non limitandosi a “rappresentarla”). E, ancora, non mancano le riflessioni di Baudrillard sui “simulacri”, né (un po’ troppo palesemente in omaggio al mainstream foucaultiano dell’antropologia contemporanea) le varie considerazioni sulle immagini come “dispositivi” di controllo disciplinare o biopolitico, veicoli di orientalismo e razzismo etc.).
Come tenere insieme questo ventaglio così ampio (e per certi versi incoerente) di posizioni teoriche? Meloni sceglie di non affidarsi a un taglio cronologico (l’evoluzione nel tempo delle idee e dei concetti), e neppure alla focalizzazione di dibattiti specifici (come si potrebbe fare partendo dalle esplicite dispute teoriche o dalla contrapposizione fra opposte posizioni). Tenta piuttosto di aggregare la sua vasta bibliografia attorno ad alcune problematiche di ricerca. Oltre a quella del patrimonio culturale e degli ecomusei, già ricordata, vorrei citarne almeno due. La prima riguarda alcune esperienze etnografiche condotte dallo stesso autore e da Valentina Lusini sui visitatori di musei e mostre d’arte, quindi sulla “osservazione degli osservatori”: tema che si connette strettamente a quello della fruizione dell’arte contemporanea e del suo più ampio “significato” sociale. Il secondo campo di riflessione o ricerca su cui Meloni si concentra è quello della violenza. Il caso delle foto delle torture di Abu-Ghraib lo porta a ragionare sui modi in cui le immagini possono funzionare da “amplificazioni” della violenza, oltre che da costruzioni discriminatorie dell’alterità; il caso delle immagini del crollo delle Torri Gemelle è l’occasione per discutere della “viralità” di immagini che rappresentano distruzione e sofferenza.
 Come in tutte le opere di sintesi, l’aspetto di maggior valore del libro sta nella capacità di costruire grandi panorami di idee, restituendo una visione d’insieme dei nodi teorici, metodologici, epistemologici che percorrono il campo di studi. Un limite, a mio parere, sta in un eccessivo ecumenismo: cioè, sono accostati punti di vista diversi e spesso incompatibili senza che questa incompatibilità sia messa a tema. Ad esempio, l’autore ha una chiara propensione (come dimostrano anche le sue opere precedenti, cfr. il volume Antropologia del consumo. Doni, merci, simboli, Roma, Carocci, 2018) per le analisi della cultura di massa che insistono sul ruolo attivo dei consumatori – contro, per intenderci, le teorie apocalittiche che vedono il consumismo come l’unilaterale colonizzazione delle soggettività umane da parte di un onnipotente Leviatano economico-politico. E non ama certo le geremiadi sulle immagini che “invadono” la sfera della vita sostituendo il virtuale al reale, sulla tecnologia che “aliena” gli esseri umani e così via.
Come in tutte le opere di sintesi, l’aspetto di maggior valore del libro sta nella capacità di costruire grandi panorami di idee, restituendo una visione d’insieme dei nodi teorici, metodologici, epistemologici che percorrono il campo di studi. Un limite, a mio parere, sta in un eccessivo ecumenismo: cioè, sono accostati punti di vista diversi e spesso incompatibili senza che questa incompatibilità sia messa a tema. Ad esempio, l’autore ha una chiara propensione (come dimostrano anche le sue opere precedenti, cfr. il volume Antropologia del consumo. Doni, merci, simboli, Roma, Carocci, 2018) per le analisi della cultura di massa che insistono sul ruolo attivo dei consumatori – contro, per intenderci, le teorie apocalittiche che vedono il consumismo come l’unilaterale colonizzazione delle soggettività umane da parte di un onnipotente Leviatano economico-politico. E non ama certo le geremiadi sulle immagini che “invadono” la sfera della vita sostituendo il virtuale al reale, sulla tecnologia che “aliena” gli esseri umani e così via.
Ma nel libro questi due tipi di approccio sono spesso accostati l’uno all’altro senza che il contrasto risalti troppo. Così, ad esempio, colpisce trovare nelle stesse pagine (84-87) il concetto di “dispositivo” che Giorgio Agamben ricava da Foucault, allo scopo di interpretare le tecnologie che producono immagini come forme di “soggettivazione” e di “assoggettamento” al potere, e le etnografie di Daniel Miller sull’uso dei nuovi media nelle comunicazioni transnazionali. Mi pare un po’ difficile pensare queste posizioni come cumulative e non alternative: si può anche sostenere che sono in definitiva compatibili, ma bisognerebbe dimostrarlo. Allo stesso modo, mi chiedo che bisogno c’era di introdurre nella riflessione sull’11 settembre una nozione non irrinunciabile come quella di biopicture, coniata da tal Mitchell come calco di “biopotere”, per dimostrare come le immagini possano «ridurre i corpi a nuda vita» – asserzione persino più oscura di quelle “obbligatorie” di Zizek sul “deserto del reale”. È vero che il libro ha la natura di una rassegna e deve dar conto di tutti i punti di vista: ma è difficile costruire mappe concettuali senza prendere posizione, e senza distinguere i concetti profondi e illuminanti, e soprattutto chiari, da certe oscurità dogmatiche. Cosa che peraltro, beninteso, Pietro Meloni fa quasi sempre, rinunciando alla sua consueta lucidità solo quando si sente in dovere di citare alcuni maître a penser filosofici.
 Ma il punto che vorrei qui soprattutto discutere, come detto, è un altro. Come in molti testi sul “visuale” o “visivo”, anche qui si rivendica per le immagini un ruolo cruciale nella produzione della conoscenza antropologica, denunciando le angustie di un certo “logocentrismo” che ha a lungo dominato la disciplina. A partire almeno da Margaret Mead, si è polemizzato con i metodi basati esclusivamente sulle parole, e si è rivendicata una “svolta visiva”, la «necessità di costruire percorsi scientifici fondati sull’uso delle immagini». Non si tratta solo del fatto, in sé ovvio, che le fonti fotografiche e filmiche hanno un inestimabile valore documentario, e una “oggettività” maggiore delle descrizioni meramente verbali. (Per inciso: sì, lo sappiamo che non esiste oggettività assoluta e che le fonti visive non sono meno autoriali di quelle verbali etc., che sono anch’esse rappresentazioni parziali dipendenti da una sintassi espressiva etc.; ma sono lo stesso più oggettive e più attendibili, e affermarlo è questione di buon senso e non di positivismo…). Ma, dicevo, non si tratta solo di un tipo particolare di fonti.
Ma il punto che vorrei qui soprattutto discutere, come detto, è un altro. Come in molti testi sul “visuale” o “visivo”, anche qui si rivendica per le immagini un ruolo cruciale nella produzione della conoscenza antropologica, denunciando le angustie di un certo “logocentrismo” che ha a lungo dominato la disciplina. A partire almeno da Margaret Mead, si è polemizzato con i metodi basati esclusivamente sulle parole, e si è rivendicata una “svolta visiva”, la «necessità di costruire percorsi scientifici fondati sull’uso delle immagini». Non si tratta solo del fatto, in sé ovvio, che le fonti fotografiche e filmiche hanno un inestimabile valore documentario, e una “oggettività” maggiore delle descrizioni meramente verbali. (Per inciso: sì, lo sappiamo che non esiste oggettività assoluta e che le fonti visive non sono meno autoriali di quelle verbali etc., che sono anch’esse rappresentazioni parziali dipendenti da una sintassi espressiva etc.; ma sono lo stesso più oggettive e più attendibili, e affermarlo è questione di buon senso e non di positivismo…). Ma, dicevo, non si tratta solo di un tipo particolare di fonti.
 La “svolta visiva” riguarderebbe piuttosto le modalità della rappresentazione etnografica e quella della comprensione antropologica. Intenderebbe cioè andar oltre il motto di Geertz – «cosa fa l’etnografo? L’etnografo scrive» – che radica il sapere antropologico nel rapporto tra l’esperienza del mondo sociale e la parola che la rappresenta: rapporto influenzato dalle regole e dalle strategie della scrittura. Non ci si dimentica così che l’etnografo può anche filmare, costruire ipertesti, allestire mostre, cioè utilizzare codici espressivi che non sono soltanto scritti? Questa obiezione viene mossa da molti anche al movimento di Writing Culture, che fa poggiare l’autorità etnografica sulle strategie stilistiche e retoriche, e ne classifica le forme in riferimento ai generi della letteratura (realismo, dialogismo, multivocalità, stile diaristico o confessionale etc.): ignorando le peculiari forme di autorità che riguardano il linguaggio visivo (p. 51-2 del testo di Meloni; un punto su cui insisteva fin dal titolo il celebre contributo di Jay Ruby, Picturing Culture. Explorations of Film and Anthropology, Chicago 2000; analoga era la riflessione di un altro testo a suo tempo molto discusso, Exibiting Cultures. The Poetics and Politics of Museum Display, a cura di I. Karp e S. D. Lavine, Washington 1991, in relazione al lavoro sulla cultura materiale e alle esposizioni museali).
La “svolta visiva” riguarderebbe piuttosto le modalità della rappresentazione etnografica e quella della comprensione antropologica. Intenderebbe cioè andar oltre il motto di Geertz – «cosa fa l’etnografo? L’etnografo scrive» – che radica il sapere antropologico nel rapporto tra l’esperienza del mondo sociale e la parola che la rappresenta: rapporto influenzato dalle regole e dalle strategie della scrittura. Non ci si dimentica così che l’etnografo può anche filmare, costruire ipertesti, allestire mostre, cioè utilizzare codici espressivi che non sono soltanto scritti? Questa obiezione viene mossa da molti anche al movimento di Writing Culture, che fa poggiare l’autorità etnografica sulle strategie stilistiche e retoriche, e ne classifica le forme in riferimento ai generi della letteratura (realismo, dialogismo, multivocalità, stile diaristico o confessionale etc.): ignorando le peculiari forme di autorità che riguardano il linguaggio visivo (p. 51-2 del testo di Meloni; un punto su cui insisteva fin dal titolo il celebre contributo di Jay Ruby, Picturing Culture. Explorations of Film and Anthropology, Chicago 2000; analoga era la riflessione di un altro testo a suo tempo molto discusso, Exibiting Cultures. The Poetics and Politics of Museum Display, a cura di I. Karp e S. D. Lavine, Washington 1991, in relazione al lavoro sulla cultura materiale e alle esposizioni museali).
 Benissimo, tutto giusto. Ma, se usciamo dalla pura retorica rivendicativa (“Basta con il logocentrismo! Pensiamo per immagini!”), non possiamo non chiederci se le immagini possiedano davvero una loro autonomia epistemologica, e se siano sufficienti a produrre un tipo di comprensione antropologica alternativo a quello offerto dagli strumenti linguistici. In altre parole: è davvero possibile, per citare il titolo di un classico degli studi visuali, “visualizzare la teoria”? (L. Taylor, Visualizing Theory, London, 1994). A me pare ci sia da dubitarne. La gran parte delle forme di rappresentazione etnografica visuale che conosciamo, e che sono esaminate nel libro di Meloni, sono accompagnate da parole: e lo stesso Meloni sostiene il necessario costante rapporto tra il visivo e il linguistico. Le immagini hanno certo grande importanza descrittiva, e sono cruciali perché consentono agli spettatori di rappresentarsi in modo più “concreto” a realtà ambientali e antropiche magari molto diverse da quelle che sono loro più familiari. Così, ad esempio, le fotografie di Pinna, Zavattini e Gilardi, o i video di Carpitella e di Mingozzi, sono oggi indispensabili per la nostra possibilità di immaginare i contesti sociali e culturali studiati da De Martino nelle sue spedizioni etnografiche nel Mezzogiorno. Si potrebbe anzi dire che il nostro rapporto con quelle esperienze di ricerca è indissolubilmente legato a quelle immagini. Tuttavia, se le isolassimo dai testi demartiniani, o dalle parole che le accompagnano (ad esempio nel documentario “La taranta” di Mingozzi), resterebbero del tutto opache rispetto all’obiettivo della comprensione antropologica, quello cioè di intendere i significati dei fenomeni culturali. In realtà la stessa idea di “isolarle” è una impossibile petizione di principio: se guardiamo oggi quelle immagini da sole, esse risuoneranno comunque con le letture che abbiamo fatto in precedenza. Quindi le “parole” e i relativi concetti ci sono sempre, anche se a metterceli è lo spettatore.
Benissimo, tutto giusto. Ma, se usciamo dalla pura retorica rivendicativa (“Basta con il logocentrismo! Pensiamo per immagini!”), non possiamo non chiederci se le immagini possiedano davvero una loro autonomia epistemologica, e se siano sufficienti a produrre un tipo di comprensione antropologica alternativo a quello offerto dagli strumenti linguistici. In altre parole: è davvero possibile, per citare il titolo di un classico degli studi visuali, “visualizzare la teoria”? (L. Taylor, Visualizing Theory, London, 1994). A me pare ci sia da dubitarne. La gran parte delle forme di rappresentazione etnografica visuale che conosciamo, e che sono esaminate nel libro di Meloni, sono accompagnate da parole: e lo stesso Meloni sostiene il necessario costante rapporto tra il visivo e il linguistico. Le immagini hanno certo grande importanza descrittiva, e sono cruciali perché consentono agli spettatori di rappresentarsi in modo più “concreto” a realtà ambientali e antropiche magari molto diverse da quelle che sono loro più familiari. Così, ad esempio, le fotografie di Pinna, Zavattini e Gilardi, o i video di Carpitella e di Mingozzi, sono oggi indispensabili per la nostra possibilità di immaginare i contesti sociali e culturali studiati da De Martino nelle sue spedizioni etnografiche nel Mezzogiorno. Si potrebbe anzi dire che il nostro rapporto con quelle esperienze di ricerca è indissolubilmente legato a quelle immagini. Tuttavia, se le isolassimo dai testi demartiniani, o dalle parole che le accompagnano (ad esempio nel documentario “La taranta” di Mingozzi), resterebbero del tutto opache rispetto all’obiettivo della comprensione antropologica, quello cioè di intendere i significati dei fenomeni culturali. In realtà la stessa idea di “isolarle” è una impossibile petizione di principio: se guardiamo oggi quelle immagini da sole, esse risuoneranno comunque con le letture che abbiamo fatto in precedenza. Quindi le “parole” e i relativi concetti ci sono sempre, anche se a metterceli è lo spettatore.
 Non sto negando il fatto che vi sia un “linguaggio” o una intelligenza visuale specifica, irriducibile sul piano cognitivo a quella del logos. Sul piano delle teorie della percezione estetica, questo è perfettamente plausibile – come mostra ad esempio l’esortazione di Wittgenstein a “osservare” piuttosto che “pensare” di fronte a un’opera d’arte. Il problema è se e in che modo una tale intelligenza visuale entra in rapporto con gli espliciti obiettivi delle scienze sociali, quelli appunto della “comprensione” (o della “spiegazione”, se si preferisce). Nel caso del tarantismo, pensiamo ad esempio al repertorio delle interpretazioni proposte da de Martino: i concetti di complesso mitico-rituale e di orizzonte “metastorico”, quelli di protezione e riscatto della “presenza”, quello di un inconscio nel quale “rimordono” conflitti inconsci che trovano configurazione nel simbolo della taranta, etc., sono tutti assolutamente logocentrici. Non c’è nulla nelle immagini in sé che possa suggerirli (anche se, una volta che li si è assimilati, le immagini possono – post hoc – sembrarne una conferma). Sono questi concetti che ci consentono di elucidare i possibili significati del tarantismo (e, per quanto mi riguarda, che rendono così affascinante la lettura di La terra del rimorso): e non mi pare che essi si leghino in modo intrinseco alle immagini.
Non sto negando il fatto che vi sia un “linguaggio” o una intelligenza visuale specifica, irriducibile sul piano cognitivo a quella del logos. Sul piano delle teorie della percezione estetica, questo è perfettamente plausibile – come mostra ad esempio l’esortazione di Wittgenstein a “osservare” piuttosto che “pensare” di fronte a un’opera d’arte. Il problema è se e in che modo una tale intelligenza visuale entra in rapporto con gli espliciti obiettivi delle scienze sociali, quelli appunto della “comprensione” (o della “spiegazione”, se si preferisce). Nel caso del tarantismo, pensiamo ad esempio al repertorio delle interpretazioni proposte da de Martino: i concetti di complesso mitico-rituale e di orizzonte “metastorico”, quelli di protezione e riscatto della “presenza”, quello di un inconscio nel quale “rimordono” conflitti inconsci che trovano configurazione nel simbolo della taranta, etc., sono tutti assolutamente logocentrici. Non c’è nulla nelle immagini in sé che possa suggerirli (anche se, una volta che li si è assimilati, le immagini possono – post hoc – sembrarne una conferma). Sono questi concetti che ci consentono di elucidare i possibili significati del tarantismo (e, per quanto mi riguarda, che rendono così affascinante la lettura di La terra del rimorso): e non mi pare che essi si leghino in modo intrinseco alle immagini.
È vero che de Martino stesso racconta di esseri accostato al fenomeno a partire dalle suggestive fotografie di André Martin, e di esser stato spinto alla ricerca dal loro sapore di inquietante arcaismo; lo stesso che si coglie nell’apparato di immagini che accompagna La Terra del rimorso, e che del libro costituisce indubbiamente parte integrante ed essenziale. E tuttavia il loro ruolo resta occasionale, non si fonde realmente con l’impianto interpretativo che l’autore propone. Tutta la retorica sulle immagini che non dovrebbero essere puramente “illustrative” trova qui i suoi limiti. Le immagini sono in questo caso esattamente illustrative; esse restano esteriori rispetto ai concetti espressi verbalmente, attraverso i quali passa la nostra capacità di interpretare il tarantismo come fenomeno culturale. O restano esteriori alla teoria, se vogliamo: per cui lo slogan del “visualizzare la teoria”, come nel titolo di Lucien Taylor sopra ricordato, appare al massimo come una provocazione senza un chiaro significato.
 Quando facciamo antropologia, siamo dunque inevitabilmente logocentrici: possiamo al massimo praticare un “logocentrismo critico”, consapevole cioè dei propri limiti e in costante dialogo con le immagini. Queste ultime sono anch’esse una forma di rappresentazione della vita e non la vita stessa, certo: eppure ci appaiono talvolta più vicine alla “cosa in sé”, a quella realtà che i concetti inseguono senza poterla mai raggiungere. Per questo le consideriamo parte fondamentale della documentazione, e magari le inseriamo nelle rappresentazioni etnografiche perché in grado di veicolare aspetti che le parole non restituiscono con altrettanta efficacia. Un altro esempio tratto dal libro di Meloni: Balinese Character di Bateson e Mead è una tra le più famose opere di etnografia fotografica. I due autori si affidano alle immagini come forma di registrazione “oggettiva”, capace di mostrare aspetti dell’ethos balinese che resterebbero opachi a una descrizione puramente verbale: la gestualità, le emozioni, gli usi del corpo, «modi di camminare, di esprimere approvazione o disapprovazione, la sofferenza e la gioia, la condivisione dello spazio pubblico, l’educazione dei bambini etc.» (ivi: 32). Indubbiamente, per i lettori non sarebbe possibile raffigurarsi con precisione ciò che gli etnografi intendono trasmettere senza le immagini, che consentono di portare in primo piano i corpi e la materialità della vita quotidiana balinese. Sono dunque fonti di importanza cruciale, tutt’altro che accessorie o decorative. Eppure sono sempre poste al servizio di un concetto, come quello di ethos, che conferisce loro un significato – che le fa partecipi, diciamo, di un processo ermeneutico che non sarebbe possibile senza la guida del piano discorsivo.
Quando facciamo antropologia, siamo dunque inevitabilmente logocentrici: possiamo al massimo praticare un “logocentrismo critico”, consapevole cioè dei propri limiti e in costante dialogo con le immagini. Queste ultime sono anch’esse una forma di rappresentazione della vita e non la vita stessa, certo: eppure ci appaiono talvolta più vicine alla “cosa in sé”, a quella realtà che i concetti inseguono senza poterla mai raggiungere. Per questo le consideriamo parte fondamentale della documentazione, e magari le inseriamo nelle rappresentazioni etnografiche perché in grado di veicolare aspetti che le parole non restituiscono con altrettanta efficacia. Un altro esempio tratto dal libro di Meloni: Balinese Character di Bateson e Mead è una tra le più famose opere di etnografia fotografica. I due autori si affidano alle immagini come forma di registrazione “oggettiva”, capace di mostrare aspetti dell’ethos balinese che resterebbero opachi a una descrizione puramente verbale: la gestualità, le emozioni, gli usi del corpo, «modi di camminare, di esprimere approvazione o disapprovazione, la sofferenza e la gioia, la condivisione dello spazio pubblico, l’educazione dei bambini etc.» (ivi: 32). Indubbiamente, per i lettori non sarebbe possibile raffigurarsi con precisione ciò che gli etnografi intendono trasmettere senza le immagini, che consentono di portare in primo piano i corpi e la materialità della vita quotidiana balinese. Sono dunque fonti di importanza cruciale, tutt’altro che accessorie o decorative. Eppure sono sempre poste al servizio di un concetto, come quello di ethos, che conferisce loro un significato – che le fa partecipi, diciamo, di un processo ermeneutico che non sarebbe possibile senza la guida del piano discorsivo.
Siamo di fronte a un “dialogo” fra immagini e parole, come si esprime Meloni? Più precisamente, forse, a una strategia discorsiva o ermeneutica che inserisce le immagini (dense di possibilità interpretative, ma non di per sé produttrici di interpretazione) nel proprio percorso. Mi sembra invece sbagliato tirare in ballo (come fa ancora Mitchell, cit.: 44) il motto wittgensteiniano sul «mostrare quello che non si può dire» come emblematico dei problemi dell’antropologia visiva. È appena il caso di ricordare che il filosofo austriaco intendeva con ciò l’impossibilità di giustificare i fondamenti del linguaggio, di spiegare la natura della relazione tra una parola e la “realtà” che essa rappresenta: quella relazione può essere solo mostrata non certo nel senso di un’immagine, ma descrivendo gli usi del linguaggio (la logica matematica nel Wittgenstein del Tractatus, i giochi linguistici in quello delle Ricerche filosofiche). Niente a che fare, dunque, col rapporto tra parole e immagini: né, a maggior ragione, con l’uso di grafici, diagrammi etc. nella scrittura etnografica (ad esempio la rappresentazione grafica del sistema segmentario nei Nuer di Evans-Prichard, o i sociogrammi in La distinzione di Bourdieu), citati come esempi di ciò che non può esser detto ma solo mostrato: questi grafici non sono “immagini” ma spazializzazioni di concetti, che servono a renderli più chiari, a “dirli” meglio, non certo a evocare intuizioni che si sottrarrebbero alla presa della linguistica e della logica.
 L’ “indicibilità” è semmai pertinente alle riflessioni di Wittgenstein sulla percezione estetica e dunque sull’arte. Non si può mai “spiegare” perché un’opera d’arte ci appaia bella o brutta, perfetta o imperfetta, inquietante o banale: o meglio, lo si fa sempre nel discorso della critica d’arte, ma si tratta di riflessioni post hoc, non di spiegazioni di una reazione estetica che è invece “primitiva”, immediata, non filtrata dalla consapevolezza discorsiva (da qui l’osservazione sui turisti che di fronte a una cattedrale si mettono a leggere nella guida le notizie sulla sua costruzione, e così non la “vedono”; L. Wittgenstein, Pensieri diversi, Milano 1980: 83). Insomma, la percezione estetica è in quest’ottica irriducibile alla razionalità discorsiva – anche se nelle pratiche artistiche concrete i due piani si intrecciano di sovente, e non solo nell’arte che si definisce esplicitamente concettuale.
L’ “indicibilità” è semmai pertinente alle riflessioni di Wittgenstein sulla percezione estetica e dunque sull’arte. Non si può mai “spiegare” perché un’opera d’arte ci appaia bella o brutta, perfetta o imperfetta, inquietante o banale: o meglio, lo si fa sempre nel discorso della critica d’arte, ma si tratta di riflessioni post hoc, non di spiegazioni di una reazione estetica che è invece “primitiva”, immediata, non filtrata dalla consapevolezza discorsiva (da qui l’osservazione sui turisti che di fronte a una cattedrale si mettono a leggere nella guida le notizie sulla sua costruzione, e così non la “vedono”; L. Wittgenstein, Pensieri diversi, Milano 1980: 83). Insomma, la percezione estetica è in quest’ottica irriducibile alla razionalità discorsiva – anche se nelle pratiche artistiche concrete i due piani si intrecciano di sovente, e non solo nell’arte che si definisce esplicitamente concettuale.
Il punto allora è il seguente: nelle scienze sociali gioca un qualche ruolo una dimensione estetico-artistica, non riconducibile alla razionalità discorsiva attorno alla quale esse si sono edificate? Non lo si può escludere, anche se i tentativi di inserire nella produzione antropologica elementi di evocazione artistica (la poesia, ad esempio, in alcuni dei più radicali seguaci di Writing culture) non hanno – mi sembra – prodotto grandi risultati). È un problema da approfondire, e certamente il libro di Pietro Meloni offre una mappa articolata e profonda per farlo. Ma è diverso dal pensare che l’uso di strumenti di riproduzione visuale metta di per sé in discussione il “logocentrismo”, o configuri una radicale “svolta” epistemologica per l’antropologia. Di presunte “svolte” ne abbiamo avute anche troppe in anni recenti, è bene andarci piano…
Dialoghi Mediterranei, n. 67, maggio 2024
______________________________________________________________
Fabio Dei, insegna Antropologia Culturale presso l’Università di Pisa. Si occupa di antropologia della violenza e delle forme della cultura popolare e di massa in Italia. Dirige la rivista Lares e ha pubblicato fra l’altro Antropologia della cultura materiale (con P. Meloni, Carocci, 2015), Terrore suicida. Religione, politica e violenza nelle culture del martirio (Donzelli, 2016), Antropologia culturale (Il Mulino, 2016, 2.a ed.), Cultura popolare in Italia. Da Gramsci all’Unesco, Il Mulino, 2018). Con C. Di Pasquale ha curato i volumi Stato, violenza, libertà. La critica del potere e l’antropologia contemporanea (Donzelli, 2017) e Rievocare il passato. Memoria culturale e identità territoriali (Pisa University Press, 2017), James G. Frazer e la cultura del Novecento. Antropologia, psicoanalisi, letteratura (Carocci 2021). Dirige la Rivista di antropologia contemporanea e dal 2017 Lares, Quadrimestrale di studi demoetnoantropologici.
______________________________________________________________