di Francesca Deidda
Quando nel 2014 decisi di dedicare un intero lavoro di tesi magistrale all’ambiziosa analisi dei significati storico-antropologici che soggiacciono alla verginità corporale di Maria, la Madre di Gesù, non avrei mai pensato che il mio contributo avrebbe potuto spaziare in un ambito non strettamente accademico.
I puntuali riferimenti alle Scritture greche (sinottiche e non) [1], così come l’impiego di un linguaggio specialistico, ne pregiudicavano senza mezzi termini una diffusione su larga scala e ne rendevano ostica la lettura – nonché la comprensione – a un pubblico profano, tendenzialmente imbevuto di tradizionali nozioni sul genere, il cristianesimo e le interconnessioni tra antropologia e studio delle religioni.
Durante la stesura ho io stessa riscontrato che, nell’incoscienza, ricalcavo schemi e principi dottrinali, dando credito a una prospettiva e una dialettica più teologica che storica, guardando alle fonti attraverso gli occhi dell’adepto, così trascurando la natura fattiva del narrato e il suo significato sostanziale. Inizialmente incastrata tra dogmi, preghiere e comandamenti, acriticamente appresi durante la pluriennale frequentazione del catechismo, ero impossibilitata dal prescindere completamente dal tessuto formativo di provenienza, che non faceva altro che soffocare la voce autonoma del passato.
Attraverso un costante iter conoscitivo, che mi ha costretta a vestire i panni del filologo, sono riuscita a riposizionare personaggi e storie entro il loro habitat naturale, rispettando in toto non solo la distanza temporale ma anche lo scarto culturale e socio-religioso.
Alla fine dei conti ho proposto una rivisitazione in chiave somacentrica della figura protagonista, evidenziando la plastica concretezza del concetto di verginità, modus vivendi et operanti estraneo non solo all’economia del sesso ma anche all’impuro e al contaminato (Douglas, 1996: 243).
A questo punto suppongo sia lecito domandarsi cosa abbiano in comune il discorso circa l’integritas fisica dell’Immacolata Vergine e le più recenti speculazioni della ormai famosa branca dei Gender Studies. La risposta è più ovvia di quanto si creda: in poche parole, l’attenzione rivolta al corpo umano come fenomeno integralmente culturale (Csordas, 1990: 35), unica entità bio-fisica costantemente capace di sussumere e fare esperienza di tutti gli istituti e le categorie pertinenti a società, cultura, religione, etica, politica (et cetera et cetera), tanto quanto delle interpretazioni e delle simbologie da esse indissolubilmente forgiate (Deidda, 2014:147-149).
Il nostro corpo è come ininterrottamente calato nell’ambiente in cui vive, da cui riceve dati che vengono elaborati in termini di informazioni soggettive, mai destoricizzato, decontestualizzato, astratto, discreto. Mai inteso come la naturale tabula rasa su cui meccanicisticamente si riflettono (come uno specchio) le dinamiche socio-culturali.
In questo momento storico, in cui la cosiddetta Teoria del gender [2] spopola in Italia, negli asili così nelle scuole primarie, e preoccupa la stragrande maggioranza delle famiglie, ritengo le mie osservazioni giochino un ruolo fondamentale nel tentativo di delucidare alcuni concetti base.
Le nozioni di sesso e genere, orientamento sessuale o ancora identità di genere sembrano aver monopolizzato l’odierna quotidianità e spalancato le porte ad una sensibilità di gusto tradizionalmente americano; sulla bocca di tutti, danno forma e senso a idee che fino ad alcuni anni addietro erano completamente sconosciute o relegate a ristretti ambiti di studio specialistico. Date per scontate, abbracciano una serie di sfumature semantiche che non dimostrano tuttavia cogliere la “verità” dei fatti. Palesano infatti la loro pericolosità in quanto ancora avvolte da un velo di mistero [3], incomprese e spesso impiegate in contesti o modalità inappropriate. Sono complici del generale atteggiamento omofobico e di un clima ancora tendenzialmente razzista. Ciò significa che nella terminologia che impieghiamo si cela un potere che abbiamo il diritto ed il dovere di maneggiare con cautela, al fine di comprendere appieno la complessità intrinseca dell’argomento ed evitare qualsiasi forma di pregiudizio o deriva conoscitiva.
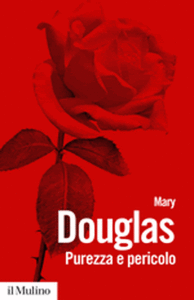 Il Logos dà forma agli oggetti di cui parla, rende effettivi gli enunciati, delimita gli spazi nominati, ne anticipa e regola gli effetti. Definisce e divide. Non si pone all’origine dei fenomeni in sé bensì li “anima”, consacrandone lo statuto ontologico, congelandoli in statiche categorie, [in questo caso specifico] nella diade sesso-genere. Intento primario sarà dunque quello di fare chiarezza sulla definizione del prisma sintetico “sex and gender” ed offrire per l’appunto una panoramica sulle interrelazioni con il corpo umano, seguendo le speculazioni della teorica di genere Judith Butler, con uno sguardo finale rivolto alla sua critica all’imperante eterosessismo.
Il Logos dà forma agli oggetti di cui parla, rende effettivi gli enunciati, delimita gli spazi nominati, ne anticipa e regola gli effetti. Definisce e divide. Non si pone all’origine dei fenomeni in sé bensì li “anima”, consacrandone lo statuto ontologico, congelandoli in statiche categorie, [in questo caso specifico] nella diade sesso-genere. Intento primario sarà dunque quello di fare chiarezza sulla definizione del prisma sintetico “sex and gender” ed offrire per l’appunto una panoramica sulle interrelazioni con il corpo umano, seguendo le speculazioni della teorica di genere Judith Butler, con uno sguardo finale rivolto alla sua critica all’imperante eterosessismo.
Prima ancora d’addentrarmi all’interno della vexata quaestio, vorrei si prestasse attenzione alla nota affermazione di Sandra Lee Bartky, che recita «siamo nati maschi o femmine, ma non maschili o femminili. La femminilità [non di meno la mascolinità] è un artificio, un prodotto» (Bartky, 1990: 65). Volendo esser più precisi, essere una donna differisce dall’esser femminile, perché il genere non è altro che «un attivo processo di appropriazione, interpretazione, reinterpretazione di possibilità culturali ricevute» (Butler, 1990: 36). La forza con cui la filosofa femminista nega esista un’automatica linea di demarcazione tra uomo e donna, che coincida con i corrispettivi attributi di maschile e femminile, deve far senza alcun dubbio riflettere. Maschile e femminile tenderebbero ad enucleare cariche e compiti speculari e, allo stesso tempo, contigui.
Eppure non esiste una corrispondenza biunivoca tra le parti in causa: il femminile o il maschile non sono prodotto causale né logica conseguenza della nascita in femmina o maschio. Da ciò si deduce che non sarà univocamente plausibile riconoscere l’uomo in un corpo maschile così la donna in uno femminile. È luogo comune correlare e riconoscere il genere in dipendenza dalle sembianze del sesso, dal cosiddetto “fantasma normativo del sesso”, e dalle funzioni adattategli per via di un apparente richiamo anatomico. Non c’è alcun bisogno ci si presenti come uomo o donna, perché è «evidente, o intuibile, quello che si è a partire da quello che, in senso lato, si ha addosso» (Deidda: 157).
Sebbene sia solito, inteso nell’accezione di “normale”, “prevedibile”, mettere in atto questa strategia interpretativa, non è detto che i parametri di sesso e genere siano interscambiabili, come non è un dato di fatto che allo scoccare della mascolinità subentri una virilità caratteriale-estetica o che, viceversa, ad una apparenza femminile segua una fragilità emotiva.
Si tratta di ruoli arbitrariamente ascritti e circoscritti, che su un piano fattuale non sono in grado di convogliare la molteplicità di espressioni o combinazioni fisico-culturali esplorabili. Una visione binaria dello spettro dei generi, soprattutto se calata entro l’immaginario eterosessuale, è dunque sempre limitativa e fuorviante. Uomini e donne aderiscono – più o meno consapevolmente – a rigide posizioni sessuali (Lacan), a un universo di regole, pretese, aspettative sociali e culturali, che non fanno altro che presentarci i singoli soggetti al maschile o al femminile, secondo una logica di reciproca esclusione. Ogni singolo individuo appare rivestire e interpretare un catalogo mentale, emotivo, comportamentale e funzionale, largamente riconoscibile sulla fisicità più spicciola, sul linguaggio verbale e gestuale, sull’uso (o non) della propria sessualità, sulla scelta di una data professione o attività ludica [4]. È l’atto che Bourdieu coniuga la «socializzazione del biologico [alla] biologizzazione del sociale» (Bourdieu, 2009: 9).
Un uomo non dovrebbe “ereditare” né sviluppare nel corso della vita delle caratteristiche tipicamente femminili, vedi il caso di chi si occupa della gestione dell’ambiente domestico o dell’educazione dei figli, mentre a una donna non dovrebbe esser concesso di indossare un certo tipo di abbigliamento o comportarsi “come un maschiaccio”, venendo meno alla sua natura. Per non dimenticare le classiche (e solide) funzioni genitoriali di madre e padre, che ben si sposano con gli attribuiti di moglie e marito, docile ed autoritario, casalinga e lavoratore, e via discorrendo.
Nella routinaria ripetizione dei ruoli uomo e donna naturalizzano e legittimano significati e forme del maschile e del femminile, venendo poi a interiorizzare i meccanismi di distribuzione del potere (dominazione maschile e soggezione femminile, gerarchia patriarcale, pater familias), e confermando che «in ogni società, ciascuno sa e deve sapere e imparare ciò che gli è richiesto in ogni situazione» (Mauss, 2000: 407).
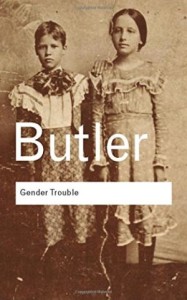 Mi pare utile richiamare un’interessante vicenda che generalmente passa inosservata, ovvero il momento dell’annunciazione al mondo del sesso del nascituro mediante un oggetto in particolare e in cui la schisi uomo/donna raggiunge massimi livelli di carica esplicativa. Fondamentale sarà a questo proposito il recupero dei bourdeiani «principi di visione e divisione sessuanti» (Bourdieu, 2009: 18), che organizzano la percezione delle identità sessuali negli imperativi di maschile e femminile. Si pensi a quando, venuta a conoscenza del sesso, la famiglia dà pubblico segnale dell’avvento con l’affissione di un nastro, rispettivamente azzurro o rosa, sulla porta di casa o sull’automobile, sceglie la fantasia e gli arredi che andranno a decorare la stanzina del nascituro, i colori dei vestiti, dei bavaglini e delle copertine, prestando particolare attenzione a fornire una corretta immagine del bimbo (ancora in grembo) e a scongiurare il presagio di un equivoco. I genitori, ben prima dell’effettiva venuta al mondo, si preoccupano di tessere una rappresentazione della prole che sia il più possibile concisa ed aderente agli standard di genere preposti. Attuano insomma una ricerca di coerenza e conformità, di continuità con le perentorie richieste scaturite dall’esterno, esercitano un controllo teso all’imprimere «l’immagine di un sistema sociale costituito da categorie di ruoli ascritti» (Deidda: 161).
Mi pare utile richiamare un’interessante vicenda che generalmente passa inosservata, ovvero il momento dell’annunciazione al mondo del sesso del nascituro mediante un oggetto in particolare e in cui la schisi uomo/donna raggiunge massimi livelli di carica esplicativa. Fondamentale sarà a questo proposito il recupero dei bourdeiani «principi di visione e divisione sessuanti» (Bourdieu, 2009: 18), che organizzano la percezione delle identità sessuali negli imperativi di maschile e femminile. Si pensi a quando, venuta a conoscenza del sesso, la famiglia dà pubblico segnale dell’avvento con l’affissione di un nastro, rispettivamente azzurro o rosa, sulla porta di casa o sull’automobile, sceglie la fantasia e gli arredi che andranno a decorare la stanzina del nascituro, i colori dei vestiti, dei bavaglini e delle copertine, prestando particolare attenzione a fornire una corretta immagine del bimbo (ancora in grembo) e a scongiurare il presagio di un equivoco. I genitori, ben prima dell’effettiva venuta al mondo, si preoccupano di tessere una rappresentazione della prole che sia il più possibile concisa ed aderente agli standard di genere preposti. Attuano insomma una ricerca di coerenza e conformità, di continuità con le perentorie richieste scaturite dall’esterno, esercitano un controllo teso all’imprimere «l’immagine di un sistema sociale costituito da categorie di ruoli ascritti» (Deidda: 161).
L’esempio, a noi tutti noto, è finalizzato a introdurre un nuovo elemento d’analisi. La formulazione dei due distinti generi è sempre e in ogni caso oppositiva e in riga con la genitalità [5], nella definizione del maschile peculiarità e limiti vengono perfettamente eretti in diretta negazione di peculiarità e limiti del femminile. Sembrerebbe che i due poli non possano condividere alcun aspetto anatomico, perché la confusione o, peggio ancora, la sovrapposizione degli stessi avrebbe conseguenze catastrofiche. E questo perché “il” corpo prende immancabilmente forma nei generi, perché la stipulazione di quella stessa differenziazione si attua in concomitanza all’affermazione dei corpi, o meglio ancora perché «bodies cannot be said to have a signifiable existence prior to the mark of their gender» (Butler, 1990: 13).
Sesso e genere sarebbero allora percepiti come il primo presupposto, l’altro conseguenza: al sesso maschile, di cui il possesso degli organi riproduttivi pene e testicoli ne è palese testimonianza, corrisponde l’individuo di genus uomo, al sesso femminile, al contrario suggellato dalla presenza di vagina e ovaie, il soggetto di genere donna. Nessuna difficoltà interpretativa, nessun disordine. Ma non tralasciamo una questione sostanziale: sebbene le distinzioni biologiche siano incontrovertibili, in quanto ognuno di noi riceve fin dal concepimento un “contenitore sessuato”, la loro traduzione in posizionamenti di genere è decisione sociale, per cui secondaria, parziale e discutibile.
Judith Butler smaschera quelle «belle menzogne [poste] a uso e consumo della cultura» (Fusaschi, 2003: 8), secondo cui la simmetria di femminilità e mascolinità sarebbe universalmente, al di là di spazio e tempo, data e ci invita nuovamente a riflettere sulle classificazioni preposte. Tutt’altro che innocenti, sesso e genere superano le semplificazioni di natura e cultura, obbligano il lettore ad un’ulteriore problematizzazione [6] ed arrivano a significare rispettivamente la norma che sovraintende le possibilità di poliedrica costruzione del soggetto e la condizione culturale in cui quella stessa lex ha campo libero d’esistere.
Andando per ordine, il sesso coincide in prima istanza con una conformazione materiale anatomica, cromosomica, ormonale, dotata di funzionalità squisitamente fisiologica, mentre il genere domina i costrutti culturali, sociali, politici, storici di cui il precedente “soffre”. In secondo luogo potremmo dire che «il primo offre quell’evidenza estetica su cui poggia ed opera il reticolo di prassi e riflessioni a cui il secondo fa capo» (Deidda: 163), nella forma di modalità di acculturazione e interpretazione del corpo [7].
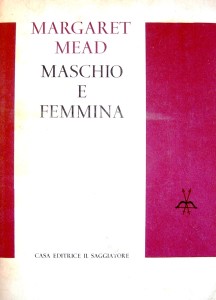 In base alle affermazioni sovraelencate, saremmo portati a credere esista perfino un oggettivo rapporto di anteriorità-posteriorità tra sesso e genere: l’uno fatalmente e aprioristicamente assegnatoci, l’altro imposto solamente a posteriori sulla carne, venuto ad aggiungersi quasi per mera cumulatio alla summa di relativi biologici. Definire allora il sex come ante genus, nonché pre-discorsivo [8], significherebbe attribuirgli un taglio di eterna irriducibilità, processo che lo rende a sua volta «pre-storico, pre-culturale e pre-sociale, pre-politico [o ancora pre-giuridico]» (Deidda:164), dimentico dunque dello storico, del culturale, del sociale, del politico di cui anche la natura è inevitabilmente contrassegnata. Quello che la Butler intende dimostrare è che la visione binaria di sesso e genere come naturale ed innaturale, originario e artificiale, così statico e dinamico risulta totalmente lesiva in termini di comprensione del fenomeno.
In base alle affermazioni sovraelencate, saremmo portati a credere esista perfino un oggettivo rapporto di anteriorità-posteriorità tra sesso e genere: l’uno fatalmente e aprioristicamente assegnatoci, l’altro imposto solamente a posteriori sulla carne, venuto ad aggiungersi quasi per mera cumulatio alla summa di relativi biologici. Definire allora il sex come ante genus, nonché pre-discorsivo [8], significherebbe attribuirgli un taglio di eterna irriducibilità, processo che lo rende a sua volta «pre-storico, pre-culturale e pre-sociale, pre-politico [o ancora pre-giuridico]» (Deidda:164), dimentico dunque dello storico, del culturale, del sociale, del politico di cui anche la natura è inevitabilmente contrassegnata. Quello che la Butler intende dimostrare è che la visione binaria di sesso e genere come naturale ed innaturale, originario e artificiale, così statico e dinamico risulta totalmente lesiva in termini di comprensione del fenomeno.
Portiamo avanti il ragionamento. Le speculazioni della filosofa trovano successiva esplicazione nella celebre teoria dell’obbligatorietà dell’eteronormatività, tesi su cui poggia la produttività del dimorfismo sessuale e il conseguente trionfo del modello familiare eterosessuale. In una società patriarcale e simbolicamente fallocentrica le posizioni sessuate di maschile e femminile adempierebbero perfettamente alle richieste imposte dall’atto riproduttivo e verrebbero legittimate come ineludibile necessità socio-logica.
Partendo dal presupposto insormontabile che la perpetuazione della specie umana avviene unicamente per mezzo di un rapporto tra sessi opposti (perché detentori di organi destinati alla procreazione), la normalizzazione della coppia eterosessuale come naturale disposizione umana è dunque qualcosa di completamente altro. È in questo frangente allora obbligatoria una denaturalizzazione della classe sesso, stratagemma mediante cui sarà possibile appurare come le dinamiche di potere e le coercizioni precettistiche siano responsabili e della sua elaborazione e della sua perenne regolamentazione entro le maglie del genere.
Tecnicamente il sesso rappresenta «una delle norme [di certo non l’unica] attraverso le quali il “soggetto” diventa possibile, quella che qualifica un corpo per tutta la sua vita all’interno del campo dell’intellegibilità culturale» (Butler, 1996: 2). In altri termini è uno degli spazi di “creatività” dell’individuo che, contemporaneamente, presiede e prende attivamente parte alle pratiche di ripetizione e sistematizzazione dei dispositivi adiacenti. Nella sua natura prescrittiva, il sesso è dunque capace di localizzare ed autorizzare il lecito (in quanto norma) ma anche di cancellare l’illecito, l’eccedente alla norma, che è frutto del medesimo lavorio di forgiatura, seppur mediante l’impiego di processi di negazione.
D’altra parte possiamo affermare che affinché venga assicurata la produttività nomotetica dell’investitura sessuale, fondamentale deve essere la processualità dell’atto stesso, la costante prassi temporale di replica e sedimentazione delle caratteristiche sessuali, responsabile della conseguente naturalizzazione dei ruoli entro il paradigma eterosessuale. E se gli individui abbisognano di un consueto rinnovamento (quella costrittiva reiterazione, che a sua volta produce il sesso), allora la valenza e l’efficacia performativa del genere non è teorizzabile al di fuori di quello stesso meccanismo di pianificazione sessuale. Se è parte integrante del potere, non può esistere un genere al di fuori della coercizione.
 Quest’ultimo sarà allora definito come quella identità venutasi a creare per mezzo della “stilizzazione” del corpo e le quotidiane modalità con cui gestualità, orientamenti, movimenti strutturano il fantasma di un genere costante, quell’«essere femminile [che] non è il prodotto di una scelta [soggettiva, volitiva] ma la citazione forzata di una norma, la cui complessa storicità è inscindibile dalle relazioni di disciplina, regolamentazione, punizione a cui l’individuo è inevitabilmente sottoposto» (Butler, 1996: 174). È esattamente la ripetitività nomotetica a ritualizzare l’egemone for- giatura che, tuttavia, mai lo determina nella totalità conclusiva.
Quest’ultimo sarà allora definito come quella identità venutasi a creare per mezzo della “stilizzazione” del corpo e le quotidiane modalità con cui gestualità, orientamenti, movimenti strutturano il fantasma di un genere costante, quell’«essere femminile [che] non è il prodotto di una scelta [soggettiva, volitiva] ma la citazione forzata di una norma, la cui complessa storicità è inscindibile dalle relazioni di disciplina, regolamentazione, punizione a cui l’individuo è inevitabilmente sottoposto» (Butler, 1996: 174). È esattamente la ripetitività nomotetica a ritualizzare l’egemone for- giatura che, tuttavia, mai lo determina nella totalità conclusiva.
Vale la pena sottolineare che, paradossalmente, la procedura d’attualizzazione sessuale deve fare i conti con la sua intrinseca inefficacia e con la negoziazione della stessa, nel senso che la «risignificazione delle norme [è] funzione della loro efficacia» (Butler, 199: 179). Infatti,
«gli agenti sociali determinano attivamente, attraverso categorie di percezione e di valutazione socialmente e storicamente determinate, la situazione che li determina. Si può anche dire che gli agenti sociali sono determinati solo nella misura in cui si determinano; ma le categorie di percezione o di valutazione che sono alla base di questa (auto)determinazione sono a loro volta in gran parte determinate dalle condizioni economiche e sociali che le hanno costituite» (Bourdieu, 1992: 102).
Possiamo in chiusura asserire che il genere è la «matrice attraverso la quale ogni volontà diventa possibile, è la condizione culturale che conferisce potere e autorità» alle prescrizioni sessuali. La determinazione del maschile o del femminile trova dunque forma e senso solamente se calata entro la sua stessa contrattazione, la moltiplicazione a n di una pratica sessuale che si “autoaggiusta” nel quotidiano, volontario e soggettivo confronto-scontro con la cornice socio-cultura di espletazione. Come infine insegna Heritier: «l’iscrizione nel biologico è necessaria, il che però non vuol dire che di questi dati elementari debba esservi una traduzione unica e universale» (Heritier, 2010: 30).
È dunque chiaro che una duplice divisione in maschile e femminile, uomo e donna, seppur costitutiva del “normale” ordine delle cose, non è mai categoria esaustiva. Talvolta perfino rischiosa, nonché irrispettosa delle possibilità altre, parallele e non di certo inferiori o minoritarie. Perché allora oggigiorno niente spaventa di più che sentirsi dire che si può esser ciò che si vuole, al di là del sesso biologico, dei costumi del paese di provenienza, delle pressioni di un sistema dominante? Perché si passerebbe per anarchici, per chi si pone in aperta antitesi al contesto culturale d’appartenenza e formazione, per chi, al contrario di quanto si creda, vuole solo delle risposte che abbiano senso.
Dialoghi Mediterranei, n.24, marzo 2017
Note
[1] Le fonti esaminate sono state i Vangeli di Marco, Matteo, Luca e Giovanni (Gaeta Vincenzo, I Vangeli. Marco Matteo Luca Giovanni) e gli Apocrifi Il Protovangelo di Giacomo e Il Vangelo dello Pseudo-Matteo (Erbetta Mario, Gli Apocrifi del Nuovo Testamento. Scritti affini ai Vangeli canonici, composizioni gnostiche, materiale illustrativo; Erbetta Mario, Gli Apocrifi del Nuovo Testamento, Infanzia e Passione di Cristo, Assunzione di Maria).
[2] Sarebbe in ogni caso più corretto parlare di Teorie, al plurale, di genere.
[3] In primis è fondamentale il riferimento al fatto si usino, anche in Italia, gli originali inglesi di sex e gender.
[4] Possiamo tranquillamente ammettere che esistono sport tradizionalmente detti da femmina, quali il balletto classico o la danza in generale, e sport da maschio, vedi box, calcio o pallacanestro.
[5] Quello che Margaret Mead chiama «il fantasma normativo del sesso» (Mead, 2009).
[6]Vorrei riportare le originali parole della filosofa «the distinction between sex and gender serves the argument that what ever biological intractability sex appears to have, gender is culturally constructed: hence, gender is neither the causal result of sex no ras seemingly fixed as sex. The unity of the subject is thus al ready potentially contested by the distinction that permits of gender as a multiple .interpretation of sex. If gender is the cultural meanings that the sexed body assumes, then a gender cannot be said to follow from a sex in anyone way. Taken to its logical limit, the sex/gender distinction suggests a radical discontinuity between sexed bodies and culturally constructed genders. Assuming for the moment the stability of binary sex, it does not follow that the construction of “men” will accrue exclusively to the bodies of males or that “women” will interpret only female bodies » (Butler, Gender Trouble:9).
[7] Si parla di «corpi sessuati» e di «generi culturalmente costruiti».
[8] Non esistono dunque un sesso e un genere pre-discorsivi perché la parola è performativa.
Riferimenti bibliografici
Bartky Sandra Lee, Femininity and Domination: Studies, in the Phenomenology of Oppression, Thinking gender, New York, 1990.
Bourdieu Pierre, Risposte. Per un’antropologia riflessiva, Bollati Boringhieri, Torino, 1992.
Bourdieu Pierre, Per una teoria della pratica. Tre studi di etnologia cabila, Cortina Editore, Milano, 2003.
Bourdieu Pierre, Il dominio maschile, Feltrinelli, Milano, 2009.
Butler Judith, Gender Troubles: feminism and sub version of identity, Think in gender, New York, 1990.
Butler Judith, Corpi che contano: i limiti discorsivi del sesso, Feltrinelli, Milano, 1996.
Csordas Thomas, The embodiment as a paradigm for anthropology, in “Ethos”, volume 18, Issue 1, March 1990.
Csordas Thomas, The sacred self. A cultural phenomenology of charismatic healing, University of California Press, London, 1997.
Csordas Thomas, Incorporazione e fenomenologia, in “Antropologia”, Annuario diretto da Ugo Fabietti, 2003, anno 3 numero 3.
Deidda Francesca, Il corpo vergine di Maria, la Madre di Gesù: un’interpretazione storico-antropologica, tesi di laurea, anno accademico 2013-2014, Università di Bologna.
Douglas Mary, Purezza e pericolo, Il Mulino, Bologna, 1996.
Fusaschi Michela, I segni sul corpo, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.
Heritier Francoise, Dissolvere la gerarchia: Maschile e femminile 2, Cortina, Milano, 2004.
Heritier Francoise, Maschile e femminile. Il pensiero della differenza, Laterza, Roma, 2010.
Mauss Marcel, Teoria generale della magia e altri saggi, Einaudi Editore, Torino, 2000.
Mead Margaret, Maschio e femmina, Il Saggiatore, Milano, 1962.
Mead Margaret, L’adolescente in una società primitiva: adolescenza in Samoa, Editrice universitaria, Firenze, 1964.
Mead Margaret, Sesso e temperamento, Il Saggiatore, Milano, 2009.
_______________________________________________________________________________
Francesca Deidda, attualmente insegnante di lingua latina e inglese in un Istituto di recupero a Monaco di Baviera, ha conseguito il titolo di Laurea Magistrale in Antropologia culturale ed Etnologia, presso l’Università degli studi di Bologna, discutendo una tesi in “Storia del Cristianesimo e Antropologia medica”. È membro del Centro di Studi sul Genere e l’Educazione (Università di Bologna), del Centro di Studi interdisciplinari di Genere (Università di Trento) e dell’organizzazione ATGENDER, (Faculty of Humanities – Utrecht).
________________________________________________________________________________








