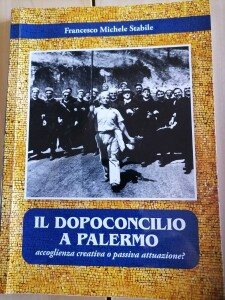Le corpose pubblicazioni di don Francesco Michele Stabile, sulla Chiesa cattolica siciliana con particolare riferimento ai suoi rapporti con il potere politico-mafioso, sono dei passaggi obbligati per chiunque voglia occuparsi della questione. Nei decenni di laboriose ricerche su documenti originali egli ha coperto per intero l’arco dell’ultimo secolo e mezzo: Il clero palermitano nel primo decennio dell’Unità d’Italia (1860 – 1870) in due volumi; La Chiesa nella società siciliana della prima metà del Novecento e I consoli di Dio. Vescovi e politica in Sicilia (1953-1963). Molto recentemente ha ripreso in maniera organica i tomi precedenti (ormai fuori commercio) nel voluminoso La Chiesa sotto accusa. Chiesa e mafia in Sicilia dall’unificazione italiana alla strage di Ciaculli (Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2022).
Per così dire a latere rispetto alle opere principali, don Stabile ha pubblicato una miriade di saggi in volumi collettanei e di articoli in riviste scientifiche e di varia cultura, concedendosi anche il piacere di agili pamphlet come Chiesa madre, ma cattiva maestra? Sulla “bolla” di Andrea Camilleri (Di Girolamo, Trapani 2020). A questa produzione ‘minore’ appartiene un recentissimo volumetto, stampato e distribuito in proprio: Il dopoconcilio a Palermo. Accoglienza creativa o passiva attuazione? (Officine Tipografiche Aiello & Provenzano, Bagheria 2022), che, a mio sommesso avviso, merita di essere conosciuto e un po’ anche discusso.
Il nucleo generativo è costituito da una relazione, tenuta dall’autore la domenica 26 gennaio 2020 presso l’Auditorium del SS. Salvatore di Palermo, nell’ambito di un convegno diocesano voluto dall’arcivescovo Corrado Lorefice per ricordare l’annunzio, da parte di papa Giovanni XXIII, il 25 gennaio del 1959, del Concilio ecumenico Vaticano II (che avrà, effettivamente, luogo dal 1962 al 1965). La questione che sta a cuore all’autore è sintetizzabile in una domanda: che effetti ha avuto il Vaticano II sulla vita delle diocesi siciliane (in particolare sulla diocesi di Palermo)? E non è una domanda puramente storiografica.
 Don Stabile, come nel suo stile, risponde in maniera documentata e misurata, senza vis polemica ma anche senza intenti apologetici: vuole parlare da storico che, in questo caso, è stato anche partecipe degli avvenimenti (è stato ordinato prete nel 1962, ha insegnato nella Facoltà teologica del capoluogo di Regione ed è stato anche vicario episcopale del cardinale Pappalardo per Bagheria e comuni limitrofi, oltre che suo consulente per molti interventi pubblici, prima di concludere il lungo ministero da parroco nella stessa Bagheria). Egli pubblica il volumetto in occasione del sessantesimo anniversario della sua ordinazione presbiterale per farne dono alle nuove generazioni di preti, quasi come un appello a recuperare quella spinta propulsiva che, dopo i pontificati di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, sembra essersi afflosciata sotto il peso di intempestive nostalgie.
Don Stabile, come nel suo stile, risponde in maniera documentata e misurata, senza vis polemica ma anche senza intenti apologetici: vuole parlare da storico che, in questo caso, è stato anche partecipe degli avvenimenti (è stato ordinato prete nel 1962, ha insegnato nella Facoltà teologica del capoluogo di Regione ed è stato anche vicario episcopale del cardinale Pappalardo per Bagheria e comuni limitrofi, oltre che suo consulente per molti interventi pubblici, prima di concludere il lungo ministero da parroco nella stessa Bagheria). Egli pubblica il volumetto in occasione del sessantesimo anniversario della sua ordinazione presbiterale per farne dono alle nuove generazioni di preti, quasi come un appello a recuperare quella spinta propulsiva che, dopo i pontificati di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, sembra essersi afflosciata sotto il peso di intempestive nostalgie.
Differente dall’autore per indole (sono un po’ meno mite caratterialmente), per competenze disciplinari (non sono uno storico, almeno non in senso professionale) e per status ecclesiale (non sono prete, ma ‘laico’ in molti sensi della parola), mi permetterò qualche chiosa a margine di cui mi assumo interamente la responsabilità.
Stabile segue, come criterio per la periodizzazione, gli episcopati che «si sono succeduti nella sede palermitana a partire da concilio: Ernesto Ruffini (1945 – 1967), Francesco Carpino (1967 – 1970), Salvatore Pappalardo (1970 – 1996), Salvatore De Giorgi (1996 – 2007), Paolo Romeo (2007 – 2015), Corrado Lorefice (2015 -….)». La “ricezione” delle decisioni conciliari fu all’inizio (1965 – 1967), con Ruffini, piuttosto un rigetto. Già a Roma si era distinto come leader della corrente conservatrice di minoranza. Un prete a lui molto caro, mi raccontò una volta che – tornando da una sessione del concilio in cui era stata approvata la Costituzione Dei Verbum (sul primato della Scrittura rispetto al Magistero papale ed episcopale) – volle confidargli fra le lacrime: «E’ la fine, è la fine. I vescovi hanno protestantizzato la nostra Chiesa». Infatti a suo avviso – come ribadì invano agli altri padri conciliari – «il Magistero sia ordinario che straordinario della Chiesa era regola prossima di fede, come regula regulans fidei et non regula regulata a Sacra Scriptura». Insomma, per lui, il cattolico avrebbe dovuto credere ciecamente qualsiasi dogma insegnatogli con autorità, sia che avesse sia che non avesse fondamento nella Bibbia.
Stabile sintetizza con un titolo efficace “Il tempo del card. Ernesto Ruffini”: «un monologo pieno di opere di carità». Un “monologo” perché la sua ecclesiologia, in linea per altro con l’impostazione predominante sino a Giovanni XXIII e a Paolo VI, non prevedeva alcun dialogo paritario fra i membri della Chiesa: come scrisse egli stesso in una Lettera pastorale del 1955, in essa vige netta «la distinzione tra autorità ecclesiastica e laicato: spetta alla prima insegnare e governare, il secondo è discepolo e suddito». “Pieno di opere di carità” perché egli fu davvero infaticabile nell’impegno a favore delle fasce disagiate della popolazione. Ma attenzione: questo attivismo, in sé lodevole, non era dettato solo da sincero amore per gli ultimi, bensì anche dalla volontà di strapparli alle tentazioni social-comuniste e di erigere la Chiesa a “baluardo” contro i “modernismi” teologici e socio-politici. Stabile contesta «la vulgata secondo la quale l’arcivescovo avrebbe negato l’esistenza della mafia» che «va ricondotta a Leonardo Sciascia» nel suo La Sicilia come metafora: infatti Ruffini fu probabilmente il primo vescovo a inserire il termine mafia all’interno di una Lettera pastorale (precisamente per la Pasqua del 1964) definendola, citando il discusso magistrato-scrittore Giuseppe Guido Lo Schiavo, «Stato nello Stato».
Il limite, enorme, di Ruffini sul tema è stato invece un altro: considerò la mafia solo come fenomeno criminale e, perciò, come «problema di ordine pubblico». Non seppe vedervi un sistema di potere affaristico-politico più ampio e pervasivo, anche perché sviato dall’avversione per gli Stati e i partiti social-comunisti: i mafiosi erano nemici dei suoi nemici e, se non avessero sparato e ucciso, avrebbero giocato un ruolo utile per la difesa dei valori tradizionali dell’Occidente cristiano.
Una riprova di questa incertezza di giudizio può individuarsi nella vicenda del nipote Attilio Ruffini che egli chiamò dalla Lombardia e sostenne nella scalata sino ai vertici della Democrazia Cristiana, anche grazie al matrimonio con Zina Maria La Loggia, figlia di una potente famiglia democristiana di Palermo. Poi, all’improvviso, è scomparso dalla scena pubblica. Secondo Vito Ciancimino aveva frequentato ambienti mafiosi: non certo in cerca di denaro, ma sicuramente di appoggi elettorali. È la ricorrente illusione di tanti politici: strumentalizzare la mafia ‘buona’ come se davvero esistesse e fosse distinta dalla mafia ‘brutale’.
Come una meteora, Francesco Carpino passò da Palermo fra il 1967 e il 1971. Egli, «pur essendo di vecchia formazione teologica, mostrò apertura alle novità del concilio. Al monologo di Ruffini seguì il dialogo di Carpino». Nell’ottobre del 1970 diede le dimissioni, le cui ragioni restano oscure. Paolo VI le respinse ma Carpino fu irremovibile e il papa, infastidito, lo relegò nella sua cittadina d’origine, Palazzolo Acreide, senza dargli incarichi di rilevo nella Curia romana. Abbiamo tre versioni: Carpino sostenne di non avere le forze necessarie «a fare fronte con energia al rinnovamento in atto nella vita della Chiesa»; altri – smentendo la narrazione del rifiuto delle dimissioni da parte di Paolo VI – ipotizzarono che gli furono imposte per punirlo di un’eccessiva indulgenza verso le Acli, la loro posizione critica nei confronti della DC e la scelta socialista; una terza versione sarebbe stata data da Carpino stesso in forma riservatissima. Una volta mi recai con alcuni amici a Palazzolo Acreide per visitarlo e ci accolse con molta gentilezza. Dopo il pranzo preparato dalla sorella Concettina, si appartò con uno di noi che, nel viaggio di ritorno verso Palermo, ci riferì uno sfogo accorato dell’ormai ex-arcivescovo: «Con quei delinquenti di preti palermitani non potevo proprio farcela più». Evidentemente non si riferiva alla totalità del clero, ma a una consistente e perniciosa fetta. In altri presbiteri lasciò, invece, un ricordo ammirato. Come scrisse monsignor Francesco Pizzo, in contrapposizione non tanto velata con il predecessore Ruffini, Carpino «non ha occupato un posto di potere, non è stato un capo od un principe; ma […] è stato un fratello tra i fratelli».
Al breve episcopato di Carpino successe il lungo ‘governo’ di Salvatore Pappalardo (1970 – 1996), «il mediatore». Ricordo l’impressione di novità che ricevemmo da un vescovo giovane, che guidava da sé l’automobile, «familiare nel contatto, senza genuflessioni nel saluto e senza bacio nell’anello, senza la tradizionale magnificenza che, al di là della personale vita privata del vescovo [di Ruffini si vociferava che andasse in giro, sotto la porpora, con indumenti rattoppati], dava della Chiesa un’immagine più che di sacralità, di potenza».
Don Stabile, opportunamente, elenca i tanti meriti di Pappalardo, anche dal punto di vista del suo distanziamento dalla DC e dell’atteggiamento – «né si condanna né si appoggia» – verso quei tentativi di aggregazione politica, come “Una città per l’uomo”, al di fuori del partito cattolico di maggioranza. Anch’io potrei aggiungere episodi che ricordo con ammirata simpatia, come quando un gruppo di cattolici ‘ortodossi’ si recò da lui per chiedergli di ‘scomunicare’ me e alcuni amici ugualmente tacciati di ‘eresia’. Egli ci convocò e ci riferì la sua (saggia) risposta ai denunzianti: «La Chiesa attraversa un periodo di grande incertezza e oscurità. Non mi pare il caso di spegnere nessuna fiammella. Lavorate con serenità: dai frutti si giudicherà l’albero».
Don Stabile, oltre che parole di stima, inserisce sommessamente qua e là delle note critiche. Per esempio, a proposito di una Lettera dell’episcopato siciliano del 1978, egli nota:
«Possiamo cogliere nel documento un primo lento distacco dalla concezione sacrale di una storia della salvezza parallela alla storia umana e una timida apertura a lasciarsi provocare da Dio attraverso gli eventi storici. La Chiesa deve fare opera di mediazione tra la vecchia concezione sacrale, immutabile, e la modernità che richiede l’accettazione della laicità, del pluralismo con capacità però di discernimento critico per cogliere il meglio che va emergendo. Però, nonostante affermazioni di buona volontà, la problematica della storia e della modernità, enunziata con la complicità di qualche teologo, credo rimanesse ancora nei vescovi un problema non pienamente risolto e che stesse ancora nella difficoltà di accettare la storia, i fatti, come luogo teologico attraverso cui Dio parla alla sua Chiesa, l’origine dell’ambivalenza di tante posizioni dei vescovi e dello stesso Pappalardo, che per un verso dicevano di accettare il nuovo, per altro riproponevano su alcune problematiche non l’apertura di un dialogo, come chiedeva Paolo VI, ma a volte una contrapposizione tra visione cristiana della vita e una visione non cristiana, accomunando in un unico fascio secolarizzazione, prassi marxista, umanesimo laicista, freudismo».
Non senza contraddirsi, nei 26 anni di episcopato, Pappalardo talora auspicava talaltra condannava forme di intesa e di collaborazione fra il cristiano e chi, «del mondo e della vita ha tutt’altra concezione». Ricordo che la sera del 31 dicembre 1983 la cattedrale era gremita di manifestanti per la pace provenienti da tutta Italia e da vari schieramenti ideologici. Il clima di entusiasmo fu spento, inopinatamente, dall’omelia del cardinale: «Qui siamo in tanti a chiedere pace per il mondo. Ma sia chiaro che solo i cristiani sanno cos’è la pace e solo essi la possono portare al mondo in virtù della grazia di Cristo». Rimasi sconcertato. Come tutte le volte in cui lo stesso arcivescovo avvertiva l’esigenza di precisare, smussare, addirittura talora edulcorare, le sue vibranti condanne della mafia. Forse era vera la voce che lo voleva proiettato verso una meno scomoda poltrona di Prefetto di qualche Congregazione vaticana alla quale difficilmente avrebbe avuto accesso se fosse apparso troppo critico verso il sistema di potere democristiano e troppo morbido verso PCI, Radicali e ‘laici’ vari.
Francesco Michele Stabile sottolinea, a ragione, i meriti di Pappalardo nell’indire grandi assemblee diocesane per sperimentare forme di co-gestione ‘sinodale’ della Chiesa palermitana, aperte non solo a preti e frati/suore, ma anche a fedeli credenti e praticanti. Ma quanto si trattò davvero di una rivoluzione teologico-pastorale e quanto di una strategia propagandistica di facciata? Ho il ricordo di una chiacchierata, dopo una cena fra pochi amici, in cui gli esternavo alcune perplessità sui frutti reali di quelle giornate un po’ caotiche in cui le lamentele e le denunzie di ciò che non andava, nella società e nella Chiesa, prevalevano di gran lunga sulle proposte costruttive e soprattutto sull’impegno effettivo per avviarne l’attuazione. Mi sorrise un po’ ironicamente – non era un tipo cupo – e mi rispose: «Ma che ti aspetti da queste assemblee generali? Si organizzano perché la gente ha bisogno di sfogarsi. Poi le scelte finali spettano a me».
Qualcosa di simile accadde in un’altra occasione quando gli manifestai disappunto per il fatto che quasi nessuna parrocchia della diocesi aveva ottemperato alla sua richiesta ufficiale di rendere pubblici i bilanci economici in modo da realizzare una qualche forma di perequazione fra parroci ricchissimi della Palermo ‘bene’ e parroci molto poveri di piccoli Comuni dell’entroterra (come era stato auspicato in uno dei ‘sinodi’ diocesani). Anche questa volta la risposta fu formulata con un tono disincantato: «La circolare l’ho mandata a ogni parroco. Se non vogliono rispondere, che ci posso fare? Gli mando i carabinieri a casa?»
Comunque l’elezione di Giovanni Paolo II fece avvertire gli effetti ‘normalizzatori’ anche in Sicilia. Pappalardo, che pure in linea teorica aveva sostenuto che non fosse più necessaria l’unità dei cattolici in un solo partito politico, di fatto non mancò mai di stimolare il rinnovamento della DC e di mettere in guardia dall’adesione a partiti differenti che avevano, con la dottrina sociale della Chiesa, convergenze solo parziali. Questa strategia dell’unico ovile partitico è destinata al fallimento (gli elettori cattolici sarebbero stati attratti sempre più da altre organizzazioni politiche, come La Rete di Leoluca Orlando e le Leghe del Nord), ma anche «il grande sogno del rinnovamento conciliare di una Chiesa povera di potere, dalla parte dei poveri, cominciò a sgretolarsi. E fu in questo periodo che si allentò la convergenza tra l’arcivescovo e parte del clero e dei cattolici più impegnati nel campo religioso e sociale che non intesero seguirlo nella scelta della riservatezza e dell’avallo alla Dc».
Veramente ci furono episodi di rottura e di contestazione verso Pappalardo, da parte di preti che gli erano stati molto vicini nel suo primo decennio di episcopato, che andarono al di là dell’allentamento della “convergenza” fra loro e il vescovo: ma don Stabile non ritiene opportuno rievocarli. Né, avendoli appresi da altri senza esserne testimone diretto, mi pare giusto che sia io qui a raccontarli.
L’espressione, trita, “senza infamia e senza lode” calza a pennello per sintetizzare gli 11 anni dell’episcopato del cardinale De Giorgi (1996 – 2007), un pugliese bonaccione determinato, per dirla con un’altra formula stereotipata, a vivere e a lasciar vivere. La fotografia della diocesi di quel periodo, scattata dal cattolico democratico Nino Alongi all’inizio del Terzo Millennio, è eloquente:
«La Chiesa palermitana parla di poveri, ma non è povera, predica la solidarietà ma non è solidale, dice di volere dialogare con la società civile ma di fatto resta chiusa nell’integralismo di sempre. Al collateralismo partitico, devastante per la politica e per la religione, ha sostituito forme di integrazione con le istituzioni dagli effetti altrettanto perniciosi; al protagonismo politico clientelare ha fatto seguire quello civile, attraverso iniziative inedite di volontariato che, in molti casi, si sono rivelate non meno forvianti; al trionfalismo preconciliare si sono aggiunte manifestazioni di ostentazione ancora più mondane».
Ovviamente De Giorgi non è l’unico responsabile di questa sorta di letargo intellettuale e sociale in cui l’intera Chiesa palermitana ristagna da un ventennio. Anzi, sarebbe scorretto non riconoscergli almeno il merito di aver istituito una Commissione di teologi per stilare una sorta di decalogo da seguire nel caso che un presbitero fosse chiamato da un latitante (mafioso) a celebrare i sacramenti nella cappella del covo segreto (come, ad esempio, fece il carmelitano scalzo Mario Frittitta su richiesta del boss Pietro Aglieri): un decalogo che prevedeva, dopo un primo incontro, che il latitante si costituisse alle autorità giudiziarie, chiedesse perdono per i danni provocati nel corso della sua carriera criminale, collaborasse per bloccare le attività illegali dei suoi colleghi di cosca.
Non certo più brillante è stato l’episcopato di Paolo Romeo (2007 – 2015), un diplomatico di lungo corso che – proprio grazie alla nomina ad arcivescovo di Palermo – raggiunge, con qualche anno di ritardo, l’agognata porpora cardinalizia. Di lui don Stabile ricorda due informazioni: la prima, positiva, che portò felicemente a termine l’iter ‘canonico’ (avviato dal suo predecessore De Giorgi) del riconoscimento a don Pino Puglisi del titolo di “martire” e di “beato”; la seconda, meno positiva, di aver lasciato cadere nel 2012 la proposta di un “Osservatorio ecclesiale” sulla mafia da istituire presso la Conferenza episcopale siciliana.
Con la nomina di don Corrado Lorefice (2015) siamo in piena attualità. La scelta di un semplice prete di provincia, in contatto con importanti centri di studi storici italiani, apparve subito in sintonia con lo stile di papa Francesco. Memore delle disavventure del cardinale Carpino, scrissi però sulle pagine siciliane di “Repubblica” che forse gestire una diocesi come Palermo si sarebbe rivelato un impegno al di sopra delle forze di un presbitero nato e cresciuto in ambienti molto più ‘familiari’, ‘protetti’. Sino ad oggi pare che, purtroppo, i fatti stiano confermando le mie preoccupazioni di allora. Don Lorefice è una persona preparata culturalmente, onestissima, con viva sensibilità civica: presentandosi alla città, disse di arrivare con il Vangelo in una mano e la Costituzione italiana nell’altra ed ebbe modo di citare l’esempio non solo di don Pino Puglisi, ma anche di Peppino Impastato.
Tuttavia – almeno sino a questo momento – non ci sono state svolte notevoli; anzi non son mancate certe ingenuità (in conseguenza delle quali la diocesi è forse l’unica grande arcidiocesi italiana senza un vescovo ausiliare) né alcune delusioni per le sue decisioni di governo. Perfino don Stabile, con tutta la sua delicatezza espressiva, non può fare a meno di notare che «l’impegno del nuovo arcivescovo, che si è richiamato allo spirito e al metodo sinodale per coinvolgere tutta la comunità, procede con lentezza». E ancora: «I frutti del coinvolgimento di tutta la comunità diocesana in un cammino sinodale sono da maturare dal momento che si nota ancora una certa distanza tra gli enunciati programmatici e la prassi pastorale delle comunità parrocchiali». Facendo eco ad alcune denunzie della teologa Valeria Trapani (che, nel 2019, si chiedeva «se la Chiesa di Palermo non abbia semplicemente subito una battuta d’arresto negli ultimi anni, o forse addirittura una retrocessione di pensiero»), don Stabile aggiunge: «Le donne, e non solo le donne, lamentano che dai primi decenni del nuovo secolo qualcosa si perde dell’eredità conciliare e che la ministerialità delle donne, pur essendo la presenza delle donne elevatissima, rimane ancora subalterna nei ruoli istituzionali della diocesi».
D’altronde, di che meravigliarsi se la generazione dei preti formatisi nello spirito innovatore del Concilio Vaticano II è ormai in quiescenza (quando non al camposanto) e se la maggior parte del clero attuale (nella fascia tra i 30 e i 50 anni) ha scelto di diventare prete nel clima sostanzialmente reazionario di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI? Come a Roma non basta un papa per invertire rotta, così a Palermo non basta un arcivescovo.
Ma ammettiamo pure che si realizzi il sogno di don Stabile di un «popolo di Dio all’interno del quale il presbitero e il vescovo, scelti dalla comunità, che ne riconosce carisma e ministero di comunione indipendentemente dal fatto che siano celibi o sposati, oppure uomo o donna, e segnati dall’imposizione delle mani, offrono il loro servizio di accompagnamento e di guida in unione con tutti gli altri carismi e ministeri per la crescita della comunità»; ammettiamo che davvero «gerarchizzazione e clericalizzazione» vengano scardinate in quanto «fonte dell’autoritarismo, del centralismo, del paternalismo, degli abusi sessuali di alcuni del clero»: potremmo forse affermare che la crisi della Chiesa cattolica si potrebbe ritenere superata?
Questi dibattiti intra-ecclesiali suscitano un misto di tenerezza e di umorismo: si svolgono come se, intanto, a livello planetario, non ci fosse una crisi di tutto il cristianesimo; anzi di tutte le religioni monoteistiche; anzi della categoria stessa “religione”. Don Francesco Michele Stabile, ancorato pacificamente nella sostanza del Credo tradizionale, non appare sfiorato da queste problematiche su cui si sta interrogando la teologia più avanzata di tutto il mondo. Eppure, da persona intelligente e consapevole dei propri limiti disciplinari, lascia aperto qualche spiraglio: «Essendo questa una lettura della vita ecclesiale contemporanea, più che allo storico il giudizio appartiene agli studiosi di pastorale, ai teologi, ai sociologi e agli psicologi». E, aggiungerei sommessamente, ai filosofi (anche se si tratta di una categoria professionale che il mio amico storico ama tanto poco quanto i giuristi).
Dialoghi Mediterranei, n. 61, maggio 2023
________________________________________________________
Augusto Cavadi, già docente presso vari Licei siciliani, co-dirige insieme alla moglie Adriana Saieva la “Casa dell’equità e della bellezza” di Palermo. Collabora stabilmente con il sito http://www.zerozeronews.it/. I suoi scritti affrontano temi relativi alla filosofia, alla pedagogia, alla politica (con particolare attenzione al fenomeno mafioso), nonché alla religione, nei suoi diversi aspetti teologici e spirituali. Tra le ultime sue pubblicazioni si segnalano: Il Dio dei mafiosi (San Paolo, 2010); La bellezza della politica. Attraverso e oltre le ideologie del Novecento (Di Girolamo, 2011); Il Dio dei leghisti (San Paolo, 2012); Mosaici di saggezze – Filosofia come nuova antichissima spiritualità (Diogene Multimedia, 2015); La mafia desnuda – L’esperienza della Scuola di formazione etico-politica “Giovanni Falcone” (Di Girolamo, 2017); Peppino Impastato martire civile. Contro la mafia e contro i mafiosi (Di Girolamo, 2018), Dio visto da Sud. La Sicilia crocevia di religioni e agnosticismi (SCe, 2020); O religione o ateismo? La spiritualità “laica” come fondamento comune (Algra 2021).
______________________________________________________________