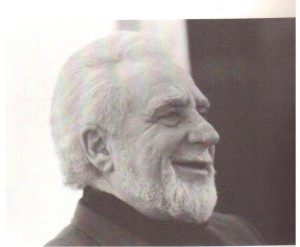Si può ambire a una restituzione, se non esaustiva, rappresentativa di un volume di cinquecento pagine, nel quale l’autore mette a giorno risonanze e memorie, tracce e testimonianze di un impegno di studi e ricerche che si dispiega in quasi quaranta anni di vita? Sicuramente no, perché se è vero che il tempo lineare consente convenzionalmente di perimetrare le tappe di un individuo, di una stagione storica, di un susseguirsi di eventi, occasioni, incontri ed esperienze umane, non meno vero è che il tempo degli umani si dispiega spesso secondo itinerari non convenzionali, reclama una singolarità che sfugge a ogni paradigma unilineare.
Così è stato per Antonino Cusumano che, con il libro Per fili e per segni. Un percorso di ricerca (Museo Pasqualino edizioni, Palermo 2020), ci offre l’occasione preziosa di emancipare dai vincoli della nuda cronologia il suo tempo e quello di chi lo ha accompagnato, a partire dalla prima stagione formativa, «lungo i tornanti di un’antropologia appresa e praticata negli anni in cui Antonino Buttitta ha traghettato la disciplina, sulla scia dell’insegnamento di Giuseppe Cocchiara, definitivamente al di là della tradizione demologica e filologica».
Per fili e per segni, in questa prospettiva, è anzitutto un tributo di fedeltà a un apprendistato che inizia nella prima metà degli anni Settanta del Novecento e si salda a quell’Elogio della cultura perduta scritto da Buttitta nel 1977, che ha rappresentato per una generazione di allievi un vero e proprio manifesto programmatico, l’ordito metodologico e critico a partire dal quale diventa possibile ritessere in un’unica trama i fili intrecciati e policromi delle culture, senza perdere di vista la lezione di Buttitta: «l’uomo è umano in quanto parte di un tutto, ma la sua umanità consiste nell’essere un tutto in una parte».
I saggi che compongono il libro testimoniano, quindi, anzitutto il clima «fervido di idee e di progetti» che prende le mosse da quegli anni, da quella Scuola, da un Maestro al quale è affettuosamente dedicato.
Forme e Segni, Figure e Orizzonti sono le quattro sezioni nelle quali l’autore traccia il calco di alcuni temi portanti delle sue ricerche: quattro termini che obbediscono con fedeltà quasi filologica sia agli indizi evocati da un titolo decisamente suggestivo, sia a un itinerario solidale con gli universi spazio-temporali attraversati negli anni.
Così, con una raffinata riflessione propedeutica sull’arte popolare siciliana (cap.I) Cusumano introduce il lettore anzitutto alla decifrazione delle forme della creatività folklorica e dei meccanismi che garantiscono continuità semantica alla comunicazione; quindi, a quelle corrispondenze tra morfologia, norma estetica e funzioni sociali che contraddistinguono la tradizione iconografica (cromatica, compositiva, rappresentativa) di diversi repertori artistici. Si comincia con le immagini di devozione (cap. II) legate alla tradizione figurativa popolare siciliana: fogli volanti recanti le figure di santi protettori, racconti illustrati nei quali ricorrono topoi narrativi su cui si edificano le diverse leggende di fondazione di un culto, repertori iconografici riconoscibili nelle collezioni del Museo Pitrè o in quell’inventario raccolto e documentato da Giuseppe Cocchiara, a cui si devono le mappe delle botteghe di “stampasanti” ma anche la geografia iconografica di una pietà devozionale spesso esposta all’oblio della memoria. Senza soluzione di continuità, dall’iconografia dei santi l’autore ci deporta nel III capitolo verso le forme non meno cariche di efficacia simbolica del pane in Sicilia: un principio nutritivo del quale segnala la «biplanarità, il suo essere alimento e segno, farina e parola […], fino ad assumere valore di anamnesis non solo del corpo ma anche del sacrificio del dio salvatore» attraverso il sacramento eucaristico che rammemora l’Ultima Cena. Da una riflessione a tutto campo sulla civiltà e sulla “comunità del pane” tra mito e storia, si procede verso l’analisi del ricco repertorio paremiologico siciliano; quindi delle forme devozionali di una “religione del pane” evidenziata a partire dal suo transito di casa in casa, dalla sua funzione di suggello di alleanze e strategie di solidarietà, fino ai pani votivi a temi zoomorfi e naturalistici che entrano a pieno titolo nel sistema rituale e cerimoniale delle architetture effimere.
Se è vero che pani fa speranza e vinu fa danza, il IV capitolo (“Pane al pane e vino al vino”) ci svela gli arcani di un legame ineludibile tra il grano e la vite, prodotti umanizzati della riproduzione ciclica della terra, che l’autore consegna al palinsesto simbolico di un Mediterraneo esemplare; per poi declinare le proprietà del vino nei proverbi siciliani, nei rituali catartici e propiziatori, nella microritualità domestica, nel tempo commemorativo del culto dei defunti e infine in quell’epifania del mistero che fa di pane e vino due metà dello stesso simbolo, «le parti costitutive di un medesimo ideogramma».
Il viaggio nelle forme prosegue con il capitolo dedicato alle proprietà simboliche del presepe (colto o popolare, esteso o miniaturizzato), che diventa narrazione plastica, teatro di un mondo che consegna alla tridimensionalità di un impianto scenografico ripetibile il tempo mitico della natività e il tempo storico della ritualità domestica. Anche qui, la fibra analitica e la pazienza riflessiva dell’autore promettono e onorano l’affidabilità di un metodo ormai riconoscibile dal lettore: la progressiva restituzione di un repertorio regionale che riposa «in un ricchissimo patrimonio di storie cumulative e di culture figurative diverse, che nel loro incontrarsi si sono reciprocamente rinnovate e riplasmate».
Se nel presepe siciliano si miniaturizza l’utopia di un paesaggio immaginario che stempera le asprezze della vita quotidiana, nei torni che plasmano l’argilla si materializzano le forme e le varianti estetiche di un’arte ceramica siciliana che nel VI capitolo si fa specchio riflesso della storia economica, sociale e culturale della regione. Sono pagine consegnate a una serrata lucidità diacronica e sincronica, che lasciano intuire, ad esempio, le potenzialità comparative di uno sguardo sulle consonanze decorative e formali delle terracotte di Mazara o di Burgio, confrontate con quelle tunisine di Djerba o di Nefta. Asse strategico privilegiato «del rapporto tra la Sicilia e gli Stati nordafricani, tra la nostra Isola e i Paesi maghrebini» la ceramica diventa così imago mundi «di quel tenace ordito di esperienze e di memorie che, a livello di strutture profonde, tiene insieme le civiltà mediterranee».
La prima sezione si chiude con un volontario dissolvimento delle forme plastiche ed estetiche della cultura materiale siciliana, per guadagnare il mito attraverso le Sirene, ibride rappresentazioni figurali di un ossimoro estetico e simbolico di cui Cusumano nel saggio ripercorre diacronicamente le varianti mediterranee, per poi approdare, ancora una volta, nella dimensione insulare dei repertori narrativi siciliani. La continuità di un’icona della seduzione e della perdizione affiora allora nelle coste di Capo Peloro, nella fata della Contea di Modica dai poteri divinatori, nella perenne immersione di Colapesce, nella metafora del tuffo nelle acque marine come gesto rituale di morte e rinascita.
Dopo le Forme, i Segni della seconda sezione del libro ci consentono anzitutto di ridisegnare la mappatura simbolica di alcuni spazi urbani consegnati al motivo della santità: San Calogero ad Agrigento e San Vito a Mazara del Vallo (nei primi due capitoli) diventano così paradigmi esemplari di una tradizione che rinnova connessioni intime con il ciclo agrario, paesaggi mitologici mediterranei rigenerati dai pani effimeri anatomorfi nei quali rivive il corpo smembrato di un dema; oppure figure il cui potere terapeutico e taumaturgico medica i morsi della follia, argina gli effetti devastanti della peste o di ripetute carestie. Sullo sfondo, le insidie di una natura indomita (mare, monti, spazi aridi) o benefica (fonti, acque lustrali) che rivivono nelle funzioni celebrative di un festino.
Quel mare che nel nucleo costitutivo del festino di Mazara in onore di San Vito diventa spazio elettivo del culto dei pescatori, nel capitolo dedicato a “Mazara città mercato senza mercato” sembra «scorrere nelle vene dell’abitato, nelle fibre più segrete del tessuto urbano […] trasformando il suo porto in luogo d’incontro e di comunicazione tra i popoli, emporio e deposito di tutti gli odori e i sapori di quel Canale che noi chiamiamo di Sicilia e che dall’altra sponda chiamano di Tunisi». La storia di una città posizionata tra due sponde diventa allora la storia di un impareggiato avamposto di frontiera, di uno spazio urbano edificato attorno alla foce di un fiume, in cui il mercato del pesce ha rappresentato fino ad anni recenti il luogo di elezione della socialità e l’espressione tautologica di una topografia carica di valenze simboliche: «la marina è il mercato e il mercato è la marina». La restituzione storica e le osservazioni etnografiche sono, come già altrove, esemplari. Anche la scrittura, sicura e asciutta, è un gioco di trame e fili sottili che irretiscono la mente del lettore nella tessitura penetrante della storia di una città posseduta dal mare.
È ancora attingendo ai fondali della storia locale che Cusumano ci consegna nel IV capitolo la memoria del mare come segno e luogo ricapitolativo dello spazio e del tempo, cosmos identitario delle comunità dedite all’attività alieutica. Ricordandoci che anche quando mutano i mezzi e le strategie di produzione, restano immutati astuzie e segreti professionali, procedimenti empirici, linguaggi, posture, credenze, rappresentazioni simboliche e modelli etici «di una cultura che “per natura” fonda, anzi affonda sul mare la propria identità».
Alla funzione paradigmatica della memoria autoctona si ispirano anche il V e il VI capitolo della sezione, dove l’autore ci riporta nel tempo della festa – recuperando alla dialettica passato-presente la processione dei Misteri di Trapani – e in quello di Gibellina, una città che nel 1968 è stata rasa al suolo da un sisma che «ha prodotto diaspora e sradicamento, ha distrutto le coordinate di quella geografia mentale che guida alla partizione degli orizzonti, alla definizione dei percorsi, delle distanze e dei confini». Di queste pagine colpisce la fibra analitica con cui l’autore ci avvicina a un luogo dell’abitare che una ricostruzione insensibile alla storia locale ha paradossalmente trasformato nel luogo del transitare. «Utopie infrastrutturali, gigantismo metropolitano e ipertrofia degli spazi hanno creato un’insanabile frattura con quella forma urbis nella quale s’identificava la popolazione contadina di Gibellina». Resta la memoria, il ricordo del paese perduto a tenere vivo nella comunità il bisogno insopprimibile di essere nel tempo, di opporsi alla disgregazione dell’oblio.
La seconda sezione del libro si chiude con il VII capitolo, il cui titolo ripropone quello del libro: con l’intento di ripensare, “per fili e per segni”, tecniche, campi semantici, trame simboliche dell’arte della tessitura, Cusumano riparte da Gibellina, dalla reliquia di stoffa denominata presente che è andata distrutta sotto le macerie del terremoto: la sua ostensione rituale nel tempo della festa consentiva alla comunità di esibire la propria devozione religiosa, consegnandola a un sistema cerimoniale peraltro ampiamente diffuso anche nei contesti islamici del Maghreb. A partire da quel presente sottratto alla storia, Gibellina è diventata sede di un Museo che accoglie drappi disegnati da famosi artisti contemporanei o eseguiti da ricamatrici locali; una sorta di museo-officina, che coniuga il modello espositivo con il laboratorio inclusivo. Dalle teche di un museo ai crinali della storia, la tessitura diventa un ulteriore motivo di esplorazione di una techne che viene ripensata in ampia prospettiva comparativa.
Nella terza sezione del volume, il paradigma simbolico cede il passo alle Figure in carne e ossa che hanno contrassegnato la tradizione demologica siciliana o ne hanno consentito il transito in un’antropologia pionieristica: da Giuseppe Pitrè e le sue note sul vocabolario marinaresco siciliano a Raffaele Castelli, suo collaboratore, un “intellettuale periferico” convertito al folklore; dalle “province” di un sapere folklorico che trova il proprio riscatto proprio nella marginalità territoriale di chi ne accoglie la dignità scientifica alla rilettura avvertita dell’opera miliare di Giuseppe Cocchiara, Storia del folklore in Italia. Il V capitolo Cusumano lo consacra alla parola poetica di Ignazio Buttitta, la cui eredità rivive nel «patrimonio di accenti, ritmi, suoni e toni nelle loro infinite variazioni popolari, un capitale immateriale che restituisce il tessuto connettivo dell’idioma di un popolo».
Nel capitolo successivo il debito della memoria è rivolto alla figura di Antonino Uccello e alla sua Casa Museo, «straordinaria testimonianza di come, attraverso un patrimonio di oggetti disposti entro un museo declinato nelle dimensioni e nell’orizzonte di una casa, di un luogo domestico di memorie familiari, sia possibile interpretare la tradizione storica e oggettivare l’identità culturale di una intera comunità». Seguono poi le pagine dedicate ad “Antonino Buttitta, un Maestro di umanità” che l’autore consegna alla luce soffusa e diffusa di un affresco biografico commovente e di un itinerario intellettuale tanto rigoroso quanto irrituale. La sezione si chiude con un elogio al minimalismo poetico di Nino De Vita, di cui Cusumano rilegge la vicenda esistenziale e la fortuna letteraria nel segno del paradosso.
Nell’ultima sezione del libro si dischiudono, infine, gli Orizzonti che riattualizzano la prima avventura antropologica dell’autore, vale a dire il suo interesse per i movimenti migratori transnazionali che hanno visto la Sicilia tramutarsi da terra di esodo a terra di accoglienza. Da Nord a Sud, prima ancora che nella traiettoria inversa e più usuale, il I capitolo ripercorre anzitutto alcuni momenti della storia migratoria dei Siciliani in Tunisia: si tratta di uno scritto riconducibile al 1998, che si affida alla bibliografia e alla letteratura di quegli anni e che (come esplicita nelle pagine introduttive) l’autore ha deciso consapevolmente di non aggiornare, per mantenere coerente la cronologia interna ai saggi che compongono quest’ultima sezione. Il valore aggiunto di una simile scelta lo si coglie considerando l’attualità di alcune intuizioni, la consapevolezza ancora oggi rara della necessità di uno sguardo sul presente illuminato dalla ricerca di un passato che dia ragione di movimenti migratori mai spontanei né casuali. Cosicché, tra le ragioni che negli ultimi decenni hanno orientato i tunisini verso la Sicilia affiora qualcosa di più del braccio di mare di soli 138 chilometri che separa le due coste: il flusso del presente appare piuttosto come un “ritorno”, «un’onda superficiale del più grande e incessante movimento di uomini e cose che da millenni percorre in profondità lo spazio mediterraneo. Soltanto l’appannarsi della nostra identità culturale e la rimozione della nostra memoria storica possono indurci a identificare i lavoratori tunisini in Sicilia nella categoria paradigmatica degli stranieri». La questione viene rinnovata nel II capitolo, dove il motivo delle migrazioni transnazionali si prolunga nelle polemiche degli ultimi anni, nelle “sindromi da invasione” che mascherano i grandi squilibri di un mercato del lavoro in cui la manodopera straniera risponde di fatto «a ben visibili esigenze delle società locali, alle necessità delle loro popolazioni, alle prestazioni e all’efficienza dei servizi essenziali».
È nel segno di una sorveglianza antropologica delle retoriche dell’integrazione che il III capitolo, dedicato alla mediazione scolastica e ai processi di acculturazione dei minori stranieri, mette a nudo la complessità e l’ambivalenza di un percorso di apprendimento linguistico ispirato alla valorizzazione della lingua materna. L’apparente plurilinguismo dei figli di immigrati nati a Mazara che frequentano la scuola tunisina rischia di diventare, in questa prospettiva, un’ulteriore esposizione alla vulnerabilità sociale. «Il plurilinguismo linguistico è ricchezza e duttilità culturale, ma può rischiare anche di produrre, se non è sostenuto da interventi coerenti e coordinati, disagi, disorientamento e perfino afasia». La sfida proposta dall’autore consiste nell’incrementare iniziative già felicemente sperimentate, ma interrotte per mancanza di finanziamenti: ad esempio «un progetto d’integrazione scolastica, attraverso un modulo bilingue di due prime classi con alunni italiani e tunisini, che proponeva l’adozione di attività didattiche d’insegnamento misto, ovvero della lingua e della cultura araba e italiana insieme».
È ancora nel segno di uno “sguardo da vicino” che nel IV capitolo la voce critica dell’autore riattualizza la ricchezza e la complessità di un’esperienza di ricerca sui tunisini di Mazara del Vallo, avviata con una tesi di laurea discussa nel 1972 e pubblicata nel 1976 da Sellerio con il titolo Il ritorno infelice. Da quella ricerca emergevano spie eloquenti di un’esperienza di integrazione a suo modo pionieristica. «Gli stranieri con le loro famiglie hanno dato vita a originali forme di comunità stanziali, hanno saputo costruire un nucleo riconoscibile di reti associative, modelli di convivenza o di semplice coesistenza». In un “ritorno infelice trent’anni dopo”, la rivisitazione analitica di questa realtà deportata nel presente tenta di arginare le gravi inadempienze di un’antropologia che ha finito per accordare al mondo politico e giornalistico piena legittimità di uso e abuso di un alfabeto improprio, consacrato a stereotipi, luoghi comuni e cascami ideologici irricevibili, consentendo di fatto l’esproprio mediatico di ogni riflessione critica sull’immigrazione straniera in Italia.
Gli ultimi tre capitoli di questa sezione rappresentano la replica più efficace contro questo rischio. In essi lo sguardo antropologico dell’autore si fa denso e serrato, si apre a nuove prospettive riflessive, a nuovi orizzonti critici. Così ad esempio il cibo multietnico può diventare nella piazza di Ballarò un laboratorio sperimentale di nuove pratiche alimentari.
«Qui si alternano e si sovrappongono le insegne che celebrano le virtù del kebab o del pollo allo spiedo, dello shingara indiano […] o del panino con le panelle o con la meusa, del couscous, del fufù ghanese […] o del dalfuri bengalese […]. Le stesse insegne dei ristoranti rivelano i tentativi di riposizionamento culturale, alcune adottando espressioni europee in consonanza con influssi cosmopoliti […], altre esplicitando una certa confidenza con la realtà ospitante (come il tunisino La Traviata)».
Se la cucina etnica si incrocia e s’interpone con quella autoctona, diventa verosimile prolungare la sfida dell’incontro anche con quelle “vite possibili” che nel VI capitolo Cusumano ripensa come figure (o vite nude) di un peregrinare contemporaneo, confidando in una nuova antropologia esistenziale nella quale ogni vita, nel suo farsi racconto e investigazione, diventa «il punto d’incrocio in cui letteratura e antropologia si sfiorano, dialogano e trovano corrispondenze a livello teorico e formale».
Il volume si chiude con un ultimo, intenso omaggio a quel Mediterraneo che abbiamo visto quasi in ogni pagina lambire le coste di una Sicilia «cerniera e anello di congiunzione tra aree comunicanti, ponte e frontiera (thaghr) tra mondi, passaggio aperto, paesaggio vivificato da intensi processi osmotici». Come nelle altre sezioni, anche qui le immagini che corredano i saggi aprono finestre sull’oggi e al tempo stesso alludono agli scenari replicabili (come forme, segni, figure, orizzonti) di un tempo metastorico. Penso per tutte all’ultima foto di Nuccio Zicari: una “Natività” sul ponte di una nave satura di rifugiati che contende il primato della sacralità e del realismo alla malinconica Natività di Caravaggio, concepita nel suo brevissimo soggiorno palermitano.
Si chiude il libro e si apre la via per ripensare i suoi transiti, i suoi approdi, le concordanze storiche e i reincominciamenti mitici, gli enigmi di una lingua e le folgorazioni di un’immagine. Ho scelto per raccontarlo la lectio facilior, ripercorrendolo “per filo e per segno” nella sua evoluzione lineare. Sono infatti convinta dell’utilità di servizio di una recensione che incoraggi il lettore a cogliere le evidenze di un testo, che lo motivi a riconoscerne le articolazioni interne. Quel che resta sommerso nella mia restituzione è il processo intimo di elaborazione, l’intenzione innovativa e la fibra riflessiva che includono a pieno titolo la fatica di Cusumano nella tradizione migliore di un’antropologia “in stile italiano”: uno stile che ha ereditato un ricco patrimonio documentario, in continuità con le radici di una demologia rigenerata, senza tradire un modello di trasmissione generazionale, ma al tempo stesso rifunzionalizzando i contenuti e i metodi della ricerca nei quadri di un impegno etnografico consapevole sia della contemporaneità che delle stratificazioni cronologiche su cui riposa il presente di ogni contesto socio-culturale.
Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020
______________________________________________________________
Laura Faranda, professore ordinario di Antropologia culturale all’Università di Roma “Sapienza”, tra i suoi percorsi di ricerca studia l’antropologia del mondo antico; l’antropologia simbolica, con particolare attenzione al rapporto tra corpo, identità di genere e linguaggio delle emozioni; l’antropologia dei processi migratori; l’etnopsichiatria e la psichiatria coloniale; le minoranze etnico-religiose e i processi di mediazione culturale tra Italia e Tunisia, fra presente e passato. È autrice di numerose pubblicazioni. Tra i titoli più recenti: Non uno di meno. Diari minimi per un’antropologia della mediazione scolastica (2005); Viaggi di ritorno. Itinerari antropologici nella Grecia antica (2009); La Signora di Blida. Suzanne Taieb e il presagio dell’etnopsichiatria (2012); Non più a sud di Lampedusa. Italiani in Tunisia tra passato e presente (2016).
_______________________________________________________________