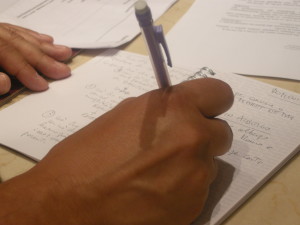di Stefano Montes
Prendete un tè? Non rispondono subito i giovani missionari. Non rispondono e mi guardano, mi guardano e sorridono. Uno dei due dice con dolcezza, dopo un breve momento di strana sospensione: “va bene, non ce n’è bisogno, non fa niente, non ti preoccupare”. Non ce n’è bisogno? “Tanto io sto per farlo, il tè, posso quindi farlo pure per voi”, ribadisco e m’incaponisco, per mostrare ospitalità e amicizia. Cosa mi costa, dopotutto! È più piacevole chiacchierare bevendo un tè, affermo tra me e me, sicuro di me, affabile e accogliente, ridanciano e alla mano. Devo dare il meglio di me – rifletto – se voglio instaurare un rapporto di lunga durata con loro, capire la loro religione, convertirli in oggetto di studio e soggetti d’interazione. Il fatto divertente è che io tento di convertirli ‘in chiave antropologica’ e loro tentano di convertirmi ‘in chiave religiosa’: gli intenti sono gli stessi, le chiavi sono diverse (anche se, come si vedrà in seguito, sono a mio parere strettamente correlate).
Comunque sia, offrire qualcosa è sempre stato segno di apertura, di inaugurazione di un franco, sincero dialogo: un dono – come direbbe Mauss (1965) – apre a un contro-dono, consente di iniziare al meglio delle condizioni sociali, assicurandosi la reciprocità dell’altro. I giovani missionari rispondono, all’unisono, quasi leggendomi nelle oscure pieghe del mio pensiero intimidito: “Come vuoi”. Ma c’è un tono strano nella loro voce, un’attesa nella risposta che suona singolare; c’è un non so che di resistenza gioviale e quieta condiscendenza allo stesso tempo. Me ne accorgo, non indago, lascio correre, ci sediamo. Vedremo. Intanto, dialoghiamo.
Il dialogo, incluso quello interreligioso, è a mio parere un percorso di acquisizione di consapevolezza nel tempo: un graduale conseguimento di appresa consapevolezza di un continuo movimento di va e vieni riflessivo – interrelazione e interazione – che attraversa le culture e gli stessi individui. Bisogna dunque dare tempo al tempo affinché sedimenti nel movimento irrefrenabile del divenire. Cominciano frattanto a spiegarmi il messaggio divino, i giovani mormoni. Sono bravi. Davvero. So bene che, al pari di una etnia qualsiasi nel mondo – al pari dei famosi trobriandesi, nuer o balinesi – hanno i loro buoni antropologi di riferimento che li osservano e li studiano (Davies 2000; Davies 2003; Cannell 2007). Mi incuriosiscono: sono oggetti di studio antropologico e sono soggetti in carne e ossa, di fronte a me, con i quali interagisco di prima mano. Mi incuriosiscono, se non altro perché, pur non praticando io stesso una religione particolare, almeno non in modo esclusivo e monologico, penso che sia importante capire, da antropologo e persona comune, che cosa «l’esperienza nel rituale possa dirci circa i luoghi e i tempi [delle pratiche e delle teorie] nel momento stesso in cui gli individui esprimono esplicitamente la centralità dell’esperienza» (Cannell 2007: 130).
L’esperienza del rituale, vissuta dall’interno dagli stessi praticanti, dovrebbe essere considerata parte integrante di una teoria antropologica della religione. Che vuol dire farne l’esperienza? Per l’appunto: esserci e condividere in tutti i sensi, al di là di un’astratta regola generale (sovente troppo restrittiva, comunque mutevole nel tempo) o di una sola forma discorsiva (soltanto in apparenza rigidamente distinta da altre). Come ricorda Turner, «è possibile che noi parliamo di un mondo della religione, ma di un altro tipo: non in quanto morale, né in quanto preghiera mentale, ma nella forma di oggetti rituali efficaci per sé, cioè in termini di spiriti e persone che hanno conoscenza del loro operare un processo rituale che può, di fatto, essere percepito» (Turner 1992: 180). Non so bene cosa io possa percepire adesso, in questa situazione, mi piace però l’idea che l’esperienza sia una possibile chiave di accesso alla cultura (religiosa) dell’altro, al di là di una (sovente rigida) morale o maniera di entrare (più formalmente) in contatto col divino.
Io sono nato in una famiglia cattolica, ma, nella mia vita individuale, ho sempre cercato di sperimentare – la radice comune tra experience and experiment è forse più visibile in inglese – altre forme di religione, dal basso, a partire giustamente dall’esperienza di un processo in corso, un processo di condivisione con l’altro. Da questo punto di vista, sono nel contesto giusto oggi: dialogico ed esperienziale. Il dialogo, quale che sia la definizione esatta del concetto, presuppone comunque un interesse a incontrare e tradurre (per) l’altro. Come trasposizione minima del senso, direi che il dialogo ha a suo fondamento un enunciato molto semplice: “parliamone”. Questo vuol dire che si è almeno in due e si è inclini, nonostante le ovvie difficoltà, a fare un certo cammino insieme, frequentandosi, comunicando, mostrando un’attitudine ad ascoltare l’altro, il suo discorso. Nel frattempo, sovrapponendosi ai miei liberi flussi di pensiero, i giovani missionari leggono, ad alta voce, qualche passo del Libro di Mormon. Io ascolto. Ne discutiamo. Soprattutto commentano, loro, e mi illustrano i vari passaggi con interessanti delucidazioni. Io non parlo molto, sicuramente meno di loro, ma osservo e tanto. Osservo e intervengo quel tanto che basta. Osservo e bevo tanto tè.
Mi viene in mente all’improvviso, tra un sorso e l’altro, mentre loro mi spiegano alcuni passi, la figura di Ricœur. Perché? Credo di poterlo intuire: più che nell’elaborazione di una vera e propria teoria con una sua specifica singolarità, l’apporto di Ricœur è consistito in una forma di filosofia volta a intrattenere uno scambio dialogico con altri studiosi al fine di affermare soprattutto una posizione etica della società e della cultura, in altri termini, per lui, una posizione fondamentalmente dialogica. Non posso che condividere l’assunto, naturalmente, ivi compreso la stretta associazione che il filosofo fa tra il desiderio di tradurre e il desiderio di dare dimora all’altro. Ricœur, di adesione cristiana, collega infatti la cultura alla traduzione e parla di ospitalità e di accoglienza dello straniero nella propria dimora: «il traduttore trova la sua ricompensa nel riconoscimento dell’intrascendibile statuto di dialogicità dell’atto di tradurre come orizzonte ragionevole del desiderio di tradurre. Di contro all’antagonismo che drammatizza il compito del traduttore, questi può trovare la sua felicità in ciò che amerei chiamare l’ospitalità linguistica» (Ricœur 2001: 49). In fondo è quello che, oggi, in pratica, stanno facendo i giovani missionari, traducendo nei miei termini – nei termini a me più accessibili – il loro credo religioso. In effetti è quello che faccio anch’io chiedendo spiegazioni e riformulazioni: faccio appello alla funzione metalinguistica, cerco di capire le loro parole con altre parole che si interdefiniscono qui, più specificamente, da un genere all’altro, dalla ‘loro’ religione alle ‘mie’, dalla loro cultura americana a quella mia, e viceversa. Ne parliamo. A casa. Ci diamo reciproca ospitalità.
Un fatto è certo: il dialogo – compreso quello interreligioso – non si basa unicamente sul tentativo di contatto tra astratte regole o istituzioni impalpabili, ma sulla discussione in vivo condotta da persone in carne e ossa, disposte a intraprenderlo e a continuarlo. Si dimentica dunque troppo spesso che il dialogo, soprattutto quello tra religioni, è comunque un dialogo tra persone: persone in carne e ossa disposte a dialogare. E si dimentica inoltre che i monoteismi, di fatto, si traducono in pluralismi di persone e pratiche non monologiche, per lo più contestualizzate. Edith Turner, poc’anzi da me citata, nella sua concezione religiosa privilegia l’aspetto ritualistico – la condivisione esperienziale – della credenza e mette in secondo piano, per esempio, la preghiera in quanto atto mentale che escluderebbe l’interazione esperienziale e diretta con altri fedeli.
Per accentuare la sua proposta, si deve però ribadire il fatto che una preghiera è difficilmente soltanto mentale o diadica, oggigiorno soprattutto. La preghiera è un genere discorsivo che prevede diverse forme di dialogismo. Per preghiera si intende solitamente, un po’ ingenuamente, la comunicazione instaurata tra un individuo e l’entità sovrannaturale. Ma c’è altro, in realtà. C’è sempre altro. C’è l’alterità, c’è la molteplicità. Di fatto, «le persone spesso pregano alla presenza di altre: in queste situazioni, [a tavola, per esempio] l’interazione è a più partecipanti, piuttosto che diadica» (Capps, Ochs 2006: 247). Pregare, tra le altre cose, significa – insistono giustamente Capps e Ochs – assumere una postura e un atteggiamento cinesico, una disposizione a comunicare con l’alterità e, al contempo, la necessità ineludibile di interagire con i propri simili in una dimensione spazio-temporale data e immaginata. Questo vuol dire che una forma di contatto con l’alterità – qual è la preghiera – possiede intrinsecamente una natura dialogica e di per sé interattiva che andrebbe, ovviamente, sottolineata e sviluppata. Se si ripensa al dialogo interreligioso su questa base e si amplia la prospettiva, non si dovrebbe allora concepirlo – banalmente – in termini strettamente oppositivi (tra una religione e l’altra viste come blocchi monolitici), ma in quanto acquisizione di consapevolezza interindividuale. Come si è visto, infatti, persino all’interno di una – apparentemente – sola forma discorsiva come la preghiera esiste una pluralità di interazioni mondane e ultramondane, molteplici (e non più soltanto diadiche), spazializzate e temporalizzate.
Come si vede, i miei pensieri si compongono e si scompaginano, si ricompongono e si riconvertono al cospetto dei giovani mormoni. Persistono, ostinati, nell’esigere un’autonomia al mio indaffarato ‘io’ centrale. Me ne rendo conto con la coda dell’occhio dell’attenzione. Dialogano tra loro. Non male, sono in tono con il tema. E io continuo – una parte del mio ‘io’ continua – nel frattempo a bere del tè e chiacchierare con i nuovi amici mormoni. Il loro fumante tè è invece sempre lì, non lo toccano più di tanto, non lo guardano nemmeno un tantino. Io bevo il mio tè lentamente, assaporandolo molto lentamente, mentre è ancora caldo, tutto attento alle loro parole, a loro rivolto con la mente e nei miei intenti; loro mi parlano del messaggio religioso, alternandosi, instancabili, uno dopo l’altro, mentre con la mente rivado a qualche giorno prima, al momento in cui li ho conosciuti.
Li ho incontrati, un paio di giorni prima, a un angolo di strada di Tartu, in Estonia, dove transito spesso con passo svelto per andare all’università. Sono simpatici. Mi fermo. Chiacchieriamo. Ci scambiamo informazioni. Non ho però tempo, sul momento: una lezione mi aspetta al varco e sono già in evidente ritardo, più del solito, più che mai. Mentre loro mi passano un numero di telefonino, il mio pensiero corre, a mia stessa insaputa, a Clifford (2004) secondo il quale gli antropologi si sono solitamente definiti, nel passato, in negativo: non siamo scrittori di viaggio, non siamo funzionari del governo, non siamo missionari. Ma è effettivamente così? La linea di discontinuità non è così netta come si crede. Prendere le distanze da alcune figure chiave consente, per differenza, di circoscrivere il campo di studio di una disciplina, ma, al contempo, instaura altre forme di continuità o di tensione: «I missionari – perlomeno alcuni di essi – erano probabilmente molto più interessati a questioni di sincretismo e di processo culturale. Questo è certamente vero per Leenhardt, per il quale cambiamento è cultura, cultura è sincretismo» (Clifford 2004: 18). Non ha tutti i torti Clifford a proposito di Leenhardt, antropologo e missionario, e di altri missionari altrettanto illuminati. Più che prendere le distanze dai missionari odierni (o altro), si dovrebbe dunque – ciò riguarda anche il processo di disciplinarizzazione dell’antropologia, ancora in corso e comunque sempre mutevole – capire che ruolo gioca il cambiamento in una cultura ad opera di alcune ‘figure dell’intercultura’ che, per diffondere forme di credenze e d’esistenza, devono necessariamente praticare il dialogo e la traduzione in forma più marcata d’altri.
Comunque sia, alla luce di quanto già detto, le questioni si rimandano e si moltiplicano vorticosamente. Le figure del dialogo (interreligioso) vanno dunque di pari passo con le figure della traduzione interculturale? La disciplinarizzazione del sapere riguarda ugualmente le forme di credenza (religiose e non)? Il dialogo (interreligioso) va ancorato alle forme di consapevolezza dei propri e altrui saperi? La focalizzazione sull’esperienza condivisa del rituale e il dialogo (interreligioso) sono strettamente interrelati? Moltiplicare le domande è già un buon segno: oltre che d’abbondanza, di disancoraggio da una sola prospettiva stereotipata e di riposizionamento delle questioni di partenza. I miei pensieri si riposizionano anch’essi, vanno avanti e indietro nel tempo e sono adesso rivolti al momento in cui ho incontrato i mormoni per la prima volta a Tartu.
I giovani mormoni parlavano e parlavano e io, nonostante l’orario, ero perso nelle mie e loro divagazioni. Ripreso però rapidamente controllo della situazione, spinto della fretta, fissavo con loro – mi proponevano infatti di passare da casa mia – un appuntamento preciso per rivederci con più calma. È incominciato così il nostro rapporto proseguito nelle diverse città in cui ho vissuto nel tempo. Da antropologo, ero e sono interessato al loro messaggio, al modo di trasmetterlo che è in fondo, per me, anche un modo per cercare di essere convertito simpaticamente, convivialmente, quindi un tentativo per provare in qualche modo l’esperienza del rituale dall’interno. Comunque sia, io sono, ieri e oggi, in una situazione di comodo, capovolta e felice etnograficamente, dialogicamente: più che andare a caccia dei miei ‘altri’ da intervistare e muovere al dialogo, sono gli ‘altri’ – i giovani missionari – che ci tengono a raccontarmi le loro storie, nel tentativo di convertirmi. Il linguaggio della trasformazione del Sé, contenuto, in una storia di conversione (Stromberg 1993), tende allora ad arricchirsi delle strategie in uso implicitamente o esplicitamente adottate dai giovani missionari al fine di persuadere della bontà della loro religione.
I missionari mormoni non fanno altro: raccontano il loro credo, ne dicono tutto il bene possibile, lo diffondono con efficacia. Fanno proseliti? Forse non del tutto consapevolmente, devono fare leva su quella che Jakobson definirebbe la funzione conativa del messaggio: dicono per persuadere (ciò non toglie che non credano sinceramente nella diffusione del loro messaggio religioso). È la loro missione generale, per due anni, ancora giovani figli di famiglia, lontani da casa, in un altro paese di cui imparano lingua e usi, rifuggendo ‘per obbligo’ i contatti con la madrepatria, qualche telefonata centellinata, qualche messaggio di posta elettronica. Insomma, un vero e proprio, lungo, inesauribile, rito di passaggio, direbbe Van Gennep (1981). Io, da parte mia, appartengo a una generazione che i riti di passaggio li ha vissuti fin da giovane, sulla propria pelle, per obbligo: una generazione costretta a ‘fare il militare’ per un anno lontano da casa, il più lontano possibile, in mezzo a tanti sconosciuti e volti nuovi da addomesticare. L’obbligo della leva, da me assolto benché con l’imposizione, me li rende ancora più simpatici e mi dà l’impressione di una condivisione reciproca, di un comune sentimento. Siamo partecipi di un’esperienza simile.
A casa, una volta rivisti i mormoni dopo il primo incontro per strada (e per ritornare risolutamente all’incipit del mio testo), voglio essere gentile. E così insisto per offrire loro qualcosa. Insisto forse troppo, e non me ne rendo per niente conto sul momento. Anche loro intendono essere gentili. Sì, lo sono. Non rifiutano dunque il tè. Non lo bevono però. Non capisco perché. Per quale motivo non so. Si raffredda. Io bevo e loro no. Loro fanno esempi e io sorseggio. Finalmente glielo chiedo, e finalmente ne parliamo. “È una sostanza eccitante”, mi dicono senza mezzi termini, adesso che hanno finito il loro discorso e – forse – possono rivelare scarti e differenze tra me e loro, separazioni possibili e talvolta irrinunciabili, senza farmi paura, senza la preoccupazione di allontanarmi da loro ideologicamente, prima del dovuto. Mi dicono che non bevono neanche caffè. Peccato! Io sono italiano, l’espresso è irrinunciabile. Ne parliamo. La questione è controversa per quanto riguarda il caffè, è vero, lo ammetto. Ma il tè? Io dico che i medici sostengono che il tè, in quantità moderate, fa bene alla salute, protegge il sistema immunitario e previene pure le carie. Cosa si può volere di più? Loro rispondono: “La nostra religione lo vieta perché è una sostanza eccitante, nociva e in ogni caso la scienza muta nel tempo, tanto vale attenersi al credo religioso”. Mi chiedo, sinceramente, se hanno letto Kuhn (1979) oppure se questa affermazione si radica nel loro effettivo (ed efficace) credo religioso (che è comunque, come ben so, radicato nella storia e sottoposto al cambiamento anch’esso). A detta di Kuhn, le conoscenze scientifiche non si accumulano al fine di rivelare una verità univoca, ma si alternano secondo i diversi paradigmi di riferimento, in accordo o meno con le diverse epoche. Il trionfo di un paradigma su un altro si fonda, in definitiva, sulla sua efficacia persuasiva e sul consenso collettivo fornito dalla comunità.
I giovani missionari hanno sicuramente il consenso della loro comunità e so per certo che anche i loro – intendo dei mormoni nel complesso – paradigmi di riferimento religioso sono mutati nel tempo. Non mi resta allora che pensare, su due piedi, a questa soluzione: i mormoni si attengono al credo religioso, nonostante possa essere in conflitto con il sapere scientifico, perché lo concepiscono al di fuori del flusso della storia, mentre la scienza sarebbe invece sottoposta ai mutamenti paradigmatici.
Mentre i miei pensieri stanno per prendere il volo e fare collegamenti d’ordine epistemologico vario, uno dei due aggiunge: “Io non sono stato bene quelle poche volte che ho provato a berlo, ho provato una strana sensazione, molto meglio quindi senza”. L’altro aggiunge di rimando: “non ne abbiamo alcun bisogno”. Bisogno? Io ripenso al ritmo della loro giornata fitta di impegni, preghiere, sport e tant’altro e penso che, per reggerlo, il loro ritmo indiavolato, al posto loro io dovrei invece berne tanti di caffè e tè. Insomma, per sintetizzare le loro risposte, in un caso è valso il risultato dell’esperienza diretta (ho bevuto il tè ma non sono stato bene) e, nell’altro, la superiorità del paradigma religioso su quello scientifico (la scienza cambia, la religione rimane immutata). Finita la bella discussione, mi dicono che è ora di andare. Il dialogo proseguirà un’altra volta. Hanno un altro appuntamento, sono già in ritardo, è tempo di levare le tende. Prendono quindi commiato. Prendiamo allora appuntamento per la prossima volta. Mi ricordano, con un sorriso, di rileggere alcuni passi importanti, quelli da loro segnalati. Promettono di darmi un testo in italiano. “Farò i compiti”, dico loro per scherzo, in inglese. Ridacchiamo, ci salutiamo nuovamente. La porta si richiude alle loro spalle. Loro vanno via e io ripenso all’accaduto.
Su un punto non ho dubbi. Non è più possibile pensare oggi, anche alla luce di quanto ho sentito poc’anzi, il ‘sapere’ e il ‘credere’ in quanto universi semantici separati, da studiare indipendentemente: essi fanno parte dello stesso universo cognitivo all’interno del quale, poi, si riassestano variamente, in seno alle diverse culture in maniera differente, magari ritagliandosi più spazio l’uno rispetto all’altro, oppure riconvertendosi gerarchicamente o, ancora, risistemandosi per opposizioni più marcate. Si potrebbe, di conseguenza, accettare l’ipotesi che il sapere e il credere siano tipi di razionalità strettamente correlate, diversamente amalgamate in funzione dei contesti: «il credere spesso riposa e perfino si consolida sulla negazione del sapere. Il credere e il sapere sembrano dunque appartenere ad una struttura elastica che, nel momento dell’estrema tensione, polarizzandosi, produrrebbe un’opposizione categorica, mentre invece, quando si allenta, arriverebbe sino a confondere i due termini» (Greimas 1985: 112). E allora? Il credere, per quanto comunemente e banalmente visto in sé come un elemento di stretta pertinenza del solo universo religioso, ha invece una portata più ampia, alleandosi con il sapere, producendo tipi di razionalità i cui effetti sono visibili pure nell’ambito del quotidiano e in altri campi d’ordine non esclusivamente sacro. Il credere/sapere è – anche – un far-credere/far-sapere la cui programmazione d’azione si articola su una sintassi multiforme basata, per esempio, sulla varia mescolanza di affermare, dubitare, rifiutare e ammettere. In quest’ordine di idee (di associazione stretta tra credere/sapere e loro programmazione sintattica), si inserisce l’ipotesi di fondo secondo cui quella che viene chiamata la ‘credenza’ è sfaccettata, quindi non esclusivamente relegata all’ambito del religioso, ma parte integrante della razionalità spicciola posta in essere persino nell’arco di una giornata, in campo profano, nell’ordinario.
Ripenso ai mormoni e alla faccenda del tè. Certo, questo è un chiaro esempio dei modi in cui si (ri)articolano scienza e fede, vita quotidiana e tensione verso l’alterità terrena e ultraterrena. Mi passa pure per la mente, però, ancora più vicino al campo dell’ordinario e al vissuto minuto, un caro amico ingegnere che si sveglia la mattina e si alza poggiando sistematicamente per terra il piede destro come modo per incominciare la giornata positivamente, di buon augurio. Lui sa bene, da ingegnere, che il suo non è un atto avente una portata scientifica, ma ci crede lo stesso e spera abbia i suoi buoni effetti, desiderati e inaspettati. Come ricorda Needham, il quale ha riflettuto sul significato del credere nelle diverse società e sulle sue eventuali modalità di traduzione interculturale: «Credere non dipende necessariamente dalla mera possibilità, una cosa può essere creduta anche quando è riconosciuta come impossibile» (Needham 1976: 67).
Situando queste considerazioni in una prospettiva dialogica e interreligiosa più ampia, si può allora sostenere la tesi secondo cui esisterebbe un continuum tra il ‘credere religioso’ e le ‘credenze al quotidiano’, un continuum ritagliato diversamente, più o meno inconsapevolmente, che sfuma tuttavia l’opposizione radicale, alla quale siamo ingenuamente affezionati, tra il sacro (la religione) e il profano (le attività giornaliere). Voglio dire con questo, senza mezzi termini, che le religioni non hanno fondamento alcuno, visto che il credere riguarda anche ampie fette del profano quotidiano? Ognuno di noi è – dovrebbe sempre essere – libero di credere ciò che più l’aggrada e lo rende felice. Io voglio qui dire, più direttamente, che è importante in chiave antropologica sganciare il credere da un solo ambito e prenderlo invece in considerazione – studiarlo – anche nelle forme più spicciole e meno evidenti del/nel quotidiano. Ciò ha ricadute evidenti nell’ambito del dialogo interreligioso. L’acquisizione di questa consapevolezza – cioè il credere si realizza anche nel minuto quotidiano – aiuterebbe certamente il dialogo tra le varie religioni perché predisporrebbe alla molteplicità della sua presenza ed effetti.
E intanto il tempo corre, corre a testa bassa come il freddo estone quando ti soffia pungente, in inverno, sull’unico frammento di viso rimasto scoperto. Sono trascorsi diversi anni nel frattempo. Il tempo corre e dove va? Il tempo vola, si presenta sovente come misura delle emozioni. Sono in auto, non più in Estonia, non più a un braccio di mare dalla Finlandia, a pochi chilometri dalla Russia. L’Estonia è lontana, nello spazio e nel tempo, persino nella mente. E io sono in auto con un ragazzo marocchino alla guida. Ci dirigiamo a tutta birra verso la gendarmeria francese di Nîmes, sud della Francia, per ritirare l’autorizzazione al ritiro di un medicinale per mio figlio Mattia che, allergico al pelo del gatto, ha avuto un attacco d’asma mentre meno ce lo aspettavamo, in vacanza, in una splendida casa che abbiamo affittato in pieno centro. Fa caldo, siamo in piena estate. L’appartamento affittato a Nîmes è bello, il gatto è andato via con la padrona, ma ha lasciato tracce, molto sensibili per un ragazzo allergico. E allora si annuncia la solita trafila: mezza giornata in ospedale, inalazioni a tappeto, desiderio di tornare alla normalità, alle passeggiate in città e fuori città, in lungo e largo al sole della Provenza. Mattia è finalmente dimesso dall’ospedale dopo la solita tiritera; l’indomani siamo a caccia di una farmacia per trovare i medicinali prescritti contro l’allergia. È un giorno festivo, bisogna trovare una farmacia di turno. Ci vado a piedi: la prima è chiusa. Vado nell’altra correndo: è chiusa anche questa. Che succede? Non so più che fare, non capisco bene, ho il fiato corto, i pensieri esausti. È la prima volta che mi succede in Francia: dover prendere dei medicinali in un giorno festivo. In Italia è semplice: basta guardare le indicazioni affisse sul muro di una farmacia qualsiasi per potere trovare quella di turno. Qui, le cose non funzionano così, mi spiega il ragazzo marocchino che ho incontrato per caso, con lo stesso mio problema, davanti la farmacia chiusa. Bisogna prima recarsi alla gendarmeria, spiegare le esigenze, mostrare la prescrizione dell’ospedale e farsi autorizzare, con un bel tampone e relativa firma del funzionario, all’acquisto del medicinale. Con l’autorizzazione, la gendarmeria darà inoltre delle indicazioni precise su cosa fare e l’indirizzo esatto dove andare per ritirare il medicinale.
Sono disperato. Ho fretta di avere il medicinale. Non so dove si trova la gendarmeria. Sono arrivato fin qui a piedi. Che faccio? Lui, il ragazzo marocchino, ha capito al volo, davanti la farmacia chiusa, che non sapevo che pesci prendere. Così, mi ha dato un passaggio. Così, abbiamo avuto l’occasione di parlare in auto, visto che abbiamo fatto un bel pezzo di strada prima di arrivare in gendarmeria e poi all’indirizzo indicato per ritirare il medicinale. E così è andata e lo racconto in breve a riprova del fatto che la solidarietà s’instaura talvolta come per magia, senza nemmeno chiedere aiuto, a dispetto della diversità e del potenziale malinteso interculturale sempre in agguato. Ma c’è altro. Come sempre. Non so perché, tra le tante altre cose, ci siamo messi a parlare di religione e vacanze. Che strana associazione! Ma è andata così. Proprio così. Chi ci crederebbe? In un saggio in cui si tende a mostrare la polivalenza del credere, persino in quanto forma di razionalità in associazione col sapere, non si può chiedere al lettore di crederci sulla parola. E intanto le cose sono andate così. Vado in farmacia, mi imbatto in un ragazzo simpatico che mi dà un passaggio con la sua auto, parliamo giusto di religione e del tempo libero, religione e stili di vita. Lui è diplomato e lavora in un cantiere edile, è sposato e musulmano. Gli piacerebbe un giorno andare in vacanza a Roma, al Vaticano. Che bello sarebbe! Si deve respirare una bella aria, un luogo religioso, con il papà. Gli ho detto: ma non sei musulmano? E lui: e allora? Mentre io cerco di sistemare il vetro della sua auto alla mia destra, che non vuol saperne di andare giù, mi dice che Nîmes può essere una città difficile, ma sicuramente meno di Parigi. Ci sono però tante persone religiose in questa città, persone oneste, dedite al lavoro.
L’associazione tra pratica religiosa, lavoro e stile di vita semplice o sano è costante, nel seguito del suo discorso: un basso continuo che accompagna i nostri discorsi. Io avrei voglia di tirare fuori il mio taccuino e segnarmi tutto di questo strano frammento di vita che mi capita tra capo e collo: l’asma di Mattia, la giornata in ospedale in piena vacanza, le farmacie fantasma, la gendarmeria e, infine, un giro in auto con un simpatico ragazzo che mi parla di religione, tutto sommato come forma di vita, una vita vissuta nel bene, lontana dal male. È tutto il contrario – penso – di quello che ci trasmettono i media sul mondo, sul terrorismo e gli attentati. Per l’amico marocchino ‘una persona di religione’ non può essere che una persona buona, votata al lavoro, curiosa delle altre religioni e luoghi di culto. Non tiro fuori il mio immancabile taccuino, non è necessario segnare tutto, anche se vorrei. Resti quel che deve restare di questo denso frammento di vita. Nel frattempo, arriviamo alla gendarmeria, ci mettiamo a turno. La fila non è lunga, ma ho il tempo di dare un’occhiata al libro di Jullien che mi porto dietro, per leggere nei tempi morti del mio lavoro-vacanza, per riflettere meglio su questo rapporto sofferto tra l’universale e il comune. Apro la pagina a caso e lo sguardo cade proprio sul rapporto tra lingua, cultura e dialogo con l’altro:
«Ma in che lingua dialogheremo se il dialogo avviene tra culture? Se viene rispettata la relazione triangolare per cui, prima di tutto, ci si volge verso la cultura a partire dalla lingua (piuttosto che a partire dalla dimensione religiosa, ideologica, ecc.), e se questa lingua è già interamente strutturata? Risponderò senza temere il paradosso: ognuno nella propria lingua, ma traducendo l’altro. La traduzione è infatti l’attuazione esemplare dell’operatività propria del dialogo: essa ci obbliga a una rielaborazione interna alla nostra stessa lingua, e quindi a riconsiderare i suoi impliciti per renderla disponibile all’eventualità di un senso altro» (Jullien 2010: 175).
Affinché il dialogo (ivi compreso quello interreligioso) sia efficace, è necessario mettersi nella pelle dell’altro, provare a tradurre l’altro, persino in quei casi in cui il piacere dell’ospitalità muoverebbe – innocentemente, come nel mio caso con i mormoni – a mettere l’altro a proprio agio, insistendo sull’offerta di una bevanda non gradita. Non tutto il male vien per nuocere, però. Penso che i mormoni abbiano voluto trasmettermi un insegnamento accettando il dono del tè ma rifiutandosi di berlo, in osservanza ai loro principi religiosi: accettano il dono, ma si attengono alle loro regole. Non è forse anche questa una forma di dialogo interreligioso? È come se avessero detto: noi seguiamo le nostre regole ma non vogliamo stravolgere le tue; siamo ligi ai nostri principi ma non vogliamo dispiacerti. Parafrasando Jullien, si potrebbe dire che il dialogo, tra noi, è avvenuto traducendo l’altro, contraccambiandolo. Da parte mia, ho ecceduto forse nell’offrire un senso di ospitalità, senza pormi il problema – perché di fatto, nella mia palese ignoranza, inesistente – delle ‘bevande’ permesse o meno nella religione mormone.
Il dialogo, avendo come implicito – almeno – un principio diadico e un sostrato processuale virtualmente in divenire, è un valido rimedio all’ignoranza e a una forma di credere staticamente intesa. Più in generale, il franco dialogo aiuta molto ad appianare le differenze – o, sarebbe meglio dire: a ritradurle e, con ciò, a risignificarle nella dimora dell’altro – perché consente di mettere in opera quello che ho chiamato, qui e lì, in questo saggio, un processo di consapevolizzazione dell’alterità e di acquisizione di un sapere interreligioso. In questo senso, oltre che tradurre l’altro ognuno nella propria lingua, sarebbe pure utile – al fine di decentrarsi ulteriormente e acquisire maggiore consapevolezza della natura situata del sapere – tradurre dalla lingua dell’altro se stessi e la propria lingua con il fine di tornare all’altro e alla sua lingua: per quanto imperfetta possa essere questa forma di traduzione interculturale, sortirebbe comunque un sicuro effetto di straniamento corrispondente in definitiva a una maggiore consapevolezza di sé e dei meccanismi di ancoraggio e disancoraggio culturale. Questo, all’ingrosso, per quanto riguarda il mio dialogo con i giovani mormoni.
Cosa ho imparato, invece, dal ragazzo marocchino? Ovviamente, che ci si aiuta e si dialoga anche quando si appartiene a religioni in principio diverse, che ci si incontra per caso e ci si aiuta anche quando non ci si conosce. Ma non è finita qui. Parlando, io e il ragazzo marocchino, abbiamo messo in collegamento mondi della religione con universi semantici altri: stili di vita più generali, il lavoro, le vacanze, il Vaticano, etc. In altri termini, abbiamo posto in essere il principio – forse implicito ma da valorizzare nel dialogo interreligioso – secondo cui l’universo del credere è in intima relazione con l’universo variegato del sociale. Naturalmente, le religioni sono, tra le altre cose, sistemi di intelligibilità del mondo: proprio per questo, però, fanno parte integrante delle più vaste dinamiche culturali (che non sono fortunatamente soltanto quelle mediatiche o quelle legate ad atti nocivi). Alla domanda ‘dialogo tra religioni o dialogo tra culture?’, la risposta è allora ambedue: le religioni sono parte integrante delle culture, del loro insieme complesso, e non elementi da esse separati. In definitiva, riassumendo, il dialogo interreligioso non deve – non può – essere scorporato dal dialogo interculturale. Per quanto formulata in modo diverso, questa è, almeno in parte, l’ipotesi di Geertz nel momento in cui afferma che i «concetti religiosi si estendono oltre il loro contesto specificamente metafisico per fornire una cornice di idee generali nei cui termini si può dare una forma densa di significato a una vasta gamma di esperienze – intellettuali, emotive, morali» (Geertz 1987: 156).
La religione è dunque un sistema culturale strettamente intrecciato alle altre dimensioni culturali: esiste, all’interno della cultura, un va e vieni di significati religiosi (e non) diretto in un senso e nell’altro, dalla religione agli altri universi semantici e viceversa. L’ipotesi era già stata messa alla prova da Geertz in una ricerca sul campo di tipo più comparativo in cui egli metteva a fronte lo sviluppo religioso in Marocco e in Indonesia, sottolineando l’importanza delle strette concatenazioni risultanti dalle condotte economiche, politiche, sociali e religiose (Geertz 1968). In altri termini: vuoi capire una religione? Vedi il suo funzionamento all’interno della cultura di riferimento e, meglio ancora, il suo modo di svilupparsi, per differenze e similitudini, in un altro luogo, magari lontano, perciò più straniante. Proprio alla fine di questo testo dedicato all’Islam in Marocco e in Indonesia, Geertz fa riferimento a due figure interessanti, conosciute per caso: un marocchino incontrato in aereo, in ansia per ciò che lo attende a New York, dove dovrà studiare; un brillante studente di matematica e fisica indonesiano che lavora a uno schema in cui convergono confusamente elementi di fisica, matematica, politica e, persino, arte e religione. Paradigmaticamente, il primo, lo studente marocchino, affronta l’ansia, in aereo, tenendo il Corano in una mano e un bicchiere di whisky nell’altra; il secondo, lo studente indonesiano altrettanto paradigmaticamente considera il suo schema cabalistico una sorta di bussola per trovare la strada nei percorsi tortuosi della caotica vita moderna. Insomma, due figure esemplari secondo Geertz che rappresentano due modi diversi ma ambedue centrali per la religione e i suoi modi di intenderla: per quanto riguarda il giovane marocchino, il ricorso ad altro, al di fuori della religione stessa (il whisky); per quanto riguarda il giovane indonesiano, il ricompattamento all’interno della religione di vari fili sociali ricondotti a unità (lo schema). Insomma, per dirla in breve, Geertz mostra che la religione, in maniera centrifuga o centripeta, nel bene e nel male, è sempre legata ad ‘altro’ nel più vasto sistema della cultura e si configura come tratto atto ad affrontare il reale, ad addomesticarlo e fronteggiarlo.
Perché il dialogo interreligioso sia più efficace, credo dunque che si debba tenere conto di questo elemento di raccordo culturale, estremamente importante in termini di definizione di un ‘oggetto culturale’ qual è la religione: in modo straniante, in qualche modo paradossalmente tautologico, si potrebbe dire che la religione non è mai soltanto la religione poiché essa è – diviene – molteplice appartenenza al sistema della cultura. E, per quanto strano possa sembrare, ciò vale anche per quelli che possono essere visti come impermeabili monoteismi e per alcune figure che li sostanziano. È la questione che si chiede Evans-Pritchard, antropologo britannico, per quanto riguarda la religione dei Nuer: può effettivamente la religione nuer essere considerata monoteistica, visto che si fonda sulla credenza in un ‘solo’ Dio (Kwoth)? La risposta che Evans-Pritchard dà è precisa: nonostante Kwoth sia uno, «è pensato differentemente per quanto riguarda i molteplici effetti e le diverse relazioni [con Kwoth intrattenute]» (Evans-Pritchard 1956: 316). Non è impertinente ricordare che la risposta che dà Evans-Pritchard è naturalmente legata al suo stile di indagine etnografica e al ruolo – importante – che assegna alla traduzione dei concetti della propria e altrui cultura. Kwoth è solo apparentemente uno: in realtà, è molteplice nei diversi livelli di esperienza che i nuer realizzano e, non sorprendentemente, nelle traduzioni, ogni volta diverse, che gli stessi nuer rendono a Evans-Pritchard, una volta interrogati sulla questione, nei vari contesti d’uso. Evans-Pritchard non si pone ovviamente il problema concernente i ‘grandi monoteismi’ e il dialogo interreligioso. Non gli interessa e la sua indagine è fondamentalmente di stampo ‘esotizzante’. Ma è pur vero che, a partire da una presupposta molteplicità di pratiche e rese traduttive nei diversi contesti d’uso, si può pensare – anche all’interno dei grandi monoteismi (quali l’Ebraismo, il Cristianesimo, e l’Islamismo) – a un’ipotesi che ne smussa una presupposta incommensurabilità di vedute nella riconversione (che è essa stessa una forma di traduzione) continua tra l’unità e la molteplicità delle credenze e pratiche concrete. Evans-Pritchard accenna qui e lì, in Nuer Religion, che ci sono diversi livelli di apprensione della religione. Ribadisce il principio che è difficile parlare semplicemente della religione dei nuer: è complicata a tal punto che nemmeno i nuer sono consapevoli di tutti i suoi aspetti.
Ciò ci porta – nella prossimità del dialogo con i nostri monoteismi – a un tratto da me considerato centrale per il dialogo interreligioso: il percorso di consapevolezza, dal basso, compiuto dai praticanti. Esso va visto, in questa prospettiva, nei due sensi: all’interno di una stessa religione e tra religioni diverse. Esso va inoltre visto, come ho cercato di fare qui e lì in questo saggio, come un percorso di traduzioni e conoscenza dialogica, più che un ricorso a concetti statici e incommensurabili. Questa è pure la ragione per cui ho preso, tra le tante altre, come riferimento la ricerca sulla religione nuer di Evans-Pritchard. Egli ricorda, in un testo più teorico, che il «compito più difficile nella ricerca di campo in antropologia risiede nella determinazione dei significati di alcune parole chiave, dalla cui comprensione dipende il successo dell’intero studio» (Evans-Pritchard 1951: 80). Allo stesso tempo, però, nelle sue ricerche etnografiche, così come nei suoi testi più teorici, la determinazione dei significati di alcune parole chiave viene sottoposta al flusso delle traduzioni che egli stesso produce e richiede ai suoi interlocutori a proposito dei più vari concetti presi in conto.
Com’è noto, andare lontano è in ogni caso fruttuoso per capire meglio ciò che ci riguarda da vicino e per procedere su base comparativa a una migliore comprensione di noi stessi. Andiamo lontano, dunque, anche per tornare a casa e ritradurci esistenzialmente. La religione nuer, per quanto poco conosciuta in Occidente, può essere un utile strumento di comparazione e conoscenza delle religioni a noi più vicine in termini differenziali e guidarci a una risoluzione: non si dovrebbe parlare di monoteismi, ‘grandi’ o ‘piccoli’ che siano, in maniera rigida, come sistemi compartimentati gli uni dagli altri e dalle culture di riferimento perché, al di qua e al di sotto dei principi regolativi di massima, i monoteismi sono praticati da individui che vivono già – come mostrano bene Geertz o Evans-Pritchard – in più dimensioni o sistemi culturali, traducendo gli uni con gli altri, e non solo in quello cosiddetto ‘dottrinario’, staticamente inteso. Naturalmente, bisogna prenderne piena coscienza individualmente.
D’altronde, persino i grandi monoteismi occidentali sono sostanziati da figure, che definirei dell’attraversamento, le quali rimodulano il sistema concettuale di riferimento e, talvolta, persino lo trasformano: le figure più rappresentative delle grandi religioni sono, di fatto, impliciti delegati alla traduzione e alla mobilità. A titolo di esempio, più che delle figure tipiche dei grandi monoteismi, vorrei fare qui riferimento a figure dell’attraversamento interreligioso di individui meno noti. Per rimanere in linea con le argomentazioni di Clifford su cambiamento e sincretismo e approfondire così la questione, prendo come primo caso quello di un altro missionario. Si tratta di Eric de Rosny, gesuita, inviato in Camerun per insegnarvi e diffondere il credo. De Rosny racconta, in un bel libro, la sua esperienza d’iniziazione alla medicina tradizionale in seno all’etnia douala (De Rosny 1981). Ottenuta l’autorizzazione dai suoi superiori, diviene infatti un ‘ganga’ – una sorta di stregone con poteri curativi – dopo una iniziazione durata diversi anni, in cui il suo maestro douala gli apre gli ‘occhi interiori’ consentendogli così di vedere e comunicare con gli spiriti, di guardare al di là delle forme sociali per meglio capire il mondo non-umano, invisibile agli altri uomini. Da prete cattolico e da occidentale, non solo accetta nominalmente, senza perdere la fede iniziale, un sistema curativo diverso da quello ufficialmente praticato in Europa, ma diviene di fatto un guaritore la cui efficacia curativa dipende da pratiche e cosmologie appartenenti a una etnia altra, locale. Una bella figura della traduzione interculturale e dell’attraversamento! Inutile dire che l’attraversamento compiuto da De Rosny è legato, come si vede bene nel suo libro, a un percorso di consapevolizzazione (della differenza culturale acquisita in seno alla cultura douala) e di conoscenza dialogica dell’altro (inteso in termini religiosi e medici).
Ancora meno conosciute sono le figure dei marrani di cui parla Nathan Wachtel nel suo bel libro La fede del ricordo (Wachtel 2003). I marrani sono i fuoriusciti dal giudasmo in seguito a una conversione forzata al Cristianesimo e costretti a migrare nel Nuovo Mondo. Grazie a una ricerca d’archivio, Wachtel rende i ritratti di alcuni di questi marrani, mostrando soprattutto un mondo eterogeneo, in cui la visione dell’esistenza è resa meno dogmatica, più tollerante, più ‘traduttiva’. Il fatto interessante è che non si tratta soltanto di un capovolgimento di una prospettiva eurocentrica: il recupero di una storia, dal basso, delle visioni di quelli che, altrimenti, si potrebbero considerare dei vinti. Si tratta pure di una riconfigurazione innovativa dei paradigmi classici della tradizione cristiana e giudaica: «per alcuni di quei nuovi cristiani, la dicotomia tra l’educazione cristiana e l’eredità ebraica conduce, o può condurre, a un distacco critico, a una riconsiderazione dell’una e dell’altra tradizione» (Wachtel 2003: XII). Ciò che rivela Wachtel, quindi, è un «ampio ventaglio che si dispiega fra i due poli, quello dei giudaizzanti ferventi, da un lato, e quello dei sinceri cristiani dall’altro, passando attraverso tutta una serie di casi intermedi e di combinazioni sincretiche» (ibidem). Tra le altre cose, Wachtel mostra inoltre, secondo me, che il dialogo tra le religioni non può esimersi dall’esaminare il rapporto instabile che si pone tra religione e violenza: la conversione forzata è una forma di violenza non solo fisica ma anche morale. Ma è anche vero che la violenza conduce, paradossalmente, come nel caso dei marrani, a una nuova riconfigurazione di canoni religiosi tradizionali, svincolandoli dalle scritture sacre e rendendoli più vicini alla vita concreta e alle pratiche rituali. I marrani subiscono una violenza e reagiscono intellettualmente e moralmente creando un sistema di pensiero più duttile.
Sebbene, quindi, condivida in generale le ipotesi parallele di Assmann (2007) e Bettini (2014) – i quali fanno un elogio del politeismo e rintracciano le cause della violenza religiosa in un radicamento del monoteismo in quanto linguaggio – ho rivolto la mia attenzione qui, più che alle scritture sacre e al loro messaggio in astratto, soprattutto alla pratica viva, esistenziale del fenomeno religioso perché, ai miei occhi, anche i monoteismi rimangono in fondo delle pratiche di traduzione praticate dal basso e non soltanto delle regole libresche ciecamente eseguite dall’alto. La violenza religiosa è, secondo me, il risultato di una forma di cecità e di oscuramento di quello che dovrebbe invece essere un percorso di consapevolizzazione del discorso altrui in quanto pratica traduttiva, persino nella sua dimensione spicciola, addirittura quotidiana. Se si dimentica questo, allora si finisce col creare rapporti di cause ed effetti nocivi e illegittimi. Come scrive Hénaff, soprattutto nel caso della cieca violenza dei terroristi: si attribuisce «a un atto turpe la grandezza di una causa sacra» (Hénaff 2016: 16).
In conclusione, cosa ho inteso fare, in sintesi, scrivendo questo saggio? Tanto per iniziare, un’analisi dal basso, vissuta fuori campo, come si direbbe nel gergo cinematografico. Prendendo spunto da alcuni frammenti di vita personale, privilegiando la profondità etnografica, ho inteso allargare la prospettiva a questioni di più ampio respiro antropologico, semiotico e filosofico. L’etnografia ha, a questo riguardo, per lo più operato in questo modo simile al mio, dal basso, nella prossimità della prima istanza: ha riflettuto sugli altri cercando di rimanere a stretto contatto con la vita del ricercatore e dei soggetti studiati. Ma, oltre a questo coagulo, c’è anche altro nei miei intenti. Prendendo spunto dalla mia stessa vita, in chiave quasi aneddotica benché comparativa, ho inteso sottolineare due ‘intrecci antropologici’ ai quali tengo molto: l’esistenza di un individuo può – deve – essere intesa come una forma di dialogo continuo con altri esseri a noi vicini e lontani; la vita stessa può essere vista come – non è altro che – una lunga ricerca di dialogismo nel suo complesso. Resta un ultimo punto da chiarire. Il particolare tono narrativo, usato in questo saggio, ha la sua importanza e punta in tre direzioni diverse. Se esso deriva, fondamentalmente, dal desiderio di mantenersi il più vicino possibile all’esperienza diretta che ho avuto dei fatti raccontati, è ugualmente vero che mira inoltre, a diluire, da una parte, la densità di alcuni concetti (disseminandoli, direbbe Derrida, senza per questo perderne la consistenza suppletiva) e, dall’altra, a rompere con alcune convenzioni di scrittura talvolta adottate in antropologia. La ‘svolta narrativa’ non è passata invano, almeno per quanto mi riguarda!
Per terminare, direi che si possono fare tanti usi della diversità (Geertz 2001). Il mio uso della diversità – com’è ormai definitivamente chiaro, spero – non deve prescindere dai modi, da me (ri)articolati, attraverso cui forme e processi del piano dell’espressione si coniugano con forme e processi del piano del contenuto. Questa (ri)articolazione è meno visibile, nella superficie del testo, a una prima lettura, perché ho teso a disseminare i concetti nella tonalità narrativa d’insieme e nel racconto delle storie da me vissute. Questa è la ragione per cui non ritengo opportuno fare una sintesi finale, puntuale e d’ordine esclusivamente teorico, circa il dialogo interreligioso e il rapporto tra monoteismi e forme dialogiche. La narrazione è, già, in sé, nel modo in cui l’ho organizzata, una logica dei possibili risvolti teorici d’ordine dialogico.
Dialoghi Mediterranei, n.22, novembre 2016
Riferimenti bibliografici
Assmann J., Non avrai altro Dio, Il Mulino, Bologna, 2007
Bettini M., Elogio del politeismo, Il Mulino, Bologna, 2014
Cannell F., “How does ritual matter”, in Questions of Anthropology, Astuti R., Parry J., Stafford C., eds., Berg, New York, 2007: 105-134
Capps L., Ochs E., “Coltivare la preghiera”, in Ochs E., Linguaggio e cultura, Carocci, Roma, 2006: 225-247
Clifford J., Ai margini dell’antropologia, Meltemi, Roma, 2004 (2003)
Davies D. J., The Mormon Culture of Salvation, Ashgate, University of Durham, 2000
Davies D. J., An Introduction to Mormonism, Cambridge University Press, New York, 2003
De Rosny E., Les yeux de ma chèvre. Sur le pas des maîtres de la nuit en pays douala (Cameroun). Plon, Parigi, 1981
Evans-Pritchard E. E., Social Anthropology, Cohen & West, Londra, 1951
Evans-Pritchard E. E., Nuer Religion, Clarendon Press, Oxford, 1956
Geertz C., Islam. Lo sviluppo religioso in Marocco e in Indonesia, Raffaello Cortina, Milano, 2008 (1968)
Geertz C., “La religione come sistema culturale”, in Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna, 1987 (1973): 111-159
Geertz C., “Gli usi della diversità”, in Antropologia e filosofia, Il Mulino, Bologna, 2001 (2000): 85-106
Greimas A. J., “Il sapere e il credere: un solo universo cognitivo”, in Del senso 2. Narrativa, modalità, passioni, Bompiani, Milano, 1985 (1983): 111-129
Hénaff M., Figure della violenza. Ira terrore e vendetta, Castelvecchi, Roma, 2016
Jullien F., L’universale e il comune. Il dialogo tra culture, Laterza, Roma-Bari, 2010 (2008)
Kuhn T., La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino, 1979 (1970)
Mauss M., “Saggio sul dono”, in Teoria generale della magia, Einaudi, Torino, 1965 (1950): 155-292
Needham R., Credere, Rosenberg & Sellier, Torino, 1976 (1972)
Ricœur P., “Sfida e felicità della traduzione”, in La traduzione. Una sfida etica, Morcelliana, Brescia, 2001 (1997): 41-50
Stromberg P. G., Language and self-transformation. A Study of the Christian conversion narrative, Cambridge University Press, New York, 1993
Turner E., Experiencing Ritual, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1992
Van Gennep A., I riti di passaggio, Bollati Boringhieri, Torino, 1981 (1909)
Wachtel N., La fede del ricordo. Ritratti e itinerari di marrani in America (xvi-xx secolo), Einaudi, Torino, 2003 (2001).
________________________________________________________________
Stefano Montes, ha insegnato Letteratura francese, Antropologia Culturale e Semiotica nelle Università di Parigi, Catania, Tartu, Tallinn, Palermo e Agrigento. Al di là delle etichette disciplinari, s’interessa ai modi molteplici secondo cui dinamiche culturali organizzano forme testuali (letterarie ed etnografiche). Nelle sue ricerche, ha privilegiato le analisi delle narrazioni di vita, lo studio delle modalità di produzione della cultura in alcuni testi esemplari, l’enunciazione della soggettività nelle teorie e pratiche antropologiche. Da alcuni anni i suoi campi di interesse scientifico vertono sulle strategie di conversione religiosa e sull’esperienza turistica.
________________________________________________________________