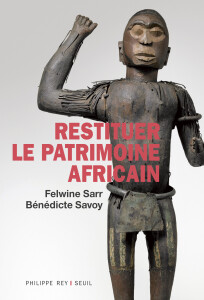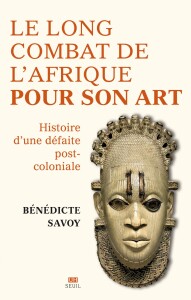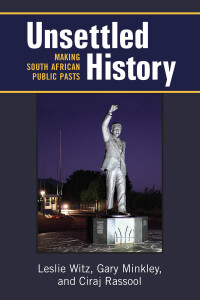Per la restituzione del patrimonio
Il 28 novembre 2017, durante il suo viaggio a Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, il presidente francese Emmanuel Macron pronunciò un discorso all’università cittadina davanti a centinaia di studenti in cui promise di impegnarsi «senza indugio» perché entro cinque anni venissero soddisfatte «le condizioni per la restituzione, temporanea o definitiva, del patrimonio africano in Africa», a partire da ventisei oggetti reali da riconsegnare al Benin, che li richiedeva da tempo. Si avviò un dibattito negli ambienti culturali tra chi era certamente d’accordo e chi, invece, temeva di vedere gallerie e musei svuotati delle opere che ne avevano fatto la ricchezza e il prestigio. La domanda era ed è quella se sia davvero possibile riportare quelle opere in Africa. C’era e c’è da affrontare innanzitutto una questione giuridica, tuttavia il tema è anche molto più complesso, perché riguarda aspetti culturali e identitari per le stesse comunità africane.
Dopo il discorso all’università burkinabé, Macron commissionò uno studio su quel tema alla storica Bénédicte Savoy e all’accademica e scrittrice senegalese Felwine Sarr, che fu consegnato esattamente un anno dopo, quindi pubblicato prima online, in francese e in inglese, poi per le Editions du Seuil – Philippe Rey, con il titolo Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle [1]. Nelle 240 pagine del documento, nella sua versione PDF online, le autrici sostengono con convinzione la restituzione a lungo termine all’Africa del patrimonio saccheggiato durante il periodo coloniale, ma ritengono anche che gli archivi documentali, fotografici e cinematografici debbano essere condivisi, consce che anche in questo campo le cose sono particolarmente articolate:
«Per restare al solo caso francese, al momento dell’indipendenza, gli archivi prodotti dalle autorità coloniali nel continente africano furono divisi in due grandi gruppi: gli archivi dell’Africa occidentale francese rimasero a Dakar in un accordo comune tra Francia e Senegal; quelli dell’Africa Equatoriale Francese, invece, furono in parte trasferiti all’Archivio Nazionale d’Oltremare, ad Aix-en Provence (archivi di sovranità), e un’altra parte rimase a Brazzaville (archivi di gestione), divisione non sempre molto rigida. Altri tipi di documenti, provenienti ad esempio da indagini etnografiche effettuate in Africa negli anni Trenta, sono stati collocati negli archivi di musei o istituti universitari» (Sarr, Savoy 2018: 34)
Nonostante gli sforzi compiuti in Europa negli ultimi anni per porre rimedio a questa deprivazione di fonti e risorse, il lavoro attuale è effettuato unicamente sugli archivi dei musei pubblici, ma i “giacimenti” di informazioni sono molti di più, perché riguardano archivi di opere, inventari, tutte le forme di valore aggiunto delle competenze prodotte attorno agli oggetti durante la loro musealizzazione, materiali audiovisivi provenienti da indagini etnografiche, registrazioni sonore, fotografie, film documentari sulle società e sugli individui africani studiati dagli scienziati. Evidentemente, la questione degli archivi amministrativi, militari e diplomatici va molto oltre quella della «restituzione temporanea o definitiva del patrimonio africano all’Africa» voluta dal presidente Macron. Per questa ragione, Sarr e Savoy avanzano nel loro lavoro la necessità di un piano specifico, affidato a specialisti di archivi e storia dell’Africa.
Limitando il discorso agli oggetti, una fase essenziale è chiaramente quella dell’inventario, della condivisione digitale e della consultazione transcontinentale, che viene proposta in quattro sezioni distinte, volte alla messa in rete ad accesso libero di tutti i beni, al fine di promuovere una restituzione ordinata del materiale iconografico, cinematografico e sonoro riguardante le società africane, nonché di un certo numero di opere autentiche ritenute importanti dagli Stati o dalle comunità interessate.
Il compito non è semplice, perché richiede un’ingente mobilitazione di risorse umane e finanziarie, dovute anche al fatto che un gran numero di musei francesi non ha un inventario aggiornato o completo. Com’è intuibile, senza un inventario facilmente accessibile le richieste di restituzione possono essere considerate solo in modo vago. Inoltre, questo aspetto tocca anche la politica sui diritti d’immagine, che evidentemente deve essere sottoposta a una revisione completa, in particolare per quanto riguarda le richieste dei Paesi africani: la biblioteca iconografica del Musée du Quai Branly-Jacques Chirac di Parigi, ad esempio, negli ultimi anni ha compiuto intense campagne di digitalizzazione delle opere e dei documenti (fotografici, sonori o cinematografici) raccolti al tempo del controllo coloniale francese in Africa, per cui Sarr e Savoy raccomandano lo sviluppo di un portale unico «che dia accesso a questa preziosa documentazione» ad un pubblico straniero che potrebbe avere difficoltà ad orientarsi tra la moltitudine di istituzioni francesi che ne sono interessate.
Bénédicte Savoy è professoressa di Storia dell’Arte all’università di Berlino e da anni è impegnata sul tema della restituzione verso l’Africa (Savoy 2023), ma oltre al “Rapporto” realizzato dopo il discorso di Macron, un suo libro di particolare interesse è Le Long Combat de l’Afrique pour son art (2023), in cui spiega che le prime richieste di restituzione africane (e dunque l’origine del dibattito internazionale) risalgono al ventennio tra il 1965 e il 1985. A metà degli anni Sessanta, infatti, la rivista “Bingo”, pubblicata a Dakar, ospitò un editoriale dell’allora direttore beninese Paulin Joachim intitolato “Rendez nous l’art nègre” (“Ridateci l’arte nera”), poi ci fu il primo Festival Panafricano di Algeri nel 1969, dove venne affrontata la questione accanto alla denuncia degli orrori del colonialismo e delle conseguenze del neocolonialismo [2]. Nel 1970 fu diffuso il cortometraggio “You Hide Me”, di Nii Kwate Owoo, in cui il regista ghanese filmò una giornata nelle riserve del British Museum di Londra, dove sono conservate decine di migliaia di opere dell’antica arte africana, realizzando un vero e proprio manifesto contro le pretese dei musei europei e a favore della restituzione delle opere d’arte all’Africa.
Dopo gli intellettuali, negli anni Settanta la richiesta è portata avanti dai politici, come il presidente zairese Mobutu nel 1973, che la avanzò all’ONU o come il senegalese Amadou-Mahtar M’Bow che nel 1978 sollevò la questione mentre era direttore generale dell’UNESCO, quando scrisse:
«I popoli vittime di questo saccheggio, talvolta secolare, non furono solo derubati di capolavori insostituibili: furono privati di una memoria che li avrebbe sicuramente aiutati a conoscere meglio se stessi, sicuramente a farsi meglio comprendere dagli altri» (M’Bow 1978).
Quelle richieste seguirono gli anni centrali dei vari processi di indipendenza ed erano motivate dalla necessità dei Paesi africani di riconnettersi con il loro patrimonio immateriale da un lato (le loro lingue, le loro filosofie, le loro storie) ma anche con il loro patrimonio materiale, ossia ciò che era stato loro tolto dai missionari e dalle potenze europee durante il periodo coloniale. In altri termini, sentivano la necessità di ritrovare le forze progettuali per costruire il proprio futuro ed essere in grado di andare avanti. Evidentemente, oggi l’Europa non fa che rispondere a quegli appelli di mezzo secolo fa, anche se le resistenze continuano ad essere molte, spesso di natura burocratica e legislativa (restituire a chi? rimpatriare dove?) o legate alla preoccupazione che altrove le opere non riceverebbero il medesimo livello di attenzione e cura. Ad esempio, alla fine degli anni Settanta, l’antropologo Jean Guiart, allora responsabile delle collezioni del Musée de l’Homme di Parigi, dichiarò di preferire degli scambi culturali piuttosto che le restituzioni unilaterali: «Personalmente valuterei una serie di accordi con istituzioni culturali che permettano scambi di pezzi e di personale […], che ci permettano di poter restituire quanto sia necessario far ritornare, ma anche di completare le collezioni con noi ogni volta che sia opportuno» (Beyer 2021). Oppure il collezionista Jean Roudillou, per il quale «la prima cosa da fare sarebbe innanzitutto e con urgenza preservare ciò che resta in questi Paesi» (Beyer 2021); infatti, nel 1978 una delle condizioni poste dall’UNESCO era che «la restituzione non comporti un degrado, affinché queste opere possano essere adeguatamente conservate nei Paesi che le recupereranno». In altre parole, il buon esito delle restituzioni dipendeva dalla capacità materiale dei Paesi richiedenti – nella maggior parte dei casi Paesi in via di sviluppo – di conservare il proprio patrimonio, nonché dalla garanzia che gli oggetti restituiti fossero «messi a disposizione del maggior numero di persone» e non rinchiusi in un ‘santuario’ chiuso al pubblico o destinato ad uso privato (M’Bow 1978).
In effetti alcune restituzioni cominciarono ad essere effettuate già tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, quando il Belgio restituì all’allora Zaire diverse migliaia di beni culturali e aiutò Kinshasa ad organizzare una rete di musei; i Paesi Bassi e l’Indonesia si accordarono per una vasta restituzione di oggetti, in particolare diverse statue buddiste e indù. In quegli anni avvennero restituzioni anche tra Paesi di altre zone del mondo, come ad esempio quelli promossi da varie istituzioni culturali statunitensi (il Peabody Museum dell’Università di Harvard, il Brooklyn Museum, l’Oakland Museum e l’Università della Pennsylvania) che restituirono numerosi oggetti culturali al Perù e a Panama; l’Australia e la Nuova Zelanda riconsegnarono alla Papua Nuova Guinea diversi oggetti etnografici; il Sud Africa restituì allo Zimbabwe degli uccelli scolpiti conservati al Museo di Città del Capo; la Nuova Zelanda ridiede più di mille oggetti culturali alle Isole Salomone e l’Australia fece lo stesso con un grande tamburo cerimoniale a Vanuatu. E l’elenco potrebbe proseguire a lungo.
La svolta è avvenuta certamente con il discorso di Macron nel novembre 2017, che segna un prima e un dopo: ormai lo slancio è dato, nonostante esistano ancora notevoli resistenze. Tuttavia, come ha dichiarato Bénédicte Savoy in un’intervista a “La Vie” nel giugno 2023, «la restituzione del patrimonio culturale africano è un grande progetto per il XXI secolo». Anche perché, come riferisce Isabel Pasquier di “France Inter”, l’Africa «è espropriata dell’85-90% degli oggetti d’arte del suo patrimonio», una situazione drammatica che si tramuta in una vera e propria tragedia per la popolazione del continente, che non ha accesso alle «fondamenta della sua cultura» (Pasquier 2021).
Il tema però non è semplicemente quello di “restituire” e di “rimpatriare” tali oggetti, perché il punto è, piuttosto, ragionare su aspetti molto più profondi, che contemplino uno sforzo a impegnarsi collettivamente sull’ingiustizia coloniale e a ripensare le collezioni etnografiche dei musei; significa, cioè, rendere plurale la conoscenza e la memoria, nonché combattere contro il razzismo. Sembrerebbe un percorso idealistico e lontano dalla concretezza pragmatica della mera restituzione, eppure è quanto propone e argomenta Ciraj Rassool, professore di Studi sul Patrimonio all’università di Western Cape, in Sudafrica, nonché consulente di numerosi musei e istituzioni culturali internazionali. Nel suo libro del 2017, scritto con Leslie Witz e Gary Minkley, intitolato Unsettled History: Making South African Public Pasts, Rassool spiega che, dopo l’apartheid, un “nuovo” Sud Africa può nascere solo da luoghi di produzione del patrimonio come musei, raccolte di fotografie, archivi… e, evidentemente, è una faccenda interna al Paese; tuttavia, può essere affrontata solo con la disponibilità della comunità più ampia, in particolare quella delle vecchie potenze coloniali.
La ragione ruota proprio intorno alla “restituzione”, che non può essere limitata alle sole opere d’arte o agli oggetti depredati dai colonizzatori, ma che deve considerare anche il profondo e lacerante tema dei resti umani prelevati dagli studiosi europei dell’Ottocento e del primo Novecento, progressivamente “oggettificati” nei musei o nei laboratori, quando invece si tratta di resti di persone, di memorie, di antenati.
In vari saggi (Rassool 2000, 2015, 2022), Rassool approfondisce questo aspetto partendo dal caso storico dell’antropologo austriaco Rudolph Pöch, che all’inizio del XX secolo dissotterrò con la sua equipe in una fattoria vicino a Mopedi, nella regione di Kuruman, in Sudafrica, i cadaveri di Trooi e Klaas Pienaar, due contadini morti poco prima di febbre malarica. A quei cadaveri furono spezzate le ginocchia per farli entrare in un barile pieno di sale e posti su un carro trainato da buoi e poi inviati in Austria. Decenni dopo, il Museo di Storia Naturale di Vienna scoprì che nella sua collezione c’erano resti di bambini ebrei e decise di voler restituirli. Ciò mise in moto un processo di restituzione dei resti umani, come quelli di Klaas e Trooi Pienaar, che facevano parte di un’intera collezione di resti dell’Africa meridionale e per molto tempo furono assemblati ed esposti come documenti o addirittura come cultura materiale.
Questo esempio mostra come la “restituzione” non possa limitarsi e ridursi a una faccenda formale, perché in realtà solleva una discussione diversa da quella sulla riconsegna delle opere d’arte e della cultura materiale. Oggi, aggiunge Rassool, anche volendo considerare la collezione in Europa di oggetti e opere d’arte originari di ex-colonie come una forma di cura, dove non c’è più un collezionismo e una musealizzazione violenti, non si può restare indifferenti dinnanzi alla conservazione dei resti umani, che fu una pratica crudele: «è ormai ampiamente accettato che la raccolta di resti umani e la conduzione di ricerche nell’antropologia fisica facessero parte della violenza del colonialismo e del razzismo» (Rassool 2022°: 60).
Se dunque è generalmente riconosciuto il sostegno alla restituzione di beni e resti umani, a questo punto emerge una nuova difficoltà: come va effettuata? La restituzione è un processo di cui si occupano i governi e gli Stati, e deve essere finanziato e seguire certe procedure, ma il caso della restituzione degli antenati non può essere ridotto alla riconsegna di frammenti biologici rappresentanti un certo tipo di storia, perché ciò che resta di quei corpi è parte di individui che furono, con storie che hanno un significato più profondo: si deve trovare un modo di commemorare che lenisca e guarisca, ma che al tempo stesso mantenga la violenza della storia e continui a mostrarla, perché non la si dimentichi e non la si debba subire nuovamente. A questo proposito, Ciraj Rassool sostiene che questa fase del processo è interamente nelle mani degli africani, perché – come ha spiegato in una conferenza tenuta a Colonia, in Germania, lo scorso 6 dicembre 2023 – non esiste alcun modello a cui riferirsi e non ci si può affidare solo ai biologi o agli anatomopatologi, perché per tali scienziati quei resti sono diventati oggetti:
«Noi, invece, li dobbiamo “riumanizzare”; per noi questa è una politica volta a invertire la disumanizzazione della vita. E invertire la disumanizzazione del museo, cioè la disumanizzazione degli esseri trasformati in oggetti seriali, in oggetti razziali» [3].

Deposizione dei resti umani del Pienaar (Per gentile concessione dell’Ambasciata del Sud Africa, Vienna)
Rassool fa riferimento alla necessità che le restituzioni siano accompagnate da cerimonie culturali, perché quei resti devono essere restituiti nelle bare. È una pratica tutt’altro che facile, perché la legislazione europea spesso non lo consente, anche se nel caso di Klaas e Trooi Pienaar i politici austriaci ed i diplomatici sono stati in grado di accordarsi e trovare una soluzione praticabile, per cui quei resti sono stati poi effettivamente riportati in Sud Africa nel 2012, dove hanno ricevuto una serie di toccanti cerimonie. Queste, in particolare, sono state “inventate” a partire da frammenti di memoria collettiva tra le comunità locali, in cui le persone ricordavano ancora Troi Pienaar, addirittura prima di sposare Klaas Pienaar: ricordavano, ad esempio, che, molto probabilmente, erano stati costretti a fuggire dal genocidio nel sud della Namibia e che erano passati in Sud Africa, dove erano diventati braccianti agricoli (Rassool 2022b).
La persona incaricata della cerimonia fu il guaritore Petrus Vaalboi, coinvolto fin dai negoziati con l’UNESCO, prima con un rito nel salone dell’Accademia austriaca delle scienze il 17 aprile 2012, spiegando ai due defunti cosa era venuto a fare e quali cambiamenti erano avvenuti nella loro terra natale, poi con una seconda cerimonia in Sud Africa, al rientro dei corpi il 19 aprile, quando – sempre rivolgendosi ai resti di Troi e Klaas Pienaar – ha illustrato il processo attraverso il quale si sarebbero riuniti al loro popolo e al loro paese [4]. Successivamente, la sepoltura ufficiale è avvenuta il 12 agosto 2012 nel cimitero pubblico di Kuruman, alla presenza dell’allora presidente del Sud Africa, Jacob Zuma, il quale ha ringraziato la delegazione austriaca con le seguenti parole:
«Cogliamo l’occasione per ringraziare il governo austriaco per aver compiuto questo passo e per aver collaborato con noi per dare una conclusione a questa dolorosa questione. Collaborando con il governo austriaco stavamo trasformando i tragici eventi accaduti ai coniugi Pienaar in un’opportunità di guarigione. È anche un’occasione per rafforzare i legami di amicizia e solidarietà tra i nostri due Paesi. […] Sono stati riumanizzati e hanno riacquistato la loro identità sudafricana, 103 anni dopo la tragedia che li ha colpiti» (Zuma 2012).
Nel confronto di chiusura dell’incontro del 6 dicembre al Rautenstrauch-Joest Museum di Colonia, Bénédicte Savoy e Ciraj Rassool hanno convenuto che bisogna insistere su un processo di restituzione collettiva: degli antenati, delle loro opere d’arte e dei loro oggetti, nonché della documentazione prodotta all’epoca. In altre parole, non si possono dissociare le persone dai loro beni, per cui deve trattarsi di una restituzione su vasta scala, che potrà dirsi completa solo se realizzata in cooperazione e accompagnata da un lavoro riparatore. Evidentemente, questo non avverrà dall’oggi al domani, ma è un impegno che, ha concluso Rassool, ci riguarderà per almeno un’altra generazione.
Questo significa anche ripensare i musei – in particolare quelli antropologici europei – in una chiave che Anna Brus e Martin Zillinger (2022) individuano nella necessità di descrivere le modalità coloniali, esplicitando le quali si può cercare un impulso postcoloniale che fornisca diverse epistemologie: «Tali impulsi creano un museo che non si sta solo trasformando, ma che può anche favorire la trasformazione ben oltre le sue mura […], coinvolgendo le comunità e le loro pratiche».
Nei musei, gli oggetti vengono esposti in modo diverso da come erano conosciuti, conservati e usati nella loro comunità originaria. Da questa consapevolezza, Nelson Adebo Abiti (2022) descrive come, dopo le devastazioni della guerra civile in Uganda conclusasi nel 2006, l’equipe del National Museum of Uganda si è recata presso le comunità che avevano sofferto esperienze di estrema violenza portando loro una lancia reale, che ormai non avevano più. Ciò ha permesso loro di effettuare dei rituali di mediazione e riconciliazione, durante i quali quelle lance «sono state trasformate da artefatto a spirito», diventando così uno strumento dell’autorità ancestrale e favorendo una riconnessione con il loro passato lacerato prima dal colonialismo, poi dalla guerra civile. In altre parole, con l’aiuto di quegli oggetti conservati presso il museo è possibile recuperare e riorganizzare i memoriali della comunità, attraverso i quali poi superare le carenze, la violenza e le lacerazioni del tessuto sociale.
Un museo consapevole che i propri manufatti possono avere un nuovo significato e un nuovo potere si trasforma in un’istituzione con una nuova mission, perché assume la capacità di favorire la cooperazione, l’elaborazione del dolore, il perdono, la giustizia, la riconciliazione, il rinnovamento.
Dialoghi Mediterranei, n. 65, gennaio 2024
Note
[1] In italiano: “Rapporto sulla restituzione del patrimonio culturale africano. Verso una nuova etica relazionale”.
[2] Si veda il film “Festival panafricain d’Alger 1969”, di William Klein, del 1969 e presentato alla “Quinzaine des Réalisateurs” al Festival di Cannes del 1971.
[3] La conferenza si è tenuta presso il Rautenstrauch-Joest Museum di Colonia, in Germania, intitolata “2018-2023. 5 Years of Making and Debating Restitution”, nell’ambito del ciclo di incontri “Cologne Crossroads Conversation”, e vi hanno partecipato Bénédicte Savoy e Ciraj Rassool. Per ulteriori informazioni o per vedere il video della conversazione: https://boasblogs.org/dcntr/5-years-of-making-and-debating-restitution/
[4] Le informazioni sono tratte da una cronaca del tempo: “The repatriation of Klaas and Trooi Pienaar to South Africa in 2012”: https://leichenimkeller.at/ev13-repatriation-pienaar
Riferimenti bibliografici
Abiti Nelson Adebo, 2021, “The Uganda Museum’s Tribal Representation: Colonial Repositories and Community Reconciliation in Uganda”, in Brus Anna, Zillinger Martin (a cura di), “Transforming the Post/Colonial Museum”, numero monografico di “ZfK – Zeitschrift für Kulturwissenschaften”, vol. 2.
Beyer Cyrille, 2021, “1978 : l’appel de l’UNESCO pour le retour d’œuvres d’art dans leur pays d’origine”, in “INA”, 28 ottobre: https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/1978-l-appel-de-l-unesco-pour-le-retour-de-certaines-oeuvres-d-art-a-leur-pays-d-origine
Brus Anna, Zillinger Martin (a cura di), 2021, “Transforming the Post/Colonial Museum”, numero monografico di “ZfK – Zeitschrift für Kulturwissenschaften”, vol. 2.
Chaudey Marie, 2023, “La restitution du patrimoine culturel africain est un grand projet pour le XXIe siècle”. Interview à Bénédicte Savoy, in “La Vie”, 29 giugno: https://www.lavie.fr/ma-vie/culture/afrique-la-restitution-du-patrimoine-culturel-africain-est-un-grand-projet-pour-le-xxie-siecle-89089.php
M’Bow Amadou-Mahtar, 1978, “Qu’est-ce que : le retour ou la restitution des biens culturels”, UNESCO, Parigi, disponibile online: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000054552_fre
Meyer Andrea, Savoy Bénédicte (a cura di), 2023, “Atlas der Abwesenheit. Kameruns Kulturerbe in Deutschland”, Dietrich Reimer Verlag, Berlino.
Pasquier Isabel, 2021, “La restitution de 26 pièces du Trésor d’Abomey au Bénin, une première historique”, in “France Inter”, 26 ottobre: https://www.radiofrance.fr/franceinter/la-restitution-de-26-pieces-du-tresor-d-abomey-au-benin-une-premiere-historique-3307870
Rassool Ciraj, Legassick Martin, 2000, “Skeletons in the Cupboard: South African Museums and the Trade in Human Remains 1907-1917”, South African Museum, Cape Town.
Rassool Ciraj, 2015, “Re-storing the skeletons of empire: Return, reburial and rehumanisation in southern Africa”, in “Journal of Southern African Studies”, vol. 41, 3: 653-670.
Rassool Ciraj, 2022a, “Rethinking the Ethnographic Museum”, in Greiner Clemens, van Wolputte Steven, Leuven KU, Bollig Michael (a cura di), “African Futures”, Brill, Leiden-Boston: 56-66.
Rassool Ciraj, 2022b, “Humans, not symbols”, trascrizione di una conferenza tenuta a Palermo il 3 giugno 2022, disponibile sul sito della “Fondazione Studio Rizoma”: https://studiorizoma.org/editorial/humans-not-symbols/
Sarr Felwine, Savoy Bénédicte, 2018, “Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle”, Editions du Seuil – Philippe Rey, Parigi.
Witz Leslie, Minkley Gary, Rassool Ciraj, 2017, “Unsettled History: Making South African Public Pasts”, University of Michigan Press, Ann Arbor.
Zuma Jacob, 2012, “Speech by President Jacob Zuma on the occasion of the reburial of Mr and Mrs Klaas and Trooi Pienaar at Kuruman, Northern Cape province”, sito del governo sudafricano, 12 agosto: https://www.gov.za/news/speeches/speech-president-jacob-zuma-occasion-reburial-mr-and-mrs-klaas-and-trooi-pienaar
_____________________________________________________________
Giovanni Gugg, dottore di ricerca in Antropologia culturale è assegnista di ricerca presso il LESC (Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative) dell’Université Paris-Nanterre e del CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) e docente a contratto di Antropologia urbana presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università “Federico II” di Napoli. Attualmente è scientific advisor per ISSNOVA (Institute for Sustainable Society and Innovation) e membro del consiglio di amministrazione del CMEA (Centro Meridionale di Educazione Ambientale). I suoi studi riguardano il rapporto tra le comunità umane e il loro ambiente, soprattutto quando si tratta di territori a rischio, e la relazione tra umani e animali, con particolare attenzione al contesto giuridico e giudiziario. Ha recentemente pubblicato per le edizioni del Museo Pasqualino il volume: Crisi e riti della contemporaneità. Antropologia ed emergenze sanitarie, belliche e climatiche.
______________________________________________________________