
De civitate dei, di Agostino, La città terrena e quella celeste, 1450-1500 ca.
Biblioteca Nazionale di Parigi ms. 19 f. 55
di Leo Di Simone
Un compito arduo attende l’umanità di questo terzo millennio ai suoi esordi. Oggi che le speranze e le attese di una umanità pacificata dall’avvento di una giustizia universale vengono violentemente frustrate da una guerra che dura oltre ogni buon senso ed ogni buon teorico intento, la minaccia di una conflagrazione atomica appare come la coerente conseguenza di un’insensatezza culturale che ha infettato il pianeta in maniera globale, una più terribile pandemia dello spirito e dell’intelletto. A nulla sono valse le importanti conquiste scientifiche che hanno contribuito a migliorare le condizioni di vita dell’umanità; vengono costantemente spazzate via da una forza violenta e primordiale che distrugge in un attimo ciò che con tanta fatica l’umanità ha cercato di costruire per riscattare se stessa.
La città degli uomini è diventata inospitale anche a causa di quel processo tecnologico di cui la modernità è andata così fiera e nessuno riflette sul fatto che ogni grande città di questo mondo ha un obice designato e preposto alla sua distruzione. Se non si corre ai ripari, in ogni nostra città le pur belle prospettive architettoniche e monumentali assumeranno la forma informe dei cumuli di macerie che osserviamo impotentemente attoniti nelle città distrutte dell’Ucraina, dello Yemen, della Siria e di tanti altri Paesi dove la guerra sta facendo tabula rasa. Le città sono sotto il segno della morte e la violenza che hanno partorito è ora su di esse e può calare da un momento all’altro su ogni altro luogo abitato. Allora sarà il deserto. La città non sarà più l’immagine microcosmica della struttura del mondo, agglomerato non sviluppato casualmente ma cresciuto secondo precise coordinate intorno ad un centro ideale, analogo terreno dell’asse celeste, omphalós, mundus, asse del mondo, secondo una concezione identificabile non solo nella Grecia antica ma anche nell’antica Mesopotamia e in Egitto. Al di là di queste ideali proiezioni simboliche si prospetta la crudezza e la brutalità del deserto, la “non città” molte volte desiderata e ricercata per sottrarsi alla tirannia di una convivenza impossibile, la ricerca di un érēmos dove ritirarsi e ritrovarsi.
Da qui la necessità di rifondare la città che per adesso assumiamo come simbolo utopico dell’armonica convivenza umana e dell’edificazione di una cultura di giustizia, di pace e di concordia tra gli esseri umani, secondo leggi ispirate dall’ideale del «buon governo» (εὐνομια), ossia dell’ordine conforme alla giustizia che già Solone (VII-VI sec. a. C.) rappresentava nella sua opera costituzionale: promulgazione di leggi ispirate a principi di equità sociale e politica, destinate ai cittadini di Atene e non pensate per i singoli, ma per la salvezza e la dignità della città, per sottrarla alla guerra civile, per tenerla lontana dalla tirannide.
A distanza di tanti secoli appare dunque necessario rifondare gli assetti giuridici, economici, etici, religiosi della nostra convivenza ormai caotica, se non si vuole che il fuoco atomico riduca la città in deserto. Ci appaiono sfocate o del tutto cancellate dalla memoria culturale le immagini di Hiroshima e Nagasaki, e nel campo della deterrenza atomica non abbiamo fatto grandi progressi negli ultimi sessant’anni, da quando cioè, in quell’ottobre del 1962, la crisi missilistica di Cuba mise gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica in procinto di far scoppiare una guerra nucleare. Ora la situazione non è cambiata e la minaccia permane.
Non tutti hanno contezza o rammentano gli enormi sforzi diplomatici messi in atto da papa Giovanni XXIII per scongiurare l’annunciata catastrofe e coronati, nell’aprile del 1963, dai pronunciamenti dell’enciclica Pacem in terris in cui il papa criticava fermamente la corsa agli armamenti e le armi nucleari. Rivolgendosi non solo ai cattolici, ma a tutte le persone di “buona volontà”, papa Giovanni sottolineava che il diritto umano più elementare è quello del diritto alla vita e che la guerra non è un mezzo adatto per difendere diritti violati. L’enciclica fu preludio di un pronunciamento ancora più duro e più netto, l’unica condanna pronunciata dal Concilio Ecumenico Vaticano II nella costituzione pastorale Gaudium et Spes del 1965, dove la riprovazione della guerra è espressa in maniera chiara ed inequivocabile:
«Ogni atto di guerra che indiscriminatamente mira alla distruzione di intere città o di vaste regioni e dei loro abitanti, è delitto contro Dio e contro la stessa umanità e con fermezza e senza esitazione deve essere condannato» [GS 80].
Ai nostri giorni, in questo frangente drammatico della storia umana in cui la crisi è totale e globale e l’emergenza bellica si accompagna a quelle economica, sanitaria, etica e religiosa, sembrano cadere nel vuoto di una cieca indifferenza istituzionale e politica le non meno accorate condanne pronunciate da papa Francesco nella denuncia dei mali che affliggono la città degli uomini. Anche tra chi ne loda gli accenti, e forse anche all’interno della stessa Chiesa cattolica, si ha la convinzione che il papa pronunci l’utopia, una verità certa invalidata dall’impossibilità di riposare in un luogo, meno che meno nella città degli uomini, luogo nato dalla paura e subito cintato di alte mura di difesa utilizzando come deterrente la paura stessa: paura dell’altro, del diverso, dello straniero, del nemico, della perdita del dominio… La moderna antropologia che indaga sulle origini dell’uomo e sulle forme della convivenza umana asserisce che la città, come struttura organizzata, è nata all’incirca cinquemila anni fa, contemporaneamente alla guerra. Come istituzione la città e la guerra nascono insieme, e non per pura coincidenza ma per rapporto organico. La guerra diventa il conflitto tra città e città, tra Stato e Stato ed è anche espressione esterna di un conflitto interno. Non per nulla il mito biblico ne attribuisce la paternità a Caino che la fonda dopo aver consumato l’omicidio del fratello per rivalità e gelosia (Gn 4,17).
Il discorso può certamente apparire antinomico, in quanto si riscontrano aspetti decisamente positivi nella città, consistenti nel vantaggio del vivere insieme, votati ad uno stesso impegno, legati ad una stessa legge, alla feconda logica dello scambio: la città come simbolo della grandezza dell’uomo, della sua inventiva, della sua natura razionale, della sua propensione estetica, della sua abilità pragmatica che connota la sua natura sociale e politica. Ma l’antinomia risiede intanto nella stessa natura dell’uomo, «angelo e bruto» ad un tempo per dirla con Pascal, per cui l’altra faccia della città tratteggia la stessa forza determinante la sua costruzione nell’istituzione del potere, che si arroga il ruolo di demiurgo, difensore e tutore.
 La città nacque attorno ai templi sacri, dove risiedevano divinità crudeli e normalmente vi si celebravano sacrifici umani per cementare col sangue votivo le sue mura e renderle inviolabili. Come ha osservato René Girard, il sacrificio – che è il sacrum facere – «contiene violenza come un esercito contiene gli attacchi dei suoi nemici e, come un esercito, contiene violenza nel senso che ne è occupato, nel senso che ha fatto della violenza la propria risorsa principale contro la violenza stessa» [1]. E questa logica antropologica ha sostenuto, fino al presente, l’espandersi delle “civiltà” in quanto queste, nel loro etimo, si ispirano alla civitas come luogo dell’orgoglio umano che per astuto processo di transignificazione assume l’accezione di miglioramento, progresso, positiva evoluzione, “civiltà” appunto!
La città nacque attorno ai templi sacri, dove risiedevano divinità crudeli e normalmente vi si celebravano sacrifici umani per cementare col sangue votivo le sue mura e renderle inviolabili. Come ha osservato René Girard, il sacrificio – che è il sacrum facere – «contiene violenza come un esercito contiene gli attacchi dei suoi nemici e, come un esercito, contiene violenza nel senso che ne è occupato, nel senso che ha fatto della violenza la propria risorsa principale contro la violenza stessa» [1]. E questa logica antropologica ha sostenuto, fino al presente, l’espandersi delle “civiltà” in quanto queste, nel loro etimo, si ispirano alla civitas come luogo dell’orgoglio umano che per astuto processo di transignificazione assume l’accezione di miglioramento, progresso, positiva evoluzione, “civiltà” appunto!
Né minore ambiguità risiede nel termine “politica”, nato nella Grecia antica già nel VII secolo a. C. per designare la nobile arte dell’organizzazione della pólis, la citta come luogo dei “molti” (οἵ πολλοί). Sia il termine “politico” che il termine “città” (πόλις) scaturiscono dalla stessa radice “πολ” della parola che dice «i molti» (οἵ πολλοί). Ma nell’assetto politico erano insite anche le lotte tra fazioni, le guerre tra le πόλεις, la lotta per il predominio e il potere. È ancora aperto tra gli studiosi il dibattito sulla questione della veridicità storica degli avvenimenti della guerra di Troia, ma i rinvenimenti archeologici di Heinrich Schliemann, che riscoprì Troia leggendo l’Iliade, hanno mostrato quella veridicità celata tra le righe del poema omerico, consentendo di collocare cronologicamente quella guerra verso la fine dell’età del bronzo, intorno al 1300-1200 a.C., come atto fondativo della “civiltà” occidentale. Dopo sette secoli circa, una guerra più subdola ma non meno nefasta cominciò a minare le basi della convivenza “civile” della pólis ad opera dell’astuzia del pensiero umano che con la retorica dei Sofisti riuscì a far passare per migliore il discorso peggiore: la politica diventò l’arte del “persuadere” e il vero e il falso persero il loro significato.
La denuncia di Socrate riferita da Platone rivela la distanza che ormai separava una politica pensata come servizio alla città da una politica congegnata e vissuta nell’ottica del principio di utilità: la politica come misura dell’utile dei governanti, le leggi plasmate secondo il principio sofistico del “giusto inganno gorgiano”, ad uso e beneficio esclusivo dei legislatori. Nel Gorgia Platone smaschera la retorica dei Sofisti e la riduce al rango di semplice abilità tecnica e irrazionale, incapace di insegnare il bene e la virtù come invece fa Socrate che nel “dialogo” ribadisce a più riprese il valore e l’importanza politica del filosofo nelle póleis, opponendosi alla spregiudicata attività dei sofisti che mirano unicamente al proprio utile ingannando i più con l’esercizio dell’eloquio retorico vacuo e infruttuoso. Guerra e cattiva politica sembrano dunque essere le cause deflagranti della distruzione della città degli uomini e ancora oggi perpetuano danni globali che si stanno rivelando irreparabili.
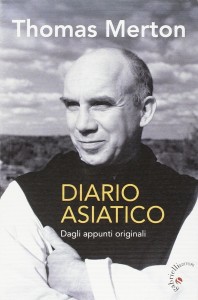 È dal 24 febbraio scorso che sorbiamo lo sbrodolarsi della retorica gorgiana dai discorsi dei potenti di questo mondo e degli accoliti di una politica asservita al potere economico dell’industria bellica; l’unica attività che non subirà certo i danni della recessione economica ormai ineluttabile, ed anzi la sua vera causa. E intanto «tutto è distrutto» come rispose il monaco e poeta buddista Thich Nhat Hahn a Thomas Merton che gli chiedeva sulla situazione della guerra in Vietnam. «Una risposta zen», commentò Merton, una risposta da monaco contemplativo che rivela l’essenza senza giri di parole [2]. «Tutto è distrutto», mentre politologi e opinionisti di geopolitica ragionano sulla questione degli armamenti nucleari, della installazione dei missili nucleari in perfetta logica col presupposto del vecchio criterio della «legittima difesa». Forniscono buone argomentazioni e sembrano ragionare bene, inquadrando nei loro obiettivi argomentativi la sagoma del nemico cui contrapporsi. Solo che nel loro ragionamento c’è un anello che non regge, ed è quello che lega la nostra coscienza storica, la nostra integrazione culturale nelle istituzioni che ci danno sicurezza, solidità, identità, alla nostra appartenenza al genere umano in quanto tale.
È dal 24 febbraio scorso che sorbiamo lo sbrodolarsi della retorica gorgiana dai discorsi dei potenti di questo mondo e degli accoliti di una politica asservita al potere economico dell’industria bellica; l’unica attività che non subirà certo i danni della recessione economica ormai ineluttabile, ed anzi la sua vera causa. E intanto «tutto è distrutto» come rispose il monaco e poeta buddista Thich Nhat Hahn a Thomas Merton che gli chiedeva sulla situazione della guerra in Vietnam. «Una risposta zen», commentò Merton, una risposta da monaco contemplativo che rivela l’essenza senza giri di parole [2]. «Tutto è distrutto», mentre politologi e opinionisti di geopolitica ragionano sulla questione degli armamenti nucleari, della installazione dei missili nucleari in perfetta logica col presupposto del vecchio criterio della «legittima difesa». Forniscono buone argomentazioni e sembrano ragionare bene, inquadrando nei loro obiettivi argomentativi la sagoma del nemico cui contrapporsi. Solo che nel loro ragionamento c’è un anello che non regge, ed è quello che lega la nostra coscienza storica, la nostra integrazione culturale nelle istituzioni che ci danno sicurezza, solidità, identità, alla nostra appartenenza al genere umano in quanto tale.
C’è stato un tempo che questo discorso della cosmopolia è stato tacciato a sua volta di retorica, ma non sono mancati i filosofi che hanno usato argomenti cosmopoliti riconoscendo che la vera patria dell’uomo è l’umanità intera. Anche ora, in tempi di rigurgiti nazionalistici e di integrismi populisti e sovranisti, il discorso appare ostico, ma in realtà funzionalmente alternativo ad una retorica che ha prodotto povertà, disuguaglianza, distruzione e morte nella città degli uomini. «Tutto è distrutto», e quello che può sembrare il riflesso romantico che ha volgarizzato il concetto dell’umanità come unica famiglia non può più essere neanche un postulato morale; fa riferimento diretto alla nostra coscienza antropica davanti alla minaccia della distruzione della specie. È un discorso realistico perché «tutto è distrutto» e il concetto di «legittima difesa» si mostra nella sua arcaicità ed appare insensato davanti all’ipotesi non peregrina dell’eventualità di un conflitto dove non ci sarebbero né vincitori né vinti. Solo il genere umano dissolto nel nulla.
Adesso dev’essere chiamata in causa la nostra vera ontologia di membri della famiglia umana. Non è più possibile alcuna distinzione, perché tutti siamo legati alla legge costitutiva della sopravvivenza, senza distinzioni di razza, perché muoiono i bianchi e i neri, né di ideologia, perché muoiono quelli di destra e quelli di sinistra, né di religione perché muoiono gli atei, i cristiani, i musulmani, i buddisti… La minaccia della distruzione della città degli uomini deve indurci a riscoprire questa nostra condizione fondamentale. Il sentirsi appartenenti responsabili della specie umana costringe a capovolgere i punti di riferimento della coscienza culturale; i temi, i modelli, le istituzioni che hanno plasmato la nostra coscienza civica ed etica hanno perso ogni fondamento, riposano sul letto di una retorica trita, stanca ed autoreferenziale che se correttamente intesa, nell’ottica dell’inganno e alla luce della verità che nega, non può non provocare un senso di estraniamento. Di fronte ai vacui ragionamenti di una retorica ormai globalizzata non si può che sentirsi stranieri, estranei a quella città che implode dalle sue stesse fondamenta che sembravano renderla sicura, le fondamenta dalle quali si ergono le mura dell’esclusione, dell’apologia culturale, dei campanilismi, dei nazionalismi, delle autarchie. Acquisire la condizione di straniero vuol dire acquisire la coscienza di umanità, ritrovare la misura universale dell’umanità dove tutte le distinzioni culturali e ideologiche vengono annullate. Permangono solo quelle dell’assoluta unicità e diversità individuale che appartengono alla natura e sono la ricchezza della specie umana, la sua variegata ontologia. Siamo tutti diversi, dunque tutti uguali nella diversità.
Come ci si può incamminare verso l’utopia concreta di una vivibile città degli uomini? Verso il ritrovamento dello stupore della bellezza della condizione umana? Verso il riacquisto dell’occhio contemplativo che sa leggere nell’intimo la nobiltà di questa natura donataci non come un diritto che ci compete ma come inspiegabile e gratuito mistero d’amore? Dove troveremo il convincimento che tutti entriamo nella città come stranieri e che della città non ne avremo mai il possesso poiché essa non ci appartiene se non nell’illusione dei privilegi sui quali ci siamo installati e che non qualificano la nostra condizione umana? Non è certo facile dare risposta a questi e a tanti altri simili interrogativi che riguardano la liberazione della coscienza dai condizionamenti che la città come insediamento culturale ci ha fornito livellando le nostre diversità di stranieri alla logica dell’omologazione, all’abitudine allo scontato, al previsto, al preordinato, al predetto di un linguaggio senza senso e non più significante. Una cultura che invece di coltivare la cooperazione tra stranieri quali tutti siamo in questa città del mondo, ha trasformato ogni straniero in nemico e ciascuno nemico di un nemico. Se gli uomini si legano tra loro in amicizie o società, regolando i loro rapporti con le leggi, ciò è dovuto soltanto al timore reciproco pensava Thomas Hobbes: «Homo homini lupus», in quanto la natura umana è fondamentalmente egoistica, e a determinare le azioni dell’uomo sono soltanto l’istinto di sopravvivenza e di sopraffazione. Se questa visione filosofica è vera non c’è alternativa al deserto ed è negata ogni possibile disposizione al cambiamento, ogni conversione di rotta, ogni evangelica metànoia insieme alla luce dell’intelletto e alla libertà del cuore che costituiscono il miracolo dell’essere umano. Il problema, a ben vedere, appare meramente culturale, al di là di ogni ragionevole dubbio che Hobbes non si è posto.
Bisognerà, per sopperire a questa ragione rassegnata all’ineluttabilità dell’esistente, recuperare una ragione utopica che possa aprire a nuove prospettive. Si potrà obiettare che dopo il fallimento delle tre grandi utopie del XX secolo, quella del comunismo così come ha avuto corso in Unione Sovietica, quella nietzscheana senza speranza sfruttata dal nazismo e quella del capitalismo neoliberale che provoca più danni delle prime due messe insieme, appare arduo parlare di utopia. Anche qui è necessario uscire fuori dagli schemi culturali che hanno relegato l’utopia nel campo dell’impossibile e riscriverne il senso nella direzione tracciata da Max Horkheimer che ne rileva due tratti essenziali: la critica di ciò che è e la rappresentazione di ciò che dovrebbe essere [3].
Utopico è ciò che non ha luogo, ma non per questo non potrebbe averlo. Se non lo ha ci sono delle cause ostative alla sua collocazione, al suo aver luogo, al suo manifestarsi, all’esserci. Forse culturalmente siamo convinti che un altro mondo non è possibile, che è impossibile edificare una città diversa dall’attuale, senza barriere difensive, accogliente invece che escludente. Marxismo, nazismo, capitalismo sono sistemi utopici senza libertà, refrattari ad una critica interna e feroci contro quanti non si identificano con essi. Hanno identificato in se stessi il luogo della loro realizzazione e del dover essere, noncuranti degli eccidi provocati dalla loro volontà di affermarsi come utopia assoluta e realizzata. Una “volontà di potenza” che superando le aspettative nietzscheane provoca, con la crescente concentrazione di ricchezza del capitalismo neoliberale, più di settantamila morti ogni ventiquattro ore [4].
Questa è la rappresentazione di “ciò che è”, della situazione che va criticata, messa in crisi nel senso di κρίνω, ossia vagliata, giudicata. Chi parla ancora di “destra” o “sinistra” in politica fa riferimento implicito a quelle utopie senza libertà il cui fallimento è scritto nella storia. Il fatto che non si trovino altre categorie per designare gli orientamenti politici è indice di ristagno culturale di un sistema chiuso in se stesso, pago della sua inefficacia, immobile nella sua inefficienza, che gira su se stesso mordendosi la coda, incapace di sogni utopici perché incapace di pensare la città degli uomini in altra forma che non sia quella attuale dei privilegi, delle discriminazioni e degli sfruttamenti a beneficio dei “migliori”, degli ἄριστοι che ritengono di avere una natura diversa rispetto ai comuni mortali per il semplice fatto di essere riusciti a sottometterli con le armi dell’usurpazione e del denaro. Non superiori per virtù e bontà ma solo per scaltrezza di accumulo di beni sottratti agli altri. L’aristocrazia “criticata” dalla Rivoluzione Francese ha saputo trasformare se stessa passando dalla categoria dinastica a quella finanziaria e oggi gli “aristocratici” sono coloro che detengono capitali pari al PIL di intere nazioni. Tutto questo non viene mai criticato dai media e dai grandi sistemi di informazione, per il semplice fatto che per la loro attività questi dipendono dalla neo-aristocrazia. Anche qui si è creato un circolo vizioso che non può andare oltre se stesso per sognare utopia, la città nuova per ogni essere umano.
Utopia vuol dire invece fede nella volontà di estendere i confini del possibile, la legittima aspirazione a una società giusta, felice, virtuosa, aspirazione che attraversa la storia delle culture e si reifica attraverso i miti della letteratura e delle religioni non per evadere dal reale ma per ricostruirlo e dare luogo ad un mondo migliore. L’utopia è futuro, futuro non solo immaginato, ma pensato conforme alla ragione. La Repubblica platonica ha molto del Regno di Dio evangelico e Platone si è tanto adoperato per la trasformazione dell’ideale in reale. «Per lui non è attribuibile agli dèi la causa della decadenza, ma all’inerzia colpevole degli esseri umani. Nessuna ὕβρις guida l’azione di chi sogna un futuro migliore, ma solo la virtù, la δίκη, il rispetto degli dèi. In definitiva la Repubblica platonica è un’istanza di razionalizzazione della società; intende superare l’essere di fatto per sporgersi verso ciò che non è ancora» [5]. Ma come conoscere “l’essere di fatto” senza l’esercizio del pensiero e della facoltà spirituale di cui l’uomo è pur dotato, in una cultura come l’attuale dove è più decisiva la soddisfazione dei bisogni che la coerenza delle idee? Come “sporgersi” verso ciò che non è ancora quando l’offerta di soddisfazione immediata che il mercato neoliberale presenta colma le frustrazioni dei perdenti e le tasche dei vincenti speculatori? Non sono forse il mito di Amazon e il macdonaldismo tra i principali ostacoli ammalianti che impediscono l’esercizio del pensiero inchiodando l’umanità all’effimero godimento del “qui e subito” imbandito dalla cupola dei privilegiati? Pare dunque impossibile in questo tempo l’utopia, nonostante la modernità non abbia mantenuto le sue promesse, il mito secolare di una società senza classi abbia subìto uno scacco colossale e l’ambiguità della mondializzazione sia, nell’esperienza di tutti i giorni, generatrice di miseria per tre quarti dell’umanità. Ma i meccanismi che provocano questo stato di disastro sono ignoti alla consapevolezza dei più, alla grande maggioranza degli emarginati. Sono noti solo ad alcuni, ai privilegiati che custodiscono gelosamente il progetto e i piani di azione per sfruttare capillarmente la maggioranza emarginata e catturarla nella loro rete.
È stata la giornalista canadese Naomi Klein a denunciare tale situazione nel suo celebre libro No Logo [6] sulla malìa delle grandi marche che monopolizzano i mercati e seducono giovani consumatori sempre più disabituati al pensiero critico e istruiti solo su piccoli segmenti del sapere che impediscono loro di avere una visione globale del reale. Per l’autrice c’è in atto un problema di informazione: non si cercano alternative perché non si conosce ciò che sta realmente accadendo. E permane dunque il problema educativo, dello studio, dell’istituzione scolastica che in un mondo globalizzato parcellizza il sapere e lo rinchiude in vasi non comunicanti, in sempre più minute specializzazioni che inibiscono visioni d’insieme, enciclopediche, di vasto respiro.
 Agli inizi di questo millennio il teologo francese Claude Geffré affermava che «il processo di desacralizzazione che ha coinciso con l’avvento della modernità, compresa come vittoria della ragione critica, aveva generato una formidabile speranza nelle possibilità illimitate del progresso scientifico e tecnico, per trionfare sulle fatalità della natura e migliorare la condizione umana»; ma anche questa utopia è stata sfatata dall’esperienza del presente, dai disastri ecologici alla pandemia, col risultato che «l’uomo del terzo millennio riesce sempre di meno a padroneggiare gli effetti perversi della scienza e della tecnologia». La sua conclusione era perentoria: «O noi avremo la saggezza di modificare il processo in corso o periremo tutti»! [7]. Chi ci libererà da questa cultura di morte? Al punto in cui siamo, sul baratro della regressione all’ottusità tribale, non ci resta che liberarci dalle chiusure ideologiche, nazionalistiche, partitiche, di classe, e respirare col respiro dell’uomo senza etichette, no logo, straniero sulla soglia della città in cerca di una nuova sapienza che può consistere nella liberazione dalla mente. «Noi non siamo impigliati nel nostro corpo ma nella nostra mente» diceva Thomas Merton [8].
Agli inizi di questo millennio il teologo francese Claude Geffré affermava che «il processo di desacralizzazione che ha coinciso con l’avvento della modernità, compresa come vittoria della ragione critica, aveva generato una formidabile speranza nelle possibilità illimitate del progresso scientifico e tecnico, per trionfare sulle fatalità della natura e migliorare la condizione umana»; ma anche questa utopia è stata sfatata dall’esperienza del presente, dai disastri ecologici alla pandemia, col risultato che «l’uomo del terzo millennio riesce sempre di meno a padroneggiare gli effetti perversi della scienza e della tecnologia». La sua conclusione era perentoria: «O noi avremo la saggezza di modificare il processo in corso o periremo tutti»! [7]. Chi ci libererà da questa cultura di morte? Al punto in cui siamo, sul baratro della regressione all’ottusità tribale, non ci resta che liberarci dalle chiusure ideologiche, nazionalistiche, partitiche, di classe, e respirare col respiro dell’uomo senza etichette, no logo, straniero sulla soglia della città in cerca di una nuova sapienza che può consistere nella liberazione dalla mente. «Noi non siamo impigliati nel nostro corpo ma nella nostra mente» diceva Thomas Merton [8].
Ci sono state nella storia dell’umanità coscienze ad alta densità di consistenza umana che hanno mostrato la capacità di attuare la conversione del cuore e la metànoia intellettuale come liberazione dai condizionamenti culturali, giungendo ad un profondo mutamento nel modo di pensare, di sentire, di giudicare le cose, di vivere. Hanno praticato, per usare la bella e originale espressione di Raimon Panikkar, la tecnica del «disarmo culturale» [9]. Panikkar ha incarnato il totale capovolgimento che si deve operare in chi aderisce al messaggio di Cristo nel modo di considerare i valori etici, culturali, politici e sociali correnti, nello spirito delle beatitudini evangeliche che sono l’espressione piena della metànoia cristiana. Questo cristiano no logo ha attraversato tutto il XX secolo e ha vissuto gli esordi del XXI (1918-2010). Nato a Barcellona da madre catalana e padre indiano fu un filosofo e un intellettuale di grande levatura, dal sapere vastissimo e in grado di padroneggiare una ventina di lingue. Ordinato prete tra le fila dell’Opus Dei, abbandonò presto questa organizzazione che giudicò integralista e si recò missionario in India dove trascorse gran parte della sua vita insegnando nelle più importanti università dell’India, degli Stati Uniti e d’Europa. Uomo dalla vita avventurosa e spirito eclettico arricchì il suo cristianesimo e il suo sacerdozio con le spiritualità del buddismo e dell’induismo, senza scadere nel sincretismo, camminando lungo tutte le frontiere spirituali, intellettuali e umane di questo mondo, tracciando sentieri del tutto innovativi in grado di fornire “materia spirituale” per una nuova edificazione della città degli uomini. Perché il male che la attanaglia, che ci attanaglia, è essenzialmente di ordine spirituale; è il mysterium iniquitatis che svela i nostri limiti di comprensione della realtà.
Il «disarmo culturale» per Panikkar inizia con il superamento della ragione moderna occidentale, che è una ragione armata «non solo perché la meta dei suoi sforzi è l’industria bellica, ma soprattutto perché è rivolta al potere e al controllo, ed è la diretta ispiratrice di quella cultura della certezza e della sicurezza che è in realtà fonte di sfiducia, di competizione parossistica e di guerra» [10]. Ma tale superamento non potrà avvenire se non facendo l’esperienza delle altre culture che il Panikkar “mistico” contempla nella grande tavola della visione di Isaia, una tavola rotonda planetaria attorno alla quale siedono tutti i popoli della terra (cfr. Is 25, 6-10). E questa visione, questa utopia si realizzerà soltanto «attraverso lo smantellamento culturale dell’Occidente». Non ci sarà nessuna pace senza tale disarmo culturale, condizione indispensabile per ricostruire la città su basi nuove, «mediante l’interculturalità assunta come elemento costitutivo della natura umana» [11]. Smantellamento culturale dell’Occidente significa per Panikkar la ricerca di un nuovo modo di pensare, superando le categorie di una scienza filosofica anch’essa chiusasi nel circolo vizioso dell’ontologia e della metafisica, ispiratrice del “metodo scientifico”, della razionalizzazione del lavoro e del “miracolo” della tecnologia.
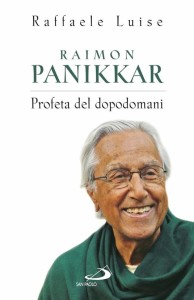 L’utopia di Panikkar non consiste nel voler andare “avanti” nella ricerca di maggior progresso tecnologico e risorse economiche per l’umanità, né “indietro” rivestendo idealismi dismessi come fanno i conservatori prescientifici e romantici; la direzione non sta neanche a “destra” né a “sinistra”, si tratta di andare “in alto”, verso la terza dimensione «e attingere una nuova forma di spiritualità capace di farci percepire e vivere tutta l’ampiezza e il respiro della realtà, senza sacrificarne alcuna parte» [12]. È la direzione di sbocco, di rottura dei circoli viziosi che hanno inglobato tutti i tentativi di riforma che nel corso dei secoli si sono succeduti insistendo solo su aspetti parziali della realtà. Continuare per questa strada sarebbe «mero maquillage» per Panikkar. Da qui la necessità di una “conversione” che significa cambiare strada, rotta, direzione. Panikkar riprende la parola chiave del lessico cristiano, metànoia, rivisitandola etimologicamente, svestendola dei significati moralistici convenzionali e devozionali, e dello stesso significato più recente del “cambiare mentalità”, attribuendole il significato forte di “trascendere il νοῦς”, di “superare il mentale”, di non pensare che il mentale sia tutto. Superamento del “cogito” cartesiano che ha preteso di intrappolare l’essere conducendo a quello «sviluppo tecnoscientifico che l’Occidente sta imponendo al pianeta. Plasmando un uomo tragicamente isolato, che sperimenta l’incubo del silenzio degli spazi infiniti, tagliato fuori com’è dalla relazione vitale col Divino e impoverito dal rapporto con una terra devitalizzata, ridotta ad un ammasso di materia ed energia» [13].
L’utopia di Panikkar non consiste nel voler andare “avanti” nella ricerca di maggior progresso tecnologico e risorse economiche per l’umanità, né “indietro” rivestendo idealismi dismessi come fanno i conservatori prescientifici e romantici; la direzione non sta neanche a “destra” né a “sinistra”, si tratta di andare “in alto”, verso la terza dimensione «e attingere una nuova forma di spiritualità capace di farci percepire e vivere tutta l’ampiezza e il respiro della realtà, senza sacrificarne alcuna parte» [12]. È la direzione di sbocco, di rottura dei circoli viziosi che hanno inglobato tutti i tentativi di riforma che nel corso dei secoli si sono succeduti insistendo solo su aspetti parziali della realtà. Continuare per questa strada sarebbe «mero maquillage» per Panikkar. Da qui la necessità di una “conversione” che significa cambiare strada, rotta, direzione. Panikkar riprende la parola chiave del lessico cristiano, metànoia, rivisitandola etimologicamente, svestendola dei significati moralistici convenzionali e devozionali, e dello stesso significato più recente del “cambiare mentalità”, attribuendole il significato forte di “trascendere il νοῦς”, di “superare il mentale”, di non pensare che il mentale sia tutto. Superamento del “cogito” cartesiano che ha preteso di intrappolare l’essere conducendo a quello «sviluppo tecnoscientifico che l’Occidente sta imponendo al pianeta. Plasmando un uomo tragicamente isolato, che sperimenta l’incubo del silenzio degli spazi infiniti, tagliato fuori com’è dalla relazione vitale col Divino e impoverito dal rapporto con una terra devitalizzata, ridotta ad un ammasso di materia ed energia» [13].
«Disarmo culturale» significa per Panikkar partecipare all’armonia del ritmo della realtà, ascoltando il ritmo delle cose che non vanno violentate ma assecondate pacificamente. Significa giungere ad una pacificazione interiore per cui non si combatte nemmeno per la pace. «Combattere per la pace è una contraddizione, perché una volta dichiarata guerra al male ci si ritrova non solo immersi in esso, ma anche dipendenti da esso. Si rimane impigliati nella rete del male ed è irrilevante se si vince o si è sconfitti, perché il veleno è già in noi» [14]. Col «disarmo culturale» si innesca tutta una nuova serie di valori umani che demonetizzano la cultura e demoliscono la Torre di Babele del governo dell’ordine mondiale, superando gli Stati nazionali, riscoprendo la forza rivoluzionaria delle religioni, dando corpo a movimenti alternativi di ogni tipo, promuovendo una più corretta informazione che liberi dal lavaggio del cervello operato dai mass media. «Disarmo culturale» non significa quietismo o pacifismo passivo; la non violenza non esclude la passione e l’entusiasmo, la ribellione, la resistenza, ma semplicemente «l’allargamento delle esperienze dell’uomo occidentale, in un momento in cui l’imporsi della tecnoscienza lo ha rinchiuso in una cosmologia parziale, strappandogli l’esperienza della felicità, della gioia, della libertà» [15].
Si tratta di acquisire quella che Panikkar chiama «la nuova innocenza» che è il risvolto della stessa medaglia della non violenza; la parola ahimsa usata da Gandhi vuol dire “non nocens”, che non fa male, che non ferisce. Così l’innŏcens latino. Una innocenza che scaturisce da una nuova forma di conoscenza che non è quella della scienza moderna che ha pervertito il senso della scientia latina, dello scire come consapevolezza o della gnosis dei Greci come conoscenza piena; o ancora di più, come il poliglotta Panikkar conclude, della dizione francese che si esprime in con-naissance, ossia naître ensemble [16]. Il «disarmo culturale» appare felicemente come un allargamento di orizzonti, superamento di steccati linguistici, etnici, filosofici che hanno etichettato arbitrariamente le cose dandoci una comprensione errata della realtà e di noi stessi. Da quando con Galilei la con-naissance è diventata calcolo e previsione e con Bacone dominio della realtà, quindi potere, la ragione occidentale è diventata una «ragione armata», ed è riuscita a sezionare tutto spaccando persino l’atomo e conducendoci al punto in cui siamo. Ora, secondo la formulazione di Horkheimer, siamo davvero costretti «alla critica di ciò che è» e se non lo facciamo peggio per noi.
Per comporre i termini dell’utopia si possono utilizzare le prospettive aperte da Panikkar per «la rappresentazione di ciò che dovrebbe essere», tenendo conto della grande importanza che questo pensatore mistico ha dato alle religioni che dovrebbero essere in linea con la direzione “verso l’alto”. Solo che non sempre lo sono state e lo sono. Il teologo spagnolo José Maria Castillo, recentemente riabilitato da papa Francesco dopo decenni di persecuzione per la sua teologia “non allineata”, ha riflettuto sul coinvolgimento che le religioni hanno avuto nella violenza mondiale, per cui ritiene che le grandi istituzioni religiose non sono più ispiratrici di utopie ma di forze che contribuiscono potentemente a sostenere il potere costituito. Per lui questo significa due cose: «finché le religioni resteranno integrate nel sistema (economico e politico) non sarà possibile recuperare l’utopia»; inoltre, «le religioni continueranno ad essere integrate nel sistema e continueranno a “legittimare” questo sistema violento e persino criminale fintantoché il sistema continuerà a fornire mezzi economici, legali e politici […] perché le religioni continuino a fomentare una moralità pubblica e privata che appoggia la violenza, tace di fronte alle aggressioni, ai diritti umani e giustifica tali comportamenti con il pretesto delle sue condanne contro il sesso, l’aborto, o con il pretesto della difesa dell’educazione religiosa che ciascuna confessione fomenta per catechizzare i propri adepti» [17]. Questo stato di cose ha “sequestrato” l’utopia che un altro mondo sia possibile e che un altro mondo diventi realtà.
Ma non ci sono proposte sul mondo che dovrebbe esistere, che dovrebbe nascere di nuovo e dall’alto, perché non conosciamo più un altro modo di pensare e di esistere e abbiamo perso la direzione verso l’alto che pure ci inabita, ma sepolta sotto la coltre culturale nella quale siamo subito avvolti alla nascita, calda e confortevole in prima istanza e che poi si trasforma lentamente in una gabbia d’acciaio, spaziosa ma gabbia, «dove viene placato sul nascere ogni dissenso». «È la condizione, divenuta oggi ordinaria, in cui si desidera vivere meglio, con più comfort, ma, tra comode alienazioni e rassicuranti conformismi, non si aspira alla libertà, né si è disposti a lottare in suo nome» [18]. Così Diego Fusaro chiosa il teorema di Étienne de La Boétie sulla servitù volontaria e sulla riluttanza al dissenso, generando la «sindrome della convenienza» che induce a rinunciare all’autonomia in cambio di piccoli vantaggi. Una condizione culturale esclusiva dell’Occidente o una più diffusa situazione antropologica?
Le religioni, però, e quelle “rivelate” almeno, guidate da un logos che le indirizza e da uno spirito che le sostiene, non possono non tornare all’atto fontale della loro con-naissance, alla prospettiva utopica che le ha generate per la costruzione della città degli uomini in cui tutti i parametri sono radicalmente asimmetrici rispetto alla citta babelica in cui viviamo. La direzione “alta” del cristianesimo, ad esempio, conduce alla contemplazione della Gerusalemme celeste, città escatologica ed utopica dove l’umanità potrà vivere in Dio ma che è anche modello della città terrestre per il paradigma dell’amore che lì come qui edifica. La città degli uomini non può che essere unificata secondo il paradigma agapico, nell’innocenza primigenia che non nuoce e fa crescere. Ma purtroppo non è così, il modello è stato alterato ed oggi «tutto è distrutto» perché:
«Due amori hanno costruito due città: l’amore di sé spinto fino al disprezzo di Dio ha costruito la città terrena, l’amore di Dio spinto fino al disprezzo di sé la città celeste. In fine, quella trova la gloria in se stessa, questa nel Signore. Quella cerca la gloria tra gli uomini, per questa la gloria più grande è Dio, testimone della coscienza. Quella solleva il capo nella sua gloria, questa dice al suo Dio: Tu sei mia gloria e sollevi il mio capo. L’una, nei suoi capi e nei popoli che sottomette, è posseduta dalla passione del potere; nell’altra prestano servizio vicendevole nella carità chi è posto a capo provvedendo, e chi è sottoposto adempiendo. La prima, nei suoi uomini di potere, ama la propria forza; la seconda dice al suo Dio: Ti amo, Signore, mia forza. Nella prima città, perciò, i sapienti, che vivono secondo l’uomo, hanno cercato i beni del corpo o dell’anima o tutti e due; oppure quanti hanno potuto conoscere Dio non gli hanno dato gloria né gli hanno reso grazie come a Dio […] Hanno venerato e adorato la creatura al posto del Creatore, che è benedetto nei secoli. Nell’altra città invece non v’è sapienza umana all’infuori della pietà, che fa adorare giustamente il vero Dio e che attende come ricompensa nella società dei santi, uomini e angeli, che Dio sia tutto in tutti» [19].
Così Agostino d’Ippona descrive con molto realismo l’esistenza di due modelli non omologabili, la cui discriminante risiede nel trascendimento. L’uomo è indubbiamente dotato della capacità di trascendimento, di trascendere se stesso, ma gli bastano i suoi sforzi per riuscirci? O deve trovare una guida “dall’alto”? A questa tematica è improntato il dialogo tra Gesù e Nicodemo nel terzo capitolo del vangelo di Giovanni (Gv 3, 1-21). Gesù propone a questo vecchio «capo dei Giudei» l’utopia del «regno di Dio» e gli dice che nessuno potrà vederlo se «non è nato dall’alto». Il testo greco gode dell’ampiezza semantica dell’avverbio ἄνωθεν, che oltre che “dall’alto” significa anche “di nuovo, nuovamente”. La vulgata, per le due volte che il termine ἄνωθεν ricorre nella pericope, traduce la prima volta renatus, la seconda dénuo. L’interpretazione latina è chiaramente di rinascita, ma una rinascita che viene dallo spirito, data la puntuale traduzione letterale del testo greco successivo: Quod natum est ex carne caro est, et quod natum est ex spiritu spiritus est [20]. E lo spirito viene dall’alto poiché «lo spirito soffia dove vuole, e ne ascolti la voce, ma non sai da dove viene e dove va» [Gv 3, 8]. È da notare che questo discorso di Gesù non è fine a se stesso; è teso a esplicitare le modalità di “vedere” e di “entrare” nel regno di Dio che nel linguaggio gesuano è sinonimo della città degli uomini, il cui modello viene dall’alto, ma un alto che è già dentro e bisogna tirar fuori, partorendolo, facendolo nascere di nuovo. «Come può avvenire» tale rinascita si interroga Nicodemo. «Tu sei maestro in Israele e non conosci queste cose?» gli risponde Gesù. Nicodemo dovrebbe sapere che la tradizione più spirituale di Israele non aveva inteso in senso meramente politico l’instaurazione del regno di Dio. L’insistenza era posta sulla giustizia che il re doveva insegnare al suo popolo. La predicazione profetica aveva poi evidenziato una possibilità ulteriore: che il re non fosse solamente un re potente, che amministra con potenza la giustizia in mezzo al proprio popolo. Il re può, invece, assumere su di sé il dramma di ingiustizia che il proprio popolo sta vivendo, prendendo su di sé le “colpe” del popolo e offrendo la propria mitezza come modalità di vita piena (cfr. Zac 9,9-10).
Con tale espressione Gesù ha voluto indicare dunque non l’instaurazione di un regno politico, ma piuttosto l’inaugurarsi di una storia condotta secondo una nuova modalità, perché illuminata da una nuova meta. L’urgenza di raggiungere tale meta è descritta appunto come presenza del regno di Dio. Essa si situa, da una parte, a livello esistenziale: se il regno di Dio è presente in Gesù, occorre che ciascuno prenda una propria decisione a riguardo (cfr. Lc 17,20-21). D’altra parte, si presenta anche a livello escatologico, di compimento finale della storia e del creato: non si tratta più di trovare le giuste mediazioni, ma di utilizzare gli strumenti assolutamente in accordo con la logica del Regno. Altrimenti, si viene esclusi da esso (cfr. Lc 12,41-47). Che questo regno abbia una valenza esistenziale è molto chiaro nei vangeli: il regno di Dio è la pienezza della vita vissuta (cfr. Lc 7,18-23; Mt 11,2-15); esso è luce (cfr. Mt 5,14), raccolto abbondante (cfr. Mt 9,37), frutto maturo (cfr. Mt 13,28-29), vino nuovo (cfr. Mc 2,22), festa di riconciliazione (cfr. Lc 15,22). L’auspicio della sua venuta è contenuto nella preghiera che Gesù insegna ai suoi discepoli: si chiede al Padre che “venga” il suo regno, nonostante sia già presente (cfr. Lc 17, 20-25); mentre la sua consistenza di lievito e di sale e le sue dimensioni di granello di senapa dicono la sua apparente irrilevanza, ma anche la sua funzione catalizzatrice nei processi di crescita antropologica.
È un regno in cui l’umanità può crescere fino a raggiungere «lo stato di uomo perfetto» come dice Paolo, «all’altezza della statura perfetta di Cristo» (Ef 4,13). Una crescita in umanità! Gesù, d’altra parte, non si è qualificato che come uomo: non figlio di Dio, non re, non rabbino, non sacerdote, non figlio di Israele, non fariseo, non sadduceo, non zelota, non monaco esseno, solo «figlio dell’uomo»! E fu radiato perché era inqualificabile, no logo, era uno straniero, uno straniero nel senso che è “per l’uomo” senza aggettivi e senza integrazioni. È stata la religione ad omologare Gesù, ad inserirlo in una tradizione che grazie a Dio oggi si sta disfacendo, a farne un oggetto culturale, addomesticato a tal punto che ci siamo serviti del suo nome per legittimare comportamenti ed etiche che lui non avrebbe mai approvato, organizzazioni e istituzioni di ogni genere che lo hanno utilizzato come un logo, e senza più ascoltare la sua parola, il suo insegnamento, senza più seguire il modello antropologico che ha coniato e incarnato. Questa “cattura” di Gesù Cristo oggi si è trasformata, per il dissolvimento delle certezze e delle tradizioni, in una perdita di fede, in uno smarrimento di carattere spirituale.
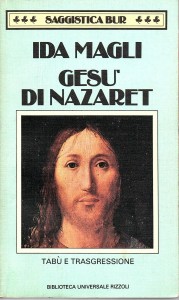 Ida Magli, antropologa “laica”, nel suo Gesù di Nazaret, ha chiamato la religione di Gesù una religione dell’umanità dell’uomo, «una religione senza le strutture fondamentali del sacro». L’analisi compiuta nel suo libro ha voluto mostrare come Gesù abbia eliminato le strutture portanti della cultura ebraica: i legami di sangue come unità di essenza, il tempo dell’attesa della salvezza, i tabù e i rituali di purificazione, la necessità del Tempio e del Sacerdozio, la differenza e la minorità delle donne… «Gesù non ha vissuto in modo inconsapevole e ovvio i valori su cui si fondava la sua cultura, ma ne ha preso le radici, profondamente nascoste, e le ha capovolte al sole e all’aria, dichiarando che esse erano ormai inutili. Tutti sono stati contro di lui [21]. Ora, non si potrebbe dare a tale capovolgimento di radici il nome di «disarmo culturale»? In quelle radici si annidava orgoglio etnico, integrismo religioso, esclusivismo salvifico, ipocrisia etica, connivenza col potere ingiusto, disuguaglianza sociale, intimidazione sacrale, discriminazione razziale e sessuale, violenza, ingiustizie, rapina, menzogna… cose tutte smascherate dal “figlio dell’uomo”, dallo straniero che non ha patrie né sa «dove posare il capo». Sprigiona da lui una umanità incontaminata da influenze culturali, vergine, innocente.
Ida Magli, antropologa “laica”, nel suo Gesù di Nazaret, ha chiamato la religione di Gesù una religione dell’umanità dell’uomo, «una religione senza le strutture fondamentali del sacro». L’analisi compiuta nel suo libro ha voluto mostrare come Gesù abbia eliminato le strutture portanti della cultura ebraica: i legami di sangue come unità di essenza, il tempo dell’attesa della salvezza, i tabù e i rituali di purificazione, la necessità del Tempio e del Sacerdozio, la differenza e la minorità delle donne… «Gesù non ha vissuto in modo inconsapevole e ovvio i valori su cui si fondava la sua cultura, ma ne ha preso le radici, profondamente nascoste, e le ha capovolte al sole e all’aria, dichiarando che esse erano ormai inutili. Tutti sono stati contro di lui [21]. Ora, non si potrebbe dare a tale capovolgimento di radici il nome di «disarmo culturale»? In quelle radici si annidava orgoglio etnico, integrismo religioso, esclusivismo salvifico, ipocrisia etica, connivenza col potere ingiusto, disuguaglianza sociale, intimidazione sacrale, discriminazione razziale e sessuale, violenza, ingiustizie, rapina, menzogna… cose tutte smascherate dal “figlio dell’uomo”, dallo straniero che non ha patrie né sa «dove posare il capo». Sprigiona da lui una umanità incontaminata da influenze culturali, vergine, innocente.
Lo psichiatra Vittorino Andreoli nel suo Il Gesù di Tutti confessa
«l’idea che la figura di Cristo, di questo grande esempio di stile di vita, sia parte di me, della mia stessa biologia. Un qualche cosa che corrisponde a un topos interiore, forse a un modello che è già stampato dentro la mia mente e che il Cristo ha semplicemente meglio delineato e persino raffigurato. È come se nella mia mente fosse tracciata una sinopia che poi si è trasformata in tela, in una pala d’altare mentre leggevo di Cristo […] potremmo dire che la conoscenza del Cristo della Storia metteva in luce il Cristo che è dentro di me e che è parte costitutiva del mio modo di pensare e di essere» [22].
È istintivo per lo psichiatra parlare di “mente”, ma la confessione di Andreoli e lo sviluppo sistematico del poderoso volume su Gesù fanno riferimento alla natura spirituale dell’uomo, quella che è necessario far “rinascere” e senza la quale il «disarmo culturale» resta nei limiti dell’utopia assoluta. Se Gesù è stato un antesignano di tale disarmo, un topos ideale, bisogna ricordarsi che «tutti furono contro di lui» e che dunque la sua “imitazione” non è di facile attuazione e il «disarmo culturale» una difficile impresa che non può essere portata avanti da singoli don Chisciotte, ma dalle religioni in prima battuta che si occupano della crescita della dimensione spirituale dell’uomo, senza la quale nessun altro miglioramento antropologico potrà darsi.
«Disarmo culturale» vuol dire, pertanto, mettere tra parentesi le peculiarità culturali e considerare solo ciò che è veramente utile all’uomo per raggiungere quella «statura perfetta di Cristo». Ciò significa sviluppare la dimensione spirituale fortemente e volutamente mortificata dalla cultura contemporanea, ma potremmo anche dire dalla cultura europea ormai da parecchi secoli. Una cultura europea che di tanto in tanto, ipocritamente, ricerca le sue radici cristiane e fa finta di rintracciarle nei reperti museali. Ora bisogna metterle al sole e all’aria tali radici in cui si annidano gli stessi mali di quelle d’Israele. Panikkar è chiaro sulla prospettiva della deculturazione per una riculturazione:
«Il cristianesimo, dopo essere stato ancorato per quasi due millenni alle tradizioni monoteiste originate da Abramo, se vuole davvero essere cattolico, deve meditare profondamente sulla kenosi di Cristo e avere il coraggio, come nel primo concilio di Gerusalemme, di svincolarsi dalla tradizione ebraica e da quella greca e romana, senza rompere con esse, e lasciarsi fecondare dalle altre tradizioni dell’umanità. Credo che appartenga alle religioni dell’Oriente il compito di liberare il messaggio di Cristo dalla corazza che lo costringe a essere rivelato soltanto attraverso una religione storica […]. In Cristo c’è la pienezza di tutta la realtà, di tutte le rivelazioni, e non è legato a una sola tradizione. I due terzi dell’umanità non si ritrovano in questo giudeo-cristianesimo, che addirittura si vuol far passare come costitutivamente greco» [23].
Ecco il punto cruciale. Il difficile punto cruciale che significa abbandonare il Cristo che abbiamo conosciuto, con i boccoli biondi e gli occhi celesti delle immagini devozionali del sacrocuorismo, e ritrovarsi soli e nella condizione di stranieri davanti ad un Cristo straniero. Da questa soglia bisogna ripartire per liberare Dio dai ristretti recinti cristiani, musulmani, buddhisti, induisti, secolari in cui lo abbiamo rinchiuso e per liberare gli uomini dall’idolatria di qualsiasi tradizione che sfrutta l’uomo per il suo tornaconto e a cui importa poco di Dio perché non gli importa nulla dell’uomo.
Ho parlato di Cristo e del cristianesimo in ordine al «disarmo culturale» perché ne ho maggior cognizione culturale di occidentale cattolico e prete. Le testimonianze non propriamente cristiane della Magli e di Andreoli semplificano la laicità e non confessionalità del discorso fatto fuori da recinti sacrali e passibile di necessari confronti interreligiosi, di un ecumenismo allargato a tutti gli uomini di buona volontà. Gesù è ancora oggi per tutti un esempio di desacralizzazione ed anche di deculturazione. Ciò che ha inteso e intende reculturare è quel topos interiore che è l’impronta di Dio impressa in ogni uomo, la sua immagine celata sotto la corazza culturale che ciascuno inevitabilmente indossa alla nascita. Il «disarmo culturale» consiste nel liberarsi dalla corazza, liberarsi dai condizionamenti, dai rallentamenti, dalla pesantezza che provoca. La religione professata e insegnata da Gesù non coincide con una cultura, è per l’uomo “senza qualità”, non nel senso di Musil ma nel senso di una non essenza culturale determinante e limitante per l’espressione di una umanità piena che non può essere tale senza Dio. La prospettiva-proposta è estensibile dunque a tutte le altre religioni i cui conflitti sono culturali prima che religiosi. Le culture hanno plasmato concezioni di Dio secondo il loro “genio” e secondo determinate condizioni storiche, sociali, politiche. Al Deus sive natura si deve aggiungere il Deus sive cultura. E l’una e l’altra definizione contraddicono la natura assolutamente ‘altra’ di Dio, impensabile e indicibile, eccedente il mondo; così come la follia della sua Kenosi in Gesù Cristo che per tale abbassamento diventa Cristo, baciato e condotto nel mondo dallo spirito che soffia dove vuole e non si può né arrestare né descrivere, né tantomeno identificare con una cultura umana.
 Il «disarmo culturale» non sarà tanto transculturale quanto metaculturale. Questa deve essere la sua metànoia che comincia in ogni individuo della specie umana che persegue il desiderio di una umanità diversa e di una vita piena, nella ricerca di un senso che non può trovare solo in sé ma che deve scoprire come dono e dono di sé. L’utopia del regno di Dio, o se si vuole della città degli uomini è quella della città “per gli uomini” che scende dall’alto ed è già tra noi nelle relazioni umane, tra coloro che si amano e cercano la giustizia: la pienezza dell’uomo che per dirla con i padri cappadoci è la sua “divinizzazione”. Accoglieranno le religioni questo compito metaculturale della metànoia? Riusciranno le donne iraniane e tutte le musulmane a liberarsi dai lori veli che non sono voluti da Dio? Riusciranno gli indù ad abolire il sistema delle caste? Riuscirà la Chiesa del tempo di papa Francesco a seguirlo nell’opera di demolizione dei bastioni? Riuscirà la Chiesa ortodossa russa a svincolarsi dalla sudditanza statale che da secoli ne reprime gli slanci rendendola in questo frangente di guerra “incredibile”? Sapremo tutti recuperare la nostra condizione originaria di uomini, di semplici uomini?
Il «disarmo culturale» non sarà tanto transculturale quanto metaculturale. Questa deve essere la sua metànoia che comincia in ogni individuo della specie umana che persegue il desiderio di una umanità diversa e di una vita piena, nella ricerca di un senso che non può trovare solo in sé ma che deve scoprire come dono e dono di sé. L’utopia del regno di Dio, o se si vuole della città degli uomini è quella della città “per gli uomini” che scende dall’alto ed è già tra noi nelle relazioni umane, tra coloro che si amano e cercano la giustizia: la pienezza dell’uomo che per dirla con i padri cappadoci è la sua “divinizzazione”. Accoglieranno le religioni questo compito metaculturale della metànoia? Riusciranno le donne iraniane e tutte le musulmane a liberarsi dai lori veli che non sono voluti da Dio? Riusciranno gli indù ad abolire il sistema delle caste? Riuscirà la Chiesa del tempo di papa Francesco a seguirlo nell’opera di demolizione dei bastioni? Riuscirà la Chiesa ortodossa russa a svincolarsi dalla sudditanza statale che da secoli ne reprime gli slanci rendendola in questo frangente di guerra “incredibile”? Sapremo tutti recuperare la nostra condizione originaria di uomini, di semplici uomini?
Ecco cosa scriveva Thomas Merton nel 1965 dopo aver lottato per pubblicare i suoi scritti scomodi sulla pace:
«La gioia di essere un uomo! Il fatto che io sia un uomo è una verità e un mistero teologici. Dio divenne uomo in Cristo. Divenendo ciò che io sono Egli mi unì a Lui e mi fece Sua epifania, cosicché ora debbo essere io a rivelare Lui. La mia stessa esistenza come uomo vero dipende dal fatto che, tramite la mia libertà, io obbedisca alla Sua luce, permettendogli di rivelarsi in me. E il mio io è il primo che vede questa rivelazione: io sono la Sua missione verso di me e, per mio tramite, verso tutti gli uomini. Come posso vederlo o riceverlo se disprezzo o temo ciò che sono, un uomo? Come posso amare ciò che sono, un uomo, se disprezzo l’uomo che è negli altri? [24].
Da questa forte consapevolezza si parte per la difficile utopia del «disarmo culturale». Se ci decidiamo a partire sappiamo anche che tutti saranno contro di noi.
Dialoghi Mediterranei, n. 58, novembre 2022
Note
[1] R. Girard, Violenza e religione, Raffaello Cortina ed., Milano 2011: 16.
[2] J. Forest, Vita di Thomas Merton, Lindau, Torino 2009: 198.
[3] M. Horkheimer, La utopia, in A. Neosuss (ed), Utopia, Barral, Barcellona 1971: 97, cit. in J. M. Castillo, L’utopia sequestrata, in Concilium 5 (2004): 47.
[4] J. M. Castillo, l’utopia sequestrata, cit.: 48.
[5] C. Stanzione, L’utopia di una società giusta in alcuni testi della letteratura greca, in Rivista di teologia Asprenas, 1(2019)234: 53.
[6] N. Klein, No logo, Rizzoli, Milano 2000.
[7] C. Geffré, IL Dio di Gesù e i “possibili” della storia, in Concilium 5 (2004): 91.
[8] T. Merton, Diario asiatico, Gabrielli ed., San Pietro in Cariano 2015: 103.
[9] Cfr. R. Luise, Raimon Panikkar, profeta del dopodomani, San Paolo, Milano 2014: 201.
[10] Ibid.: 200.
[11] Ibid.
[12] Ibid.: 12.
[13] Ibid.: 13.
[14] Ibid.:198.
[15] Ibid.: 202.
[16] Ibid.: 199.
[17] J. M. Castillo, L’utopia sequestrata, cit.: 54-55.
[18] D. Fusaro, Pensare altrimenti, Einaudi, Torino 2017: 111.
[19] A. Agostino, La città di Dio, Rusconi, Milano 1984: 643, 691-692.
[20] Gv 3,6: τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστιν, καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος πνεῦμά ἐστιν.
[21] I. Magli, Gesù di Nazatet. Tabù e trasgressione, Rizzoli, Milano 1987: 196.
[22] V. Andreoli, Il Gesù di tutti. Vite, morti e resurrezioni dell’uomo che si fece Dio, Piemme, Milano 2013: 17.
[23] Cit. in R. Luise, Raimon Panikkar, cit.: 73.
[24] T. Merton, Scrivere è pensare, vivere, pregare. Un’autobiografia attraverso i diari a cura di Patrick Hart e Jonathan Montaldo, Garzanti, Milano 2001: 320.
_____________________________________________________________
Leo Di Simone, teologo, scrittore, esperto di musica liturgica e di arte sacra, ha insegnato Antropologia culturale e Liturgia presso la Facoltà Teologica di Sicilia (Palermo), l’Istituto di Scienze Religiose di Mazara del Vallo e l’Istituto Teologico di Scutari (Albania). È presbitero della Diocesi di Mazara del Vallo e docente stabile di teologia presso la Scuola Diocesana di Teologia. Nella stessa Diocesi coordina il progetto “Operatori di pace” e dirige l’Ufficio Diocesano per i Migranti. Attualmente è Referente diocesano per il Sinodo dei Vescovi. Tra le sue pubblicazioni, si segnalano i seguenti volumi, editi da Feeria (Panzano in Chianti – Firenze): Liturgia secondo Gesù. Originalità e specificità del culto cristiano. Per il ritorno a una liturgia più evangelica (2003); Vexilla Regis. La croce dipinta di Mazara del Vallo. Icona pasquale della liturgia (2004); Beato Angelico. L’estetica del Verbo incarnato (2004); Le rotte dei Misteri. La cultura mediterranea da Dioniso al Crocifisso (2008); Liturgia medievale per la Chiesa postmoderna? La questione del “rito antico” nel racconto del “rito romano” (2013). Ha curato, per i tipi de Il Colombre, il volume Trasfigurazione. La Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo. Culto Arte e Storia (2006). L’ultimo suo volume è un saggio biografico su Thomas Merton: Il romanzo di Thomas Merton. Un umanista cristiano nell’era postcristiana, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani (2018).
______________________________________________________________









