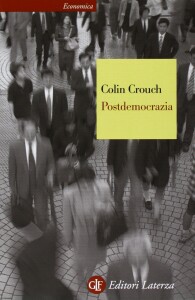La democrazia arretra nel mondo al pari dell’ecosistema. Lo dimostrano alcuni fatti decisivi, accaduti nell’ultimo quarto di secolo, che conviene annotare. Nel 1996, i fautori del mercato libero favoriscono, con il Trattato di Cardiff, la liberazione dei prezzi dell’energia, abolendo qualunque tetto e facilitando prezzi non giustificati, adesso alle stelle con l’invasione russa dell’Ucraina. Nel 2007 a Manhattan crolla il colosso bancario Lehman Brothers, il secondo 11 Settembre americano con ripercussioni catastrofiche nel pianeta, milioni di posti di lavoro perduti a causa della recessione. Nel frattempo s’impone la grande distribuzione, vale a dire migliaia di centri commerciali e, in particolare, la gigantesca catena di vendite on line, in primis quella nata in un garage di Seattle, cioè l’Amazon dell’uomo oggi più ricco del mondo, Jeff Bezos.
La grande finanza all’arrembaggio conquista il ponte di comando del vapore ed è la fine del capitalismo tradizionale, i cui costi rovinano in particolare sulle spalle dei meno abbienti e della piccola borghesia, operai, commercianti al minuto, artigiani. Salta il rapporto antico e consolidato, anche se conflittuale, salariato-padrone, spariscono tutele e contratti a tempo indeterminato. Saltano le garanzie sindacali e i consigli di fabbrica, le aziende delocalizzano gli impianti in Paesi dove la manodopera è più a buon mercato e le direzioni finanziarie in paradisi fiscali, le élite finanziarie condizionano i governi, anche di sinistra che non proteggono più, nascono la Brexit e Donald Trump, succede l’assalto a Capitol Hill, subentrano al comando le destre populiste o autoritarie o, come nel recente caso italiano, non del tutto disconnesse da una matrice fascista.
 È la Postdemocrazia, bellezza, e tu non puoi farci niente, direbbe con sorriso sardonico Humphrey Bogart. Ma non tutto sembra perduto, come potrebbe rispondere Colin Crouch, l’inventore di questo neologismo, il sociologo ed economista di Oxford, autore dell’omonimo, recentissimo libro. Ma vediamo di andare avanti con più ordine.
È la Postdemocrazia, bellezza, e tu non puoi farci niente, direbbe con sorriso sardonico Humphrey Bogart. Ma non tutto sembra perduto, come potrebbe rispondere Colin Crouch, l’inventore di questo neologismo, il sociologo ed economista di Oxford, autore dell’omonimo, recentissimo libro. Ma vediamo di andare avanti con più ordine.
L’annuale rapporto dell’autorevole settimanale inglese “The Economist” conferma, anche quest’anno, il perdurante e continuo arretramento delle democrazie nel mondo. Il Democracy Index attesta in forma scrupolosa che un terzo abbondante delle nazioni (37 per cento) è dominato da regimi dittatoriali, che diventa maggioranza allargato ai Paesi a governo autoritario, mentre le democrazie, tra piene e incompiute, non superano il 45 per cento del totale, mentre il punteggio medio globale rispetto ai diritti individuali scende al massimo storico nei quindici anni di rivelazione, spinto anche dalle restrizioni a causa della pandemia. Scende anche nelle democrazie compiute come Canada, Danimarca, Inghilterra e Austria. Gli Stati Uniti, con Trump, passano nell’elenco inferiore delle incompiute, l’Italia retrocede pure. In Africa e Asia il peggio, Siria, Libia, Iran, Congo-Kinshasa, Yemen e Corea del Nord si contendono il primato dei sistemi più liberticidi. Italia al posto 35, ancora prima del governo delle destre, come “imperfetta” a maggior cagione dello scarso funzionamento dei governi e ben lontana dalle democrazie europee.
 Dagli analisti dell’Economist il tasso di democrazia viene ottenuto secondo cinque indicatori: processo elettorale e pluralismo, libertà civili, funzionamento del governo, partecipazione politica, cultura politica. A ognuno di essi viene assegnato un punteggio da 0 e 10 e sulla base della media viene raggiunta una quota che inserisce le nazioni in quattro categorie: democrazie piene, democrazie imperfette, regimi autoritari, regimi dittatoriali. E ad oggi proprio il sistema democratico resta una chimera in Medio Oriente e in larga parte dell’Asia, dell’Africa, dell’Europa dell’Est e in America centrale, mentre altrove la rappresentanza è entrata in crisi allorché si è interrotto il rapporto decennale fra democrazia e crescita economica. Siamo dunque passati ad una nuova e insidiosa epoca senza accorgercene, nonostante gli allarmi suonati da alcuni pensatori di fama internazionale come Bauman o il già citato Crouch?
Dagli analisti dell’Economist il tasso di democrazia viene ottenuto secondo cinque indicatori: processo elettorale e pluralismo, libertà civili, funzionamento del governo, partecipazione politica, cultura politica. A ognuno di essi viene assegnato un punteggio da 0 e 10 e sulla base della media viene raggiunta una quota che inserisce le nazioni in quattro categorie: democrazie piene, democrazie imperfette, regimi autoritari, regimi dittatoriali. E ad oggi proprio il sistema democratico resta una chimera in Medio Oriente e in larga parte dell’Asia, dell’Africa, dell’Europa dell’Est e in America centrale, mentre altrove la rappresentanza è entrata in crisi allorché si è interrotto il rapporto decennale fra democrazia e crescita economica. Siamo dunque passati ad una nuova e insidiosa epoca senza accorgercene, nonostante gli allarmi suonati da alcuni pensatori di fama internazionale come Bauman o il già citato Crouch?
Se è difficile smentire l’assioma che la grande finanza condizioni e persino predisponga la linea dei governi, dovremmo concludere che ad essa non serva più come prima un sistema democratico composto da diritti e contrappesi. Questo silente passaggio epocale avviene in contemporanea con un’altra tipologia di crisi: quella delle socialdemocrazie occidentali e dei partiti di sinistra che hanno perduto consensi accettando di fatto le pratiche neoliberiste a difesa del mercato e rinunciando in buona parte a proteggere le fasce più esposte della popolazione, un tempo si sarebbe detto la classe operaia. Il risultato più eclatante, almeno in Italia, è il trionfo del “lavoro precario”: secondo l’Istat, i nuovi assunti con contratto a termine sono in percentuale il doppio dei contrattualizzati a tempo indeterminato, nonostante il “bonus” contributivo per chi assume donne e under 36. Oltre un terzo dei precari è impiegato per un mese. In analogia, sono quasi preistoria gli autunni caldi delle lotte in fabbrica, tenuto conto della perdita di potere contrattuale e politico dei sindacati interni e confederali. Di pari passo abbiamo assistito alla parziale scomparsa del “padrone” tradizionale, il padrone del vapore talvolta sostituito da una holding finanziaria con sede in una capitale balcanica, in Asia o in un isolotto paradiso fiscale. Non sono rare le chiusure improvvise di aziende con un semplice comunicato o un licenziamento per mail o via whatsapp.
 Quasi vent’anni fa il politologo di Oxford Colin Crouch, teorico della postdemocrazia, apparentava il sistema della manipolazione politica alle tecniche di marketing usate per vendere prodotti, anche tramite le televisioni di grandi gruppi privati. E indicava a prototipi le televisioni di magnati come Silvio Berlusconi e Rupert Murdoch, subdole emittenti che hanno indirizzato politicamente l’opinione pubblica senza distinzione di classi sociali e il New Labour inglese e Forza Italia a simboli postdemocratici, mentre sul piano industriale «la ricchezza di beni e servizi non veniva creata attraverso la produzione di beni e servizi reali, ma attraverso la rivalutazione costante di titoli finanziari acquistati e rivenduti all’infinito». E allorché quel sistema produttivo è crollato – Too big to fail (troppo grande per morire) era la credenza – i governi non hanno esitato a salvare le banche trasformando in debito pubblico un colossale fallimento del settore privato.
Quasi vent’anni fa il politologo di Oxford Colin Crouch, teorico della postdemocrazia, apparentava il sistema della manipolazione politica alle tecniche di marketing usate per vendere prodotti, anche tramite le televisioni di grandi gruppi privati. E indicava a prototipi le televisioni di magnati come Silvio Berlusconi e Rupert Murdoch, subdole emittenti che hanno indirizzato politicamente l’opinione pubblica senza distinzione di classi sociali e il New Labour inglese e Forza Italia a simboli postdemocratici, mentre sul piano industriale «la ricchezza di beni e servizi non veniva creata attraverso la produzione di beni e servizi reali, ma attraverso la rivalutazione costante di titoli finanziari acquistati e rivenduti all’infinito». E allorché quel sistema produttivo è crollato – Too big to fail (troppo grande per morire) era la credenza – i governi non hanno esitato a salvare le banche trasformando in debito pubblico un colossale fallimento del settore privato.
Il malcontento che ne è scaturito ha scardinato il sistema delle classi sociali, travolgendo le tradizionali differenze per reddito e stile di vita. Da qui i nuovi modelli incarnati da chi raggiungeva successo e ricchezza in un batter di ciglia, da qui la diffusione di xenofobie e di forte diffidenza verso il diverso, nonché la richiesta di governi forti, se non autoritari, o in conflitto di interesse, a difesa delle frontiere dai flussi migratori – il muro di Trump lungo il confine con il Messico, il blocco delle vie dei migranti lasciati al gelo dei Balcani, i Decreti sicurezza di Salvini ministro, il muro a Ventimiglia di Macron.
Gli emblemi di questa stagione di transito politico e antropologico cosmico, supportato da giornale e tv, con poche eccezioni ora in mano ai grandi gruppi finanziari, sono, oltre al Cavaliere in Italia, Trump in Usa, Bolsonaro in Brasile, Erdogan in Turchia, Johnson in Gran Bretagna, Orban in Ungheria, Modi in India, Un fenomeno che Zygmunt Bauman spiegava così: «Siamo di fronte alla crisi delle istituzioni politiche esistenti. La gente crede sempre meno che le istituzioni politiche inventate dai nostri antenati, come partiti e parlamenti, possano mantenere le promesse. E molti di noi pensano di sostituirle». Secondo l’autore del celeberrimo Modernità liquida, siamo in una fase di interregno, come la definiva Gramsci; e ricorda che «non hanno infatti portato agli obiettivi sperati le manifestazioni pubbliche in Iran, che Hillary Clinton aveva definito “la prima rivoluzione democratica fondata su Internet”. E nemmeno movimenti come quello degli indignados in Spagna o come la Primavera araba: Tutti attendevano l’estate araba – continua Bauman – ma quello che è arrivato è stato l’inverno arabo, direttamente dopo la primavera».
Mentre la dittatura soft dell’alta finanza mostra per intero il suo predominio, non ci appare per nulla illusorio – qualcuno potrebbe esagerare dicendo patetico – registrare alcuni contrappesi avversi alle tendenze distopiche dell’umanità. In un quadro mondiale predisposto al conformismo, vanno segnalate almeno due chances che possono far risorgere il sol dell’avvenire: il mondo social e la questione ambientalista.
 Ma la domanda tutt’ora senza una risposta definitiva è la seguente: internet è ancora democratica? Secondo la politologa Nadia Urbinati della Columbia University, la tesi “più rete uguale più democrazia” è ancora tutta da provare, mentre i mille esperti del digitale, consultati dal Pew Research Center di Washington, a maggioranza hanno risposto no, la rete indebolirà i sistemi democratici. Eppure se decine di governi usano la mano forte, un motivo ci sarà. Le primavere arabe cominciarono e finirono su internet, ma l’ultimo report Freedom on the Net dell’Ong Usa Freedom House ha verificato che 56 Paesi hanno processato o arrestato utenti della rete per i loro post e altri 21 periodicamente oscurano internet per evitare mobilitazioni o stati di crisi, a confermare che il sistema digitale è un lusso libertario che i sistemi autoritari non si possono permettere. Con campagne su Facebook o su Twitter si sono dimessi governi e ministri, sono stati depennati candidati alle elezioni dei quali erano emerse gravi colpe o contraddizioni fatali, messe all’indice aziende inquinanti o truffaldine. Dall’altro versante, c’è il sistema anche organizzato delle fakenews che può favorire l’elezione di un presidente, come sembra sia accaduto per Donald Trump, o creare sfiducia nella popolazione come nel caso dei vaccini antiCovid.
Ma la domanda tutt’ora senza una risposta definitiva è la seguente: internet è ancora democratica? Secondo la politologa Nadia Urbinati della Columbia University, la tesi “più rete uguale più democrazia” è ancora tutta da provare, mentre i mille esperti del digitale, consultati dal Pew Research Center di Washington, a maggioranza hanno risposto no, la rete indebolirà i sistemi democratici. Eppure se decine di governi usano la mano forte, un motivo ci sarà. Le primavere arabe cominciarono e finirono su internet, ma l’ultimo report Freedom on the Net dell’Ong Usa Freedom House ha verificato che 56 Paesi hanno processato o arrestato utenti della rete per i loro post e altri 21 periodicamente oscurano internet per evitare mobilitazioni o stati di crisi, a confermare che il sistema digitale è un lusso libertario che i sistemi autoritari non si possono permettere. Con campagne su Facebook o su Twitter si sono dimessi governi e ministri, sono stati depennati candidati alle elezioni dei quali erano emerse gravi colpe o contraddizioni fatali, messe all’indice aziende inquinanti o truffaldine. Dall’altro versante, c’è il sistema anche organizzato delle fakenews che può favorire l’elezione di un presidente, come sembra sia accaduto per Donald Trump, o creare sfiducia nella popolazione come nel caso dei vaccini antiCovid.
Se dal mondo digitale le risposte sono ambivalenti, l’ultima frontiera che può fare la differenza è la coscienza ambientalista. L’annuale vertice Coop 27 sul clima, inopinatamente ospitato da un Paese dittatura come l’Egitto, è stato l’ennesimo fallimento, mancando l’obiettivo di contenere in un grado e mezzo in più il riscaldamento del pianeta, ben sapendo che il prossimo mezzo grado superiore porterà nuovi sconvolgimenti. Ma attorno al vertice osservava, si agitava come marea anche colorata, interveniva, dimostrava una galassia di nuova generazione composta da giovani esperti, leader di movimenti, studiosi, rappresentanti di associazioni e di comunità indigene in pericolo di estinzione, l’altro mondo unito da certezze scientifiche e politiche universali, deciso a non fare un passo indietro, capace di aggregare la nuova generazione del pianeta non su vaghe stelle ecologiste – perché il tema riesce a mobilitare ragazzi di tutto il pianeta – ma sulla giustizia ambientale, il concetto nuovo che contempla l’abitabilità del pianeta di domani. Un concetto di società futura che fa coincidere la giustizia sociale con la protezione dell’ambiente. E su di loro che possiamo contare. Come se fosse l’ultima spiaggia incontaminata.
Dialoghi Mediterranei, n. 59, gennaio 2023
Riferimenti bibliografici
Zygmunt Bauman, Modernità liquida, Laterza Roma, Bari, 1999
Colin Crouch, Postdemocrazia, Laterza, Roma, Bari, 2003
Colin Crouch, Combattere la postdemocrazia, Laterza, Roma, Bari, 2020
Democracy Index, The Economist, 2022
Report Launch, Freedom on the Net, 2022
___________________________________________________________________________
Antonio Ortoleva, ex giornalista del Giornale di Sicilia, già direttore e co-fondatore del periodico antimafia “Il Quartiere nuovo” di Palermo e docente di giornalismo a contratto presso l’Università di Palermo. Autore di reportage di viaggi, del volume C’era una volta l’India e c’è ancora, Navarra Editore, e più recentemente dello stesso editore Non posso salvarmi da solo. Jacon, storia di un partigiano.
______________________________________________________________