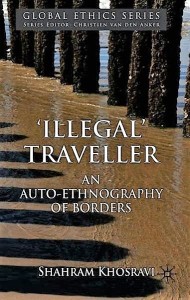di Mariangela Vitrano [*]
In questo breve saggio, prendendo spunto dalla mia personale esperienza, ho scelto di analizzare il concetto di ‘casa’ in chiave antropologica. Ho voluto, per così dire, confrontarmi in prima persona con il modo di guardare teoricamente e prendere in conto esperienzialmente questo concetto da parte di alcuni antropologi. In particolare, ho fatto riferimento a tre autori e testi singolari: Shahram Khosravi e la sua sofferta autoetnografia di migrante ‘Illegal’ Traveller; Michael D. Jackson e il suo saggio etnografico su sé stesso in quanto antropologo e sui Warlpiri dell’Australia At home in the world; Daniel Miller e la sua etnografia di una strada di Londra Cose che parlano di noi. Nel va e vieni di posizioni e definizioni, ne è nato un confronto proficuo, teorico e pratico, che mi ha portata a riaffermare un aspetto della mia identità e, al contempo, a ribadire la flessibilità di un concetto che, forse più di altri, muta il suo senso specifico in base ai contesti in cui viene espresso e vissuto.
Il concetto di casa, come mostrano i tre antropologi menzionati, acquisisce valenze diverse in culture diverse, lontane dalla mia. Per quanto strano possa sembrare a noi occidentali, il concetto di casa è variamente definito e si collega ad altri concetti rispetto a quelli più comuni nella nostra cultura. Per questa stessa ragione, prima di passare in rassegna, con uno sguardo da lontano, le strategie proposte dai tre antropologi al fine di ‘accerchiare’ il concetto di casa, ho preferito proporre una mia prima versione di casa, sentita e privata. L’analisi comparativa dei tre autori è dunque posta in relazione alla mia stessa esperienza di casa, il mio modo di sentirla e viverla e al suo incrociarsi con altre individualità, insomma con quello che in definitiva potrebbe essere considerato un rimescolamento di esperienze soggettive situate nel sommovimento stesso della cultura.
Casa mia
Mi trovo adesso, fisicamente, nel luogo da sempre designato tale dai miei genitori, un luogo che mi hanno sempre detto fosse ‘casa’ e che io ho acquisito con il passare del tempo, vivendo. Ci sono e ci rifletto, immagino e cerco di capire. Non posso sapere esattamente come sia successo che io abbia acquisito questa nozione. Quel che è certo è che riconosco come casa una struttura chiusa, con quattro mura, usci e vani adibiti a varie attività umane quali dormire, mangiare, lavarsi, etc. È certo che ho interiorizzato gradualmente la nozione di casa indirettamente, senza averne avuta una consapevolezza teorica precedente, così come si acquisisce una lingua nativa: essendo costantemente sottoposta a influssi e orientamenti linguistici e culturali che, nel tempo, hanno contribuito a determinare la mia nozione di casa. Ciò di cui sono più consapevole è però che, con la nozione di casa, in sua stretta associazione, si è pure formato il concetto di identità. Il processo di acquisizione di casa non è infatti fine a se stesso: va di pari passo, soprattutto per quanto mi riguarda, con l’acquisizione del concetto di identità.
Alla definizione di casa in quanto spazio variamente distribuito su una superficie, si deve quindi aggiungere un altro tratto pertinente alla sua definizione: l’affezione emotiva e la sicurezza che ne deriva. Casa è un luogo sicuro rispetto ai luoghi pubblici, alla strada. L’interno (casa) e l’esterno (fuori) sono separati anche da azioni precise e non soltanto da soglie materiali. Che succede in casa? Qual è la prima azione a essere messa in atto istintivamente? Si chiude la porta e ci si ritrova automaticamente in uno ‘spazio proprio’: personale e familiare, al riparo da agenti esterni, al sicuro dalla loro mutevolezza. La definizione di casa è sovente indistinguibile da quella di famiglia: è casa, dove ci sono mamma e papà. Così è stato sicuramente per me. Da bambini, ancora ben lontani dal pensare a un’alternativa possibile, di fronte a questi deliziosi pacchetti preconfezionati di senso, ci si adagia con il cuore. E così penso che sia successo a me. La frattura, per quanto mi riguarda, si è creata con un evento luttuoso che ha posto un termine al senso di sicurezza e appartenenza derivante dall’essere a casa, in famiglia.
Credo di aver perso il senso dell’‘essere a casa’ in modo stabile quando ho perso mio papà. Ricordo ancora la sensazione, fisica e mentale. Avevo sette anni e l’evento mi colpì come un pugno allo stomaco. Tutto cambiava! Nonostante fossi una bambina, ricordo con precisione che sentii venire meno quello che per me era il legame più importante: con esso, veniva meno anche quella stabilità che associavo alla casa, alla sua accezione di allora. Papà soffriva di epatite da quando aveva tre anni; aveva superato un primo trapianto all’età di diciotto mentre il secondo, all’età di trenta, non fu possibile. Insieme a lui, persi anche l’idea che mi ero fatta di casa, di famiglia. Tempo dopo, mi ritrovai a vivere, sotto un tetto diverso dal mio, insieme ad altre persone. Volente o nolente, quella doveva essere la mia casa e la mia nuova famiglia. Con la perdita di mio padre, ho perso quello che era all’epoca un tratto della mia identità: l’essere a casa, con mio padre e mia madre, stabilmente e senza scosse. Ciò ha comportato pure una ricerca di una sorta di stabilità di cui non sempre sono stata consapevole: per colmare un vuoto che sentivo strettamente associato al mio passato e al divenire irruente delle cose.
Così, nel tempo, ho cercato di riappropriarmi del mio passato, della mia identità di una volta, di una certa stabilità. È mai possibile farlo veramente, tuttavia? Il tempo passa e, con il passare del tempo, mutano le condizioni stesse attraverso cui l’identità si forgia. Comunque sia, io ho cercato un contatto con il passato tornando nel posto in cui vivevo da piccola. C’era ancora parecchio mobilio; c’era una vetrina piena di oggetti che avrebbero dovuto ricordarmi cosa fosse casa per me; avrebbero dovuto, ma io li sfioravo, li guardavo, sorridevo eppure non riuscivo a sentire nulla che mi coinvolgesse veramente o mi consentisse di riafferrare il senso del passato. Nell’arco della mia vita, in effetti, ho spesso creduto di aver ritrovato il significato di quello che pensavo fosse la casa, ma non ho mai fatto in tempo ad abituarmi che, immediatamente, con il cambiare delle situazioni, cambiava il senso di ‘casa’. Ho sentito su di me il peso del cambiamento. Così, fatico ancora oggi ad abbandonarmi a quello che per me è ‘casa’ e, con questo, a lasciare spazio al flusso della vita a essa associato; piuttosto, continuo a credere all’esistenza di un altro posto ipotetico di cui, però, ignoro la localizzazione fisica. È la mia immaginazione a farmi pensare questo o il senso di una ricerca personale ancora incompiuta, in buona parte inconsapevole? Forse, un inizio di maggiore consapevolezza posso ancorarlo a un evento.
Prima ancora di affrontare la questione in chiave antropologica con un lavoro di tesi, ricordo che cominciai a chiedermi, con maggiore consapevolezza, cosa significasse per me ‘casa’ in occasione di un seminario universitario sulla sensibilizzazione a tematiche LGBTIQ; avvenne, più esattamente, durante un brainstorming riguardante il senso del termine casa. Ricordo che andai alla lavagna e scrissi: “Un luogo in cui ci si sente protetti”. Per la prima volta sentii di aver allargato il mio margine di ricerca personale a un ‘luogo’: un luogo indefinito e indefinibile, non astratto né concreto, né reale né immaginario, ma un luogo semplicemente. Insomma, ho capito che avevo come punto di partenza un luogo; ho capito che questo punto di partenza si dibatteva nella discontinuità tra passato e presente, tra un evento luttuoso e lo scorrere degli eventi quotidiani, tra il senso da attribuire alla famiglia acquisita e all’attribuzione di affetti vecchi e nuovi. Ecco, il senso di casa per me! Ha a che vedere con tutto questo: il senso di casa acquisisce un ordine in relazione ad altri concetti che ho vissuto, nella mia diretta esperienza, in modo forse troppo discontinuo e purtroppo instabile.
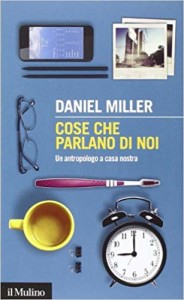 Le popolazioni aborigene e la Coscienza Cosmica
Le popolazioni aborigene e la Coscienza Cosmica
Jackson [1], nella sua pubblicazione del 1995 At home in the world, parla del suo fieldwork nella comunità Warlpiri nel territorio nord dell’Australia, mettendo in risalto la peculiare concezione di casa di questo popolo. Per poter arrivare alla comprensione di questo concetto è indispensabile passare per la sfera religiosa che permea la cultura Warlpiri. Gli aborigeni australiani sono stati riconosciuti, da studi scientifici, come popolo la cui religione rappresenta causa e effetto di tutte le cose e dell’intera esistenza stessa. La cultura religiosa aborigena è quella animista e tutti gli esseri umani altro non rappresenterebbero che dei corpi atti a contenere l’energia vitale derivante da un unico grande collettivo spirituale chiamato Coscienza Cosmica. Questa Coscienza Cosmica risiede in una dimensione atemporale e aspaziale: The Dreaming, ovvero il sogno. Si tratta di una dimensione parallela a quella umana, eterna e onnipresente, esistita durante il Tempo del Sogno, prima che tutte le cose venissero create. I Warlpiri credono, infatti, che la terra altro non fosse che materia vergine prima di essere investita e plasmata dalla potente energia divina. Sulla base di questa credenza, la visione aborigena assegna sacralità potenziale a ogni luogo e stabilisce una rete di relazioni originarie tra ogni essere vivente e ogni luogo creando un rapporto speciale tra uomo e natura. Ogni uomo è legato a un luogo particolare dove l’antenato della sua tribù ha creato qualcosa o il suo spirito ancestrale ha lasciato segni del proprio passaggio. Quel luogo sarà sempre casa, quale che sia il suo destino e nonostante la sua separazione più o meno temporanea da esso.
Ciascun aborigeno, alla sua nascita, riceve per diritto ereditario una sezione di canto le cui strofe sono proprietà privata inalienabile e che decretano la sua appartenenza a un determinato territorio. I canti in questione vengono denominati storylines e disegnano, sul territorio australiano, una ricca e accurata toponomastica musicale che coincide con il viaggio originario di ogni creatura ancestrale. Questa concezione dell’appartenenza, in stretta connessione con quella di casa, è diversa dalla mia, dalla cultura in cui vivo. In Occidente, è infatti più difficile riconoscere una concezione in cui si assegna una così forte dimensione sacrale alla casa e ai luoghi di appartenenza. Per quanto mi riguarda personalmente, inoltre, sballottata come sono stata tra diverse case, mi viene difficile attribuire un senso di casa a un luogo preciso e unico. Per quanto riguarda gli aborigeni, la questione si fa interessante anche per quel che riguarda invece la mobilità. Un esempio rappresentativo ci è fornito da Miller.
In Cose che parlano di noi, Daniel Miller esegue un originale lavoro etnografico in una via di South London che consiste nella selezione di dodici appartamenti, su un centinaio analizzati, attraverso la quale si articolano i dodici capitoli del suo libro. Miller, insieme a Fiona Parrot, dottoranda in antropologia, prova a guadagnarsi la fiducia e l’indispensabile consenso dei residenti per avere accesso alle loro abitazioni. Vi entrano per capire e analizzare che rapporto le persone hanno con le loro case e con i loro oggetti, per decifrare il complesso linguaggio della materialità, rivelatore delle relazioni interpersonali dei soggetti. Nel loro studio, si imbattono nell’abitazione in subaffitto di un aborigeno australiano, perennemente diviso tra Australia e Gran Bretagna a causa degli spostamenti che il suo lavoro gli impone. Le sue origini sono australiane ma, a differenza di ciò che testimonia il fieldwork di Jackson sulle tribù autoctone, lui sente di essere a casa quando apre il suo portatile. Malcolm è un uomo molto dinamico, viaggia continuamente e si sposta da una parte all’altra del pianeta per rispondere a esigenze e opportunità lavorative e, quindi, distante dai familiari, riconosce quale suo valido indirizzo la sua posta elettronica.
Nonostante il suo nomadismo, il suo computer gli permette di ‘trovarsi sempre in casa’, una casa dove tutti possono rintracciarlo e ricevere sue notizie. Malcolm aggiorna il suo laptop secondo l’uso che dovrà farne, lo personalizza e, potremmo dire, lo ‘arreda’ secondo le sue preferenze. Inoltre è meticolosamente ordinato, a un passo dal diventare un vero archivio della sua vita. La spiegazione a quest’ultimo risvolto rimanda inevitabilmente alla cultura d’origine che abbiamo precedentemente descritto e che coinvolge, seppur sviluppatasi in contesti sociali differenti, parte della sua individualità e del suo vissuto. Per la sua cultura d’origine non contano tanto i beni quanto i legami di parentela e la loro tracciabilità. Molti gruppi aborigeni rifiutano infatti la trasmissione materiale della proprietà del parente defunto. Così è stato pure per Malcolm il cui senso di appartenenza non è passato attraverso i beni da ereditare ma attraverso il progetto di archiviare l’intero lignaggio della madre. Il portatile, a maggior ragione, costituisce per Malcolm il senso di casa e appartenenza perché gli consente, tra le altre cose, di essere un archivio.
Più in generale, si può dire che i popoli aborigeni sono nomadi, ma questo non nega il forte senso di appartenenza che caratterizza la loro cultura: una cultura in costante evoluzione, generata dal continuo spostamento. Dal mio punto di vista, è affascinante che qualcuno, in qualche parte del mondo, abbia delle radici identitarie così profonde da non poterle mai dimenticare nonostante i cambiamenti. In fondo, benché viaggi molto, anche l’aborigeno di cui parla Miller si è creato delle radici e ha un senso di casa che non entra in contrasto con la sua cultura d’origine. Malcolm è un nomade che non dimentica la cultura di appartenenza e riesce a creare, attraverso il suo portatile, un forte senso di appartenenza. Un punto va però chiarito a riguardo. In una prospettiva più occidentale, il nomadismo ha un’accezione negativa: chi non ha dimora è pericoloso, condurrebbe una vita sregolata e per questo vivrebbe ai margini. Questa associazione, come suggerisce Jackson nella sua etnografia, è data dall’importante considerazione che si attribuisce, in alcune culture occidentali, ai confini e alle categorizzazioni quali condizioni indispensabili dell’esistenza.
Se, in sintesi, devo confrontare quanto detto con la mia personale esperienza di casa, devo ammettere uno spaesamento: nella mia concezione di casa, figurano – vorrei che figurassero – elementi quali la stabilità e la continuità con il passato, più che il nomadismo e il mutamento di cui si parla per gli aborigeni. Abbandonarmi dunque all’indeterminatezza di questa nozione e destrutturarla non è – stato – semplice, per me, che, come molti, mi sento insicura di fronte all’incognito e a una realtà priva di direzioni precise. Tuttavia, documentandomi, da persona comune e da antropologa, ho scoperto che esistono differenti concezioni di casa sia in senso materiale sia simbolico. Spesso i due livelli coincidono nella cultura occidentale, ma non è così per altre culture e non lo è nemmeno per i Warlpiri [2] Tra i popoli nomadi dell’Asia (per esempio kazaki, mongoli, uzbeki) è diffuso l’utilizzo di tradizionali abitazioni mobili, Yurta, costituite da uno scheletro in legno e una copertura di feltro di lana di pecora; si tratta di una struttura smontabile e trasportabile adatta a uno stile di vita nomade. Queste curiosità di cui parlo provengono dalla documentazione su Instagram [3] di un viaggio insolito intrapreso da tre ragazzi palermitani che hanno dato il titolo A Pechino col pandino alla loro impresa consistita nel raggiungere Pechino con un pandino: iniziativa che ha reso partecipi milioni di persone in questo cammino verso la Cina e che è stato un viaggiare alla riscoperta di se stessi e della propria cultura a paragone con delle altre di gran lunga diverse e che hanno rimodellato anche ciò che per il viaggiatore significava ‘casa’. Il viaggio, gli spostamenti e la migrazione sono tratti cruciali nella formazione dell’identità, non solo culturale: tratti che mettono in discussione, comunque, la concezione che ognuno di noi ha di casa.
La migrazione, tuttavia, è diversa dal viaggio per piacere. È bene ribadirlo. La migrazione è molto spesso sofferta e comporta afflizioni che si vorrebbero invece evitare. Detto questo, al pari del viaggio per piacere, la migrazione costituisce un elemento di profonda riflessione antropologica per quanto riguarda l’appartenenza e il sentimento dell’essere o non essere a casa. ‘Illegal’ Traveller: An Auto-Ethnography of Borders scritto da Shahram Khosravi [4] è un lavoro composito di ricerca etnografica che si nutre di osservazione sul campo tra migranti illegali (anche lui lo è stato) e di corsi universitari sulla migrazione irregolare. Khanemirza è l’unico luogo menzionato come ‘casa’ nella stesura dell’etnografia e presentato come un ricordo di serenità, ma sarà anche il luogo meno vissuto dall’autore che dovrà confrontarsi presto con pregiudizi radicati nei confronti della sua cultura d’origine. In un ambiente, come quello iraniano, di profondi scontri fisici, politici e culturali, in un clima di persecuzione, Khosravi asserisce che non sempre la madrepatria è sinonimo di ‘casa’. Quella che dovrebbe essere un’appartenenza, non lo è per lui in quanto migrante in fuga dal proprio paese.
L’odissea del migrante alla ricerca di un posto sicuro – un luogo da chiamare casa – inizia con un scelta tra la vita e la morte di fronte alla quale pochi esiterebbero. Fuggito in Svezia, nella speranza di una tregua, Khosravi trova davanti a sé muraglie invisibili rispetto agli insormontabili confini materiali in Iran, ma, proprio per questo, più difficili da distruggere. Khosravi sarà vittima di un reato con movente razzista; così, in ciò che si è lasciato alle spalle e nella fallita ricerca di un posto sicuro in cui approdare, risiede il principio di quello che si profilerà come un eterno, estenuante esilio: ritrovarsi nella stessa situazione di pericolo e solitudine in ogni parte del mondo. Nelle affermazioni di Khosravi si leggono sentimenti di incompiutezza, di sospensione tra due poli ormai non più appartenenti alla sola sfera fisica ma anche spirituale:
«Homelessness means not recognizing anywhere as home. [..] Homelessness as a paradigm, as a way of being in the world, as a lifestyle, as ethical and aesthetic normativity opens the door to accepting the other as she is, not as how we want her to be. Only when home has vanished and humanity is no longer territorialized, only then, there will be a chance for humanity» (Khosravi 2010 : 95-96).
Anche Jackson durante la sua permanenza in Australia viene travolto da sensazioni simili:
«I had an ambivalent relationship with my homeland. You feel estranged from your European roots yet cannot identify wholeheartedly with the indigenous culture of the land. You live betwixt and between, uneasy about your origins, unsure of where you stand, in two mind about your identity and allegiance» (Jackson 1995 : 6).
In conclusione, abbiamo in oggetto vari modi di guardare a un termine in apparenza simile, qual è quello di casa, attraverso diverse percezioni e esperienze: da una parte Jackson che si spoglia delle sue vesti culturali, lascia casa per fondersi con le popolazioni aborigene dei Warlpiri e sperimentare il loro modo di vivere la casa; dall’altro lato, Miller che ci mostra l’altra faccia della medaglia senza per questo vivere come un nativo e fondersi con loro. Attraverso i due studi antropologici si comprende bene la diversità del concetto di casa e l’importanza di reti di concetti paralleli che contribuiscono alla sua definizione. L’identità di ognuno di noi, e quindi anche la cultura, non è immobile; cultura e identità sono elementi in costante ridefinizione, strettamente associati al percorso di vita e al senso di finalità.
Il modo di ‘abitare’ uno spazio, così come il ‘sentirsi a casa’, variano nelle culture e nel tempo, nel bene e nel male. Khosravi costretto a lasciare l’Iran per poter sopravvivere, si ritroverà poi, in quanto perpetuo migrante, a farne una professione: quella di antropologo. La sua esistenza sembra fluttuare in una terra di mezzo in cui non v’è pace né riposo se non nell’accettazione del movimento, della trasformazione, della migrazione e del cambiamento. Fatte le dovute differenze, il punto di vista è però condiviso da Jackson: «We are manifold figures, continually shifting our ground» (Jackson 1995: 161). Esistere, spostarsi, cercare: è in questo incessante ed instancabile peregrinare che giace la nostra meta. E per quanto mi riguarda più particolarmente? La mia casa interiore non esiste: quantomeno non si vede e non è un luogo in cui posso tornare nei momenti in cui vorrei interporre una frontiera tra me e il mondo. Inoltre, c’è una consistente frattura tra quello che percepisco come ‘casa’ e quello che vorrei che fosse: “Un luogo in cui ci si sente protetti”. Io non mi sento mai protetta nel mio incessante percorso di persona in movimento nel mondo. La strada verso casa è una strada che io non so ripercorrere: come un vecchio uomo che vaga in preda alla sua inafferrabile perdita di memoria, io rischio di perdermi. Così, ho tentato di riconoscere la mia dimora nei passi che quotidianamente getto, nel cammino che intraprendo.
La mia casa è forse un punto metaforico, astratto: è la città che scelgo di visitare, il gradino sul quale decido di sedermi per aspettare un amico, la mia casa è lo strato di superficie in cui transito e niente più di questo, insomma una sorta di At home in the world con radici mobili e meno profonde del viandante: «Man’s real life is not a house, but the Road, and… life itself is a journey to be walked on foot» (Chatwin 1989: 273).
A conti fatti, sono ancora alla ricerca di un senso di casa più esteso o ho accettato quel grado di instabilità che caratterizza ogni vita individuale? Allo stadio attuale della mia ricerca, posso senz’altro dire che sono più consapevole del fatto che «l’abitare è rivelatore dei modi attraverso cui le identità, proprie e altrui, si dispongono più intimamente: capire come si abita è allora un modo per manifestare, a se stesso e agli altri, le discretizzazioni semantiche soggiacenti le nozioni di identità e, per opposizione, quelle di alterità» (Taverna, Montes 2016). Tuttavia, anzi proprio per questo, più che rispondere direttamente alla domanda precedente, preferisco concludere con un estratto, molto poetico, di un’intervista per me significativa:
«Casa è dove lasci e ricevi qualcosa che ti forma, che ti forgia dentro, casa è un abbraccio, una carezza, un bicchiere di vino. Casa è dove la tua anima apprende ed inizia il suo cammino: tortuoso o meno. Casa è il chiedersi perché molte volte non hai più motivo di creare immense difese ma sai per certo che il ricordo di ciò che ti ha segnato non va via. Casa è riflessione. Casa, la vera casa ha l’anima gitana. Un posto fisso con mura e tetto per trovare ristoro e da dove riprendere la tua marcia. Ecco cosa per me è casa» [5].
Dialoghi Mediterranei, n. 36, marzo 2019
[*] Testo della relazione presentata al Convegno internazionale “Peoples and cultures of the world”, Università degli Studi di Palermo, 24-25 gennaio 2019.
Note
[1] Jackson è un antropologo e poeta neozelandese, ha insegnato in importanti università australiane, danesi e americane. Dal 2005 è professore e studioso di ‘religioni mondiali’ alla Harvard Divinity School. E’ stato insignito, nel 1976, del Commonwealth Poetry Prize e, nel 1981, del New Zealand Book Award for poetry. Attira l’attenzione, senza dubbio, la particolarità nel saper unire la sensibilità di antropologo e quella di poeta e scrittore.
[2] Nella lingua inglese, per esempio, esiste una diversificazione lessicale e semantica tra ‘Home’, concetto astratto e ‘House’, entità materiale.
[3] Social network attualmente tra i più utilizzati
[4] Shahram Khosravi è docente del dipartimento di scienze socio-antropologiche all’Università di Stoccolma, in Svezia, studioso di antropologia delle frontiere surclassa tutte le definizioni teoriche della dottrina geopolitica e offre, piuttosto, una riflessione antropologica sui modi in cui le frontiere vengono esperite, vissute e interpretate da coloro che le abitano e le attraversano.
[5] Estratto di un’intervista a Florina Alina Elle Abitabile, sopravvissuta all’orfanotrofio lager di Câmpulung in Romania e adottata all’età di due anni e mezzo da una famiglia italiana.
Riferimenti bibliografici
Chatwin B., What Am I Doing Here, Viking, New York, 1989
Jackson M. D., At home in the world, Duke University Press, Durham and London, 1995
Khosravi S., ‘Illegal’ Traveller: An Auto-Ethnography of Borders, Palgrave Macmillan, Houndmills, 2010
Miller D., Cose che parlano di noi. Un antropologo a casa nostra, Il Mulino, Bologna, 2014
Taverna L., Montes S., “La cultura dell’abitare in chiave proustiana. Saggio di metodo”, in Dialoghi Mediterranei, n.17, gennaio 2016
_____________________________________________________________________
Mariangela Vitrano, neo-laureata in Lingue e Letterature moderne e Mediazione Linguistica all’Università degli Studi di Palermo, si interessa di antropologia e in particolare dei processi migratori, non solo in quanto fenomeno sociale ma anche artistico ed esistenziale.
___________________________________________________________________________