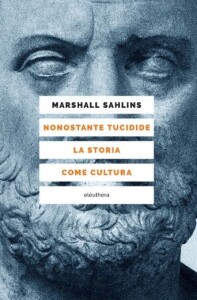Che quello antropologico non sia uno sguardo oggettivo e distaccato rispetto alla realtà è un dato di fatto ormai assodato. L’antropologia, in quanto discorso posizionato sull’altro, non si limita infatti a rappresentare fedelmente oggetti concretamente esistenti là fuori, bensì li produce (e riproduce) secondo strategie metodologiche, epistemologiche e retoriche che mirano a estrarli dal continuum storico-sociale in cui sono immersi. Tutto il discorso antropologico, dunque, è “finzione”: non nel senso che sia gratuito rispetto al reale, bensì perché pretende di fissare istantanee all’interno del flusso continuo dell’esistenza. La confusione tra modelli e realtà probabilmente arriva da qui, da questo paradosso che costringe i ricercatori a convivere con i propri interlocutori e a stare nella relazione solo per portare a casa delle fotografie che, una volta scattate, vengono decontestualizzate e rese inevitabilmente altre – altre dall’ambiente in cui sono state raccolte e in fin dei conti altre rispetto al mondo da cui proviene il ricercatore.
Com’è stato più volte evidenziato, il discorso antropologico produce alterità (o forse è meglio dire che produce modi di intendere l’alterità) e lo fa attraverso l’impiego di particolari griglie analitiche: l’insieme degli attrezzi che i suoi cultori hanno approntato per avvicinarsi alla comprensione di questa chimera inscrivendola in un testo. “Cultura” è uno di questi strumenti: il più importante e insieme il più problematico; il più problematico proprio perché il più importante. Sulla cultura, negli ultimi decenni, si è scritto tanto; si è detto tutto e il contrario di tutto. Da categoria in grado di far saltare gli odiosi determinismi biologici che hanno alimentato a lungo razzismo e xenofobia, a dispositivo normativo produttore di nuovi e più subdoli determinismi, essa è oggi fonte di notevole imbarazzo per gli addetti ai lavori.
L’imbarazzo, com’è noto, deriva dal processo di reificazione/essenzializzazione cui essa è andata progressivamente incontro alimentando (anche) posture differenzialiste ambigue e pericolose nelle loro ricadute politiche. Tale imbarazzo deriva inoltre dalla ‘coscienza sporca’ degli antropologi, ovvero dal riconoscimento di averla plasmata all’interno dello spazio coloniale e di aver contribuito attivamente a irrigidirla. Nel 1991, sintesi e insieme punto di arrivo di una lunghissima riflessione critica, Lila Abu-Lughod pubblicava un saggio destinato a far discutere a lungo: Writing against Culture. Nel testo l’antropologa palestinese-americana portava alle estreme conseguenze decenni di attacchi all’immagine stereotipata di cultura che l’antropologia aveva costruito e adoperato; reagiva altresì alla pubblicazione di un altro caposaldo dell’antropologia critica di quegli anni, Writing Cultures di James Clifford e George Marcus, che, a suo avviso, aveva nascosto i problemi politici dell’etnografia dietro pavidi tecnicismi retorici.
Il discorso di Abu-Lughod (1991) verteva essenzialmente sulla necessità di svelare le asimmetriche relazioni di potere che sostengono da sempre il progetto antropologico: l’inevitabile e netta distinzione tra «selves» attivi e assertivi e «others» passivi e marginali (Ivi: 138). Il concetto di cultura, da questa prospettiva, si configura come il dispositivo attraverso il quale l’antropologia, persino quella più sensibile e attenta, ribadisce la distanza tra chi conosce e chi è conosciuto perché lavora «to enforce separations that inevitably carry a sense of hierarchy» (Ibidem). Tutto ciò, continua Abu-Lughod, emerge in modo particolarmente drammatico quando soggetti storicamente discriminati, le donne o i nativi, fanno antropologia e si ritrovano loro malgrado a riprodurre un dispositivo analitico fondamentalmente incapace di non dominare l’altro (chiunque esso sia) marginalizzandolo, facendolo parlare all’unisono e condannandolo a un’eterna diversità rispetto a chi autorizza il discorso scientifico.
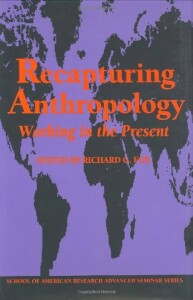 Per combattere tale postura, Abu-Lughod proponeva allora una soluzione radicale: non bisogna soltanto sbarazzarsi di un concetto scientificamente inutile e politicamente pericoloso, ma è necessario «scrivere contro la cultura» per smascherarne limiti, ambiguità e connivenze. A tal fine, individuava tre procedimenti in grado di decolonizzare definitivamente l’antropologia traghettandola verso un nuovo «umanesimo tattico» (Ivi: 157-160): 1) privilegiare, con Bourdieu e Foucault, l’analisi della relazione dialettica tra “pratiche” e “discorsi” per andare «against the assumption of boundedness, not to mention the idealism, of the culture concept» (Ivi: 148); 2) avviare un «anthropological turn to history» sensibile al cambiamento (Abu-Lughod, 1991: 149); 3) produrre «etnografie del particolare» utili a combattere il culturalismo e cogliere, finalmente, la ricchezza delle più diverse soggettività (Ivi: 149-157).
Per combattere tale postura, Abu-Lughod proponeva allora una soluzione radicale: non bisogna soltanto sbarazzarsi di un concetto scientificamente inutile e politicamente pericoloso, ma è necessario «scrivere contro la cultura» per smascherarne limiti, ambiguità e connivenze. A tal fine, individuava tre procedimenti in grado di decolonizzare definitivamente l’antropologia traghettandola verso un nuovo «umanesimo tattico» (Ivi: 157-160): 1) privilegiare, con Bourdieu e Foucault, l’analisi della relazione dialettica tra “pratiche” e “discorsi” per andare «against the assumption of boundedness, not to mention the idealism, of the culture concept» (Ivi: 148); 2) avviare un «anthropological turn to history» sensibile al cambiamento (Abu-Lughod, 1991: 149); 3) produrre «etnografie del particolare» utili a combattere il culturalismo e cogliere, finalmente, la ricchezza delle più diverse soggettività (Ivi: 149-157).
L’argomentazione di Abu-Lughod parte da premesse indiscutibili e coglie con grande lucidità il legame tra posture differenzialiste e pratiche di esclusione/marginalizzazione dell’altro. Ciononostante, a mio avviso, non convince quando vuole spingere la disciplina a fare a meno senza rimpianti del concetto di cultura. Ora, è sotto gli occhi di tutti il modo in cui “cultura” venga spesso reificata in un’entità oggettiva dal carattere omogeneo, discreto e prescrittivo; per non parlare poi di come sovente oscuri la pluralità di voci e le asimmetriche relazioni di potere all’interno delle varie comunità. Tuttavia, sono convinto che un’antropologia senza cultura presenti molti più problemi di quanto a prima vista ne possa risolvere. Se, d’altra parte, è la stessa Abu-Lughod a puntualizzare più volte, opportunamente, quali sono le inaccettabili accezioni del termine da cui dovremmo guardarci – quelle che lo trasformano in uno schiacciasassi senza tempo, internamente coerente e chiuso all’esterno –, perché rinunciare al concetto in quanto tale anziché lavorare a una sua opportuna calibrazione?
Concentrarsi solo su un’antropologia del soggetto alle prese con sistemi di potere può dirci qualcosa di veramente profondo sull’essere umano e sui suoi modi di essere umano? Siamo davvero convinti, insomma, che gli interessantissimi racconti di libertà anti-strutturale riportati da Abu-Lughod a proposito delle donne beduine (Ivi: 154-157), narrazioni analoghe a quelle che avevano nutrito la sua indimenticabile etnografia del 1986 (Sentimenti velati), siano effettivamente più comprensibili rinunciando in toto al ricorso alla cultura?
La cosiddetta “antropologia critica”, che si è sviluppata anche grazie al lavoro di Abu-Lughod, tutta votata a cogliere – legittimamente s’intende – il politico nel culturale e a smascherare le logiche di dominio e sopraffazione della nostra società in rapporto alle altre, rischia – come si dice in questi casi – di gettar via il bambino con l’acqua sporca. Essa, infatti, spesso dimentica di indagare il culturale nel politico minando alla radice la stessa legittimità dell’approccio antropologico e uniformandosi a filosofie politiche (e della storia) che ne depotenziano la portata. Fabio Dei (2017) l’ha rilevato con grande chiarezza: unendo in matrimonio il decostruzionismo più spinto a una visione vetero-marxista delle dinamiche sociali, la critical anthropology concepisce la ricerca come smascheramento della mano invisibile del Potere nascosta sotto la coltre della cultura. Legittima cioè, un pensiero pre-antropologico che si concilia a fatica, nonostante il condivisibile impegno politico a favore degli ultimi/esclusi, con la densità dell’incontro etnografico e la fluidità dei terreni di ricerca. Così facendo, l’antropologia è, per il suo bene, trascinata sul terreno della militanza ed è spinta a liberarsi della cultura in nome della scandalosa rivelazione che tra soggetto e Potere non c’è praticamente alcuna mediazione se non pura ideologia e coercizione strutturale.
 Probabilmente invece il concetto di cultura qualcosa da dire ce l’ha ancora e ad essere strenuamente combattuti e smascherati devono essere semmai i suoi usi indebiti. Indulgere sull’importanza della cultura, dunque, non significa attardarsi su posizioni di retroguardia ignare dei contemporanei sviluppi della disciplina o, peggio ancora, su atteggiamenti reazionari che decidono pavidamente di ignorare che tutto è politica. Indulgere sull’importanza della cultura, al contrario, vuol dire sintonizzarsi sull’attività simbolica dell’essere umano, ovvero sull’attività semiotica che conferisce significato – contingente, temporaneo e prospettico – a quel complesso di fenomeni cui, di volta in volta, ci riferiamo con i termini “società”, “politica”, “economia”, “filosofia”, “arte”. Il tutto, ovviamente, non dimenticando mai di sottolinearne la storicità, l’apporto decisivo delle diverse agencies alla sua formazione e riproduzione e la porosità dei suoi confini. E non trascurando, infine, un dettaglio importante: ciò che gli antropologi studiano non sono mai le culture in quanto tali, bensì quel che le persone – e tra esse, beninteso, gli antropologi – pensano siano le culture.
Probabilmente invece il concetto di cultura qualcosa da dire ce l’ha ancora e ad essere strenuamente combattuti e smascherati devono essere semmai i suoi usi indebiti. Indulgere sull’importanza della cultura, dunque, non significa attardarsi su posizioni di retroguardia ignare dei contemporanei sviluppi della disciplina o, peggio ancora, su atteggiamenti reazionari che decidono pavidamente di ignorare che tutto è politica. Indulgere sull’importanza della cultura, al contrario, vuol dire sintonizzarsi sull’attività simbolica dell’essere umano, ovvero sull’attività semiotica che conferisce significato – contingente, temporaneo e prospettico – a quel complesso di fenomeni cui, di volta in volta, ci riferiamo con i termini “società”, “politica”, “economia”, “filosofia”, “arte”. Il tutto, ovviamente, non dimenticando mai di sottolinearne la storicità, l’apporto decisivo delle diverse agencies alla sua formazione e riproduzione e la porosità dei suoi confini. E non trascurando, infine, un dettaglio importante: ciò che gli antropologi studiano non sono mai le culture in quanto tali, bensì quel che le persone – e tra esse, beninteso, gli antropologi – pensano siano le culture.
Mi pare, questo, l’obiettivo che Marshall Sahlins si è posto con Nonostante Tucidide. La storia come cultura, opera presentata in Italia da Eleuthera (2023) a quasi vent’anni dalla pubblicazione originale (2004) e a poco più di due dalla scomparsa dell’antropologo di Chicago. Questo volume, letto quasi unanimemente come un tentativo di iniettare un po’ di antropologia nella pratica storiografica, è a mio avviso molto di più: un elogio della sensibilità antropologica svolto attraverso la valorizzazione del tanto bistrattato concetto di cultura. Per usare una metafora calcistica, l’antropologo americano non si limita a giocare in difesa respingendo le incursioni avversarie per poi partire in contropiede; imposta invece una gara d’attacco in cui la cultura, opportunamente declinata e svuotata da ogni essenzialismo, viene utilizzata come chiave per estendere il raggio d’azione dell’antropologia a campi solitamente distanti. Tale finalità, d’altra parte, è del tutto coerente con la traiettoria scientifica dell’autore, il quale per tutta la sua prolifica carriera ha sostenuto da una prospettiva strutturalista critica la specificità del contributo antropologico combattendo con veemenza e gusto per la polemica ogni forma di riduzionismo: quello materialista di Marvin Harris, quello genetico di Edward Wilson e della sociobiologia, quello nativista di Gananath Obeyesekere nella controversia a proposito della morte del capitano Cook alle Hawaii, quello governamentale degli epigoni di Michel Foucault.
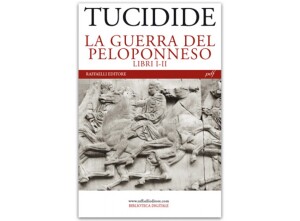 Il volume nasce come un omaggio a Tucidide e alla sua opera più rappresentativa, La guerra del Peloponneso: il testo con il quale il grande storico greco supera il modello erodoteo depurandolo dall’influenza del mitico, del trascendentale e soprattutto del culturale. Con il suo rigore metodologico e con il suo obiettivo di fondare un discorso oggettivo e universale, Tucidide è unanimemente considerato il padre della storiografia. Tale omaggio, tuttavia, nel perfetto stile di Sahlins, si trasforma presto in un riconoscimento critico e in un dialogo senza sconti: lo storico attico, infatti, non è ricordato per aver trasceso la cultura in nome dell’universalità della “natura umana”, ma per aver semmai incarnato la cultura ateniese del suo tempo scrivendo un manuale sulla naturalizzazione della norma che è diventato il modello di molte narrazioni dell’Occidente.
Il volume nasce come un omaggio a Tucidide e alla sua opera più rappresentativa, La guerra del Peloponneso: il testo con il quale il grande storico greco supera il modello erodoteo depurandolo dall’influenza del mitico, del trascendentale e soprattutto del culturale. Con il suo rigore metodologico e con il suo obiettivo di fondare un discorso oggettivo e universale, Tucidide è unanimemente considerato il padre della storiografia. Tale omaggio, tuttavia, nel perfetto stile di Sahlins, si trasforma presto in un riconoscimento critico e in un dialogo senza sconti: lo storico attico, infatti, non è ricordato per aver trasceso la cultura in nome dell’universalità della “natura umana”, ma per aver semmai incarnato la cultura ateniese del suo tempo scrivendo un manuale sulla naturalizzazione della norma che è diventato il modello di molte narrazioni dell’Occidente.
Se, argomenta Sahlins, è stato proprio Tucidide a metterci nei guai (dal punto di vista epistemologico), la lettura attenta del suo capolavoro, oltre a rendergli l’onore delle armi, può rivelarsi il modo migliore per uscire dalle secche di una visione essenzialista della storia e della cultura che le unisca finalmente in una sintesi efficace. Da questo punto di vista, dunque, Nonostante Tucidide dialoga con un classico di Sahlins, Isole di storia (2016; ed. or. 1985), riprendendone il programma: «il problema è oggi quello di far esplodere il concetto della storia attraverso l’esperienza antropologica della cultura» e viceversa far «esplodere la concezione antropologica della cultura» attraverso l’esperienza storica (Sahlins 2016: 18-19). Esplosione, beninteso, che nulla a che fare con la dismissione del concetto, bensì con il reale superamento della sua immagine ipostatizzata e normativa.
Che cos’è un fatto storico? Chi fa la storia? Dove si colloca l’azione individuale all’interno della struttura sociale? E che rapporto ha con gli schemi culturali?, si chiede a più riprese Sahlins, e nel rispondere non ha paura di tirar fuori dalla cassetta degli attrezzi dell’antropologia strumenti desueti o inconsueti – comparazione nello spazio e nel tempo, opposizioni binarie dal sapore vagamente saussuriano (sovente non così vago…), schemi genealogici di parentele reali o mitiche, schismogenesi batesoniana, exotopia bachtiniana – per interpretare eventi apparentemente scollegati – il celeberrimo scontro tra Atene e Sparta per l’egemonia dell’Ellade del V secolo a.C., un’oscura (almeno per noi occidentali) guerra polinesiana tra i regni figiani di Bau e Rewa del XIX secolo d.C., la vittoria dei New York Yankees alle World Series del 1939 e quella dei New York Giants alle finali del 1951, l’elezione presidenziale di George W. Bush alla Casa Bianca del 2001, l’epopea di Napoleone Bonaparte in Europa all’inizio del XIX secolo d. C., il tragico scontro tra i fratellastri Ratu Raivalita e Ratu Cakobau per il predominio a Bau del 1845, l’incidente diplomatico tra Cuba e Stati Uniti per la custodia di Eliàn Gonzalez, bambino conteso tra il papà castrista e gli zii esuli a Miami a cavallo tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Zero. Che cos’hanno in comune fatti così distanti e appartenenti a diversi ordini del discorso? Sono, possiamo dire con Sahlins, snodi utili a indagare dicotomie decisive per la strutturazione dei saperi antropologici e storiografici: cultura Vs natura, soggetti collettivi Vs individualità, evento Vs struttura.
L’argomentazione del ricercatore americano è rapsodica e propensa alla battuta brillante, il racconto dettagliatissimo dei fatti è inframezzato da parentesi teoriche che mirano a costruire progressivamente un quadro interpretativo generale. In antropologia e in storia, sostiene Sahlins, la cultura è sempre importante: essa non determina i fatti, ma li coordina, dà loro un senso e li organizza (Sahlins 2023: 21). Dimenticarla o metterla da parte conduce a riduzionismi/essenzialismi basati, secondo i diversi punti di vista, sulla sopravvalutazione di istinti naturali ritenuti universali o sulla sopravvalutazione di soggettività assolute alle prese con sistemi (politici, economici) astratti. Al contrario, ogni attore sociale occupa una posizione all’interno di uno schema culturale che ne orienta le azioni: se gli individui non sono “messi occasionali” dello “Spirito umano”, come certe antropologie hanno a lungo sostenuto, le loro attività sono nondimeno rese significative dalle reti di relazioni all’interno delle quali essi si trovano in un determinato momento.
Procediamo con ordine. Nel primo dei tre lunghi capitoli del volume, il grandioso affresco di Tucidide sullo scontro tra Ateniesi e Spartani (431 a.C. – 404 a.C.) è paragonato ad una guerra tra due regni dell’arcipelago delle Fiji: Bau, potenza talassocratica simile alla polis attica, e Rewa, la cui economia, come quella della città lacedemone, era principalmente basata sulle attività di terra. Il confronto apparentemente spericolato serve a Sahlins a fissare due obiettivi: da una parte criticare l’indifferenza per la cultura e la conseguente sopravvalutazione tucididea delle innate disposizioni umane generatrici di storia (avidità, ricchezza, gloria, potere, etc.); dall’altra smontare l’immagine discreta e isolata di società (e culture) impiegata da Tucidide per spiegarci le cause della guerra del Peloponneso. Partendo dal confronto transculturale con la realtà figiana e citando fonti archeologiche e recenti acquisizioni dei classicisti di professione, Sahlins dapprima impiega il concetto di “exotopia” coniato da Michail Bachtin per sostenere il carattere dialettico/dialogico delle dinamiche (inter)culturali: «ci vuole un’altra cultura per capire una cultura altra». Quindi ricorre al concetto di “schismogenesi” di Gregory Bateson per mostrare come Atene e Sparta (o, il che è lo stesso, Bau e Rewa), lungi dall’essere mondi opposti da sempre, sistemi chiusi che entrarono in rotta di collisione a causa del loro carattere nazionale, si siano progressivamente costruite come «antitipi strutturali, trasformazioni l’uno dell’altro» attraverso «processi sincronici di opposizione complementare».
L’economicismo imperialista degli Ateniesi, quello che Tucidide finirà per scambiare con la “natura umana”, insomma, diventa una disposizione caratteriale innata proprio nel V secolo a.C. e proprio in rapporto a Sparta; analogamente il miraggio spartano, ovvero l’immagine austera, frugale e chiusa degli Spartiati, si codifica nello stesso periodo e per le medesime ragioni. La relazione costitutiva tra Ateniesi e Spartani, come quella tra gli abitanti di Bau e quelli di Rewa, è fatta di «differenze sistematicamente e storicamente correlate», di «differenze interdipendenti». E poiché, continua Sahlins, il dinamismo di Atene/Bau e il conservatorismo di Sparta/Rewa sono interconnessi, «non si può scrivere la storia dell’uno senza quella dell’altro». Le divergenze, dunque, non si spiegano rintracciando atemporali nuclei identitari puri, bensì indagando la relazione tra ordini culturali che «avevano al contempo sia una storia propria sia una storia interdipendente di opposizioni complementari»; osservando altresì i modi in cui Atene e Sparta, nel V secolo d.C., seppero fare «sistema delle loro differenze» anche tramite l’elaborazione mitica del loro passato ancestrale.
È evidente come il discorso di Sahlins vada ben oltre la guerra del Peloponneso e la guerra della Polinesia per estendersi invece alle relazioni interculturali tout court. Proprio grazie all’occultamento delle dinamiche culturali, infatti, Tucidide ha costruito un quadro analitico potentissimo che ha influenzato a lungo il modo occidentale di fare storia (e antropologia). Se egli, eliminando il fantastico e il simbolico, ci ha dato l’impressione di essere più scienziato di Erodoto, ci ha al contempo trasmesso la fascinazione per la dittatura degli stimoli naturali e del «desiderio corporeo». Oltre che dell’universale. Un’attrazione che affiora ciclicamente nei contemporanei riduzionismi e che si porta dietro contraddizioni analoghe a quelle che serpeggiano tra le pagine immortali di Tucidide: come mai – si chiede retoricamente Sahlins – se la “natura umana” è uguale dappertutto, Ateniesi e Spartani (per non parlare di Corinzi e Melii) si sono comportati in modi differenti in situazioni analoghe?
Partendo da questo spinoso interrogativo, nel secondo e nel terzo capitolo la riflessione si sposta sul rapporto tra cultura e agentività individuale, tra struttura ed evento. È una domanda, quella precedente, cui il grande storico ateniese non hai mai dato risposta (un quesito che forse non si è mai posto) e che ha probabilmente alimentato l’oscillazione semantica che percorre La guerra del Peloponneso: quella tra grandi soggetti collettivi (gli Ateniesi, gli Spartani, etc.) e grandi individualità (Pericle, Alcibiade, etc.). A volte, infatti, ad essere protagonisti sono i singoli; altre, invece, le comunità. Ma chi o cosa ha agito effettivamente in quella storia? Chi ha determinato l’esito del conflitto? E più in generale, chi o cosa agisce nella storia? Chi o che cos’è il soggetto storico?
Si tratta, sostiene Sahlins, di un problema retorico tanto soggettivo quanto culturale, legato com’è al particolare racconto di un episodio da parte di un osservatore/narratore ben posizionato e dalla struttura del cambiamento storico/evento occorso. La scelta, rigorosamente a posteriori, di un agentività individuale o collettiva, cioè, dipende dalle strutture della e nella storia: strutture di tipo “evolutivo/cumulativo” simili a quelle che nel 1939 portarono i New York Yankees a vincere il campionato di baseball americano dominando la stagione dall’inizio alla fine o “strutture di tipo evenemenziale” simili a quelle che determinarono il clamoroso trionfo dei New York Giants nel 1951, quando alle 11:58 del 3 ottobre Bobby Thomson realizzò il fuoricampo decisivo nell’incontro finale contro i Brooklyn Dodgers (che erano stati in testa al campionato dalla prima giornata). Nel primo caso la temporalità è lineare, non ci sono eventi decisivi né individualità che spiccano e il soggetto, al netto delle buone o cattive prestazioni dei singoli nelle singole partite, è sempre collettivo. Nel secondo, invece, si tratta proprio di «un’altra “storia”»: il tempo sembra contrarsi e il senso di tutto sembra convergere teleologicamente nell’atto decisivo del singolo (in questo caso il tiro di Bobby Thomson). Forse allora, conclude Sahlins, in Tucidide l’oscillazione di cui sopra risponde a qualcosa di analogo: a parlare sono Ateniesi, Spartani, Melii o Corinzi quando si tratta di «riproporre i tradizionali comportamenti politici delle città che rappresentano, o quando sostengono il mantenimento di un certo status quo»; ma quando si tratta di decisioni a posteriori rivelatesi importanti (entrata in guerra, strategie belliche, scelte positive o disastrose), «gli oratori sono […] individui specifici».
Questo ennesimo, banale ed eretico confronto interculturale ha una funzione ben precisa nell’economia del testo: far luce, dopo la riflessione sul rapporto tra natura e cultura, sulla relazione tra individuo e società. Per quanto anche tale aspetto sia oggi relegato in secondo piano, apparentemente liquidato dalle filosofie/antropologie dell’agency individuale, Sahlins non rinuncia a dire la sua e si lascia anzi andare a una densa riflessione teorica che tocca con acume e ironia non pochi nodi disciplinari. La sua attenzione cade soprattutto sul versante di sinistra della dicotomia “soggetto Vs struttura” e prende di mira la «leviatanologia» delle strutture, ovvero la postura discorsiva che produce «draconiane visioni di mostri culturali autonomi con il potere di plasmare i soggetti individuali a loro immagine e somiglianza». Dopo una rapida critica alle tradizionali cattedrali superorganiche di Alfred Kroeber o Leslie White, passa all’analisi dell’ultima declinazione, in ordine di tempo, della «soggettività senza agentività»: le antropologie della repressione/egemonia che vedono nella cultura solo una proiezione fantasmatica del volto repressivo del Potere (statale, economico, etc.) – una mera patina ideologica, cioè.
Il bersaglio è evidentemente un certo foucaultismo modaiolo, ma nella critica finisce anche il concetto di egemonia gramsciana (sebbene, ed è un peccato non saperne di più, gli sparuti cenni non permettano di capire veramente che tipo di conoscenza avesse Sahlins dell’opera di Antonio Gramsci). Si tratta, scrive Sahlins, di posture decisamente anti-antropologiche che non fanno il bene della disciplina e che anzi fanno apparire molti antropologi comicamente intenti «a dimostrare antropologicamente che l’antropologia è impossibile».
Il punto di vista di Sahlins è il seguente: se la cultura viene ridotta a sovrastruttura ideologica di un Potere invisibile e pervasivo che colonizza senza alcuna mediazione qualunque istituto sociale, politico ed economico, le forme simboliche si dissolvono in meri «effetti di asservimento» e l’antropologo è ridotto a investigatore dei modi di espressione di questo potere. Ciò, tuttavia, genera aporie piuttosto serie. In primo luogo, queste antropologie si basano su un’immagine normativa ed essenzializzata di cultura; un’immagine speculare e rovesciata della cultura normativa ed essenzializzata che tali indirizzi disciplinari vorrebbero invece smascherare. La cultura – scrive infatti lo studioso americano – «non è mai così monoliticamente repressiva come le attuali antropologie dell’egemonia vorrebbero far credere». Gli indirizzi che decidono di eliminarla dalle proprie analisi, dunque, cadendo nella stessa postura riduzionista contro cui si scagliano a parole, ne eliminano in realtà una visione caricaturale e ridicola. In secondo luogo, la già menzionata dissoluzione delle forme culturali in effetti di asservimento postula l’esistenza di soggetti astratti alle prese con dispositivi egemonici altrettanto astratti. Sahlins non lo dice direttamente, ma il suo ragionamento lo implica: liquidata come non pertinente l’attività simbolica (se proprio non vogliamo usare il termine cultura) degli individui, che cosa differenzierà, nello spazio e nel tempo, la loro azione davanti agli istituti repressivi che vogliono controllarli e determinarne i comportamenti? E ancora: chi crea o autorizza tali istituti repressivi? Essi si comportano ovunque allo stesso modo?
Ridotta a una forma di speculazione allegorica, un’antropologia così concepita si condanna allo studio di un soggetto senza terreno sotto ai piedi alle prese con agenzie egemoniche impersonali che di fatto, però, sono le sole forze in grado di animarlo costringendolo ad agire sotto i loro impulsi o a reagire/opporsi ai loro stimoli. In tal modo l’essenzialismo attribuito arbitrariamente alla “Cultura” per denunciarne l’inesorabile violenza epistemica si riversa sul “Soggetto” in quanto crocevia di un «sistema univoco, atemporale e totalizzante di categorie e relazioni» non mediate. Dalla “leviatanologia” alla “soggettologia”, dunque, facce diverse della stessa medaglia: «il tentativo di ridurre le forme sociali generali alle disposizioni soggettive, o viceversa, come se fossero in una sorta di corrispondenza mimetica».
Che cosa non colgono, però, questi atteggiamenti che sopravvalutano ora la struttura ora l’individuo? Non colgono il campo intrinsecamente intersoggettivo in cui si muove l’ordine culturale il fatto che «vivendo la cultura in un modo specifico, una persona la esprimerà in modo unico, il che è per così dire un andare al di là di essa pur essendo in essa». Gli esseri umani, scrive Sahlins, producono storia a partire da posizioni all’interno di una rete di relazioni: dal momento che tali relazioni possono essere istituzionali o congiunturali (o entrambe le cose), tra ordine culturale e agentività individuale non v’è mai opposizione incolmabile. La storia crea i creatori di storia.
Nell’ultima parte del secondo e per l’intero terzo capitolo, Sahlins affronta analiticamente questi problemi distinguendo tra agentività sistemica e agentività congiunturale: personaggi come Napoleone Bonaparte, Pericle, Nicia o i re figiani sono esempi del primo tipo – figure che si trovano in una posizione strutturale tale da metterli in condizione di determinare il corso degli eventi (senza tuttavia che il loro comportamento sia culturalmente prestabilito); i protagonisti dell’affaire Gonzalez tra Cuba e Stati Uniti per la custodia del piccolo Eliàn sono invece esempi del secondo tipo – figure strutturalmente minori che la contingenza ha reso in qualche modo agenti decisivi. In entrambi i casi, le azioni individuali si inseriscono, sulla base del diverso posizionamento dei singoli, in una cornice che fonde motivazioni private/personali e questioni strutturali più grandi (morali, politiche, economiche, religiose, familiari – in una sola parola culturali). La collocazione degli attori sociali, allora, «implica sempre uno schema culturale più ampio di persone, cose e valori che conferisce potere a chi fa la storia e dà efficacia alle sue azioni, anche se i risultati possono non essere quelli previsti».
 Questo aspetto accomuna tanto i detentori di agentività congiunturale, tanto quelli di agentività sistemica. All’inizio degli anni Duemila, dunque, le condizioni strutturali e la cornice culturale non prescrivevano un esito necessario per la vicenda di Eliàn (alla fine tornato a Cuba dal padre); così come nel 1845 la rivalità tra i figli del re della guerra di Bau Ratu Tanoa, Ratu Cakobau e Ratu Raivalita, per quanto perfettamente inserita nello schema politico-culturale figiano (Cakobau era l’erede designato al trono, ma Raivalita, in qualità di vasu, ovvero figlio della sorella di Tanoa, godeva di un potere simbolicamente più importante di quello del cugino) e nell’opposizione struttural-complementare tra Bau e Rewa, non doveva ineluttabilmente concludersi con l’omicidio del secondo ad opera di sicari del primo. Tutto poteva andare diversamente. Tutto può andare diversamente.
Questo aspetto accomuna tanto i detentori di agentività congiunturale, tanto quelli di agentività sistemica. All’inizio degli anni Duemila, dunque, le condizioni strutturali e la cornice culturale non prescrivevano un esito necessario per la vicenda di Eliàn (alla fine tornato a Cuba dal padre); così come nel 1845 la rivalità tra i figli del re della guerra di Bau Ratu Tanoa, Ratu Cakobau e Ratu Raivalita, per quanto perfettamente inserita nello schema politico-culturale figiano (Cakobau era l’erede designato al trono, ma Raivalita, in qualità di vasu, ovvero figlio della sorella di Tanoa, godeva di un potere simbolicamente più importante di quello del cugino) e nell’opposizione struttural-complementare tra Bau e Rewa, non doveva ineluttabilmente concludersi con l’omicidio del secondo ad opera di sicari del primo. Tutto poteva andare diversamente. Tutto può andare diversamente.
Il concetto di cultura è scivoloso, subdolo e solo apparentemente scontato: come diceva Clifford Geertz (1988: 11), paragonandolo ad una rete continuamente tessuta e ritessuta, noi esseri umani spesso finiamo per impigliarci tra le sue maglie. Fuor di metafora: tendiamo a dimenticare che le culture sono modelli flessibili e aperti, non realtà concrete, internamente omogenee e chiuse all’esterno. E ciononostante esse ci rendono umani e danno senso (senso – beninteso – contingente e temporaneo; in una parola: storico) alle nostre azioni, alle nostre costruzioni, financo ai nostri corpi. Il grande merito del testo di Sahlins, allora, è quello di mostrarci quante cose si possano ancora fare con la cultura e quanto senso abbia ancora de-scriverla – anche in vista di un’azione autenticamente politica – piuttosto che scriverle contro fingendo che non abbia importanza.
Dialoghi Mediterranei, n. 65, gennaio 2024
Riferimenti bibliografici
Abu-Lughod L. 1991, “Writing Against Culture”, in Fox R. G. (a cura di), Recapturing Anthropology. Working in the Present, Santa Fe, School of American Research: 466-479.
Dei F. 2017, “Di Stato si muore? Per una critica dell’antropologia critica”, in Dei F., Di Pasquale C. (a cura di), Stato, violenza, libertà. La «critica del potere» e l’antropologia contemporanea, Firenze, Donzelli Editore: 9-49.
Geertz C. (1988), Interpretazione di culture, Bologna, Il Mulino.
Sahlins M. 2016, Isole di storia. Società e mito nei mari del sud, Milano, Raffaello Cortina Editore.
Sahlins M. (2023), Nonostante Tucidide. La storia come cultura, Milano, Eleuthera.
_____________________________________________________________
Dario Inglese, ha conseguito la laurea triennale in Beni Demo-etnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo e la laurea magistrale in Scienze Antropologiche ed Etnologiche presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. Si è occupato di folklore siciliano, cultura materiale e cicli festivi. A Milano, dove insegna in un istituto superiore, si è interessato di antropologia delle migrazioni e ha discusso una tesi sull’esperimento di etnografia bellica Human Terrain System.
______________________________________________________________