di Piero Vereni
Si sapeva dal giugno 2020 che diversi agenti di polizia penitenziaria del carcere di Santa Maria Capua Vetere erano iscritti nel registro degli indagati per il modo violento in cui era stata condotta una “perquisizione generale straordinaria” organizzata il 6 aprile. Da alcuni giorni era partita una protesta dopo che un detenuto addetto alla distribuzione dei pacchi spesa era stato messo in isolamento, contagiato dal coronavirus. Il 5 aprile la protesta aveva raggiunto l’apice quando un centinaio di detenuti avevano eretto delle barricate con alcune brande, chiedendo garanzie per la loro salute.
La situazione era tesissima da settimane in tutte le prigioni italiane, dopo che l’interruzione immediata e senza alternative delle visite a causa del lockdown nazionale e la mancanza di un’effettiva prevenzione sanitaria avevano suscitato in diverse carceri ai primi di marzo una serie di scontri che avevano prodotto dodici morti tra i detenuti. La risposta dell’allora ministro Bonafede era stata netta: «Fuori della legalità e, addirittura, nella violenza, non si può parlare di protesta, si deve parlare semplicemente di atti criminali», confermando il legalismo populista caratteristico del movimento politico da cui proveniva [1]. Fortunatamente, una decina di giorni dopo la perquisizione, l’Ufficio del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale aveva trasmesso le informazioni in suo possesso alla Procura, che avevano consentito l’avvio delle indagini.
I morti di marzo e le violenze di aprile erano quindi notizie in parte già note all’opinione pubblica, ma c’era voluta, oltre un anno dopo, la pubblicazione di alcuni video registrati durante la perquisizione per ridestare l’attenzione della società civile (Trocchia 2021). Quel che è qui importante notare è l’arco degli stati d’animo suscitato dalle immagini fatte circolare: orrore, sgomento, rabbia, senso di ingiustizia. Nessuno dei commenti ha mai argomentato sulla base dello stupore per le azioni riprodotte, come se, in un certo senso o da qualche punto di vista, quelle immagini, per quanto sconvolgenti, non fossero davvero inaspettate, ma parte di un implicito sapere comune.
Un sintomo di questo atteggiamento cinico o rassegnato è il modo in cui la retorica delle “mele marce” si è impossessata delle figure pubbliche protese a garantire il perdurare dell’istituzione carceraria, e il contemporaneo crollo dell’inibizione da parte del mass media. Questa contrapposizione tra “mele marce” e “si sapeva da sempre” corrisponde chiaramente a un unico modello “libidinale”, direbbe Slavoj Žižek, per cui il potere è contemporaneamente fonte di repressione (grazie alla legge, unico strumento che hobbesianamente può consentire lo sviluppo della civiltà) e, tramite il meccanismo di identificazione, sorgente mediatrice di un godimento altrimenti represso [2].
Ci sono, dice Žižek, due padri per ciascuno di noi: uno che reprime in nome della Legge, che ci controlla dunque e impedisce il soddisfacimento immediato e distruttivo del principio di piacere; e uno soggiacente, di fatto occulto, colui che prova il piacere del godimento con la madre, e con cui ci identifichiamo proprio per condividerne il godimento. Quanto più il potere è gerarchico, tanto più questo modello di doppia relazione sembra imporsi. Senza entrare troppo nella visione žižekiana, per i nostri scopi potrebbe valere questa semplice ipotesi: e se il carcere, come istituzione, si articolasse proprio su tale doppio livello, spingendoci a reprimere il principio di piacere (rappresentato dalla libidine criminale) in cambio del soddisfacimento indiretto per la consapevolezza che il principio di morte (rappresentato da chi il carcere invece lo gestisce e lo controlla) deve comunque trovare una sua via di sfogo, con la quale identificarsi?
 Il carcere (almeno quello italiano), appena lo si guardi un poco da vicino, manifesta un congenito paradosso: da un lato la Costituzione italiana e l’Ordinamento Penitenziario dichiarano che la sua funzione principale è quella di rieducare la persona detenuta e condurla a un sano reinserimento sociale; d’altro canto, non solo questa risocializzazione proclamata sembrerebbe realizzarsi con lo strumento paradossale della desocializzazione radicale, ma permane evidente nel senso comune la sensazione – raramente (almeno fino a poco fa) l’accettazione esplicita – che la pena inflitta serva prima di tutto a far soffrire il condannato. La funzione rieducativa e quella afflittiva sono cioè in tensione, o in condizione di doppio legame, direbbe Gregory Bateson: quale si privilegi, si danneggerà il soddisfacimento dell’altra.
Il carcere (almeno quello italiano), appena lo si guardi un poco da vicino, manifesta un congenito paradosso: da un lato la Costituzione italiana e l’Ordinamento Penitenziario dichiarano che la sua funzione principale è quella di rieducare la persona detenuta e condurla a un sano reinserimento sociale; d’altro canto, non solo questa risocializzazione proclamata sembrerebbe realizzarsi con lo strumento paradossale della desocializzazione radicale, ma permane evidente nel senso comune la sensazione – raramente (almeno fino a poco fa) l’accettazione esplicita – che la pena inflitta serva prima di tutto a far soffrire il condannato. La funzione rieducativa e quella afflittiva sono cioè in tensione, o in condizione di doppio legame, direbbe Gregory Bateson: quale si privilegi, si danneggerà il soddisfacimento dell’altra.
Didier Fassin (2018) sostiene a questo riguardo che la funzione punitiva sia una «passione contemporanea» e, nella sua disamina della carcerazione come pena standard, prende esplicitamente le mosse dalla riflessione nietzschiana sulla Genealogia della morale, in particolare dalla seconda dissertazione, che Fassin rilegge come spiegazione del passaggio dalla giustizia come compensazione o riequilibrio di uno stato originario trasgredito, alla giustizia invece concepita come espiazione di quella colpa attraverso la sofferenza del trasgressore. Fassin trasferisce nell’altrove etnografico quel che Nietzsche aveva ridotto al tempo passato: gli Altri, come gli Antichi, pratica(va)no la giustizia come atto eccessivo che andava a compensare un eccesso precedente. Giustizia e vendetta, in questa logica, si equivalgono non tanto come punizione del trasgressore, quanto come ricomposizione di uno squilibrio.
 La contemporaneità occidentale (che nel modello di Fassin gioca la parte che il Cristianesimo ha in quello di Nietzsche), venuta meno la morale naturalmente violenta dei signori e ossessionata dal doversi dimostrare civilizzata di fronte alla barbarie primitiva che portava la giustizia dentro il corpo del trasgressore, traduce il suo senso di giustizia in afflizione, punizione verso chi abbia trasgredito. Fassin ripropone però il modello nietzschiano (l’afflizione rimpiazza per noi quel che per loro era invece compensazione) in versione edulcorata, per cui la compensazione che lui rileva con l’ausilio dell’etnografia antropologica verrebbe praticata in forme blande, o addirittura non praticata affatto, lasciando al trasgressore lo scorno della vergogna più che le conseguenze di un riequilibrio violento.
La contemporaneità occidentale (che nel modello di Fassin gioca la parte che il Cristianesimo ha in quello di Nietzsche), venuta meno la morale naturalmente violenta dei signori e ossessionata dal doversi dimostrare civilizzata di fronte alla barbarie primitiva che portava la giustizia dentro il corpo del trasgressore, traduce il suo senso di giustizia in afflizione, punizione verso chi abbia trasgredito. Fassin ripropone però il modello nietzschiano (l’afflizione rimpiazza per noi quel che per loro era invece compensazione) in versione edulcorata, per cui la compensazione che lui rileva con l’ausilio dell’etnografia antropologica verrebbe praticata in forme blande, o addirittura non praticata affatto, lasciando al trasgressore lo scorno della vergogna più che le conseguenze di un riequilibrio violento.
La violenza, questa mi pare la tesi paradossale di Fassin, è in gran parte nella responsabilità della “contemporaneità”, appassionatasi all’idea stessa di punire, con il risultato finale che carcerazione (che sappiamo da Foucault aver sostituito forme fisicamente più violente di punizione corporale) e violenza vengono fatte coincidere, mentre il riequilibrio praticato dai popoli di interesse etnografico (che per Nietzsche altro non era che la naturalità della violenza) diventa spesso un generale disinteresse o una reprimenda paternalistica.
Non posso entrare nel dettaglio di questa interpretazione del carcere come forma passionale del piacere di punire, e mi limito a due considerazioni finali. Una di ordine logico, e una basata sull’evidenza empirica.
Sul piano logico, assumere la Genealogia della morale come una fonte attendibile di una supposta passione contemporanea per la punizione che prende la forma privilegiata dell’incarcerazione (ma per Fassin è proprio il piacere di punire che sembra aver acquisito una nuova legittimazione morale nel tempo presente) equivarrebbe a prendere L’origine della famiglia di Fredrich Engels come una fonte attendibile per la ricostruzione antropologica dell’evoluzione dei sistemi sociali.
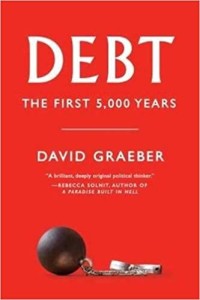 Sappiamo, invece, che Engels si basava per la sua teorizzazione su fonti dell’evoluzionismo oggi considerate del tutto inattendibili. Perché allora dare credito a Nietzsche, quando sostiene che il piacere di punire deriva dall’interiorizzazione del senso di colpa ereditato dal debito verso gli antenati, quando insomma collega colpa e debito, ma senza citare neppure di passaggio David Graeber (2011) che a questo tema ha dedicato un volume di oltre cinquecento pagine? Non sto dicendo che Graeber abbia ragione (il suo pensiero è ancor più obliquamente nietzschiano di quello di Fassin), ma piuttosto che la riflessione su tematiche culturali legate alla contemporaneità dovrebbe essere articolata a partire dalle fonti disponibili oggi, non nel 1887.
Sappiamo, invece, che Engels si basava per la sua teorizzazione su fonti dell’evoluzionismo oggi considerate del tutto inattendibili. Perché allora dare credito a Nietzsche, quando sostiene che il piacere di punire deriva dall’interiorizzazione del senso di colpa ereditato dal debito verso gli antenati, quando insomma collega colpa e debito, ma senza citare neppure di passaggio David Graeber (2011) che a questo tema ha dedicato un volume di oltre cinquecento pagine? Non sto dicendo che Graeber abbia ragione (il suo pensiero è ancor più obliquamente nietzschiano di quello di Fassin), ma piuttosto che la riflessione su tematiche culturali legate alla contemporaneità dovrebbe essere articolata a partire dalle fonti disponibili oggi, non nel 1887.
E questo mi porta alla considerazione conclusiva, vale a dire al fatto che i dati empirici in nostro possesso sembrano confermare l’ipotesi che la volontà di punire sia tutt’altro che una passione moderna e abbia piuttosto radici nell’attivazione adattiva di comportamenti “prosociali”, vale a dire orientati alla messa in funzione di norme e al rafforzamento di istituzioni.
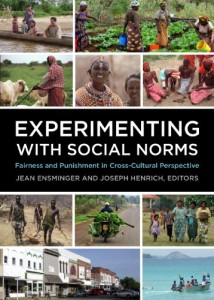 Fehr, Fischbacher e Gächter (2002) hanno dimostrato che oltre alla reciprocità ordinaria (per cui tendiamo a cooperare quando sappiamo di trarne un vantaggio) gli esseri umani praticano estesamente la “reciprocità forte”, che ci induce a punire, anche a nostre spese, coloro che invece non cooperano. E un amplissimo studio comparativo condotto da una ventina di antropologi ed economisti (Ensminger, Henrich 2014) ha confermato che tutte le culture sanzionano in qualche modo i comportamenti non sociali, prevedendo certo forme diversissime di punizione ma giustificando comunque in modo non-nietzschiano il piacere di punire, che non è un godimento individuale di matrice morale ma può essere compreso nella sua valenza evolutiva come un sentimento condiviso che facilita l’integrazione sociale e il comportamento cooperativo.
Fehr, Fischbacher e Gächter (2002) hanno dimostrato che oltre alla reciprocità ordinaria (per cui tendiamo a cooperare quando sappiamo di trarne un vantaggio) gli esseri umani praticano estesamente la “reciprocità forte”, che ci induce a punire, anche a nostre spese, coloro che invece non cooperano. E un amplissimo studio comparativo condotto da una ventina di antropologi ed economisti (Ensminger, Henrich 2014) ha confermato che tutte le culture sanzionano in qualche modo i comportamenti non sociali, prevedendo certo forme diversissime di punizione ma giustificando comunque in modo non-nietzschiano il piacere di punire, che non è un godimento individuale di matrice morale ma può essere compreso nella sua valenza evolutiva come un sentimento condiviso che facilita l’integrazione sociale e il comportamento cooperativo.
Il cinismo con cui dunque abbiamo appreso la non-notizia che nelle prigioni la violenza è sistematica e il sopruso non solo generalizzato, ma addirittura oggetto di vanto interno tra gli operatori della polizia penitenziaria, potrebbe avere una sua spiegazione relativamente semplice, che tiene assieme il processo di identificazione di Žižek e la reciprocità forte di Fehr: ci aspettiamo che i detenuti vengano puniti, oltre la retorica della rieducazione, e la parte indecente di noi gioisce per interposta persona del piacere di punire che vediamo nelle immagini rese pubbliche.
Il carcere come istituzione, delegando questo piacere nell’occulto e nel non detto, resta incapace di realizzare la sua funzione rieducatrice, dato che chi viene punito subisce la punizione solo come sopruso privato o privilegio di casta, e non come dettato collettivo, processo rituale esplicitato e necessario alla reintegrazione sociale. Fin quando il carcere non riprenderà la sua funzione pienamente rituale di processo di riequilibrio attraverso forme di punizione sancite socialmente, aspettiamoci altre Santa Maria Capua Vetere, e altre sopracciglia sollevate, a seconda della posizione, a rimarcare che “si tratta di qualche mela marcia” oppure che “tanto si sapeva che non poteva che essere così”.
Dialoghi Mediterranei, n. 51, settembre 2021
Note
[1] Agenzia Vista. Roma, 11 Marzo 2020 – Il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede in Aula al Senato per l’informativa sulla situazione nelle carceri italiane dopo le proteste dei detenuti. Online https://www.youtube.com/watch?v=4wNQc1CZC8I
[2] Il pensiero di Žižek su questa anfibolia del potere è sintetizzato molto lucidamente in un testo di Matthew Sharpe (2005), non causalmente dedicato all’analisi degli eventi di Abu Ghraib, quando cioè si seppe che alcuni soldati americani della base di Guantanamo non solo torturavano i prigionieri iracheni, ma si fotografavano in pose grottesche e facevano circolare le foto tra di loro.
Riferimenti bibliografici
Ensminger, J., Henrich, J.P. (a cura di) 2014, Experimenting with social norms: fairness and punishment in cross-cultural perspective. New York, Russell Sage Foundation.
Fassin, D., 2018, Punire: una passione contemporanea, Milano, Feltrinelli.
Fehr, E., Fischbacher, U., Gächter, S., 2002, Strong Reciprocity, Human Cooperation, and the Enforcement of Social Norms, «Human Nature» 13, 1: 1–25. https://doi.org/10.1007/s12110-002-1012-7.
Graeber, D., 2011, Debt: The First 5,000 Years; Brooklyn, NY, Melville House.
Nietzsche, F., 2008 [1887], Genealogia della morale. Uno scritto polemico, Milano, Adelphi.
Sharpe, M., 2005, A Few Good Men: Psychoanalysis, Abu Ghraib and (The) American Right, «Psychoanalysis, Culture & Society», 10: 168-185.
Trocchia, N., 2021, “Ora che c’è il video nessuno può più ignorare il pestaggio di Stato”, «Domani» 29 giugno 2021, online https://www.editorialedomani.it/fatti/video-pestaggio-carcere-santa-maria-capua-vetere-inchiesta-amb06s81
Piero Vereni, professore associato di Antropologia culturale nell’Università di Roma “Tor Vergata”, insegna «Urban & Global Rome» nel campus romano del Trinity College (Hartford, Connecticut). Dal 2018 è abilitato di prima fascia nel settore M-DEA/01 Discipline Demoetnoantrologiche. Ha effettuato ricerche sul campo sul confine della Macedonia occidentale greca (1995-97) e sul confine irlandese (1998-99). Si è occupato di antropologia politica e delle identità e antropologia dei media, e attualmente conduce ricerche di antropologia economica sulla diaspora della paternità bangladese, sul sistema carcerario in Italia, sulla diversità religiosa a Roma e sulla funzione politica delle occupazioni a scopo abitativo. Tra le sue ultime pubblicazioni ricordiamo: “Come si rimane. Diaspore religiose e strategie di permanenza culturale”, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Rivista trimestrale, 1/2020. “Il nodo gordiano e il filo di Arianna. La forma dello spazio nella crisi del Covid-19”, in Documenti geografici, 1 (ns), gennaio-giugno 2020. “De consolatione anthropologiae. Conoscenza, lavoro di cura e Covid-19”, in F. Benincasa e G. de Finis (a cura di), Closed. Il mondo degli umani si è fermato, Roma, Castelvecchi, 2020; Perché l’antropologia ci aiuta a fare politica (e a vivere meglio), Roma, Castelvecchi, 2021.
______________________________________________________________








