Uno dei dilemmi più cruciali per l’uomo, malgrado le sue capacità rispetto ad altri esseri viventi, è quello di non aver potuto risolvere, sul piano razionale, l’opposizione vita/morte. Quel fenomeno ineluttabile per cui ogni forma di esistenza, nel suo processo evolutivo e nello scorrere del tempo, è destinata inevitabilmente a concludersi fino all’annientamento. Questo dato oggettivo ha comportato nell’uomo, in ogni epoca e di ogni provenienza, la necessità di elaborare sistemi mitici di protezione che in qualche modo compensassero la perdita irreversibile di un congiunto e garantissero il prolungamento della vita dopo la morte, sia pur in una dimensione oltremondana.
Ernesto de Martino ha dimostrato in modo esemplare come la morte, qualsiasi morte, improvvisa, per vecchiaia o per malattia, provochi nell’individuo un senso di smarrimento, quello che definisce la “crisi della presenza”, l’annullamento del sé e della propria identità. Ecco perché i sistemi culturali di elaborazione del lutto, il cordoglio collettivo che si stringe attorno ai familiari del defunto, servono proprio a superare questo momento di criticità, di destabilizzazione e di rottura dell’equilibrio, a risolvere sul piano simbolico ciò che a livello biologico e naturale risulta irrimediabile. Da qui, ad esempio, le tecniche del lamento funebre nel mondo antico o del pianto rituale nella bassa Lucania del Mezzogiorno d’Italia: tentativi di destorificazione mitica del negativo che rendono possibili il trapasso del defunto dalla morte fisica all’eternità spirituale.
Anche Philippe Ariès, nel suo lungo excursus storico dal Medioevo all’età moderna, osserva che la morte non è mai un fatto fisico e individuale, ma coinvolge tutto il gruppo sociale e diviene lacerante se non controllata attraverso cerimonie pubbliche solenni che ripropongano la solidarietà dell’individuo con la sua stirpe e la sua comunità (1985: 716). La paura collettiva della morte è dovuta al fatto – secondo lo storico francese – che essa apre una breccia nel sistema di protezione contro la natura e il suo aspetto selvaggio. Di fronte a questo pericolo ricorrente occorrono strategie particolari che fanno sì che la morte non possa essere lasciata a sé stessa e ai suoi eccessi, ma venga imprigionata e trasformata in uno spettacolo. Non un’avventura solitaria, quindi, ma un fenomeno pubblico che coinvolge e rinsalda la comunità intera.
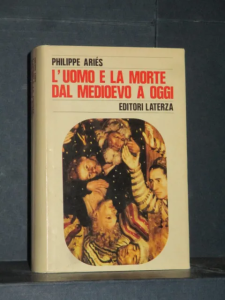 Su questi argomenti torna ad interrogarsi, da un punto di vista psicanalitico, Massimo Recalcati, nel suo ultimo libro dal titolo La luce delle stelle morte. Saggio sul lutto e sulla nostalgia, edito da Feltrinelli (2022). Cosa è, in definitiva, la luce delle stelle morte, quello strano fenomeno astrofisico per cui da un corpo dell’universo non più esistente, possa emanarsi una luce che illumina il nostro presente? Un qualcosa che non c’è più, che è scomparso per sempre, definitivamente morto, ma che continua, con la sua luce, a ravvivare la nostra esistenza.
Su questi argomenti torna ad interrogarsi, da un punto di vista psicanalitico, Massimo Recalcati, nel suo ultimo libro dal titolo La luce delle stelle morte. Saggio sul lutto e sulla nostalgia, edito da Feltrinelli (2022). Cosa è, in definitiva, la luce delle stelle morte, quello strano fenomeno astrofisico per cui da un corpo dell’universo non più esistente, possa emanarsi una luce che illumina il nostro presente? Un qualcosa che non c’è più, che è scomparso per sempre, definitivamente morto, ma che continua, con la sua luce, a ravvivare la nostra esistenza.
Da questa premessa lo studioso riconosce due forme di nostalgia e di lutto come separazione irreversibile: l’una, quella classica, è la nostalgia come rimpianto del passato, quel senso di struggimento per quello che abbiamo vissuto e non è più con noi, di chi guarda indietro bloccando il divenire del tempo e considerando la propria esistenza come un processo tutto retrospettivo che a volte rischia di diventare patologico. La seconda è proprio quella che scaturisce dalla luce delle stelle morte, ed è una nostalgia intesa non in senso conservativo come un archivio di ricordi, ma al contrario diviene generativa nel momento in cui anche un piccolo dettaglio, un piccolo gesto, una frase irrompano improvvisamente nella nostra vita, proiettandoci verso l’avvenire. È questo il senso di un’eredità riuscita, quando la memoria di quanti ci hanno accompagnato nel corso della nostra esistenza, illumina il nostro cammino e ci orienta nel futuro, recuperando il passato in senso positivo.
Punto di partenza necessario per l’Autore è il riferimento a Freud che al lutto e alla melanconia ha dedicato grande spazio nei suoi studi, a partire dalla constatazione che il dispiegarsi dell’esistenza è scandito da una serie di tagli e separazioni: dalla placenta, dal cordone ombelicale, dal seno materno, dalle proprie feci e dalla madre. La condizione stessa per vivere è quindi quella di uscire fuori dal sé, andare verso l’altrove. In questo senso quando si perde l’altro, cioè l’oggetto del proprio desiderio, si perde inevitabilmente una parte del sé. Perdere qualcuno equivale a perdersi, e qui torna Ernesto de Martino. Questo perché la nostra vita stessa è in funzione dell’altro, non può umanizzarsi senza la presenza dell’altro, come del resto aveva intuito già Aristotele quando osservava che l’uomo è un animale sociale: ullus homo, nullus homo.
Da qui – come dicevamo – l’importanza dei riti della sepoltura, presenti negli umani ma non nel mondo animale: un congedo simbolico del defunto da parte di chi resta ancora vivo che certamente non cancella il dolore della perdita, ma riconosce che la vita umana, diversamente da quella animale, ha necessità di essere ricordata per non morire definitivamente. Ed è per questo che Antigone sfida le leggi di Creonte per garantire la sepoltura al proprio fratello.
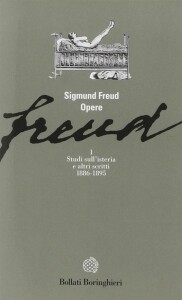 Freud si sofferma sull’esperienza del lutto come lavoro e come risposta al trauma della separazione in quanto tale, nel momento in cui può subentrare, in chi resta, una reazione depressiva che determina una stagnazione melanconica tendente a cronicizzarsi. In questo senso l’assenza dell’altro diventa paradossalmente una presenza ingombrante da cui non ci si può liberare, restando ancorati al passato. Questo avviene per Freud sia con l’eccessiva idealizzazione del defunto, una sorta di coazione a ricordare, sia con l’eccesso opposto, quello della de-idealizzazione, diffamazione e aggressività nei confronti del proprio familiare scomparso, l’altra faccia di uno stesso sentimento. Vi è infine la mania, altrettanto perturbante, quella che, cancellando ogni traccia dei legami affettivi, tende a rimuovere del tutto il dolore della perdita e a vivere nell’immediatezza del presente, in un edonismo sfrenato e senza limiti.
Freud si sofferma sull’esperienza del lutto come lavoro e come risposta al trauma della separazione in quanto tale, nel momento in cui può subentrare, in chi resta, una reazione depressiva che determina una stagnazione melanconica tendente a cronicizzarsi. In questo senso l’assenza dell’altro diventa paradossalmente una presenza ingombrante da cui non ci si può liberare, restando ancorati al passato. Questo avviene per Freud sia con l’eccessiva idealizzazione del defunto, una sorta di coazione a ricordare, sia con l’eccesso opposto, quello della de-idealizzazione, diffamazione e aggressività nei confronti del proprio familiare scomparso, l’altra faccia di uno stesso sentimento. Vi è infine la mania, altrettanto perturbante, quella che, cancellando ogni traccia dei legami affettivi, tende a rimuovere del tutto il dolore della perdita e a vivere nell’immediatezza del presente, in un edonismo sfrenato e senza limiti.
Il lavoro del lutto diviene a questo punto una terapia necessaria, che lentamente aiuta il soggetto melanconico a rientrare in sé e a liberarsi del peso della perdita, eliminando l’oggetto e spostando la propria libido verso nuove sfere di desiderio. Quando questa pulsione verso la vita riemerge, il lavoro del lutto può considerarsi concluso (Freud).
Su quest’ultimo punto Recalcati intravede una terza possibilità che è quella di considerare il lutto non un processo con un inizio e una fine, ma qualcosa di incompiuto, che non si esaurisce mai definitivamente. Questo perché, come diceva Sartre, la vita stessa è un viaggio senza ritorno e ogni aspettativa, ogni attesa è un’attesa del nulla, come avviene in Aspettando Godot di Samuel Beckett. Non diversamente dall’Ulisse omerico, l’eroe nostalgico per eccellenza, che non rimane mai appagato dal suo rientro a Itaca ma è costretto a rimettersi immediatamente in viaggio. Anche Abramo, da un altro punto di vista, esprime la medesima condizione: il suo è un viaggio senza ritorno verso la terra promessa.
La verità è, come sostiene Vito Teti (2020), che la nostalgia prescinde dall’attaccamento ai luoghi, al tempo o alle persone: è piuttosto una condizione esistenziale dell’uomo, che, in quanto homo nostalgicus, esprime in una tensione costante con l’Altrove. In questo senso il viaggio va inteso in senso metaforico come un perenne desiderio di spostarsi e questo avviene sia in chi parte, abbandonando le proprie radici, sia in chi resta in luoghi che non rimangono mai gli stessi. Si parla tanto di occasioni perdute, aspettative disattese: la nostalgia non è soltanto per quello che abbiamo lasciato indietro, ma anche per l’avvenire che ci attende. Anguilla e Nuto de La Luna e i falò di Cesare Pavese, i due vecchi amici che rivelano le due facce della nostalgia: partire e restare. Entrambi tormentati dallo stesso sentimento, dalla constatazione che niente può essere più come prima.
Due grandi opere d’arte installate sui luoghi delle catastrofi esprimono in modo eloquente questo sentimento dell’incompiuto: Reflecting Absence, di Michael Arad e Peter Walker, che ricorda, a futura memoria, l’attentato terroristico alle Torri gemelle del 2001 e il Cretto di Burri, sulle macerie del terremoto del Belice nel 1968. In entrambi i casi non vi è nessuna rimozione del dolore, nessun rigetto del lutto, ma il tentativo di elevare quell’orrore alla sublimazione del linguaggio artistico. Nel primo caso, di quelle grandi vasche che rievocano, incise sui bordi, i nomi delle vittime, il vuoto non è occultato, ma diviene il centro stesso dell’opera. Anche il Cretto di Burri a Gibellina che si erge sulle macerie della città distrutta, non vuole cancellare la drammaticità di quell’evento, ma avvolge le rovine elevandole a fatto estetico.
Non è forse questo il senso di ogni opera d’arte, quella di garantire l’eternità di fronte alla contingenza del divenire e al consumo inesorabile del tempo? Così come le nature morte di Giorgio Morandi che da un lato recano i segni del tempo attraverso la polvere che avvolge gli oggetti, ma, dall’altro, stanno come sospese nel vuoto, su un piano metastorico che garantisce loro l’eternità.
Sul rapporto passato presente si gioca allora un nuovo volto della nostalgia, che può essere anche una tensione verso l’incognita del futuro: è ancora Walter Benjamin a ricordare la figura dell’Angelo della storia, con le ali trascinate in avanti da un vento inesorabile, ma con lo sguardo di chi resiste e guarda indietro, sulle macerie del passato, non considerandole come reliquie, ma per riscattarne la sorte.
Con questa consapevolezza, che apre la strada a diverse prospettive, Recalcati esorta i suoi lettori a fare buon uso della memoria, considerandola non una semplice scatola di ricordi, ma piuttosto un dispositivo generatore di stimoli che, sull’esempio dei nostri Lari, ci lega al passato spingendoci avanti. Non si tratta solo di un antidoto per risanare quelle perdite che appaiono irreversibili, ma probabilmente è l’unico modo per sfuggire al consumo vorace del tempo, alla tirannia del presente che oggi rischia di travolgerci.
Dialoghi Mediterranei, n. 60, marzo 2023
Riferimenti bibliografici
Ariès, Philippe
1985 L’uomo e la morte dal Medioevo a oggi, Bari, Laterza
Benjamin, Walter
2006 Tesi di filosofia della storia, in Opere complete, vol. VII: Scritti 1938-1940, Torino, Einaudi
De Martino, Ernesto
1975 Morte e pianto rituale. Dal lamento funebre al pianto di Maria, Torino, Boringhieri
Freud, Sigmund
1980 Lutto e melanconia, in Opere (1917-1923), vol. VIII, a cura di C. Musatti, Torino, Bollati Boringhieri
Recalcati, Massimo
2022 La luce delle stelle morte. Saggio su lutto e nostalgia, Milano, Feltrinelli
Sartre, Jean Paul
1997 L’essere e il nulla. Saggio di ontologia fenomenologica, trad. it. Di G. del Bo, revisione a cura di F. Fergnani e M. Lazzari, Milano, il Saggiatore
Teti, Vito
2020 Nostalgia. Antropologia di un sentimento del presente, Bologna, Marietti
2022 La Restanza, Torino, Einaudi
______________________________________________________________
Orietta Sorgi, etnoantropologa, ha lavorato presso il Centro Regionale per il catalogo e la documentazione dei beni culturali, quale responsabile degli archivi sonori, audiovisivi, cartografici e fotogrammetrici. Dal 2003 al 2011 ha insegnato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo nel corso di laurea in Beni Demoetnoantropologici. Tra le sue recenti pubblicazioni la cura dei volumi: Mercati storici siciliani (2006); Sul filo del racconto. Gaspare Canino e Natale Meli nelle collezioni del Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino (2011); Gibellina e il Museo delle trame mediterranee (2015); La canzone siciliana a Palermo. Un’identità perduta (2015); Sicilia rurale. Memoria di una terra antica, con Salvatore Silvano Nigro (2017).
______________________________________________________________










