di Antonino Cusumano
Leggere e scrivere dopo l’esperienza pandemica sembrano essere diventate posture e pratiche in qualche modo mutate di segno e di senso. È come se l’attraversamento di questa totalizzante e drammatica prova di forte impatto fisico e psicologico abbia provocato l’implosione delle parole, la loro rovinosa destrutturazione. Di “crisi della parola” aveva già scritto in Vere presenze nel 1998 il grande critico George Steiner che aveva definito “il tempo dell’epilogo” (una parola che ospita il Logos) il nostro vivere immersi nel collasso dei significati, nella loro torsione ideologica, negli astratti giochi della decostruzione che hanno spezzato i legami tra parola e mondo. Non può che cominciare dunque dal linguaggio qualsiasi moto di riflessione critica e di rigenerazione culturale, dalla radice filogenetica del nostro essere nel mondo, dalla lingua cioè che unica ermeneutica della realtà «non conosce finitudine concettuale o proiettiva». Per usare ancora le acute osservazioni di Steiner,
«Al di sopra del minimo livello vegetativo, le nostre vite dipendono dalla nostra capacità di dire la speranza, di affidare alle subordinate ipotetiche e ai futuri i nostri sogni attivi di cambiamento, di progresso e di liberazione» (ivi: 64).
Nell’ansia di ripensare il nostro modo di abitare la terra e di riorganizzare lo sguardo sulla vita e sulla morte siamo impegnati a ridefinire o a invenire le parole nel duplice senso del verbo latino di ritrovare e di inventare. Ci aiuta in questo il latinista Ivano Dionigi che ha pubblicato una sorta di breviario di ecologia linguistica, Parole che allungano la vita (Raffaello Cortina 2020), per rimparare a nominare le cose del mondo, per oggettivare quanto accade attorno a noi e dentro di noi in questo nostro presente alieno, imprevedibile e inintelligibile.
«C’è un inganno, un’ipocrisia, una non-verità nelle nostre parole: scriviamo flessibilità ma i giovani leggono disoccupazione, usiamo l’eufemismo economia sommersa ma sappiamo bene che si tratta di lavoro nero, diciamo guerra preventiva ma gli interessati vivono un’aggressione; e mai fu parola più opaca della sbandierata trasparenza. Questa deriva e degenerazione di un linguaggio disossato e artificiale investe e sfigura parole che ritenevamo durature e universalmente condivise: la dignità ridotta a un decreto, la politica a un contratto, la pace a condono fiscale» (ivi: 38).
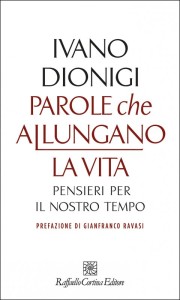 Il bisogno da tempo avvertito di ritrovare le parole e riconnetterle alle cose è oggi diventato esigenza primaria, pregiudiziale, un’emergenza esistenziale, dopo che abbiamo conosciuto da un lato la negazione dei riti civili e sociali, la cancellazione degli abbracci, la dissimulazione dei sorrisi dietro la mascherina, l’evaporazione delle relazioni, e dall’altro il profluvio della comunicazione virtuale, l’uso smodato dei social, il trionfo delle tecnologie digitali, la palingenesi del lavoro a distanza. Tornare a rifondare l’alfabeto per rinnovare il lessico e ricongiungere significati concreti a significanti precisi è come riannodare il filo spezzato che lega la memoria al futuro, i trapassati ai nascituri, è come ritornare alla Genesi dopo l’Apocalisse, perché generare nuova vita a vocaboli, lemmi, discorsi equivale a risemantizzare la realtà, costruire nuovi immaginari, progettare società nuove.
Il bisogno da tempo avvertito di ritrovare le parole e riconnetterle alle cose è oggi diventato esigenza primaria, pregiudiziale, un’emergenza esistenziale, dopo che abbiamo conosciuto da un lato la negazione dei riti civili e sociali, la cancellazione degli abbracci, la dissimulazione dei sorrisi dietro la mascherina, l’evaporazione delle relazioni, e dall’altro il profluvio della comunicazione virtuale, l’uso smodato dei social, il trionfo delle tecnologie digitali, la palingenesi del lavoro a distanza. Tornare a rifondare l’alfabeto per rinnovare il lessico e ricongiungere significati concreti a significanti precisi è come riannodare il filo spezzato che lega la memoria al futuro, i trapassati ai nascituri, è come ritornare alla Genesi dopo l’Apocalisse, perché generare nuova vita a vocaboli, lemmi, discorsi equivale a risemantizzare la realtà, costruire nuovi immaginari, progettare società nuove.
Probabilmente per questo si sono recentemente moltiplicate iniziative editoriali che hanno pubblicato lemmari e dizionari della pandemia, raccolte di voci, testimonianze, racconti che attorno a parole chiave articolano idee, ragionamenti e dibattiti sull’impatto sociale ed esperienziale dell’epidemia e sugli orizzonti culturali che si dispiegano oltre la crisi, per il dopo Covid 19. Così è anche per il Manifesto per riabitare l’Italia, un’opera a cura di Domenico Cersosimo e Carmine Donzelli, da poco edita dalla Donzelli, un ideale sillabario che mette in primo piano la questione territoriale nel nostro fragile e frammentario Paese. Da qui la necessità non solo di risalire alle sorgenti della lingua per riscoprire il senso dei luoghi ma anche di invertire lo sguardo, di modificare posture intellettuali e traiettorie investigative, di spostare l’attenzione dal centro ai margini, e da qui ricomporre e riaggregare un’immagine più compiuta ed equilibrata dell’Italia e delle sue mille contrade, dell’«itala gente e delle sue molte vite».
Di questi temi, di queste istanze (coscienza del luogo, invertire lo sguardo) aveva già cominciato a scrivere Pietro Clemente giusto tre anni fa, nel settembre 2017, quando sulle pagine di questa rivista inaugurò lo spazio significativamente intitolato “Il centro in periferia” che da allora ad oggi raccoglie documenti, studi, narrazioni e testimonianze intorno a quell’idea dell’Italia «Paese di paesi», come l’autore l’aveva felicemente definita negli anni novanta del secolo scorso.
«“Porre il centro in periferia invece di sviluppare il periferico a partire dal centro” è esattamente l’idea che ci tiene in rete e che capovolge la tendenza della modernità, in cui i centri trascinano le periferie nella uniformità. Oggi invece è tempo che siano le periferie a definire nuove centralità basate sulle differenze e si facciano carico dell’immenso e titanico impegno di far voltare indietro lo sguardo delle grandi città. In altre parole una idea nuova di civiltà complessiva non può che nascere dai luoghi piccoli perché in essi sono visibili e riprogettabili i nessi che fondano la civiltà, le relazioni sociali e quelle con la natura».
Così Pietro Clemente nel n. 27 di Dialoghi Mediterranei, una sorta di Manifesto che è perfettamente consonante con quello oggi elaborato da Cersosimo e Donzelli, il cui obiettivo è quello «di aprire una grande discussione intellettuale, civile e politica, sui modi con cui si può riabitare l’Italia, ripensare le forme stesse dell’insediamento, della mobilità, del rapporto con l’ambiente e con la salute, del lavoro, della qualità della vita», muovendo dalla consapevolezza che «ci sono tante Italie nell’Italia. Non si tratta di contrapporle le une alle altre. Si tratta di ricomprenderle tutte, fino ad includere gli stessi margini del centro, le periferie metropolitane che misurano assai spesso una lontananza dai centri ben più radicale di quanto non dica la distanza fisica», perché l’Italia «dimenticata, marginalizzata, è tutt’altro che residuale».
Parole e concetti che ripropongono una questione che la pandemia ha epifanicamente disvelato in tutta la sua drammaticità, denunciando gli squilibri, le vulnerabilità, le criticità di un territorio diseguale nella morfologia ma anche e soprattutto nella demografia, nell’economia, nella disponibilità di infrastrutture e di servizi. Non più due o tre Italie secondo schemi d’interpretazione resi obsoleti dalla globalizzazione e dall’evoluzione di geografie e mappe non più corrispondenti alle rappresentazioni del passato. Da un lato la crisi del modello metropolitano, della sua egemonia, della sua bulimia, dall’altro l’anoressico disseccamento dei piccoli paesi, la spoliazione delle vite e delle presenze umane, il crescente vuoto degli insediamenti ai margini delle concentrazioni ipertrofiche dei grandi centri intasati, atrofizzati, incapaci di aggregare e integrare, non più in grado di sostenere una funzione direzionale e «di legittimare il loro ruolo trainante per l’intero sistema delle economie, delle relazioni sociali, dei valori simbolici».
Al primo punto del Manifesto è richiamata la terribile prova che nel campo sanitario ha recentemente e palesemente dimostrato la debolezza dei presidi di medicina territoriale e l’insostenibilità dei grandi ospedali specializzati destinati a soccombere «di fronte alla virulenza dello shock esogeno». È il collasso del paradigma novecentesco che celebrava in una sorta di narrazione teleologica lo sviluppo lineare e progressivo, l’eccellenza dei poli urbani autocentrati, la unidirezionalità della crescita e dell’espansione illimitate. È la certificazione che il sistema asimmetrico e disarticolato che ha governato la politica e l’uso pubblico del territorio ha esaurito la sua spinta propulsiva, ha prodotto strappi e lacerazioni nel tessuto sociale e civile, dismissioni di servizi e di attività produttive e sconnessioni sempre più profonde tra città e campagne, tra istituzioni centrali e luoghi periferici, e financo tra rappresentanti e rappresentati. Da qui, negli oscuri meandri dell’Italia più marginalizzata possono incubare i risentimenti alimentati da certo populismo, il disprezzo per le élite tecnocratiche, l’insorgere di pericolose derive autoritarie.
 Nel decalogo del Manifesto, che è frutto di un serrato confronto tra università, centri di ricerca e associazioni, non si persegue un anacronistico e ingenuo localismo ma si progetta un ambizioso processo democratico che investe e impegna una visione nazionale, la costruzione di reti sostenute da coscienze dei luoghi e cittadinanze attive, dal protagonismo di nuove soggettività e nuove prospettive affrancate dal rigido e meccanico dualismo: egemonia/subalternità. Non più riconducibile a questa dimensione gerarchica è quell’Italia cosiddetta minore ma certo non minoritaria che «produce già da anni stimoli alternativi, fantasie d’impresa», innovazioni culturali nelle tradizioni e nelle memorie, originali esperienze di socializzazione del patrimonio, di valorizzazione delle risorse e di condivisione dei beni. Muove da questi margini vivi e vitali, dai paesi resilienti e resistenti, dalle province che conservano autonomie e individualità, dalle comunità che sperimentano economie circolari e rigenerazione delle relazioni pubblico/privato, muove da queste realtà dinamiche il recupero dei saperi locali, di certo welfare di prossimità, di fondamentali princìpi di coesione e di sussidiarità orizzontale, la sfida a contrastare spopolamento e depauperamento, abbandoni e disuguaglianze, omologazione culturale e disgregazione sociale attraverso alleanze intergenerazionali e forme di mutualità che mettono insieme mercato ed etica, interessi individuali e solidarietà collettive, nuovi modi di lavorare, di investire e di produrre, di abitare e di vivere.
Nel decalogo del Manifesto, che è frutto di un serrato confronto tra università, centri di ricerca e associazioni, non si persegue un anacronistico e ingenuo localismo ma si progetta un ambizioso processo democratico che investe e impegna una visione nazionale, la costruzione di reti sostenute da coscienze dei luoghi e cittadinanze attive, dal protagonismo di nuove soggettività e nuove prospettive affrancate dal rigido e meccanico dualismo: egemonia/subalternità. Non più riconducibile a questa dimensione gerarchica è quell’Italia cosiddetta minore ma certo non minoritaria che «produce già da anni stimoli alternativi, fantasie d’impresa», innovazioni culturali nelle tradizioni e nelle memorie, originali esperienze di socializzazione del patrimonio, di valorizzazione delle risorse e di condivisione dei beni. Muove da questi margini vivi e vitali, dai paesi resilienti e resistenti, dalle province che conservano autonomie e individualità, dalle comunità che sperimentano economie circolari e rigenerazione delle relazioni pubblico/privato, muove da queste realtà dinamiche il recupero dei saperi locali, di certo welfare di prossimità, di fondamentali princìpi di coesione e di sussidiarità orizzontale, la sfida a contrastare spopolamento e depauperamento, abbandoni e disuguaglianze, omologazione culturale e disgregazione sociale attraverso alleanze intergenerazionali e forme di mutualità che mettono insieme mercato ed etica, interessi individuali e solidarietà collettive, nuovi modi di lavorare, di investire e di produrre, di abitare e di vivere.
Al testo del Manifesto si accompagnano cinque interventi di studiosi di diverse discipline e competenze, così da contestualizzarne i contenuti dal punto di vista geografico (Pasqui), economico (Viesti), sociologico (Sciarrone), politico (Urbinati) e artistico (Montanari). Connessioni è il leitmotiv delle pagine che incrociano nel dibattito sguardi diversi ma sembrano ritrovarsi nell’idea comune di un progetto di relazioni che unisce quanto è attualmente frammentato tra aree interne e città, tra periferie metropolitane e piccoli paesi, tra coste e valli, tra flussi globali e comunità locali. Nessuna presunta autosufficienza può salvare dal declino i luoghi la cui interdipendenza ne segna inevitabilmente i destini. Sciarrone critica il centralismo delle Regioni; Urbinati individua nella crisi delle rappresentanze politiche una delle cause del degrado della vita locale come «vita civile partecipata»; Pasqui sottolinea il valore della diversità come tratto costitutivo del nostro Paese e presupposto ineludibile delle “alleanze” da costruire; Viesti scrive delle risorse esogene e endogene che necessariamente associate e variamente combinate contribuiscono allo sviluppo umano, sociale ed economico dei territori; Montanari infine si richiama alla densità storica e culturale che ogni piccolo luogo d’Italia conserva e custodisce, così che ogni paese è intreccio di vite e di memorie, dove «tutto è avvenuto, tutto è nel presente. Ogni albero, ogni roccia, ogni fontana contiene dentro di sé gli dèi più antichi. L’aria e la terra ne sono impastate e intrise. Con gli dèi, gli uomini e i loro fatti: sui selciati delle strade, sugli asfalti delle automobili, risuona l’eco di passi innumerevoli»: sono parole di Carlo Levi citate da Montanari che, per rimarcare il valore civico consegnato nei nessi essenziali tra democrazia e spazio pubblico, risale alle esperienze politiche dell’Italia comunale, delle cui virtù non si può forse dire meglio di quanto ha scritto Carlo Dionisotti a proposito di:
«quell’Italia municipale, non regionale, che è esistita per secoli, indomita, troppo vigorosa e aspra per essere selvaticamente paga di sé, per potersi chiudere nel suo guscio, ma troppo anche per accettare una docile subordinazione politica o letteraria alla regione, o alla nazione» (1970: 133).
Tutti, nell’elogiare la dimensione locale – mai localistica – dove vivono gli uomini e da dove si rapportano al “mondo largo”, sentono il bisogno di sfuggire alle dicotomie usuali modernità/tradizione, urbano/rurale, pianura/montagna e indicano vie nuove e composite progettate sulla compresenza delle diversità, sulla forza della interazione dei fattori e della complementarietà delle funzioni. Anche nelle 28 voci in cui si articola il corpo del libro, la sua parte più cospicua, sono ribadite le ragioni della decentralizzazione sociale e urbanistica, non solo come argine a future crisi sistemiche ma anche come stile di vita, riequilibrio demografico, recupero di quel Capitale quotidiano che, come scrive Angelo Salento, «garantisce stabilità e perequazione (…), l’indispensabile presupposto della connessione, della coesione, dell’affiliazione sociale e politica». A lungo privatizzazioni e tagli lineari hanno rarefatto l’accessibilità ai beni e servizi essenziali soprattutto nelle aree marginali dove scuole, uffici postali, presidi sanitari, stazioni e piccole filiere economiche sono stati cancellati sulla base di approcci aziendalisti ai rapporti tra costi e opportunità. Ne è derivato anche il rovinoso sfaldarsi di quella capillare rete di insediamenti sparsi e infrastrutturali che assicurava la manutenzione del territorio nel governo di canali, boschi, tratturi e terrazzamenti.
Da Abbandoni a Terra le 28 parole chiavi affidate ad altrettanti autori descrivono una costellazione di temi che gravitano attorno al documento programmatico del Manifesto e ne scandagliano gli aspetti storici, i risvolti concettuali, le inferenze politiche, le ripercussioni spaziali, le prospettive oltre l’orizzonte del virus. Attraversa i diversi contributi un pensiero nuovo, radicale e pragmatico: la convinzione che dalla crisi non si può uscire se non superando i confini del sistema entro il quale siamo abituati a ragionare, l’invito a connettere e mettere in tensione lo sguardo sul mondo e l’attenzione ai luoghi, la spinta all’innovazione tecnologica da un lato, e la memoria di quei saperi tradizionali che si risolvono nella cura ambientale, nel valore della cooperazione, nella tenuta della comunità, dall’altro lato. Voci del Dizionario che assimilano l’innovatore al «tipo mertoniano del ribelle» (Barbera); la cura ad una battaglia contro le disuguaglianze e le storture territoriali (Costa); la cooperazione ad un modello culturale eminentemente pedagogico, orientato alla «condivisione di un destino in un contesto fisico limitato» (Teneggi); la comunità infine ad un mondo in cui il welfare è considerato un investimento, il diritto di cittadinanza esteso a tutti gli abitanti che «condividono l’intuizione che anche e soprattutto nelle aree interne, per fare economia, bisogna fare società», costruite sui desideri piuttosto che sui bisogni (Tantillo).
In questo alfabeto ci sono parole come Accessibilità, Acqua, Boschi, Cambiamento climatico, Montagne, Resilienza, Risorse, Terra che nel richiamare le sempre più precarie condizioni di vivibilità mettono in relazione i mutamenti degli habitat naturali con le fratture economiche e sociali, le dolorose faglie prodotte dagli esodi, la marginalizzazione delle aziende contadine di piccola scala, il depauperamento dei beni pubblici. Tuttavia nelle stesse pagine si segnalano anche le incoraggianti sperimentazioni dal basso che vedono negli ultimi anni i giovani avvicinarsi all’agricoltura, «i neorurali, che con le loro scelte di vita e di lavoro sfidano la rigida e miope logica economicista, intraprendendo percorsi produttivi con approcci e sguardi olistici» (Corrado-Ebbreo), i “ritornanti” o “nuovi montanari” che «trovano nei patrimoni montani le occasioni per fare impresa» (Dematteis). Segni di un’inversione di tendenza, della lenta maturazione di un diverso ‘senso comune’ del lavorare, del consumare, del vivere. Processo a cui può contribuire la Scuola (Luisi-Renzoni), «la più diffusa e capillare infrastruttura collettiva del Paese», «baricentro di un possibile progetto di rigenerazione che possa rispondere a domande di qualità dell’abitare e della vita quotidiana», una scuola che nella ridefinizione dei suoi spazi, e con una politica di analisi e ascolto dei luoghi, può recuperare «un’idea sociale e una visione cooperativa dell’educare».
Altre voci approfondiscono le Fragilità territoriali (Lanzani), da quelle demografiche a quelle ambientali, socioeconomiche e infrastrutturali; le Disuguaglianze (Nisticò), che determinano asimmetrie di opportunità e di accesso ai servizi acutizzate dagli effetti dello shock esogeno; le Politiche (Lucatelli), fin qui poco attente a quelle aree interne del nostro Paese dove pur vive quasi un quarto della popolazione italiana. Di grande interesse sono le riflessioni sui concetti cardinali che ispirano il progetto del Manifesto. Uno dei due curatori, Domenico Cersosimo, chiarisce che i Luoghi, «scomparsi dalla narrazione dominante da circa un ventennio, ben prima del coronavirus», sacrificati dai processi di standardizzazione e deterritorializzazione, non sono nonostante tutto diventati «piattamente equipotenziali, inanimati, vuoti di attori e di capacità distintive». L’autore rimarca la personalità di ciascun luogo nella consapevolezza che «continuiamo ad abitare un mondo curvo, rugoso, disuguale, e in luoghi, ognuno con le proprie dotazioni e connotazioni di vulnerabilità e resilienza». La loro vita dipende dalle reti formali e informali che gli abitanti costruiscono giorno dopo giorno. Carmine Donzelli, l’altro curatore del volume, si occupa invece dei Margini che «non esistono in natura, al pari dei centri; sono piuttosto il frutto di processi storici di esclusione, di marginalizzazione», infelice esito di «incurie, disattenzioni, trascuratezze». Di Confini scrive Fabrizio Barca che da Ministro della coesione fu promotore della Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne (SNAI) e, nel disegnare la mappa dell’Italia che verrà, tra federalisti e antifederalisti propone una terza via, «una visione comune di area», ovvero «cosa vorremmo essere, di cosa vorremmo e potremo vivere, fra venti-trenta anni», un confronto in cui siano presenti e attivi, «oltre alle diversità interne, tutti i punti di vista esterni rilevanti: quello dello Stato e delle Regioni che guidano (assieme) la politica; quello dei centri di competenza delle imprese private e sociali; e ancora della cultura nazionale, universitaria e creativa».
A rimettere al centro le aree marginali del Paese hanno partecipato i Migranti (Membretti), il cui insediamento pari a oltre un milione e mezzo di presenze ha rappresentato «un’occasione di rilancio delle micro-economie territoriali, di resilienza, di ringiovanimento della popolazione, di innovazione sociale». D’altra parte, «il virus ci ha insegnato – osserva Vito Teti che ha firmato la voce Paese – che ogni luogo può essere periferia o centro del mondo; che la nostalgia può essere rivolta in avanti e non all’indietro. I luoghi, i paesi, i centri storici, le città, le periferie non potranno rinascere se non si inventa una nuova idea dell’abitare e della rigenerazione, se non si ristabilisce un rapporto con la terra, il paesaggio, il mondo animale, i luoghi della produzione, le persone». La parola Persone è attentamente illustrata da Pietro Clemente che nel fare la storia del concetto occidentale alla luce dell’immagine antropologica – plurale, mutevole, sociale – la riscatta dall’astrattezza del soggetto individuale e la «mette con i piedi per terra» ovvero la riconnette in consustanziale continuità con i luoghi, «dove si può sperimentare un’idea equilibrata, dinamica, relazionale di persona e qualche nucleo di una forma culturale nuova ma legata alla dimensione più antica della terra». Anche per Antonio De Rossi e Laura Mascino, coautori di due tra i lemmi più significativi del Dizionario, Patrimonio e Rigenerazione, alla progettazione del futuro del nostro Paese concorre la memoria del nostro passato, la riscoperta di tradizioni e culture materiali, beni patrimoniali che vanno tuttavia sostenuti da processi di rigenerazione: «la ricostruzione di economie locali, l’innovazione a base culturale, la riformulazione del welfare, i processi di riuso del patrimonio, i temi energetici e le pratiche virtuose, l’agricoltura sociale, la partecipazione dei cittadini, le pratiche di gestione condivisa dei beni, le nuove forme di partnership pubblico-privato, ecc.».
 Nel restituire in una sintesi inevitabilmente approssimativa il fil rouge che unisce le 28 voci in appendice al Manifesto per riabitare l’Italia, si rende visibile il carattere sostantivo di questo libro che in tutta evidenza non è soltanto una raccolta, se pure importante, di pagine, di studi attenti e acute riflessioni ma è corpo di un progetto concreto, proposta empirica e pragmatica, laboratorio di idee e di appelli. Un prontuario o vademecum complementare ed esito naturale dell’altro libro, Riabitare l’Italia, edito appena due anni fa dalla stessa Donzelli a cura di Antonio De Rossi. Due testi che nella loro consustanzialità progettuale dialogano all’interno di un unico ragionamento, di una immagine del nostro Paese da rifondare, da ricostruire ribaltando l’ordine convenzionale del guardare e del pensare, mettendo al centro quei piccoli paesi delle aree interne che costituiscono l’orditura della trama rizomatica dell’Italia plurale dai mille campanili. Tanto più che nella sfida contro la pandemia alcune di queste comunità sono rimaste indenni dal contagio, potendo contare non solo sull’isolamento fisico ma anche su volontariato e associazionismo, su una governance di prossimità e di mutualità nella gestione dell’emergenza sanitaria, pur pagando il prezzo della grave deficienza sul piano delle infrastrutture tecnologiche e delle reti digitali.
Nel restituire in una sintesi inevitabilmente approssimativa il fil rouge che unisce le 28 voci in appendice al Manifesto per riabitare l’Italia, si rende visibile il carattere sostantivo di questo libro che in tutta evidenza non è soltanto una raccolta, se pure importante, di pagine, di studi attenti e acute riflessioni ma è corpo di un progetto concreto, proposta empirica e pragmatica, laboratorio di idee e di appelli. Un prontuario o vademecum complementare ed esito naturale dell’altro libro, Riabitare l’Italia, edito appena due anni fa dalla stessa Donzelli a cura di Antonio De Rossi. Due testi che nella loro consustanzialità progettuale dialogano all’interno di un unico ragionamento, di una immagine del nostro Paese da rifondare, da ricostruire ribaltando l’ordine convenzionale del guardare e del pensare, mettendo al centro quei piccoli paesi delle aree interne che costituiscono l’orditura della trama rizomatica dell’Italia plurale dai mille campanili. Tanto più che nella sfida contro la pandemia alcune di queste comunità sono rimaste indenni dal contagio, potendo contare non solo sull’isolamento fisico ma anche su volontariato e associazionismo, su una governance di prossimità e di mutualità nella gestione dell’emergenza sanitaria, pur pagando il prezzo della grave deficienza sul piano delle infrastrutture tecnologiche e delle reti digitali.
Un patto tra questa Italia dei margini e il resto del territorio nazionale potrebbe forse innescare quella ricomposizione materiale e culturale auspicata per uno sviluppo sostenibile che tiene insieme centri e periferie, Nord e Sud, pianure e montagne. Perché, a guardar bene, l’Italia resterebbe un Paese inintelligibile e inimmaginabile se non provassimo a leggerlo e a studiarlo all’interno della dimensione policentrica della sua identità, ovvero nell’orizzonte delle specificità e individualità regionali, nel contesto del frastagliato panorama delle peculiarità urbane e provinciali. Anche il più piccolo centro della più lontana periferia, pur costretto ai margini dei luoghi istituzionali e decisionali del potere, non è mai rimasto, infatti, completamente estraneo alle vicende culturali nazionali, partecipando in forme e modi originali alla formazione della coscienza collettiva del nostro essere e sentirci italiani. Così che l’immagine più vera e persuasiva del nostro Paese può essere disegnata solo a partire dalla pluralità degli apporti municipali, in considerazione delle diverse particolarità locali, delle molteplici articolazioni territoriali, della straordinaria varietà degli usi, dei costumi, delle tradizioni e delle lingue. Di quel patchwork screziato che rende unica e inconfondibile l’Italia.
 Se l’idea della nazione stenta ancora a diventare senso comune dal momento che probabilmente la diffusione della sua consapevolezza appare debole e precaria, per effetto dei ritardi nella genesi dell’unità politica e amministrativa non meno che delle controverse vicende della sua gestione, la percezione del sentimento di cittadinanza in forza del quale non ci è indifferente il luogo che abitiamo è sostanzialmente fondata e radicata sulla ricchezza delle differenze di città e province, su quel delicato tessuto connettivo alimentato da simboli e memorie che unisce la Penisola, da Aosta a Trapani. Dentro questa storia nazionale complessa e stratificata la provincia non è sempre e comunque periferia, non sottintende nella dialettica con il centro un rapporto di diretta e mera subalternità. Lo sostiene lo storico Giuseppe Galasso:
Se l’idea della nazione stenta ancora a diventare senso comune dal momento che probabilmente la diffusione della sua consapevolezza appare debole e precaria, per effetto dei ritardi nella genesi dell’unità politica e amministrativa non meno che delle controverse vicende della sua gestione, la percezione del sentimento di cittadinanza in forza del quale non ci è indifferente il luogo che abitiamo è sostanzialmente fondata e radicata sulla ricchezza delle differenze di città e province, su quel delicato tessuto connettivo alimentato da simboli e memorie che unisce la Penisola, da Aosta a Trapani. Dentro questa storia nazionale complessa e stratificata la provincia non è sempre e comunque periferia, non sottintende nella dialettica con il centro un rapporto di diretta e mera subalternità. Lo sostiene lo storico Giuseppe Galasso:
«Sia in economia che nella vita culturale il rapporto tra centro e periferia non è determinabile soltanto come una condizione di pura e semplice dipendenza. Accanto alla dipendenza, al di là di essa, c’è la vita della periferia, con le sue proprie specifiche ragioni distintive e caratterizzanti (…). È vero che la provincia è sempre e dappertutto la provincia, ma, nello stesso tempo, ogni provincia ha i suoi caratteri originali e le sue specificità» (1985: VII, XIII).
Lo ribadisce il critico letterario Alberto Asor Rosa:
«Occorre tener presente che in Italia la “provincia” è una dimensione non trascurabile dell’operare culturale: anche quando non produce essa direttamente, costringe chiunque a tenerne conto. E provincia non vuol dire, esclusivamente, una certa dislocazione geografica (anche se pure questo elemento non è assente): vuol dire, soprattutto, un certo tipo di corrispondenza tra cultura e Paese reale, fra intellettuali e società, che si sforza di registrare più fedelmente, in un certo senso, ciò che l’Italia è al di là delle prospezioni dei gruppi intellettuali evoluti» (1975:1072).
Che tra la città e la provincia si dispiega una intensa e feconda dialettica di corrispondenze e contraddizioni, di consonanze e discordanze, di simmetrie e disarmonie, componenti fondamentali della trama unitaria del complessivo quadro della storia culturale nazionale, era fermo convincimento anche di Leonardo Sciascia che a proposito della vita in provincia così ha scritto:
«Provincialismo non è il vivere in provincia e il fare della provincia oggetto di rappresentazione: provincialismo è il serrarsi nella provincia con appagamento, con soddisfazione, considerandone inamovibili e impareggiabili i modi di essere, le regole, i comportamenti; e senza mai guardare a quel che fuori della provincia accade, senza riceverne avvertimenti, stimoli, provocazioni al pensare feconde, alla visione della realtà fermentanti. A Roma, a Milano, a Parigi, e scrivendone, e tentando di darne rappresentazione, si può essere tanto più provinciali che in un paese della Sardegna, della Sicilia, del Friuli» (1989: 111).
L’idea di provincia è dunque in Sciascia assai lontana – almeno dal punto di vista intellettuale – da quel mondo respinto ai margini dall’accidia e dall’angustia della preclusione, vocato al rancore e al risentimento. Sembra essere invece vicina a quella rappresentazione offerta dal Manifesto che racconta delle tante Italie «mescolate in ogni luogo che si riconfigurano dinamicamente, incessantemente» e guarda ai paesi come archivi di vita ancora preziosa, custodi del senso e del sentimento di comunità, depositi della ricchezza simbiotica di natura e cultura, di quel palinsesto patrimoniale che conserva i valori simbolici inscritti nella storia del territorio.
«Scegliere il paese oggi – ha esemplarmente chiarito Pietro Clemente (1997: 39) – non significa trovare le vere radici emiche pure e antiche, ma costruire una nuova relazionalità, e riconoscersi nei propri antenati. Forse il paese è concetto nostro, italiano, di una società multiforme, paesana e cittadina, dallo Stato debole e dalla periferia resistente, in cui l’unità è raggiunta davvero quando – senza scandalo – si può dire che essere italiani è appartenere a un Paese fatto essenzialmente di paesi».
Se questo è vero sul piano culturale non può non essere vero anche nelle strategie e nelle prospettive politiche che, mobilitate per riabitare l’Italia, non possono non contemplare – come ha scritto Nadia Urbinati nel Manifesto – «una visione di rinascita della vita ‘locale’ come vita civile partecipata e della rigenerazione della rappresentanza politica nazionale». Parole che nel tempo confuso della pandemia, nel buio della dittatura del presente, valgono a indicare un orizzonte, una speranza, una qualche idea di futuro possibile.
Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020
Riferimenti bibliografici
A. Asor Rosa, 1975, La cultura, in Storia d’Italia, vol. IV, Einaudi Torino.
D. Cersosimo, C. Donzelli, 2000, Manifesto per riabitare l’Italia, Donzelli, Roma.
P. Clemente, 1997, Paese/Paesi, in M. Isnenghi (a cura), I luoghi della memoria. Strutture ed eventi dell’Italia unita, Laterza Bari-Roma: 5-39.
P. Clemente, 2017, Piccoli paesi decrescono. Una rete per una battaglia di generazione, in “Dialoghi Mediterranei”, n. 27, settembre.
A. De Rossi, 2018, Riabitare l’Italia. Le aree interne tra abbandoni e riconquiste, Donzelli, Roma.
I. Dionigi, 2000, Parole che allungano la vita, Raffaello Cortina, Milano.
C. Dionisotti, 1970, Culture regionali e letteratura nazionale in Italia, in “Lettere italiane”, XXII, aprile-giugno: 133-43.
G. Galasso, 1985, Introduzione a M. G. Chiodo, Intellettuali in provincia, Guida Napoli: VII-XIII.
C. Levi, 1964, Un volto che ci somiglia. Ritratto dell’Italia, Einaudi, Torino.
L. Sciascia, 1989, Fatti diversi di storia letteraria e civile, Sellerio, Palermo.
G. Steiner, 1998, Vere presenze, Bompiani, Milano.
_____________________________________________________________
Antonino Cusumano, ha insegnato nel corso di laurea in Beni Demoetnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo. La sua pubblicazione, Il ritorno infelice, edita da Sellerio nel 1976, rappresenta la prima indagine condotta in Sicilia sull’immigrazione straniera. Sullo stesso argomento ha scritto un rapporto edito dal Cresm nel 2000, Cittadini senza cittadinanza, nonché numerosi altri saggi e articoli su riviste specializzate e volumi collettanei. Ha dedicato particolare attenzione anche ai temi dell’arte popolare, della cultura materiale e della museografia. È autore di diversi studi. Nel 2015 ha curato un libro-intervista ad Antonino Buttitta, Orizzonti della memoria (De Lorenzo editore). La sua ultima pubblicazione, Per fili e per segni. Un percorso di ricerca, è stata edita dal Museo Pasqualino di Palermo (2020).
______________________________________________________________









