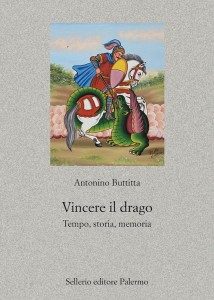Ho avuto l’occasione di discutere, assieme a Pietro Clemente, nel corso del Seminario Parole chiave su Folklore, Demologia, Cultura popolare, Tradizioni contadine, tenutosi presso l’Università “Sapienza” di Roma, ideato e diretto da Antonello Ricci, il testo Ideologie e Folklore di Antonino Buttitta [1]. Ciò avveniva nell’aprile del 2017, due mesi dopo la scomparsa dell’autore, che avrebbe dovuto essere presente, come tutti ci aspettavamo, avendolo per altro molti colleghi e amici recentemente incontrato di persona (e salutato per l’ultima volta, senza saperlo), nel convegno su Giuseppe Pitrè e Salvatore Salomone Marino, da lui organizzato a Palermo agli inizi di febbraio) [2]. Quella che doveva essere anche un’occasione di confronto diretto con Buttitta, si trasformò, così, in un ricordo commosso, sia da parte mia che di Clemente, che ci impegnammo, tuttavia, nel tentativo di collocare nella giusta prospettiva storiografica e critica, con concreto riferimento anche al presente che la disciplina andava attraversando, il libro [3].
Un libro che, stando a una dichiarazione del suo autore, rilasciata nel corso di una conversazione con Antonino Cusumano pubblicata nel 2015, egli vedeva come «una rassegna di studi in cui è ancora prevalente la tradizione accademica della disciplina, anche se sono anticipati temi e orientamenti nuovi» [4]. Lo stesso Clemente ritenne giusto riportare nel Seminario l’opinione dello studioso (forse severa con sé stesso, ma non del tutto fuori luogo), accompagnandola con una frase: «con lo sguardo di poi, Buttitta non riconobbe quel libro come caratterizzante il suo percorso, se non come tappa» [5]. In realtà sia io che Clemente, sia pur con accenti differenti, riconoscevamo nel libro molto di più di quanto l’autore stesso, poco tempo prima, sembrava intenzionato a riconoscere. Personalmente, anche sulla base di un’analisi comparativa con alcuni significativi studi coevi, pur evidenziandone alcuni limiti, soprattutto rispetto alla sua possibilità di proiettarsi nel futuro, di essere utilmente letto nelle assai mutate condizioni dell’antropologia nazionale del nuovo secolo, lo consideravo (mi si perdoni l’autocitazione) «un’opera riassuntiva rispetto a un percorso già svolto […], ma anche un’opera seminale, in cui vengono enunciati interessi e tracciati indirizzi che saranno poi perseguiti negli anni a venire. Nella produzione dell’autore, un libro crocevia o forse, più precisamente, un libro ponte (tra passato e futuro)»[6].
Se mi sono soffermato su questa circostanza è perché, iniziando la lettura del libro che qui presento, Vincere il drago. Tempo, storia, memoria (Palermo, Sellerio, 2022, a cura di E. Buttitta, prefazione di A. Cusumano), al termine dell’introduzione, ho visto evocato dall’autore, tra altri, il libro di cui nel Seminario ci eravamo occupati. Scrive Buttitta: «i problemi posti e le risposte indicate in questo volume sono la filigrana dei miei scritti; in particolare, Ideologie e folklore (1971), Semiotica e antropologia (1979), L’effimero sfavillio (1995), Dei segni e dei miti (1996)». Mi sembra molto significativo, e in qualche misura introduttivo rispetto all’analisi che effettuerò, il mutamento di prospettiva dell’autore. Perché l’opera di oggi rinvia, in effetti, a mio parere, a quella di oltre cinquanta anni fa, con un avvertibile segno di continuità, indicando un’esemplare coerenza di percorso. E tale coerenza ha comportato il riconoscimento (sia pur tardo, ma si sa che è possibile comprendere soltanto verso la fine, voltandoci indietro, il cammino che abbiamo effettuato), da parte dell’autore, di alcuni punti nodali, di alcuni temi e problemi cardine che hanno caratterizzato in modo diuturno la propria esperienza di ricerca e riflessione.
Sul piano critico, per Buttitta sembra valere quanto egli scrive a proposito della cultura siciliana nel suo complesso, risultato di molteplici accrescimenti che non cancellano ciò che è sotto o prima, ma vanno a sommarvisi; la sua cultura e la sua prospettiva teorica restano sostanzialmente immutate, malgrado le ulteriori cospicue sedimentazioni che nel corso del tempo vanno aggiungendosi e stratificandosi, malgrado gli arricchimenti susseguitisi.
Vincere il drago, un dispositivo testimoniale e testamentale (tornerò in chiusura su questa mia definizione), è una raccolta saggistica composita e di notevole complessità. In alcuni saggi, come a esempio in quello intitolato L’identità della Sicilia, si sente marcatamente il tono dell’occasione che lo ha motivato; in altri s’intravedono gli obbiettivi prossimi che li hanno mossi; in altri ancora la narrazione si disancora dall’occasione contingente e meglio si segue allora la traccia dialogica dallo studioso perseguita (quella che lo ha unito, a esempio, agli scrittori, a Leonardo Sciascia, a Ignazio Buttitta e ai più lontani maestri di costante riferimento, tra i quali Jorge Luis Borges), con un notevole arricchimento della possibilità di lettura e interpretazione di pagine non sempre facili e di immediato approccio.
Purtroppo non possediamo una mappa orientativa rispetto ai flussi di superficie e alle mille correnti carsiche che compongono il libro. Sarebbe stata utile una nota relativa al percorso filologico di ciascuno degli scritti, dalla loro occasione e dal loro primo concepimento sino alla stesura finale quale l’autore l’ha effettuata e quale, ulteriormente, risulta dal pregevole e commosso lavoro editoriale del curatore e del prefatore, premurosamente e valorosamente impegnati nella difficile redazione di un’opera postuma, come si sa, piena di svolte labirintiche e di tracce irrisolte. Naturalmente per questo libro va tenuto molto presente il suo carattere postumo, per il quale, qualsiasi sia stata l’occasione e il tempo della genesi, l’autore ha voluto vanificare ogni sforzo archeologico (nel senso foucaultiano del termine), per riconsegnare ogni pagina a una sua attualità, portandola definitivamente con sé.
 La varietà dei temi trattati nei saggi che compongono il libro è difficilmente riassumibile in uno spazio relativamente breve quale quello a mia disposizione. La Sicilia di un Siciliano ne campeggia al centro, con le sue consuetudini popolari e tradizioni intellettuali, con il suo paesaggio economico, culturale e sociale, con i suoi mali endemici e le sue nuove miserie, con la sua separazione classista e la sua permanente illusione di diversità e irriducibilità, con i suoi demologi, antropologi, scrittori. Sinteticamente scrive Cusumano nella sua prefazione: «lontanissimo da ogni asfittica retorica e da certo sicilianismo vissuto come vittimismo, da studioso convintamente europeo e partecipe della civiltà intellettuale espressa dagli sviluppi del pensiero scientifico, Buttitta non esita ad affermare che nascere in Sicilia è comunque un privilegio e con Borgese ribadisce che la Sicilia è ‘un’isola non abbastanza isola, meno che nazione, più che regione’. Il suo sguardo inclusivo e riflessivo è parte intima e consustanziale della cultura che studia dall’interno, nelle sue tradizioni storiche di lunga durata e nelle sue migrazioni tra sincronia e diacronia, tra alto e basso, tra globale e locale».
La varietà dei temi trattati nei saggi che compongono il libro è difficilmente riassumibile in uno spazio relativamente breve quale quello a mia disposizione. La Sicilia di un Siciliano ne campeggia al centro, con le sue consuetudini popolari e tradizioni intellettuali, con il suo paesaggio economico, culturale e sociale, con i suoi mali endemici e le sue nuove miserie, con la sua separazione classista e la sua permanente illusione di diversità e irriducibilità, con i suoi demologi, antropologi, scrittori. Sinteticamente scrive Cusumano nella sua prefazione: «lontanissimo da ogni asfittica retorica e da certo sicilianismo vissuto come vittimismo, da studioso convintamente europeo e partecipe della civiltà intellettuale espressa dagli sviluppi del pensiero scientifico, Buttitta non esita ad affermare che nascere in Sicilia è comunque un privilegio e con Borgese ribadisce che la Sicilia è ‘un’isola non abbastanza isola, meno che nazione, più che regione’. Il suo sguardo inclusivo e riflessivo è parte intima e consustanziale della cultura che studia dall’interno, nelle sue tradizioni storiche di lunga durata e nelle sue migrazioni tra sincronia e diacronia, tra alto e basso, tra globale e locale».
Tutto attorno, il retroterra filosofico classico e moderno su cui lo studioso poggia parte cospicua della sua personale declinazione della sicilianità (Giudizio e giustizia in Aristotele, a esempio); questioni di natura teorica, quali quelle legate alla performatività degli atti narrativi (Storie di vita e vite di storia, a esempio) o alla posizione delle immagini nel contesto delle culture antiche e moderne (“Quando in alto il cielo” e Immagine e conoscenza, arte e verità, a esempio); problemi contemporanei, quali quelli legati all’immigrazione, visti però nella prospettiva di epoche storiche differenti e nell’ottica di lungo periodo che è sempre presente nei ragionamenti dell’autore (I nuovi schiavi). Su tutto il tema ricorrente del rapporto tra tempo, storia e memoria (Cultura e tempo, a esempio, Pensiero e mito).
La molteplicità dei tracciati sin qui richiamati e la pluralità di sguardi con i quali sono visitati, quello filosofico, demologico, antropologico, storico-religioso, linguistico e semiologico, letterario, ricomposti dentro una visione unitaria dei fatti della cultura e in una prospettiva disciplinare olistica, disegnano un percorso ermeneutico peculiare, strettamente legato a una fase degli studi italiani negli anni Settanta e Ottanta, nella quale, come ha sostenuto Clemente, il lavoro di Buttitta si legava «a un approccio antispecialistico e di connessione tra varie discipline intorno a grandi problematiche, sul tema dell’unità della conoscenza umanistica e scientifica» […] fedele a un modello di «conoscenza generale e interdisciplinare sulla natura umana, sui significati fondamentali, sul rapporto uomo-natura, su ragione e sentimento, sulla logica e sulla poesia» [7].
Una formula riassuntiva che mi sembra ben evidenzi aspetti essenziali del lavoro di Buttitta, così come si è espresso nel corso della sua esperienza scientifica e come è ben compendiato nel libro. Rispetto al lessico di Clemente mi discosterei soltanto per quel che concerne il termine interdisciplinare perché mi sembra che lo sguardo di Buttitta comportasse un olismo tutto interno alla visione disciplinare; di una disciplina, naturalmente, che racchiudeva e rappresentava tutte le altre in modo perspicuo. Buttitta non mi sembra avesse particolare propensione per l’interdisciplinarietà, così come convenzionalmente e spesso contraddittoriamente è stata invocata nel periodo della sua attività (amava ascoltare le voci degli altri, che erano “convocati alla cattedra di Palermo” proprio perché portassero il loro contributo di autonoma conoscenza), ma riteneva l’antropologia culturale, quale egli la praticava, una disciplina omnicomprensiva, capace di riassumere al suo interno i molteplici approcci alla visione dell’uomo e della sua vicenda naturale e storica. Ciò non vuol dire, naturalmente, che egli ritenesse l’antropologia una scienza forte, definita, circoscritta e impermeabile. La forza dell’antropologia stava, per lui, nella sua capacità autonoma di rifondare il discorso della scienza e della filosofia, all’interno di un perimetro dai confini labili, a volte indefiniti, ma proprio per questo da ricercare con ostinazione (più volte, sentendolo parlare, ho riflettuto sul fatto che, senza averlo mai espressamente detto o scritto, Buttitta sembrava pensare dell’antropologia ciò che Pierre Bourdieu pensava della sua sociologia, una scienza che ha per sua caratteristica di non voler essere una scienza come le altre).
È però reale l’irrequietezza di Buttitta a stare nei confini disciplinari quali erano disegnati dalla demologia in auge nella seconda metà dello scorso secolo, con la sua forte caratterizzazione per altro post-demartiniana, e dall’antropologia declinata secondo formule del tutto estranee alla tradizione scientifica nazionale, sovente recitate in modo pappagallesco (chiunque lo ha frequentato ha potuto godere dei suoi caustici aneddoti e dei suoi ironici giudizi rispetto alla sempre più numerosa schiera di attardati seguaci di esterofile declinazioni della riflessività).
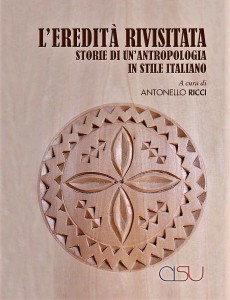 Nel mio intervento al Seminario ricordato in apertura rilevavo, già per quegli anni di prima maturità dello studioso, la sua tensione verso una declinazione siciliana della disciplina. Declinazione che, oltre ad avere un preciso riscontro politico nella gestione accademica e nella configurazione dei rapporti tra scuole di pensiero e tra gruppi di influenza, voleva dire, sul piano teorico, alcune cose: il desiderio, innanzitutto, di non ripetere ossessivamente i mantra dominanti nel contesto nazionale, ma di ricercare negli strati più validi della tradizione demologica e antropologica siciliana, ragioni per reinventare un’originalità del discorso disciplinare; il bisogno, poi, di un forte radicamento filosofico del contesto antropologico (che nel panorama italiano, al di là del marxismo schematico di alcuni anni e del più durevole gramscianesimo, a volte di maniera, era manifesto soltanto in un autore, Ernesto de Martino, con cui, come meglio vedremo avanti, egli era poco in sintonia, anche per la radicale diversità dei loro orizzonti filosofici); la necessità, infine, di connessione dell’istanza critica dell’antropologia con la concreta cultura antropologica dei suoi studiosi, a partire da sé stessi, in modo da tenere a freno le componenti del tutto teoriche e astratte, ciò che non transitasse attraverso una rimeditazione del dolore e del dramma connessi alla propria condizione esistenziale e alla propria tradizione.
Nel mio intervento al Seminario ricordato in apertura rilevavo, già per quegli anni di prima maturità dello studioso, la sua tensione verso una declinazione siciliana della disciplina. Declinazione che, oltre ad avere un preciso riscontro politico nella gestione accademica e nella configurazione dei rapporti tra scuole di pensiero e tra gruppi di influenza, voleva dire, sul piano teorico, alcune cose: il desiderio, innanzitutto, di non ripetere ossessivamente i mantra dominanti nel contesto nazionale, ma di ricercare negli strati più validi della tradizione demologica e antropologica siciliana, ragioni per reinventare un’originalità del discorso disciplinare; il bisogno, poi, di un forte radicamento filosofico del contesto antropologico (che nel panorama italiano, al di là del marxismo schematico di alcuni anni e del più durevole gramscianesimo, a volte di maniera, era manifesto soltanto in un autore, Ernesto de Martino, con cui, come meglio vedremo avanti, egli era poco in sintonia, anche per la radicale diversità dei loro orizzonti filosofici); la necessità, infine, di connessione dell’istanza critica dell’antropologia con la concreta cultura antropologica dei suoi studiosi, a partire da sé stessi, in modo da tenere a freno le componenti del tutto teoriche e astratte, ciò che non transitasse attraverso una rimeditazione del dolore e del dramma connessi alla propria condizione esistenziale e alla propria tradizione.
Vincere il drago, a mio avviso, presenta ancora molto evidenti questi intenti fondamentali dell’antropologia di Buttitta. Condotti su di un piano di più coesa e sistematica consapevolezza. Direi che, ma mano che la proposta della riflessività si andava affermando nello spazio-tempo disciplinare italiano, lo studioso ne avvertiva il carattere effimero e la strumentale adesione di una parte del mondo accademico nazionale, ma coglieva anche l’istanza di radicale rinnovamento che la determinava, sapendone trarre ulteriori motivazioni per quel processo di revisione epistemologica cui egli era sensibile. Le propensioni dei lontani anni Settanta si vanno così coagulando in un itinerario originale di riesame del canone disciplinare, in una rivisitazione dell’istanza riflessiva, se per essa intendiamo il bisogno di rivedere schemi interpretativi angusti e legati a stagioni inattuali della vicenda disciplinare.
Buttitta intraprende, così, un suo peculiare viaggio nei territori della riflessività, in compagnia di aiutanti magici: Niels Bohr, Werner Karl Heisenberg, Albert Einstein, a esempio, su di un versante (originalità di questo percorso, che lo porta a chiedere elementi per la messa in discussione del paradigma delle scienze sociali e dell’antropologia non alla letteratura o agli studi culturali ma alle cosiddette scienze esatte e, conseguentemente, all’epistemologia e alla filosofia della scienza); Agostino, Giovanni Battista Vico («l’unico grande filosofo che ha avuto il nostro Paese!»), Karl Marx, Karl Popper, sull’altro versante (anche qui con un tentativo di uscire dalle convenzioni dominanti nel mondo accademico italiano, con la sua ordinata gerarchia platonica, crociana, gramsciana per attingere a una diversa linea interpretativa del rapporto tra essere e mondo, storia e memoria, individuo e società (nelle fortunate conversazioni che ho potuto avere con loro mi ha sempre sorpreso l’ammirata propensione per Vico di antropologi così diversi come Buttitta e Michael Herzfeld e la loro comune convinzione che il misunderstanding italiano circa la vicenda culturale e sociale complessiva del Paese e la miopia della disciplina a decifrarne aspetti fondamentali nascessero da questa sottovalutazione); uno stuolo d’anime di letterati, che sanno dire, per lo studioso, le cose meglio di noi, con Borges come psicopompo.
Senza dubbio, al di là di queste scelte di carattere generale, l’opera di revisione del paradigma antropologico si salda stabilmente alla prospettiva linguistica e semiologica. È questa prospettiva che contiene, nell’analisi del linguaggio e delle categorie costitutive della significazione, la prospettiva antropologica e quelle filosofica e scientifica; la sostanziale unità del sapere che Buttitta invoca e persegue nelle sue analisi promana dalla cerniera linguistico-semeiotica, dalla sua intrinseca capacità di tradurre su di un piano scientifico l’ambigua oscillazione del comportamento individuale e sociale, dal suo imprescindibile radicamento in una teoria filosofica del linguaggio.
Nella varietà di temi, problemi, approcci, che ho sin qui, molto sinteticamente e, per certo, anche schematicamente ricordato, il recensore è portato a soffermarsi su quanto più da vicino sollecita la sua sensibilità, e attiene anche alla propria vicenda intellettuale. È inevitabile, dunque, che porti la mia attenzione sul saggio dedicato a De Martino e la fine del mondo. Con qualche premessa che può rendere meglio intellegibile lo scritto e la sua posizione nel dispositivo complessivo del volume.
Come ho ricordato, ancora nell’intervento al Seminario romano del 2017, Buttitta pone in epigrafe del suo testo del 1971 un, poi divenuto assai noto, breve passo demartiniano relativo all’impegno dell’antropologo («…ma io entravo nelle case dei contadini pugliesi come un ‘compagno’ …»). Rilevavo lì come il tono complessivo del volume e il suo impianto teorico mi apparissero molto distanti dall’istanza demartiniana, sia quella complessiva, sia quella, più puntualmente richiamata, dell’impegno. Ipotizzavo allora, e ciò ancor più oggi mi sembra plausibile, che quello fosse un modo per mantenere una possibilità di dialogo, evocando la comune appartenenza al contesto democratico e progressista, con uno studioso assai lontano da lui. Nel corso del tempo poi, sia nelle private, a volte accese, conversazioni su temi culturali e scientifici avute con Buttitta, sia nei numerosi interventi pubblici, la sua distanza da de Martino è divenuta quasi un fatto proverbiale nel ristretto contesto degli studiosi italiani. Forse tale distanza si è rafforzata attraverso la vicinanza con Alberto Mario Cirese, la cui ostilità per l’etnologo era nota ed esplicita, certamente attraverso il divergente cammino offerto dalla sua frequentazione di correnti importanti dello strutturalismo europeo.
 Mi sono interrogato spesso sul fatto che anche alcuni miei distinguo rispetto ad aspetti della teoria e, soprattutto, della pratica demartiniane fossero stati sollecitati dalle conversazioni intercorse con Buttitta, pur restando le mie opinioni di gran lunga distanti dalle sue. Nel saggio su de Martino presente in questo libro, un saggio che però, è bene sottolinearlo, viene da lontano, essendo stato già pubblicato, in forme assai simili, nel 2005 [8], chiude la questione, fa i conti con il più anziano collega, individuato non come uno studioso, un professore o un accademico ma, con cavalleresca lealtà, come un intellettuale di grande spessore. Fa i conti con lui e con il suo pensiero, non rinunciando a sottolineare alcune macroscopiche contraddizioni nell’apparato teorico con cui l’etnologo aveva affrontato i contadini del Mezzogiorno, con l’evidenziazione della contrapposizione tra un dichiarato storicismo (quello, sia detto per inciso, che non consentiva a de Martino alcun rapporto con gli studiosi provenienti dagli Stati Uniti, accusati di assoluta insensibilità storiografica) e un praticato evoluzionismo, tra marxismo, sia pur sui generis e approccio psicologistico. I demartiniani contadini del Sud sono figli e nipoti, per Buttitta, di quelli di Pitrè e dei primitivi di Lucien Lévi-Bruhl. Ma individuando anche i pilastri su cui fondare, a futura memoria direi, una possibile linea di vicinanza, a me sembra con un evidente intento riparatorio. Ovviamente tale linea taglia del tutto fuori la trilogia meridionalista di de Martino e raccorda il lavoro sulla fine del mondo direttamente con Il Mondo magico. Opzione critica non nuova nell’esegesi demartiniana [9], e ribadita qui, più che attraverso una puntuale analisi comparativa dei due testi (Il mondo magico è evocato una sola volta, ma in una chiave significativa), attraverso l’enfatizzazione implicita di tematiche del primo libro nella disanima del secondo. Questa linea esegetica taglia del tutto fuori Morte e pianto rituale che è invece il testo che meglio potrebbe raccordare i due estremi prima ricordati, dotandoli di una consequenziale linea di sviluppo: l’opera è ricordata da Buttitta, in modo riduttivo in vero, soltanto per la palmare appartenenza di alcuni suoi passaggi teorici all’ambito evoluzionista. Il saggio su de Martino non smentisce, in definitiva, la lontananza di Buttitta, ma in qualche misura, con un complesso lavorio intellettuale, la sublima; l’individuazione del carattere vissuto della paura di fine del mondo da parte dell’etnologo, del costrutto esistenziale (ed esistenzialista) che permea l’opera, dell’abbandono delle passate contraddizioni per un approccio che faccia pace con psicologia, psicoanalisi e psichiatria clinica, restituiscono l’opera e l’autore a una legittimità teorica che Buttitta considera, con precisa intuizione storica e storiografica, di grandissima attualità.
Mi sono interrogato spesso sul fatto che anche alcuni miei distinguo rispetto ad aspetti della teoria e, soprattutto, della pratica demartiniane fossero stati sollecitati dalle conversazioni intercorse con Buttitta, pur restando le mie opinioni di gran lunga distanti dalle sue. Nel saggio su de Martino presente in questo libro, un saggio che però, è bene sottolinearlo, viene da lontano, essendo stato già pubblicato, in forme assai simili, nel 2005 [8], chiude la questione, fa i conti con il più anziano collega, individuato non come uno studioso, un professore o un accademico ma, con cavalleresca lealtà, come un intellettuale di grande spessore. Fa i conti con lui e con il suo pensiero, non rinunciando a sottolineare alcune macroscopiche contraddizioni nell’apparato teorico con cui l’etnologo aveva affrontato i contadini del Mezzogiorno, con l’evidenziazione della contrapposizione tra un dichiarato storicismo (quello, sia detto per inciso, che non consentiva a de Martino alcun rapporto con gli studiosi provenienti dagli Stati Uniti, accusati di assoluta insensibilità storiografica) e un praticato evoluzionismo, tra marxismo, sia pur sui generis e approccio psicologistico. I demartiniani contadini del Sud sono figli e nipoti, per Buttitta, di quelli di Pitrè e dei primitivi di Lucien Lévi-Bruhl. Ma individuando anche i pilastri su cui fondare, a futura memoria direi, una possibile linea di vicinanza, a me sembra con un evidente intento riparatorio. Ovviamente tale linea taglia del tutto fuori la trilogia meridionalista di de Martino e raccorda il lavoro sulla fine del mondo direttamente con Il Mondo magico. Opzione critica non nuova nell’esegesi demartiniana [9], e ribadita qui, più che attraverso una puntuale analisi comparativa dei due testi (Il mondo magico è evocato una sola volta, ma in una chiave significativa), attraverso l’enfatizzazione implicita di tematiche del primo libro nella disanima del secondo. Questa linea esegetica taglia del tutto fuori Morte e pianto rituale che è invece il testo che meglio potrebbe raccordare i due estremi prima ricordati, dotandoli di una consequenziale linea di sviluppo: l’opera è ricordata da Buttitta, in modo riduttivo in vero, soltanto per la palmare appartenenza di alcuni suoi passaggi teorici all’ambito evoluzionista. Il saggio su de Martino non smentisce, in definitiva, la lontananza di Buttitta, ma in qualche misura, con un complesso lavorio intellettuale, la sublima; l’individuazione del carattere vissuto della paura di fine del mondo da parte dell’etnologo, del costrutto esistenziale (ed esistenzialista) che permea l’opera, dell’abbandono delle passate contraddizioni per un approccio che faccia pace con psicologia, psicoanalisi e psichiatria clinica, restituiscono l’opera e l’autore a una legittimità teorica che Buttitta considera, con precisa intuizione storica e storiografica, di grandissima attualità.
E, ancora nell’ottica cui prima ho fatto cenno, è inevitabile che mi soffermi brevemente anche sui saggi dedicati alle immagini, già prima richiamati. L’immagine è stata oggetto che ha affascinato Buttitta sin dagli esordi della sua attività, e su precisi repertori figurativi appartenenti alla tradizione siciliana, come si ricorderà, con un approccio innovativo che coniugava salde competenze demologiche e avanzate sensibilità semeiotiche, egli si è sovente cimentato [10]. Il mio stesso interesse per le immagini legate ai contesti popolari, i cui esiti si concretizzarono in un volume apparso nella medesima collana in cui è Vincere il drago, da lui per altro fondata, molto deve al suo esempio e al suo incoraggiamento, pur essendosi poi sviluppato in un ambito metodologico-critico differente [11].
La vicenda delle immagini nel mondo antico, nella tradizione orientale e mesopotamica, in quella cristiana, con tutte le diatribe, le dispute teoriche, le contraddizioni e i compromessi, sullo sfondo di imponenti lotte di potere, che vi ebbero luogo, è visitata da Buttitta in modo sintetico ma dotato di grande perspicuità e lucidità. Gli fanno da guida, nel suo itinerario, essenzialmente tre filosofi puri (per così dire), quali Pavel Aleksandrovič Florenskij (anche matematico e soprattutto mistico, con evidente coincidenza, pur nella diversità degli approcci teorici, con quell’idea unitaria e rischiarata del sapere che Buttitta custodiva), Regis Debray e Jean-Jacques Wunenburger; senza alcuna concessione, dunque, nei confronti delle nuove prospettive conoscitive delle immagini collegate con la teoria dell’agency, con i Visual Studies, con la storia e la critica d’arte strutturalista e post-strutturalista, con l’iconologia (Aby Warburg) e la più recente Bildwissenschaft, con le teorie cognitive (alla David Freedberg, per intenderci).
L’immagine è posta in relazione con il pensiero, con le strutture logiche, con la parola, in un tentativo di definizione filosofica della sua funzione, che tenta poi di ricollocare le singole rappresentazioni all’interno delle logiche di potere e dominio correnti. Nessun approccio ontologico, dunque, nessuna postura frontale (di fronte alle immagini, Georges Didi-Huberman), nessun tentativo di guardare dietro le immagini, partendo dalle logiche sociali e agentive che sono loro connaturate (Michael Baxandall, Alfred Gell). La stessa traccia semeiotica che così efficacemente aveva guidato Buttitta nelle sue concrete esperienze di ricerca sui repertori, e che ancora dà un tono all’intero volume, è qui sottaciuta e, direi, messa da canto. Ciò che conduce il gioco è l’idea della realtà delle immagini e della contrapposizione tra realtà e rappresentazioni, con una sostanziale idea di continuità dell’atteggiamento umano nel corso dei millenni.
Quest’idea, però, unita all’ancoraggio alla prospettiva esclusivamente filosofica che prima ho indicato, rendono, a mio avviso, più fragile il discorso rispetto alla modernità e alla post-modernità, che vedono regimi di creazione e d’uso (nonché d’interpretazione) delle immagini radicalmente diversi. L’idea del medium, a esempio, del mezzo tecnico che consente all’immagine di essere creata e all’autore di emergere come tale, è vista nel segno della causalità artigianale caratteristica dei mondi pre-moderni e non nel senso del dramma del dominio dell’uomo sull’imperiosità di mezzi tecnici che costruiscono le immagini contro e malgrado lui, secondo l’impostazione (anch’essa filosofica) di Vilém Flusser. La temporalità delle immagini, altro tema cruciale affrontato nell’esegesi contemporanea, conduce Buttitta nei territori dell’astoricità à la Focillon e non in quelli, mi sembra di maggiore pregnanza euristica ed ermeneutica, dell’anacronismo, à la Didi-Huberman. Più in generale, rispetto al quadro di fondo tracciato dallo studioso, occorre osservare che se è vero che le immagini possono essere realtà perché queste ultime s’incarnano in loro, è pur vero che possono esserlo anche perché colonizzano la realtà; e i due ordini problematici, come si può comprendere, appaiono radicalmente diversi.
Ho richiamato, di passaggio, per avviarmi alla conclusione, le propensioni letterarie di Buttitta. Vorrei tornarvi brevemente su non soltanto per il costante dialogo con le opere degli scrittori che Buttitta intrattiene [12], ma anche perché la sua stessa pagina saggistica è pagina letteraria di notevole eleganza.
Le propensioni letterarie di Buttitta sono, nel libro, copiosamente espresse, sempre accompagnate da motivazioni legate, in modo più o meno immediato, alla personale sensibilità, allo stile di scrittura dei singoli autori prescelti, alla valenza filosofica ed epistemologica del loro pensiero, alla loro capacità di portare prove dell’umano sul tavolo dello studioso degli uomini. Vi è stata, naturalmente, una strada, direi quasi obbligata, che Buttitta ha percorso in questo particolare ambito: la lezione paterna, felicemente ricordata nel saggio Del padre e per Ignazio; l’appartenenza al contesto della casa editrice Sellerio e la vicinanza con Elvira (cui il nostro libro è dedicato); l’amicizia, fatta anche di numerose occasioni di collaborazione, più volte evocate, con Sciascia. Quanto, insomma, portava verso una direzione scrittoria, romanzesca, un ambito razionalista e geometrico, di derivazione illuministica (anche se le pagine sullo scrittore di Racalmuto, non sic et simpliciter illuminista, sul suo non del tutto compiuto illuminismo, sono di significativo e problematico interesse – Delle feste religiose o di Leonardo Sciascia); verso quella che Vincenzo Consolo definì, in una sua intervista del 1999, una direzione comunicativa piuttosto che espressiva, una direzione scrittoria piuttosto che narrativa [13].
Ora, la cultura linguistica di Buttitta, i fondamenti poetici della sua sensibilità letteraria, la sua straordinaria vocazione di narratore che sapeva ben riassumere le qualità della narrazione mercantile e di quella contadina, secondo gli assunti benjaminiani esemplarmente enunciati nel saggio su Nicolai Leskov [14] (che egli ben conosceva), la sua esistenziale appartenenza alla declinazione barocca della cultura occidentale, avrebbero fatto pensare a una propensione per Consolo; e per Giuseppe Bonaviri, a esempio, di cui non gli ho mai sentito parlare nella sua fluente e generosa disanima, con gli amici, dei “fatti di storia letteraria e civile”, di Beniamino Joppolo, forse; e tra gli stranieri per Alejo Carpentier, Juan Rulfo, João Guimarães Rosa. Per tutte quelle personalità letterarie, insomma, in cui l’impegno civile si coniugava con un impegno di destrutturazione di codici linguistici ritenuti complici delle logiche del dominio, in cui il mistilinguismo o plurilinguismo, come lo aveva definito, con riferimento a Consolo, Cesare Segre, il visionarismo s’impongono come obbligata strategia eversiva. Unica smagliatura nelle sue scelte elettive, il particolare che rivela il buon dio di warburghiana memoria, la dichiarata consuetudine, in realtà in questo libro non particolarmente evidente, ma ben nota a chi aveva l’onore di frequentare lo studioso, con Fernando Pessoa. «I know not what tomorrow will bring…», avrebbe potuto essere frase pronunciata da Buttitta non soltanto, come la vulgata vuole per Pessoa, in punto di morte, ma in qualsiasi momento della vita.
Poche righe di conclusione. Vincere il drago è un libro che, come ancora ricorda Cusumano, «ripercorre i tornanti dei complessi e annosi dibattiti che hanno occupato la comunità scientifica e fa chiarezza su teorie e metodologie, modelli e ideologie, false innovazioni e vecchie insipienze accademiche». Ma è anche un libro, come ho ricordato in apertura, che mi piace definire dispositivo, nel senso che Giorgio Agamben ha dato al termine di derivazione foucaultiana, di atto linguistico e letterario di alta performatività sociale, teso a serrare l’interlocutore dentro una strategia del convincimento [15]; ed è un libro, ancora, che vuole costituire impegnato atto di testimonianza di scelte e convinzioni (lo studioso, «del beneficio del dubbio, si serviva in silenzio», commossamente ricorda Emanuele Buttitta nella sua nota introduttiva); che ambisce, infine, a essere lascito testamentale, qualcosa che deve contribuire, in modo univoco e unidirezionale, alla comprensione del travagliato e felice passaggio di un uomo su questa terra e del suo rilevante lascito culturale.
Dialoghi Mediterranei, n. 54, marzo 2022
Note
[1] Cfr. A. Buttitta, Ideologie e Folklore, Palermo, Flaccovio, 1971. Per gli atti di quel Seminario, si veda A. Ricci (a cura di), L’eredità rivisitata. Storie di un’antropologia in stile italiano, Roma, Cisu, 2019.
[2] Cfr. Pitrè e Salomone Marino. Convegno internazionale di studi a cento anni dalla morte, Palermo, 23-26 novembre 2016. Si veda R. Perricone (a cura di), Pitrè e Salomone Marino. Atti del convegno internazionale di studi a 100 anni dalla morte, Palermo, Edizioni del Museo Pasqualino, 2017.
[3] Cfr. A. Ricci (a cura di), L’eredità rivisitata. Etc., cit.: 179-196.
[4] Cfr. A. Buttitta, Orizzonti della memoria. Conversazioni con Antonino Cusumano, Alcamo, Ernesto Di Lorenzo, 2015: 100.
[5] P. Clemente, in A. Ricci (a cura di), L’eredità rivisitata. Etc., cit.: 179.
[6] F. Faeta, in A. Ricci (a cura di), L’eredità rivisitata. Etc., cit.: 189-190.
[7] P. Clemente, in A. Ricci (a cura di), L’eredità rivisitata. Etc., cit.: 187.
[8]Rendendo accessibile il testo di una conversazione che Buttitta aveva tenuto a Matera il 27 ottobre 2003. Si veda A. Buttitta, Le apocalissi e il pensiero di Ernesto de Martino, in B. Baldacconi, Pierangela Di Lucchio (a cura di), Dell’Apocalisse. Antropologia e psicopatologia in Ernesto de Martino, Napoli, Alfredo Guida Editore, 2005: 55-65.
[9]Per un’ultima, in ordine di tempo, messa in relazione tra le due opere, si veda G. Charuty, Relire Le mond magique, in E. De Martino, Le monde magique, préface et traduction de G. Charuty, Paris, Bartillat, 2022: 6-42.
[10] Si vedano A. Buttitta, Cultura figurativa popolare in Sicilia, Palermo, Flaccovio, 1961: Id., La pittura su vetro in Sicilia, Palermo, Sellerio, 1972; Id., Gli ex voto di Altavilla Milicia, Palermo, Sellerio 1983.
[11] Cfr. F. Faeta, Il santo e l’aquilone. Per un’antropologia dell’immaginario popolare nel secolo XX, Palermo, Sellerio, 2000.
[12] Mi è gradito ricordare in proposito l’altra opera postuma di Buttitta, portata a termine assieme a suo figlio Emanuele. Cfr. A. Buttitta, E, Buttitta, Antropologia e letteratura, Palermo, Sellerio, 2018.
[13] Cfr. V. Consolo, Come ho scritto i miei libri, intervista di M. Belpoliti ed E. Grazioli, in “Doppiozero”, 21 gennaio 2022; https://www.doppiozero.com; consultazione del 30 gennaio 2022.
[14] Cfr. W. Benjamin, Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nicola Leskov, in Angelus Novus. Saggi e frammenti, trad. di S. Solmi, Torino, Einaudi, 1982/2: 247-274.
[15] Si veda G. Agamben, Che cos’è un dispositivo? Roma, Nottetempo, 2006.
______________________________________________________________
Francesco Faeta, professore di Antropologia culturale, ha insegnato presso le Università della Calabria e di Messina; insegna ora come professore esterno presso la Scuola di Specializzazione per i Beni Culturali DEA dell’Università “La Sapienza” di Roma. Docente Erasmus nelle Università di Valladolid e de’ A Curuña, è stato Direttore di Studi invitato all’École Pratique des Hautes Études di Parigi, nel 2004, fellow e associate researcher dell’Italian Academy for Advanced Studies in America presso la Columbia University, nel 2012. Ha effettuato ricerche in ambito europeo, con particolare riferimento al Sud d’Italia. Fa parte dei comitati scientifici di riviste italiane e straniere e dirige, per Franco Angeli, la collana Imagines. Studi visuali e pratiche della rappresentazione. Tra le sue ultime pubblicazioni Le ragioni dello sguardo. Pratiche dell’osservazione, della rappresentazione e della memoria, Torino, Bollati-Boringhieri, 2011; Fiestas, imágenes, poderes. Una antropología de las representaciones, Vitoria Gasteiz-Buenos Aires, Sans Soleil Ediciones, 2016; La passione secondo Cerveno, Milano, Ledizioni, 2019; Il nascosto carattere politico. Fotografie e culture nazionali nel secolo Ventesimo, Milano, Franco Angeli, 2019; L’albero della memoria. Scrittura e immagini, Palermo, Museo Pasqualino 2021. Di imminente uscita Vi sono molte strade per l’Italia. Ricercatori e fotografi americani nel Mezzogiorno degli anni Cinquanta, Soveria Mannelli (Cz), Rubbettino.
______________________________________________________________